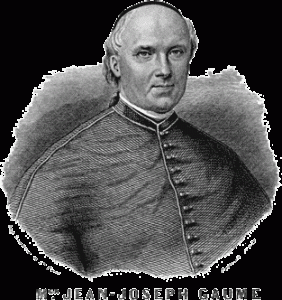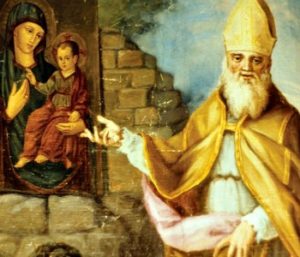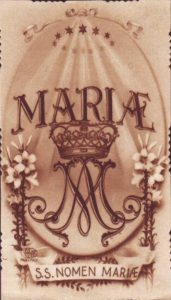Spirito Santo: IV creazione: il cristiano (2).-
Svolgimento del cristiano.
[Mgr. J.-J.Gaume, Trattato dello Spirito Santo: capp. XXI, XXII, XXIII -Firenze 1887]
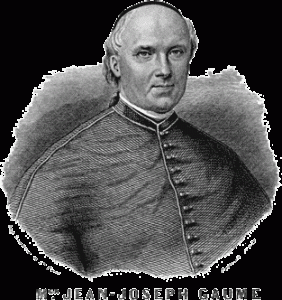
(In questi capitoli che riguardano ancora la “quarta creazione” dello Spirito Santo, cioè il Cristiano, viene tratteggiata con chiarezza una “aritmetica spirituale”, che nella sua linearità, semplicità ed evidenza, fa impallidire tutti i sistemi umani escogitati da presunti sapienti, che nulla hanno potuto comprendere della Sapienza divina se non marginali dettagli, male interpretati ed utilizzati; in particolare viene destituita di ogni fondamento razionale, la numerologia della “scimmia” di Dio, piatto forte della “cabala spuria”, veleno che, con i suoi simboli, segni e cifre, attossica i popoli cristiani che, ignari, cadono nella ennesima rete tesa loro, mediante servi occulti, sedicenti “illuminati”, dal “signore dell’universo”! [N.d.r.] Mettiamoci comodi e gustiamoci, centellinandole, queste leccornie spirituali che edificano la mente e lo spirito, confermandoci sempre più nella fede all’unico vero Dio, Uno e Trino, Creatore dell’universo e di ciò che contiene, e nella sua unica e vera CHIESA, la Chiesa di Gesù-Cristo, guidata dal “vero” romano Pontefice, la Chiesa Cattolica romana, unico mezzo attraverso il quale si giunge alla salvezza eterna.)
# # #
Il cristiano riceve la vita nell’acqua del Battesimo: tale è il primo articolo della fede cattolica e la quarta creazione dello Spirito Santo nel nuovo Testamento. La vita del cristiano è la grazia. La grazia è il tesoro di tutte le ricchezze. Con essa e per essa noi possediamo tutte le virtù soprannaturali infuse, intellettuali e morali: le tre virtù teologali, le quattro virtù cardinali, madri di tutte le altre; lo Spirito Santo medesimo in persona con tutti i suoi doni. Ciò essendo, che cosa manca al cristiano? Tutto quello che manca al bambino che é nato. O sia figlio di povero o figlio di re, mancano ad esso i mezzi di conservare la vita, della quale è in possesso. Cosi del cristiano. Possessore di una vita divina, mancano a lui i mezzi di conservarla e di perfezionarla. Vediamo con quale liberalità lo Spirito Santo ha provvisto ai bisogni del bambino.- Noi accenniamo gli ineffabili misteri della grazia. Dinanzi a noi sta per rivelarsi tutto il sistema d’educazione o piuttosto di deificazione, posto in opera dallo Spirito Santo, per condurre il cristiano fino alla perfetta rassomiglianza col suo fratello maggiore, il Verbo fatto carne. Questo magnifico sistema racchiude i sacramenti, le virtù, i doni, le beatitudini ed i frutti. Disposti con una meravigliosa sapienza, questi mezzi conservatori e deificatori, si sovrappongono, s’incatenano, si prestano un mutuo concorso, e fanno dello svolgimento del cristiano il capo d’opera dello Spirito Santo, la sua opera propria o, come dice san Paolo, la costruzione di Dio: Dei “aedificatio estis”. E prima di tutto non basta avere la vita, bisogna conservarla e svilupparla. Tale è il fine dei Sacramenti. – « I sacramenti della nuova legge, dice san Tommaso, sono istituiti per un duplice scopo: guarire le malattie dell’anima, e darle la forza di compiere gli atti della vita cristiana. Senza dubbio la grazia, considerata in generale, perfeziona l’essenza dell’anima, dandole una certa somiglianza all’essere divino. Ora, dall’essenza dell’anima derivano le sue potenze: ne risulta che perfezionando l’essenza dell’anima, la grazia comunica alle sue potenze nuove perfezioni. Queste perfezioni, chiamate virtù e doni, le rendono capaci delle loro funzioni particolari; ma non basta. Vi sono nella vita cristiana certi atti speciali per i quali un effetto particolare di grazia è necessario. I sacramenti sono stabiliti in vista di questi atti speciali, a fine di comunicare al cristiano il peculiare aiuto di cui ha bisogno per compierli. Per conseguenza siccome le virtù e i doni aggiungono qualche cosa alla grazia, considerata in generale, cosi la grazia sacramentale aggiunge alla grazia in generale, alle virtù e ai doni una forza divina in rapporto con ciascun sacramento, » [“Sacramenta novae legis ad duo ordinantur, videlicet; ad remedium contra peccatum et ad perfìciendam animam in his qua e pertinent ad cultum Dei secundum ritma christianae vitae”. m p., q. 68, art. 1 corp. – “Ita gratia saeramentalis addit super gratiam communiter dictam et super virtutes et dona, quoddam divimim auxilium ad consequendum sacramenti finem”. Id., art. 2, corp]. I sacramenti sono stabiliti per guarire le infermità dell’anima; ma come raggiungono essi il loro fine? Il Battesimo è stabilito contro il difetto di vita divina: la Confermazione, contro la debolezza naturale ai bambini; l’Eucaristia, contro le cattive inclinazioni del cuore: la Penitenza contro il peccato mortale o la perdita della vita divina; l’estrema Unzione, contro i residui dei peccati e i languori dell’anima; l’Ordine, contro l’ignoranza e la dissoluzione della società cristiana ; il Matrimonio, contro la concupiscenza personale e contro l’estinzione della Chiesa che sarebbe la cessazione della vita divina sulla terra. [“Baptismus est directe contra culpam originalem; poenitentia, contra culpam actualem mortalem; estrema unctio, contra culpam venialem; ordo, contra ignorantiam; matrimonium, contra cuncupiscentiam; eucharistia, contra malitiam; confirmatio: contra infìrmitatem”. Conc. Vaur., 1368, c. X, et S. Thom., III p., q. 65, art. 1, corp.]. – Questo è appunto l’insieme più completo dei rimedi preservativi e curativi di tutte le infermità dell’anima, compresavi la morte medesima. Chi l’ha concepito, chi l’ha stabilito e chi le ha dato l’efficacia? Lo Spirito Santo. – Ma non è che metà dell’opera sua. Rimane da svolgersi la vita divina. Come la vita naturale, cosi la Vita soprannaturale si svolge mediante gli atti. Quali sono gli atti speciali della vita cristiana, pei quali la grazia dei sacramenti è indispensabile? In virtù della mirabile uniformità che regna tra l’ordine spirituale e l’ordine materiale, questi atti sono nel numero di sette e corrispondono ad altrettanti atti analoghi della vita corporea. Nell’ordine naturale, bisogna che l’uomo nasca, che si fortifichi, che si nutrisca, che guarisca, che mantenga la sua salute e che divenga membro della società, tanto per dirigerla, come per conservarla. Parimente, nell’ordine soprannaturale bisogna che il cristiano viva da figlio di Dio. La grazia propria del battesimo gli dà e la nascita divina e lo spirito del Cristianesimo. – « La misericordia di Dio ci ha salvato, dice l’Apostolo, mediante la lavanda di rigenerazione e di rinnovellamento dello Spirito Santo ; cui egli diffuse in noi copiosamente per Gesù Cristo salvator nostro. » [Ad. Tit, III, 5, 6]. – Bisogna eh’ egli acquisti le forze convenienti per sopportare la fatica del dovere, e sostenere le battaglie della virtù. La confermazione gli comunica lo Spirito Santo come principio di forza. Di qui quella parola di Nostro Signore ai suoi discepoli già battezzati : « Io manderò sopra di voi il promesso dal Padre mio. Trattenetevi dunque in città fino a tanto che siate rivestiti di virtù dall’ alto. » [Luc., XXIV, 49]. Occorre che egli si nutrisca di un cibo relativamente alla sua vita divina. L’Eucaristia gli dà questo cibo : « Io sono il pane vivo, che sono disceso dal cielo, dice il Verbo incarnato; se poi non mangerete la carne del Figliuolo dell’uomo, e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. [Joan., VI, 51-54]. » Nascere, crescere e mantenere la sua vita basterebbe all’uomo, se corporalmente e spiritualmente egli possedesse una vita impassibile. Ma siccome egli va soggetto ad infermità gravi e frequenti, ha bisogno di rimedi. S’egli perde la salute, la penitenza glie la rende, secondo queste parole: « Guarite l’anima mia perché io ho peccato. I peccati saranno rimessi a chi voi gli rimetterete.1 » [Ps. XL. – Joan.. XX, 23]. – Se le sue forze sono alterate da languori e dalle infermità, egli ne ritroverà la pienezza nell’estrema unzione. Questo sacramento purifica l’uomo dagli avanzi del peccato, lo fortifica nell’ ultimo combattimento e lo prepara ad entrare in possesso della gloria eterna. « Se vi è tra voi chi sia malato, dice san Giacomo, chiami i preti della Chiesa e facciano orazione sopra di lui, ungendolo coll’olio nel nome del Signore, e se trovisi con dei peccati gli saranno rimessi.2 » [Jac., V, 14]. – Nei cinque primi sacramenti, il cristiano trova tutti gli espedienti necessari agli atti della vita individuale. Come Essere sociale, bisogna che compia i doveri della società della quale è membro. I due ultimi sacramenti gliene forniscono i mezzi. Due cose sono essenziali a qualunque consorzio umano; la direzione e la conservazione. Occorrono uomini pubblici incaricati di condurre gli altri. – Il sacramento dell’ordine dà dei ministri alla Chiesa e delle guide ai fedeli. « Ogni pontefice, dice l’apostolo, preso di tra gli uomini è preposto a pro degli uomini a tutte quelle cose che Dio riguardano, affinché afferisca doni e sacrifici pei peccati. » [Hebr., V, 1,2] – Ci vogliono delle famiglie per perpetuare la società: nel consacrare l’unione degli sposi, il sacramento del matrimonio arreca loro le grazie necessarie per adempiere cristianamente ai loro doveri, perpetuare la Chiesa e popolare il cielo. Quindi quella parola di san Paolo ; « Il matrimonio è un gran sacramento in Gesù Cristo e nella Chiesa. » [Eph., V, 32. Et S. Th., III p., q. 65, art. 1, corp.]. -Da ciò che precede vediamo in complesso la ragione d’essere di ciascun sacramento e il posto che occupa nel disegno del nostro svolgimento divino.-Tutti, come il battesimo, ci comunicano la grazia, e per conseguenza lo Spirito Santo che ne é inseparabile; ma in ciascun sacramento questa comunicazione ha un fine speciale, relativamente ai bisogni della nostra vita spirituale. Ne risulta che per la grazia multiforme dei sacramenti, lo Spirito Santo dà al cristiano la vita divina con i mezzi di conservarla e di farne gli atti. In questa guisa viene adempita la prima parte della missione del Verbo incarnato che diceva: Io sono venuto affinché essi abbiano la vita: “Ego veni ut vitam habeant”. Come si compie la seconda, cioè: affinché essi l’abbiano più abbondantemente, “et ut abundantius habeant”. Sta scritto che l’unigenito Figliuolo di Dio cresceva in età e in sapienza dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini: cosi il cristiano, suo fratello, deve seguire lo stesso progresso. Nel concetto divino, lo sviluppo della vita della grazia deve andare grado a grado a diffondersi nella vita della gloria: “Gratia inchoatio gloriae”. La pure non si arresterà. Al contrario salirà essa di continuo, di perfezioni in perfezioni, di felicità in felicità, per i secoli dei secoli. Per quali modi lo Spirito vivificatore procura Egli queste ascensioni del tempo, preludio delle ascensioni dell’eternità? attivando il germe di vita che Egli ha posto in noi, in modo da fargli accordare tutto ciò che Egli può dare. Ora come abbiamo veduto, la grazia è un principio divino, il quale opera sull’essenza stessa dell’ anima e su tutte le sue potenze. Come principio di una forza e di una fecondità incalcolabile, Egli produce nell’ uomo effetti molteplici, sovrumani, teandrici. – In ragione del duplice destino dell’uomo, la grazia si divide in due grandi specie. Il cristiano non è un essere isolato, ma un essere sociale; più sociale, se è lecito dirlo, di tutti gli altri uomini, poiché appartiene alla società universale, il cui scopo è di fare dell’umano genere un sol popolo di fratelli. Senza dubbio, dovrà egli lavorare alla deificazione personale; che è la prima legge del suo essere. Ma come figlio della Chiesa dovrà altresì, nei limiti della sua vocazione, lavorare per la gloria di sua madre e alla deificazione dei suoi fratelli. – Quest’è una nuova legge alla quale non può sottrarsi. Essa è talmente imperiosa che, qualunque cosa faccia, ogni uomo è necessariamente medium: medium del Verbo santificatore, o medium di Satana corruttore. Quindi due sorta di grazie, ovvero due applicazioni della grazia, la grazia santificante e la “gratis data. Intorno a questo principio fondamentale ascoltiamo l’Angelo della scuola : « Tutte le opere di Dio, dice san Tommaso, sono fondate nell’ ordine. Ora, è legge dell’ordine universale che certe creature siano ricondotte a Dio per mezzo di altre creature. La grazia, avendo per iscopo di ricondurre l’uomo a Dio, segue le leggi dell’ordine, ciò é dire che essa riconduce a Dio certi uomini, per mezzo di altri uomini. Quindi due sorte di grazie. La prima che unisce l’uomo a Dio si chiama grazia, gratum faciens, perchè essa ci rende gradevoli presso Dio. La seconda, mediante la quale 1’uomo aiuta il suo fratello a venire a Dio, si chiama “gratia gratis data”, perché essa non ha per iscopo la santificazione personale di colui che la riceve, e che non gli è punto data in vista dei suoi meriti. » [“Secundum hoc igitur duplex est gratia. Una quidem, per quam ipse homo Deo conjungitur, quae vocactur gratia gratum faciens. Alia vero, per quam unus homo cooperatur alteri ad hoc quod ad Deum reducatur”. I, II, q. 111, art. l, corp.]. – Da questa unica sorgente della grazia, divisa in due fiumi inessiccabili, escono tutte le meraviglie del mondo cristiano, meraviglie di virtù private, che hanno Dio e gli Angeli per testimoni; meraviglie di splendide virtù che hanno il genere umano per ammiratore; virtù private, brillante famiglia di perfezioni che completandosi le une con le altre, portano il cristiano al più alto punto di rassomiglianza con Dio [Conc. Trid., sess. VI, c. 7]; virtù pubbliche che fanno risplendere sulla fronte della Chiesa 1’incomunicabile sigillo della verità; virtù pubbliche e private di cui vive, senza saperlo, il mondo medesimo ; imperocché egli vive dello Spirito Santo e di Lui solo. Presentiamo in iscorcio il quadro di tutte queste meraviglie. Egli ci farà ad un sol colpo d’occhio, cogliere l’insieme degli elementi di cui si compone la nostra generazione divina, e l’ordine perfetto nel quale essi si coordinano. Il conte de Maistre dice che il corpo umano apparisce più meraviglioso sulla tavola anatomica che nella più bella attitudine della vita. Cosi è del cristiano. Meglio di tutto il resto, l’anatomia di questo capolavoro dello Spirito Santo ne riveste l’ammirabile bellezza, perché essa pone alla scoperto, nelle sue misteriose operazioni, la sapienza dell’Artefice che l’ha formato. – Ecco, secondo i maestri della scienza, un saggio di autopsia cattolica: o se si vuole, l’indicazione dei gradini della scala misteriosa, per la quale l’uomo sale dalla terra al cielo: e di figliuolo d’Adamo diventa figliuolo di Dio. – Mediante il battesimo lo Spirito Santo comunica all’anima la vita soprannaturale; mediante gli altri Sacramenti. – Ei la fortifica e la conserva. Ma come il chicco del grano non è affidato alla tèrra che per propagarsi in mèssi, cosi l’elemento soprannaturale non è depositato nell’anima se non che per manifestarsi con abitudini soprannaturali, e queste abitudini si chiamano “Virtù”. Come i Sacramenti, le Virtù sono in numero di sette : tre Teologali e quattro Cardinali. Alle virtù si aggiungono i “Doni”. Come ispirazioni permanenti dello Spirito Santo essi perfezionano le virtù, comunicando in loro un nuovo impulso, una energia più sostenuta, una tendenza più eminente. Se ne constano sette: e formano, dice un Concilio, le sette grandi santificazioni del cristiano. [“Haec dona, juxta sacras scripturas, consimiliter septem esse asserimus, quasi septem sanctifìcationes fìdelium mentium”. Conc. Vaur., c. I]. – Aiutato da questi mezzi potenti, il cristiano è in stato di credere come conviene gli articoli del simbolo, e di praticare i precetti del decalogo, ciò che è il fine della vita e il principio della gloria. Notiamo di passaggio col Concilio già citato, che il simbolo si divide naturalmente in sette articoli relativi alla SS. Trinità, e sette relativi al Figliuolo di Dio fatto uomo. Parimente i dieci precetti del decalogo si riferiscono alle sette virtù teologali e cardinali. Arrivato alla perfezione della vita divina, rimane al cristiano il mantenervisi, poiché da sé medesimo non è capace. La sua naturale debolezza unita agli’assalti incessanti dei suoi nemici, l’espone di continuo a cadere. La grazia che abbiamo vista manifestarsi in virtù e in doni, si manifesta qui in preghiere. Le sette domande della orazione domenicale corrispondono ai sette Doni dello Spirito Santo. Tutte le volte che noi pronunziamo quest’adorabile orazione, chiediamo la conservazione e l’accrescimento di questi doni divini; e lo stesso Spirito Santo onde renderla efficace la dice nell’anima del cristiano, con gemiti da non potersi narrare. I sette Doni dello Spirito Santo conservati e fortificati dalla preghiera divengono nelle mani del cristiano come tante armi di precisione contro i suoi nemici. Satana ci assale con sette armi che appellansi i sette peccati capitali. I sette doni dello Spirito Santo ne formano adeguata opposizione. – Dichiarando coraggiosamente questi nobili combattimenti della virtù il cristiano si mantiene ordinato. – L’ordine gli procaccia la pace con Dio, co’ suoi fratelli e con sè medesimo, e questa pace dà nascimento alle sette “beatitudini. – Finalmente glorioso sarà il frutto di buone fatiche, secondo la parola della Scrittura: Bonorum enim laborum gloriosus est fructus. [Sapien. III, 15]. Ora, poiché non vi sono fatiche migliori di quelle che si compiono nel vasto campo della vita spirituale, a queste nobili fatiche corrispondono i dodici frutti dello Spirito Santo. Questi frutti deliziosi danno all’anima che se ne ciba, un saggio di quello che tutti gli racchiude, il frutto cioè della vita eterna: Fructus in vìtam aeternam. Allorquando verrà la fine dei tempi, il cristiano, deificato dallo Spirito Santo, entrerà in possesso di questo frutto incomparabile, la cui vista, il gusto, il godimento, inonderà di delizie indicibili: imperocché questo frutto sarà Dio medesimo, veduto, gustato, posseduto senza timore, con un amore senza limiti. [Additiamo qui la frequente ripetizione del numero sette negli elementi della nostra santificazione. Più sotto cercheremo di dare la ragione di questa ripetizione misteriosa. “Articuli Symboli pertinentes ad deitatem sunt septem…. Articùli autem ad naturam a Filio Dei assumptam, sunt septem…. Virtutes theologicae cum cardinalibus, totidem. Sacramenta Ecclesiae totidem. Dona Spiritus sancti, totidem. Petitiones in dominica oratione contentae, totidem. Vitia capitalia, totidem”. Conc. Vaur. c. I. —- Intorno al numero dodici che misura i frutti dello Spirito Santo, bisogna notare due cose: la prima, nella Sacra Scrittura il numero dodici indica la perfezione assoluta. La seconda, ciascun dono avendo parecchi atti, il numero dei frutti supera necessariamente quello dei doni. Per non ne citare che un esempio : dal dono di pietà escono le sette opere di misericordia corporale, e le sette opere di misericordia spirituale; ciò che costituisce la perfezione della carità]. – Pur tuttavia noi non conosciamo ancora, fuorché gli effetti della grazia santificante, principio della deificazione personale del cristiano. Per dare un’idea completa dei tesori diffusi dallo Spirito Santo nell’anima battezzata, bisogna mostrare gli effetti della grazia gratuita. Il cristiano, come essere sociale e figlio della Chiesa, deve, lo ripetiamo, travagliare alla gloria della madre sua e alla deificazione dei suoi fratelli. A questo scopo tre cose sono indispensabili: conoscere a fondo le verità cristiane, a fine di ammaestrarne gli altri; essere in stato di provarle, senza di che l’insegnamento sarebbe inefficace; avere il talento di esprimerle per far gustare la dottrina. 2 S. Th., l a 2ae, q. 111, art. 4, Corp.]. – Tali sono gli effetti della grazia “gratis data”. Essi comprendono, come il fine comprende i mezzi, tutti i doni esteriori enumerati da san Paolo. « A ciascuno, dice egli, è data la manifestazione dello Spirito Santo per utilità. E all’uno è dato per mezzo dello Spirito il linguaggio della sapienza; all’altro poi il linguaggio della scienza secondo il medesimo spirito. A un altro la fede; a un altro il dono delle guarigioni; a un altro l’operazione dei prodigi; a un altro la profezia; a un altro la discrezione degli spiriti ; a un altro ogni genere di lingue; a un altro l’interpretazione delle favelle. » [I Cor., XII, 7, 10]. – Comuni a tutti i cristiani, poiché tutti debbono travagliare alla salute de’ loro fratelli, questi doni sono loro comunicati in differenti proporzioni, secondo la vocazione di ciascuno. Da prima il dono d’insegnare la verità. Egli suppone una cognizione della religione superiore a quella che basti per la salute. Quindi la fede, cioè dire in complesso una vista chiara, ed una certezza incrollabile delle cose invisibili, principio dell’insegnamento cattolico. Inoltre bisogna conoscere le principali conseguenze di questi principi. Di qui il “linguaggio della sapienza” che é la estesa cognizione delle cose divine. – Fa d’uopo possedere altresì una grande abbondanza di fatti e di esempi spesso necessari per dimostrare le cause; quindi il “linguaggio della scienza” che è la cognizione delle cose umane, attesoché il mondo invisibile si rivela agli occhi nostri mediante il mondo visibile. In seguito viene il dono di provare. Nelle cose che sono del dominio della ragione, la prova della dottrina insegnata si fa per via del ragionamento. Nelle cose dell’ordine soprannaturale, con mezzi riservati alla potenza divina. Questi mezzi sono miracoli e profezie. Contrariamente a tutte le leggi della natura, rendere la sanità agli infermi, la vita ai morti : miracolo. Di qui la “grazia delle guarigioni”. Manifestare l’onnipotenza di Dio, fermando il sole, per esempio, ovvero dividendo le acque del mare: miracolo. Quindi la grazia dei prodigi. A queste prove dell’onnipotenza di Dio sul mondo materiale, deve qualche volta unirsi la prova della sua conoscenza infinita del mondo morale. Quindi la grazia della profezia, che é la conoscenza dei futuri contingenti. Di qui ancora la grazia del discernimento degli spiriti, vale a dire la cognizione dei segreti i più reconditi del cuore. Finalmente il dono di comunicare. Esso può essere considerato sotto un duplice aspetto: il primo, dal punto di vista della lingua nella quale il dottore della verità dee parlare, e del modo con cui deve parlare. Da ciò il dono delle favelle e la grazia del linguaggio, che insegna il vero significato delle parole di una lingua straniera. [Vedi S. Th, l a, 2ae, q. 111, art. 4, corp.]. -Tale è il rapido quadro della formazione del cristiano mediante lo Spirito Santo. Noi domandiamo al filosofo, qualunque si sia, se nelle sue investigazioni ha mai trovato, se nelle sue meditazioni ha mai concepito nulla di così magnifico, di cosi completo e di meglio legato di questo complesso di mezzi, mediante i quali si sviluppa in ciascuno di noi il principio divino, e con i quali noi medesimi lo sviluppiamo negli altri, sino alla misura del Verbo incarnato nella sua età perfetta? Quando si pensa che, a malgrado di tutte queste perfezioni, il cristiano quaggiù non è che un Dio cominciato, qual lingua può dire le sue glorie, allorché in cielo sarà un Dio consumato? « Carissimi, scrive san Giovanni, noi siamo adesso figliuoli di Dio ; ma non ancora si è manifestato quel che saremo. Sappiamo che quand’egli apparirà, saremo simili a Lui; perché lo vedremo qual egli è . 1 » [I Ep., III, 2. — I d . , E v . XXII, 20]. – Per apprezzare come conviene un superbo edifizio non basta conoscere i ricchi materiali di cui è composto; fa d’uopo sapere in quali proporzioni, con qual arte, secondo quali calcoli sono stati posti in opera. Abbiamo enumerati gli elementi che entrano nella formazione del cristiano, o, per ricordare una figura dei sacri libri, i materiali impiegati dallo Spirito Santo nella costruzione del suo tempio vivente. Ma qui non è che una parte delle meraviglie che noi dobbiamo ammirare. -Per conoscerle tutte, bisogna studiare le matematiche divine, secondo le quali ha lavorato l’abile artefice. – Ora, in ciò che precede si è certamente notato l’uso del numero dieci e del numero dodici. Ma come non essere stati colpiti dalla ripetizione costante del numero sette? La struttura del cristiano sembra basarsi in grande su questo numero. Se vi sono dodici articoli nel simbolo, dodici frutti dello Spirito Santo e dieci precetti nel decalogo, vi sono altresì sette sacramenti, sette virtù madri, sette domande nel Pater, sette doni dello Spirito Santo, sette beatitudini, sette peccati capitali, sette opere di carità corporale e sette opere di carità spirituale. – Credere che questo numero sia arbitrario, sarebbe un errore. La sapienza infinita ha presieduto alla formazione del mondo spirituale con più cura, se é possibile, che alla creazione del mondo fisico. Se questo numero non è arbitrario, se non può esserlo, quale n’è la significazione misteriosa? Perché ritorna egli cosi sovente nell’opera più degna di Dio? Per rispondere è necessario balbettare alcune parole intorno alla scienza dei numeri sacri e del numero sette in particolare. – Questo studio non è una digressione. Non abbiamo da seguire lo Spirito Santo nelle sue vie, e fare ammirare i calcoli dell’adorabile operaio che ha fatte tutte le cose con misura, numero e peso? [“Omnia in mensura, et numero, et pondero disposuisti.” Sap., xi, 21]. – Oggi, d’altronde, che il materialismo più non vede nei numeri altro che delle cifre, é egli fuor di proposito ricordare, almeno di passaggio, una scienza familiare ai primi cristiani, filosofica fra tutte, ricca di profonde vedute, e risplendente di magnifiche armonie?
I Numeri.
La scienza dei numeri, che non bisogna confondere con l’arte del calcolo, non è una scienza immaginaria. Chi oserebbe tassare in tal modo una scienza che fu, sino dalla più remota antichità, l’oggetto dello studio e dell’ammirazione dei veri filosofi? Uno dei più grandi geni che siano comparsi nel mondo, sant’Agostino, la coltivava con una specie di passione. Questo stesso ardore era per lui il termometro del sapere e il segno del genio. « A misura, dice egli, che l’uomo dotto e l’uomo di studio si liberano della materialità che gli circonda, quanto più essi vedono chiaramente il numero e la sapienza, tanto più essi amano l’uno e l’altro. » [“Docti et studiosi, quanto remotiores sunt a labe terrena, tanto magis et numerum et sapientiam in ipsa veritate contuentur et utrumque carimi habent”. De lib. arbitr., lib. II, c. XI, n. 31, 32, opp. t. I, p. 875-976]. – Queste parole dell’ illustre dottore significano che agli occhi del genio purificato, i numeri, formanti la parte più eminente della scienza umana, sono la base dell’universo, le leggi che presiedono alla sua conservazione. Fatto per essi, per essi sussiste, ad essi egli deve tutta la sua bellezza. « Considerate, continua il gran vescovo, il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che racchiudono; ciò che brilla al disopra del vostro capo, o che striscia a’vostri piedi, o che vola nell’ aria, o che nuota nelle acque: tutte queste cose sono belle, perché hanno dei numeri; togliete i numeri, esse perdono all’istante la bellezza e la vita.1 » [S. Aug., De Ub. arbitr., ubi supra, p. 982]. – Niente di più vero. Togliete il numero dal firmamento e voi avete la scossa e la rovina degli astri. Togliete il numero dalla terra, dal mare, dagli elementi, da tutte le creature, voi non avete più né ordine, né armonia, né esistenza, poiché l’ordine, l’armonia, l’esistenza riposano essenzialmente sopra tanti numeri, vale a dire sopra tante proporzioni calcolate con precisione. In luogo suo che abbiamo noi? Il caos. Tra 1’ordine e il caos, tra la bellezza e la bruttezza, tra la vita e la morte, tra 1’armonia e il disaccordo, è il numero solo che costituisce la differenza. – Se le opere di Dio riposano sul numero, le opere del1’uomo, immagine di Dio, riposano altresì sul numero. Ogni operaio, ogni artista ha davanti agli occhi dello spirito un numero, cioè dire un complesso di proporzioni al quale egli conforma il suo lavoro. La sua intelligenza travaglia, la sua mano si affatica, i suoi strumenti si muovono finché l’opera esterna, di continuo guardata nel lume interiore del numero, non giunga alla perfezione e soddisfaccia lo spirito, giudice interiore che contempla il numero, modello dell’opera. Finche non vi giunge, voi avete un’opera imperfetta, e se mai se ne allontana affatto, voi avete una cosa mostruosa, una cosa senza nome, perché è senza numero. – Togliete per esempio il numero da una composizione musicale, voi avrete suoni discordanti e voci confuse. « Il numero, dice il Conte de Maistre, è la barriera evidente tra il bruto e noi…. Iddio ci ha dato il numero, ed è per il numero che a noi si mostra, come è per il numero, che l’uomo si mostra al suo simile. Togliete il numero, voi togliete le arti, le scienze, la parola e per conseguenza l’intelligenza. Riconducetelo, con esso ricompariscono le sue due figlie celesti, l’armonia e la bellezza. Il grido diventa canto, il rumore riceve ritmo, il salto è danza, la forza si chiama dinamica, e le linee sono tante figure. » – Non solamente le opere dell’ uomo riposano come quelle di Dio sul numero,- ma sono fatte col numero. Ciò che mette in movimento le membra dell’operaio, è il numero; imperocché esse si muovono in cadenza. Se voi attribuite al piacere il movimento misurato delle sue membra, voi avete il ballo. Cercate ora ciò che piace nel ballo; il numero risponderà: sono io. – Contemplate la bellezza delle forme nel corpo: chi la costituisce? i numeri che rimangono fissi nello spazio. La bellezza del movimento nel corpo a che cosa è dovuta? ai numeri che si muovono nel tempo. Così succede di tutte le opere dell’uomo, come di tutte le opere di Dio. Il numero, e il numero solo, dà loro l’essere e la bellezza. [(Sapientia) dedit numeros omnibus rebus, etiam infìmis. S. Aug., ubi supra, p. 976. — “Tolle numerum in rebus omnibus, et omnia pereunt. Adirne saeculo computum, et cuncta ignorantia caeca complectitur. Nec differre potest a caeteris annnalibus, qui calculi nescit rationem”. Superi, De operib. sanctissimae Trinitatis, lib, LXII ; De Spirit. sanct., lib. VII, c. XIV]. – Come si vede la scienza dei numeri racchiude le leggi dell’ordine universale, come pure la rivelazione dei più profondi misteri. A ragione dunque i più bei geni se ne sono preoccupati. Se nei tempi moderni essa é caduta in dimenticanza, bisogna attribuirla alla debolezza della ragione, conseguenza inevitabile dello scadimento della fede. Il mondo è pieno di abbachisti, ma non abbiamo più matematici. Si disprezza la scienza dei numeri, perché, ridotta all’arte materiale del calcolo, essa è alla portata di tutti. Quanto alla vera scienza dei numeri, alla filosofia dei numeri, in una parola, alla matematica divina, la si dispregia; atteso che ella non ha una applicazione immediata agli interessi della vita animale, e che non può essere altro che il patrimonio di pochi. [“Multos novi numerarios et muneratores, vel si quo alio nomine vocandi sunt, qui summe ac mirabiliter computant: sapientes autem perpaucos”. S. Aug., ubi supra, p. 875]. – Cercare la scienza dei numeri, non è dunque tener dietro ad una chimera. Ma che cosa è il numero? I numeri sono nel tempo e nello spazio, ma non sono né il tempo, né lo spazio. I numeri sono indefiniti, immutabili, eterni. Non avvi potenza umana che possa cambiare l’ordine dei numeri, o violarne l’essenza. Chi può, per esempio, fare che il numero che segue l’uno non sia due, o che il numero tre sia divisibile in due parti eguali? [“Ergo aeternos esse (numero) non negas. Imo fateor. S. Aug., De Musica, opp., T.1, p. II, p. 870; Id., De morib. Manich. c. XL, opp. t. I, p. II, p. 1170; De civ. Dei, lib. XII, c. XVIII]. -Cosa è dunque il numero? « Se volete saperlo, risponde sant’Agostino, elevatevi al disopra delle opere di Dio, nelle quali il numero risplende da tutte le parti. Elevatevi al disopra dell’anima umana che in essa ha la vista interiore del numero. Andate sino a Dio: là nel santuario intimo della sapienza medesima, vedrete il numero eterno, tipo e sorgente di tutti i numeri. Ma la sapienza medesima esiste ella per il numero, o consiste nel numero? Io non oso affermarlo. » [“….Sapientiam existere a numero, aut consistere in numero, non ausim dicere”. De lìber. arbitr., ubi supra, p. 976]. – Una cosa é certa: se il numero nella sua essenza non è la stessa sapienza, realizzata nelle opere di Dio, ne è pero l’espressione la più perfetta. Un’ altra cosa è egualmente certa; vi sono dei numeri, soprattutto nella sacra Scrittura, che sono sacri e pieni di misteri. 22 [“Numeros in Scripturis esse sacratissimos et mysteriorum plenissimos, ex quibusdam quos inde nosse potuimus, dignissime credimus”. S. Aug., Quaest. in Gen., c. CLIII; opp. t. III, p. 657]. – La tradizione di tutti i secoli è unanime su questo punto. Sacri, poiché è Dio medesimo che gli ha fissati; pieni di misteri, perché sono le leggi venerabili dell’ordine morale, e l’espressione dei rapporti intimi tra l’uomo e le creature, tra Dio e l’uomo, tra il tempo e l’eternità. A questo doppio titolo essi sono degni di un profondo rispetto e di un ardente studio. – Quali sono questi numeri misteriosi e sacri? Se ne conta una quantità infinita. Nella sola costruzione del Tabernacolo, sant’Agostino ne conta più di venti che tutti son pieni di misteri. [“Magnum mysterium figuratimi est, quando jussum est tabernaculum fabricari. Multa ibi numerosa dieta sunt in magno sacramento. Serm. 88, c. VI, opp. t. V, p. I, p. 645. — S. Th., 2a 2ae, q. 87, art. 1, corp.]. – Ci basti studiarne qualcuno. I più notevoli sono : il numero tre, il quattro, il sette, il dieci, il numero dodici e i loro multipli. – Tanto nell’Antico che nel Nuovo Testamento, il numero tre ritorna più di 359 volte; il numero quattro, 165 volte; il numero sette 347 volte; il numero dieci 239 volte; il numero dodici 177 volte; il numero quaranta 152 volte, e il numero cinquanta 61 volte. -Se facciamo attenzione che la Bibbia è di tutti i libri conosciuti il solo che indichi costantemente e con una precisione, apparentemente minuziosa, i numeri delle cose, delle misure, degli anni; che la Bibbia è l’opera della sapienza infinita; che nulla vi è d’inutile; che tutto in essa è mistero e verità; che Dio ha fatto tutto con numero; come non riconoscere in questa ripetizione sorprendente, l’intenzione evidente d’ammaestrarci? Ma che cosa c’insegnano i numeri sacri? Secondo i Padri, e sant’Agostino in particolare, il numero tre c’insegna la SS. Trinità. In Dio, vi è unità, trinità, indivisibilità. Il numero tre è uno e indivisibile; per dividerlo bisogna frazionarlo, cioè dire romperlo e distruggerlo. Da Dio vengono tutti gli esseri. Dal numero tre, unità primordiale, derivano tutti i numeri. – II Dio uno e trino ha scolpito la sua impronta su tutte le sue opere. Di qui quell’assioma della filosofia tradizionale: Tutte te cose sono uno e tre: “Porro omnia unum sunt et trìa”. – Il numero tre, rivelatore del Dio creatore, redentore e santificatore, trovasi quasi ad ogni pagina della Scrittura. Inoltre il Dio uno e trino, Creatore, Redentore e Santificatore ha fatto tutto, e ancora fa tutto col numero tre. Nell’ordine fisico, col numero tre, il mondò è tratto fuori dal nulla. Noi vediamo il Padre che crea; il Principio o il Figlio pei quale è creato; lo Spirito Santo che feconda il caos. Col numero tre il mondo è salvato. Noè che deve ripopolarlo ha tre figli: trinità terrestre, immagine viva della trinità creatrice. – Nell’ordine morale tutta l’esistenza del popolo ebreo, figura di tutti i popoli, è basata sul numero tre. La sua nascita in Isaac ha luogo col numero tre. Per annunziarlo ad Abramo, tre personaggi misteriosi appariscono al patriarca che non ne adora che un solo. Tre misure di farina sono adoprate a fare il loro pasto. – La liberazione dell’Egitto si fa col numero tre. Mosè salvatore del popolo, è tenuto nascosto da sua madre durante tre mesi. Gli Ebrei domandano a Faraone il permesso d’internarsi nel deserto per tre giorni. – La religione è stabilita sul numero tre. Ogni anno Israele deve celebrare tre grandi solennità nell’unico tempio di Gerusalemme. Costantemente egli prescrive di offrire nei sacrifizi tre misure di farina. Tre imbasamenti di pietra pulita sostengono l’atrio interiore del tempio di Salomone, tre gradini di pietre segate, il grande spazio lo circonda al di fuori. Il mare di bronzo riposa sopra tre bovi rivolti ad Oriente, tre all’Occidente, tre a Mezzogiorno, tre a .Settentrione: trinità che sorregge tutto, che è dappertutto e tutto vede. – La società, con i diversi avvenimenti che la distinguono è regolata dal numero tre. Così tre città d’asilo sono al di qua del Giordano e tre al di là. Gli esploratori di Giosuè si nascondono tre giorni nelle montagne vicine a Gerico. La presa della città e la conquista della Palestina sono il risultato di quella misteriosa ritirata. – Col numero tre si compiono i miracoli consolatori e liberatori della sacra nazione. Per colmarla di abbondanti benedizioni, l’arca dimora tre mesi nella casa di Obededom. Elia si china tre volte sul figlio della vedova di Zarepta, per ridonarlo alla vita. Prima d’ essere favorito dalle sue grandi rivelazioni, Daniele dee digiunare tre settimane, e tre volte al giorno voltarsi verso Gerusalemme per adorare. A fine di forzare Nabuccodonosor a confessare pubblicamente il vero Dio, tre fanciulli sono gettati nella fornace. Un soggiorno miracoloso di tre giorni dentro le viscere di una balena dee servire di credenziale a Giona a preparare la conversione di Ninive. Avanti di presentarsi ad Assuero, Ester ordina agli Ebrei tre giorni di digiuno: essa è obbedita; e contro ogni aspettiva, Israele, salvato dallo sterminio, diventa libero di rientrare nella terra de’ padri suoi. – Questi tratti sparsi segnalano l’ufficio continuo e sovrano del numero tre nell’antico mondo. Non meno interessante è il posto che esso tiene nel nuovo mondo. – L’incarnazione del Verbo è come la creazione del mondo rigenerato. L’augusto mistero si compie col numero tre. Il Padre copre Maria con la sua ombra onnipotente; lo Spirito Santo forma l’umanità del Figlio: il Verbo s’incarna. Quando é necessario manifestare il mistero rigeneratore e far conoscere il Figlio di Maria per il Padre del mondo nuovo, il numero tre ricomparisce con splendore sulle rive del Giordano: il Verbo è battezzato, il Padre Lo proclama suo Figlio, e lo Spirito Santo discende sotto la forma di una colomba. – Nel corso della sua vita mortale, il Redentore avrà bisogno di confermare la sua missione. Chi Gli renderà testimonianza in cielo e sulla terra, davanti agli Angeli e davanti agli uomini? Il numero tre. Cristo è la verità, dice san Giovanni, e ve ne sono tre che Gli rendono testimonianza in cielo: il Padre, il Verbo, e lo Spirito Santo: e ve ne sono tre che gli rendono testimonianza sulla terra: lo spirito, l’acqua e il sangue. [Joan., V, 7, 8]. Sul Tabor vuole egli manifestare la sua divinità: tre apostoli gli servono da testimoni. Nell’orto degli olivi egli deve mostrare in tutta la sua realtà la natura umana; tre apostoli gli servono ancora di testimoni, e questi stessi discepoli potranno affermare davanti all’universo intero ch’egli è Dio e uomo insieme. – Finalmente, quando è venuta l’ora in cui deve salvare il mondo col suo sangue, col numero tre si compierà il mistero, restando Gesù tre ore sulla croce e tre giorni nel sepolcro. – Come parteciperà l’umanità ai meriti del Redentore, e come di figlia di Adamo diventerà ella figlia di Dio? Per il numero tre. È in nome del Dio uno e trino che il mondo nuovo prenderà nascimento nelle acque battesimali, come il mondo antico l’aveva presa in nome dello stesso numero nelle acque primitive. Queste acque rigeneratrici chi le farà conoscere alle nazioni? Il numero tre. Pietro é a Cesarea: il vaso misterioso che gli annunzia la rovina del muro che separa il giudeo dal gentile, discende tre volte dal cielo, e tre uomini vengono a cercare il pescatore di Galilea per pregarlo di battezzare gli incirconcisi. – Il mondo è nato, ma bisogna che viva. Egli vivrà del numero tre. La fede, la speranza e la carità saranno il suo alimento divino sino alla fine del suo pellegrinaggio. La sua eterna dimora dovrà le sue perfezioni misteriose al numero tre. La Gerusalemme celeste ha tre porte all’oriente, tre all’occidente, tre al mezzogiorno, tre al settentrione. Perché in questi esempi e in cento altri che possiamo citare, il numero tre e non il numero quattro, cinque, sei o otto? Nessuno può dire che questo numero è arbitrario o forzato. Liberamente impiegato da una sapienza infinita esso racchiude un mistero. Questo mistero l’abbiamo indicato: il numero tre è il segnale rivelatore della Trinità. Adoprato nelle opere capitali dell’Onnipotente, la creazione, la redenzione, la glorificazione insegnano all’uomo creato, redento, glorificato di Chi egli sia opera, su qual tipo è stato formato, ed a Chi deve render gloria. – Per quanto umile sia ogni creatura, porta essa scolpito su di sé il numero tre, a fine di annunziare a tutti con quell’ impronta indelebile chi è il suo Autore ed il suo proprietario. Come per esempio il cervo di Cesare, il cui collare portava scritto: “Io appartengo a Cesare, non mi toccate; la pianta come l’animale dice all’uomo: io appartengo a Dio uno e trino, rispettatemi. [“Ternarius vero numerus Patrem et Filium et Spiritum Sanctum insinuate”. S. Aug., Serm. 252, c. X, t. I, p. 1521]. .-.- Passiamo al numero quattro. Manifestandosi al di fuori, la SS. Trinità produce gli esseri creati, il tempo e lo spazio. Quest’ è che rappresenta il numero quattro, che segue immediatamente il numero tre e che ne procede. Diversamente dal numero tre, il numero quattro é divisibile. Tale è la condizione del tempo, e delle cose del tempo. Ciò nonostante, come avvi il tre in ciascuna creatura, avvi pure in ciascuna natura qualche cosa di indivisibile e d’immutabile: ed è l’essere. Da ciò deriva che, se tutto perisce, nulla rimane annientato. – Con le quattro unità di cui si compone il numero quattro, rappresenta la materia, composta di quattro qualità: altezza, lunghezza, larghezza e profondità: il mondo diviso in quattro punti cardinali; il tempo, formato di anni di cui ciascuno si decompone in quattro stagioni: “il numero quattro è dunque la misura e la legge delle cose create”. – A giudizio dei Padri, questa significazione del numero quattro, semplice o moltiplicato, è invariabile nella Scrittura. «Se il numero tre è il segno dell’eternità, il segno di Dio in tre persone e dell’anima in tre facoltà, il numero quattro, dice sant’Agostino, è il segno del tempo e della materia. » Come segno del tempo: l’anno di cui si compongono i secoli si divide in quattro parti: la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno. Questa divisione non è affatto arbitraria, atteso che essa segna dei cambiamenti palpabili nella natura. La scrittura conta pure quattro venti, sull’ ali dei quali si propagano in quattro canti del mondo, e i grani delle piante e il seme evangelico. » [“In quaternario numero est insigne temporum, etc.” Serm. 552, c, X, t. I, p. I, p. 1521. — “Manifestum est ad corpus quateraarium numerum pertinere,propter elementa notissima quibus constat”. Enarrat. in ps. VI, t. IV, p. I, p. 32]. – Ammiriamo come il numero quattro completa l’insegnamento del numero tre. Questo, rivelatore della Trinità e dell’eternità, dice all’uomo, che Dio solo è indivisibile, immutabile ed eterno. Come segno della creatura e del tempo, il numero quattro gli dice, che il tempo e tutto ciò che appartiene al tempo, è divisibile, mutabile, perituro: che la terra è un luogo di passaggio; che noi vi siamo viandanti, e che la vita è un camminare continuo verso l’immutabile;22 [II tempo, questa immagine mobile dell’immobile eternità.]. – Ciò che insegna di per se stesso, il numero quattro continua ad insegnarlo per le sue quantità. Fecondato dai numero tre arriva a dodici. Fra tutti i numeri, il dodici è uno dei più sacri. Egli rappresenta la creazione tutta quanta, il tempo, lo spazio, vivificata dalla SS. Trinità e chiamata alla deificazione. Nel giorno del giudizio, dice il Verbo Creatore, Redentore e Santifìcatore, dodici seggi saranno preparati per i dodici Apostoli chiamati a giudicare le dodici tribù d’Israele. – « Che cosa significano questi dodici seggi, domanda sant’Agostino? Perché il numero dodici e non un altro? – Il mondo si divide in quattro parti, secondo i quattro punti cardinali. Di queste quattro parti, gli abitanti sono chiamati, perfezionati e santificati dalla SS. Trinità. Poiché tre volte quattro fanno dodici, voi vedete perché i santi appartengono al mondo intero, e perché vi saranno dodici seggi preparati ai dodici giudici delle dodici tribù d’Israele. Difatti, da una parte, le dodici tribù d’Israele rappresentano non solo l’universalità del popolo ebreo ma di tutti i popoli; dall’altra, i dodici giudici rappresentano l’universalità dei santi, venuti dalle quattro parti del mondo e chiamati a giudicare i peccatori venuti pure dalle quattro parti del mondo. Così dal numero dodici, sono rappresentati tutti gli uomini, giudici e giudicati, radunati dalle quattro parti. del mondo dinanzi al tribunale dell’Uomo-Dio. » [Enarrat. in ps. 49, c. 8, t. IV, p. 640] – Quante volte nel suo misterioso, ma eloquente linguaggio, il numero dodici ricorda questi grandi dommi della creazione degli uomini per mezzo della santa Trinità, della loro vocazione al battesimo per mezzo della medesima e del conto che avranno da rendere all’ultimo giorno, delle tre facoltà della loro anima che ne formano l’immagine della SS.Trinità! Noi gli vediamo scritti nei dodici figli di Giacobbe; nelle dodici tribù d’Israele; nelle dodici fontane del deserto, dove si dissetarono gli Israeliti, pellegrini della terra promessa; nelle dodici pietre preziose del razionale, sulle quali è scolpito il nome delle dodici tribù, nei dodici mortai d’oro per il servigio del tabernacolo; nelle dodici ampolle d’argento per le libagioni; nei dodici esploratori di Mose e nelle dodici pietre depositate nel letto del Giordano. – Noi gli troviamo più chiari ancora nei dodici Apostoli; nelle dodici sporte piene di avanzi di pani miracolosi, e nella celebre visione di san Pietro. « Il capo della Chiesa universale, dice sant’Agostino, vide un vaso simile ad un lenzuolo scendente dal cielo, sostenuto dai quattro canti ei nel quale si trovavano animali di ogni specie. La visione ebbe luogo tre volte. Quel vaso sostenuto dai quattro angoli era la figura del mondo diviso in quattro parti, e che doveva essere tutto evangelizzato: ecco perché sono stati scritti quattro Vangeli. – Questo vaso che scende tre volte dal cielo segna la raccomandazione che il Figlio di Dio fece a’ suoi apostoli, di battezzare tutte le nazioni nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. – « Di qui pure, il numero di dodici apostoli. Questo numero non è nient’affatto arbitrario. Che dico io? È talmente sacro, che bisognò completarlo dopo l’apostasia di Giuda. Ma perché dodici apostoli e non più di dodici? – Perché il mondo, diviso in quattro parti, doveva essere chiamato al Vangelo in nome della SS. Trinità. Ora, quattro moltiplicato per tre dà dodici: numero della Chiesa universale, nella quale sono gli ebrei ed i gentili figurati dagli animali di ogni specie, contenuti nel vaso misterioso. » [Enarrat, in ps, 103, t. IV, p. 1640]. – Le stesse verità proclamate dal numero dodici le vediamo ancora nei dodici giudici del mondo e le vedremo risplendenti di una nuova luce nei dodici fondamenti in pietre preziose e nelle dodici porte della Gerusalemme futura; nei dodici frutti dell’albero della vita, infine nelle dodici stelle che compongono in cielo l’eterna corona della Chiesa. – Questa non è però che una parte dei solenni insegnamenti dati dal numero quattro. Moltiplicato col numero dieci, altro numero sacro del quale parleremo in breve, quale insieme di leggi mirabili e rivelazioni feconde offre alla meditazione degli spiriti attenti! – « Il numero quaranta, dice sant’Agostino, segna la durata del tempo, durante il quale travagliamo sulla terra. » [“Quadragenarius numerus tempus hoc significat, in quo laboramus in saeculo”. Serm. 252, c. X, t. I, p. I, p. 1521]. – O gran genio che avete già visto, e come tutta la storia vi rende testimonianza! – Come tante energiche figure della vita dell’uomo quaggiù, delle sue fatiche e dei suoi patimenti, le acque del diluvio non cessano di cadere sulla terra, per quaranta giorni e quaranta notti. Il pericoloso viaggio degli esploratori di Mosè dura quaranta giorni. Mosè medesimo digiuna quaranta giorni sulla montagna, prima di ricevere la legge. Gli Ebrei, popolo tipo dell’umanità, errano quarant’anni nel deserto prima di valicare il Giordano. Durante quaranta giorni, il gigante Golia insulta il campo d’ Israele: figura trasparente del demonio, che insulta la Chiesa, per tutta la durata del suo pellegrinaggio. Davide regna quarant’anni: immagine del vero Davide, il cui regno abbraccia la totalità del tempo. – Elia nutrito di un pane miracoloso, digiuna quaranta giorni e quaranta notti, prima d’arrivare in cima del monte di Dio: è il cristiano fortificato dalla grazia, in cammino verso l’eternità. Il doloroso sonno d’Ezechiele per l’espiazione dei peccati di Giuda, dura quaranta giorni, durata totale della vita cristiana, definita dal concilio di Trento, una penitenza perpetua. Quaranta cubiti formano la lunghezza del tempio. Una dilazione di quaranta giorni è accordata a Ninive; è il tempo dato al genere umano per convertirsi. Avanti la presa di Gerusalemme fatta da Antioco, cavalieri e carri armati, attraversano il cielo per quaranta giorni. Il gran penitente del mondo, il Verbo incarnato, digiuna quaranta giorni; e dopo la sua resurrezione rimane sulla terra, istruendo i suoi discepoli durante quaranta giorni. – « I tre grandi digiuni di quaranta giorni, continua sant’Agostino, segnano tutta la durata del mondo e la condizione dell’uomo sulla terra. Mosè digiunando quaranta giorni è il genere umano sotto la legge; Elia digiunando quaranta giorni è il genere umano sotto i profeti; Nostro Signore digiunando quaranta giorni, è il genere umano sotto il Vangelo. Ora, siccome la vita dell’uomo sotto il Vangelo deve durare sino alla fine del tempo, il digiuno di Nostro Signore è stato perpetuato dalla Chiesa, a fine di avere tutto il suo significato. – Vedete come é ben posto! qual tempo meglio adattato per ricordarci la nostra condizione terrena, digiunando e mortificandoci, come i giorni vicini alla passione del Salvatore ? » [“In qua ergo parte anni congruentis observatio quadragesimae constitueretur, nisi confini atque contigua dominicae passionis?” Epist. XV, clas. 2, c. xv, t. 31, p. I, p. 207: Id., Serm, 51, c. XXII, t. V, p. I, p. 429].
Numero dieci e numero sette
Il numero quaranta rappresenta il tempo con le sue divisioni, le sue successioni, le sue penose fatiche e le sue lotte incessanti. Ma il tempo non è che il cominciamento della vita, e per il cristiano il vestibolo della beata eternità. Qual numero ricorderà all’uomo questa verità consolante? Il numero dieci aggiunto al numero quaranta. Questa addizione non ha d’arbitrario nulla di più degli altri calcoli sacri. I più grandi geni ne hanno riconosciuta la profonda giustizia. Secondo san Tommaso, il numero dieci è il segno della perfezione. – Perché? Perché è il primo e insuperabile limite dei numeri. Al di là di dieci, i numeri non continuano ma ricominciano da uno. [“Decima est perfectionis signum, eo quod denaxius est quodammodo numerus perfectus, quasi primus limes numerorum, ultra quem numeri non procedunt, sed reiterante ab uno”. 2a, 2ae, q. 87. art. 1, cor. ; et p. in, q. 31, art. 8, corp.]. Cosi in tutte le cose, allorché siamo arrivati alla perfezione non si continua, ma si ricomincia. L’orologiaio, per. esempio, che ha fatto una mostra perfetta, non continua a lavorarvi, ma ne ricomincia un’altra. Il fatto del numero dieci, come limite dei numeri, è di tutti i paesi e di tutti i tempi. Qual prova più evidente che esso non è arbitrario né di umana invenzione? Bisogna dunque riconoscere ch’è misteriosamente divino e divinamente misterioso. – Da ciò deriva, secondo il giudizio dei Padri, che nella Scrittura lo Spirito Santo l’usa cosi sovente, per notare la perfezione tanto in bene che in male. In nome d’Isaac, Abramo manda il suo servo Eliezer con dieci cammelli carichi di doni, a chiedere una sposa per suo figlio: quest’è il vero Isacco che cerca la Chiesa, la vera Rebecca, e gli offre come patto di nozze, i suoi dieci comandamenti, principio della sua deificazione. Dieci fratelli di Giuseppe vanno a cercare del grano in Egitto: quest’è l’universalità degli uomini che domandano il pane di vita al vero Giuseppe. Mosè riceve da Dio dieci comandamenti, né più né meno; è la perfezione della legge. – Dieci candelabri d’oro risplendono nel tempio di Gerusalemme, perfezione della luce la quale con i dieci comandamenti illumina la Chiesa, tempio augusto di cui Gerusalemme non era che la figura. Il salterio di David ha dieci corde; perfezione della lode. Dieci lebbrosi si presentano a Nostro Signore; è tutto il genere umano infermo, che implora la sua guarigione. Il principe del Vangelo distribuisce dieci monete ai suoi servi, per farle valere durante la sua assenza: dieci comandamenti sono dati a tutti gli uomini, per praticarli, e giungere alla perfezione. La bestia dell’Apocalisse ha dieci corni: simbolo della sua terribile potenza: e dieci diademi sul capo: segno dell’immensa estensione del suo impero. – Il numero dieci, preso in sé stesso come limite insuperabile dei numeri, è dunque il segno della perfezione. Se si aggiunge al numero quaranta, egli conserva la stessa significazione, ma diviene più evidente e si applica ad un ordine di cose più elevato. Quaranta e dieci fanno cinquanta: questo numero segna la riunione del tempo e dell’eternità. Lasciamo parlare sant’Agostino: « Il numero quaranta è la misura del tempo : epoca di sudori, di lacrime, di fatiche, di patimento e di doloroso pellegrinaggio nel deserto della vita. Ma allorché avremo ben compiuto il numero quaranta, camminando nella strada dei dieci comandamenti, riceveremo il denaro promesso alle buone opere. Cosi, al numero ben riempito di quaranta, aggiungete la ricompensa del danaro composto di dieci, ed avrete il numero di cinquanta. – Quest’è la misteriosa figura della Chiesa celeste, in cui Dio sarà lodato, senza interruzione, nei secoli dei secoli. – « Di quest’inni eterni, di queste pure gioie che niuno potrà rapirci, non ne godiamo ancora. Nonostante ne abbiamo una caparra, allorché durante i cinquanta giorni che seguitano la risurrezione del Salvatore, ci asteniamo dal digiunare e facciamo risuonare il giocondo alleluia, » [Enarrat. in ps. 150, t. IV, p.II, p. 2411, 2412; Serm. 252, c. XI, I, p. I, p. 1521; Id., Serm. 210, c. VI, p. 1342]. -Tutta la Scrittura conferma nel modo il più splendido la spiegazione dell’illustre dottore. L’arca, soggiorno di tutto ciò che dee sfuggire alla morte, è cinquanta cubiti di larghezza; il tabernacolo, immagine della Chiesa per la quale saranno salvi tutti gli eletti, ha cinquanta anelli per formare le cortine di porpora che la circondano. – Al momento della loro partenza gli Ebrei schiavi in Egitto, sacrificano l’agnello pasquale. Camminano quaranta giorni nel deserto e dopo dieci giorni di fermata a’ piè del Sinai; per conseguenza cinquanta giorni dopo la loro liberazione, ricevono la legge di timore, scritta da Dio medesimo sopra tavole di pietra, e portate dal monte da Mosè. Avviene la nuova alleanza. Il Figliuolo di Dio, il vero agnello pasquale è immolato, e cinquanta giorni dopo, la legge di carità, è data al mondo dallo Spirito Santo medesimo che lo scrive nei cuori. – La Pentecoste, cioè dire la cinquantina giudaica, pegno di felicità per la sinagoga, la Pentecoste cristiana, pegno di felicità per la Chiesa, e l’una come l’altra figura è arca di felicità della Gerusalemme futura! Questa misteriosa concordanza dei numeri rapisce d’ammirazione il gran vescovo d’Ippona. « Chi non preferirebbe, esclama, la gioia che cagionano i misteri di questi numeri sacri, allorquando sfolgorano di splendore della sana dottrina a tutti gli imperi del mondo anche i più floridi? Non vi pare egli che i due Testamenti, come i due serafini del tabernacolo, cantino eternamente le lodi dell’Altissimo e si rispondano dicendo: Santo, santo, santo, è il Signore Dio degli eserciti? » [E p i s t class. II, c. XVI, t. II, p. I, p. 208]. – Il numero cinquanta, formato di dieci e quaranta, racchiude un altro mistero di una bellezza sorprendente: “magnae significationis”, come dice parimente sant’Agostino. Il Redentore del mondo ordina agli Apostoli di gettare la loro rete a destra della barca. Essi obbediscono e riconducono centocinquantatre grossi pesci. Di nuovo, perché questo numero e non un altro? Quale ne è il significato; poiché ve ne ha uno, atteso che è determinato dalla sapienza infinita? «Tutti gli uomini, continua sant’Agostino, sono chiamati dalla Trinità a fine di vivere santamente il tempo della vita, rappresentato dal numero quaranta, e di ricevere la ricompensa segnata dal numero dieci. Ora il numero cinquanta moltiplicato per tre forma centocinquanta. Aggiungete il divino moltiplicatore, la SS. Trinità, tamquam multiplicaverit cum Trinitas, e voi avete centocinquantatre che è il numero dei pesci trovati nella rete, numero perfetto che comprende la totalità dei santi. » [“Quia in nomine Trinitatis vocati sunt omnes, ut in quadragenario numero bene vivant et denarium accipiant, ipsum quinquagenarium ter multiplica, et fìunt centum quinquaginta. Adde ipsum mysterium Trinitatis, fìunt centum quinquaginta tres, qui piscium numerus in dexfcra inventus est: in quo tamen numero innumerabilia suntmillia sanctorum”. Serm.252, c. XI, ubi supra]. – Tali sono i numeri o le proporzioni geometriche, secondo le quali è stata fatta, e nelle quali é rinchiusa la maggior opera di Dio: la salute dell’uman genere. – Ma per quali mezzi gli uomini pervengono alla salute? e questi mezzi riposano su dei numeri? quali sono questi numeri? Tutto il mondo conosce la parola del Verbo redentore: Se voi volete entrare nella vita, osservate i comandamenti. Ora i comandamenti sono in numero di dieci. Per essere del numero degli eletti fa d’uopo dunque tenersi nel numero dieci, come in una fortezza, vale a dire che i dieci comandamenti debbono essere il limite dei nostri pensieri e delle nostre azioni. – Ma da sé stesso l’uomo non può adempire i dieci comandamenti, ha bisogno della grazia. Chi la dà? Lo Spirito dei sette doni. Cosi per fare un santo, ci vogliono due cose: i dieci comandamenti e i sette doni dello Spirito Santo. “La salute riposa dunque sul numero dieci e sul numero sette”. Fa egli meraviglia che il capo d’opera della sapienza infinita riposi sul numero, poiché le creature più umili, come il moscerino e il filo d’erba sono state fatte con numero, peso e misura? Abbiamo già veduto che il numero dieci e il numero sette, riuniti, formano e comprendono tutti gli eletti; vale a dire tutti coloro che adempiono la legge con l’aiuto dello Spirito Santo. Sant’Agostino lo mostra ancor più chiaramente. « Difatti, egli dice, se voi sommate dieci e sette, aggiungendo le une alle altre cifre che le compongono, voi arrivate a centocinquantatre, ed avete, come è stato spiegato più sopra, la moltitudine innumerevole dei santi, designati dai centocinquantatre pesci. » [“Lex habet decem praecepta: Spiritus aùtem gratiae, per quam solam lex impletur, septiformis legitur…. Decem ergo et septem tenent omnes pertinentes ad vitam a et emani, id est legem implentes per gratiam Spiritus…. Si computes ab uno ad decem et septem fìunt centum quinquaginta tres, et invenies numerum saerum fìdelium atque sanctorum in eoelestibus cum Domino futurorum”. S. Aug., Serm. 248, c. iIV, t. V, p. I, p. 1499]. Ecco l’operazione: 1+ 2 + 3 + 4 + …. etc. + 17 = 153. (153 è uno di quei numeri detti: “numeri triangolari”, cioè il numero che risulta dalla somma di tutti i precedenti lo stesso. Il numero triangolare si ottiene dalla formula: n. x (n.+1) : 2 [nel nostro caso: 17 x (17+1) : 2 = 17×18 = 306:2 = 153] – n.d.r. -). – Se l’ordine morale, la virtù, la santità riposano sul numero dieci, combinato col numero sette, ne risulta che il segno del disordine morale o del peccato è il numero undici, e la totalità del disordine morale o del peccato, lo stesso numero moltiplicato per sette. (Non per nulla il numero 11 è in numero simbolico più impiegato da tutte le obbedienze della massoneria, sinagoga di satana– n.d.r.). Spieghiamo questo nuovo teorema della geometria divina. Siccome il numero dieci segna la perfezione della virtù sulla terra, e della beatitudine nel cielo, cosi il numero undici dee necessariamente indicare il peccato. Che cosa è infatti il peccato? È una trasgressione della legge. – Come il suo nome lo dice, la trasgressione ha luogo allorquando si esce dal limite del dovere, segnato dal numero dieci. Ora uscendo da dieci, il primo numero che si riscontra naturalmente, è l’undici. 11 [“Lex enim per decem, peccatim per undecim. Quare peccatum per undecim? Quia transgressio denarii est ut eas ad undenarium. In lege autem modus fìxus est; trasgressio autem peccatum est. Jam ubi transgrederis denarium ad undenarium venis”. S. Aug. S erm . 83, c. VI, t. V, p. I, p. 645]. – Perciò nel Vangelo il numero undici non è mai moltiplicato per dieci ma per sette. Perché non é egli moltiplicato per dieci? Perché dieci è il segno della perfezione e che comprende la Trinità rappresentata da tre; e l’uomo rappresentato da sette, a cagione dell’anima con le sue tre facoltà, e del corpo con i suoi quattro elementi. Ora la trasgressione non può appartenere alla Trinità. Per moltiplicare undici, segno del peccato, resta dunque sette, a motivo dei peccati dell’anima e del corpo. I peccati dell’anima sono la profanazione delle sue tre facoltà, come i peccati del corpo sono la profanazione dei suoi quattro elementi. – Questa semplice parola della lingua dei numeri, invela luminosamente il significato generalmente incompreso, delle minacele tante volte ripetute in Amos. Parlando per bocca del profeta, Iddio dice: «Se Damasco commette tre e quattro delitti, io non gli perdonerò. Se Gaza commette tre e quattro delitti, non gli perdonerò. Se Tiro commette e tre e quattro delitti, non gli perdonerò. Se Edom commetterà tre e quattro delitti, non gli perdonerò. Se i figliuoli di Aminone commettono tre e quattro delitti, io non gli perdonerò. » [Amos, c. I, 8-18]. – Perché il Signore perdonerà uno e due e non perdonerà tre e quattro? Perché tre e quattro componendo il numero sette, segnano la trasgressione totale della legge e la ribellione completa dell’uomo composto di un’anima e di un corpo. Così undici, moltiplicato per sette, segna la totalità della trasgressione e l’ultimo limite del peccato. V’è egli bisogno di ripetere che questo misterioso calcolo non ha nulla d’arbitrario? È la Verità stessa che 1’adopra e che ci dà il significato. Pietro ha ricevuto il potere di legare e di sciogliere tutti i peccati. Egli domanda al divino Maestro quante volte gli dovrà perdonare. Senza attendere la risposta, si affretta ad aggiungere: fino a sette volte? Non solo sino a sette volte, ripigliò Nostro Signore, ma fino a settanta volte sette. [Matth., XVIII, 21, 22]. – A meno che non si accusi la eterna Sapienza d’aver parlato a caso, bisogna convenire che questo numero ha la sua ragione d’essere. Qual è questa ragione e perché questo numero e non un altro? Meno, sarebbe stato troppo poco, più sarebbe stato inutile. Meno, sarebbe stato troppo poco, perché tutti i peccati sono remissibili, e che se ne ottiene il perdono tutte le volte che si domanda con sincerità. Più, sarebbe stato inutile, poiché settanta volte sette, indica l’universalità dei peccati, come l’abbiamo visto, e la perpetuità della remissione, come noi vedremo. – Difatti, un nuovo sprazzo di luce ci rivela il significato del numero settantasette, facendo brillare in tutto il suo splendore l’adorabile sapienza che ha disposto tutto con numero. San Luca, descrivendo la genealogia del Redentore, conta in tutto settantasette generazioni. Cosi negli eterni consigli, la discesa del Piglio di Dio sulla terra ha avuto luogo nel momento preciso in cui settantasette generazioni di peccatori erano passate, a fine di mostrare con questo numero misterioso, ch’egli era venuto per cancellare l’universalità dei peccati commessi dal genero umano. [S. Aug. Serm . 83, c. IV, t. V, p. 1, p. 644]. – Abbiamo spiegato il numero sette combinato con i numeri dieci e undici; rimane a spiegarli presi isolatamente. Di tutti i numeri sacri, il sette è, secondo il giudizio dei Padri della Chiesa, interpreti incomparabili della Scrittura, uno di quei numeri che racchiudono i più numerosi e più profondi misteri: eccone alcuni. Composto di tre, segno della Trinità, e di quattro, segno del tempo, il numero sette rappresenta il Creatore e la creatura.2 2 [“Septenarius numerus indicat creaturam, quia sex diebus Deus operatus est et septimo ab operibus quievit”. S. Aug., Serm. 252, c. x, ubi supra.]. Esso gli rappresenta e nei loro caratteri generali e nella loro intima natura, vale a dire nella loro totalità. Totalità dell’uomo, composto di un’anima con tre facoltà: memoria, intelletto e volontà: e di un corpo con i quattro elementi e le quattro qualità della materia: lunghezza, larghezza, altezza e profondità. – Totalità di Dio, la sapienza settiforme che ha creato il mondo, che lo conserva e che lo santifica. [“Spiritus sanctus in Scripturis septenario praecipue numero commendatur”. S. Aug.t Enarrat, in ps. 50, t. IV, p. 2411, 2412]. Ora, il Creatore e la creatura comprendono tutto ciò che è. Il numero sette è dunque la formula completa degli esseri. Esso esprime non solamente il finito e l’infinito, ma altresì la differenza che gli distingue, e i rapporti che gli uniscono. Uno è immutabile indivisibile, l’altro mutabile e divisibile: uno è principio, l’altro effetto. [“Septenarius numerus quo universitatis signifìcatio saepe figurato, qui etiam Ecclesiae tribuitur propter instar universitatis”. S. Aug. epist, class. 2, t. II, p. I, p. 196]. – Nel suo significato naturale il numero sette è dunque una protesta permanente contro tutti i sistemi erronei del panteismo, o dell’eternità della materia, o del razionalismo, o della indipendenza dell’uomo. Con la universalità degli esseri, il numero sette segna ancora la totalità del tempo. Nulla di più chiaro, poiché sette giorni che vanno e vengono senza interruzione, compongono i mesi, gli anni ed i secoli.33 [“Et quare septies pro eo quod est semper ponatur, certissima ratio est : septem quippe diebus venientibus et redeuntibus, totum volvitur tempus”. Id., Serm. 114, t. V, p. 1, p. 822]. Dai significati fondamentali del numero sette, risultano le applicazioni così frequenti che lo Spirito Santo fa nella Scrittura. Queste applicazioni diventano altrettante rivelazioni, ricche d’insegnamenti e risplendenti di bellezze. Cosi a fine di ripopolare il mondo, Dio ordina a Noè di fare entrare nell’arca sette paia d’animali puri. Quando tutto è pronto per la vendetta, egli concede ancora sette giorni di ravvedimento ai colpevoli. Quando le acque del diluvio hanno diminuito, Noè aspetta sette giorni, prima di mandare una seconda volta la colomba, poi sette altri, innanzi di rimandarla una terza. Per giurare la sua solenne alleanza con Àbimelech, Abramo sacrifica sette agnelli: Giacobbe serve sette anni per ottenere Rachele; immagine del vero Giacobbe, che fatica durante le sette età del mondo, per conquistare la vera Rachele, cioè la Chiesa sua sposa. Le spighe piene e le vacche grasse, simbolo della piena abbondanza dell’Egitto, sono in numero di sette. I funerali di Giacobbe durano sette giorni: eloquente rappresentazione della vita dell’ uomo nella valle delle lacrime. Gli Ebrei mangiano il pane azzimo per sette giorni, durante i quali il pane lievito deve essere escluso dalle loro case sotto pena di morte: mortificazione completa del corpo e dell’ anima per entrare in comunicazione con Dio per la manducazione dell’agnello pasquale. – Il candelabro del tabernacolo ha sette bracci: calore e luce universale dello spirito dei sette doni: le mani dei sacerdoti debbono essere consacrate durante sette giorni. Innanzi di ricevere la vittima, l’altare deve essere purificato per sette giorni di seguito e asperso sette volte. La purificazione delle lordure dura sette giorni. – Alle tre feste solenni, il popolo ebreo, tipo di tutti gli altri, deve offrire sette agnelli. Sette settimane d’anni formano il Giubileo. Sette nazioni nemiche occupano la terra promessa: non è che dopo averle annientate che gli Ebrei saranno i pacifici possessori della terra di benedizione: bella figura dei sette peccati capitali, la cui distruzione può sola metterci in possesso della pace, della coscienza e della beatitudine eterna. Se, come non se ne potrebbe dubitare, il numero sette non è adoperato arbitrariamente nei misteri della vera religione, bisogna aspettarsi di vedere il demonio servirsene sovente nelle pratiche del suo culto.1 1 [I pitagorici chiamavano il numero sette il numero venerabile, venerabilis numerus. Apud serrarium Bibl, c. XII, p. 7. Varrone c’insegna che nessun altro era più sacro presso i pagani: M. Varrò in primo librorum qui inscribuntur Hebdomades, vel De imaginibus, septenarii numeri virtutes potestatesque multas variasque dicit : Aul. Gell., lib. III, c X]. – Ora questa grande scimmia di Dio, più istruito di noi dei profondi misteri del numero sette, vuole che i suoi sacerdoti non diventino tali che sacrificando sette montoni. Balaam a fine di riuscire nelle sue evocazioni, ordina a Balaac d’innalzare sette altari, e vuole per vittime sette vitelli e sette agnelli. Oggi ancora, sette abluzioni dell’idolo formano il rito sacro dell’adorazione solenne presso gli Indiani. – Costantemente i sette agnelli ritornano in tutti i sacrifici: doppia immagine e della totalità dei peccati e dell’efficacia onnipotente del sangue dell’Agnello “vero” per cancellarli. Cosi per pacificare il Signore terribilmente irritato, Ezechia fa immolare sette tori, sette castrati, sette capri e sette agnelli. Dopo il ritorno della schiavitù, per espiare tutti i peccati della nazione, si sacrificano settantasette agnelli. Purificato, Israele può marciare contro i suoi nemici che furono dinanzi a lui per sette vie: sconfitta completa. – Siccome lo Spirito Santo è l’anima del mondo, e che la sua settiforme influenza si fa sentire a qualunque creatura per illuminarla, purificarla, glorificarla, così il numero sette gli appartiene in un modo speciale. Egli forma, possiamo dirlo, la proporzione geometrica di tutte le sue operazioni. Da ciò l’uso cosi frequente che se ne fa nell’antico e nel Nuovo Testamento. – Sette sacerdoti con sette trombe fanno cadere le mura di Gerico: così i sette doni dello Spirito Santo rovesciano l’impero del demonio. Nelle sette trecce dei suoi capelli risiede la forza di Sansone: i sette doni dello Spirito Salito, forza del cristiano, martire della guerra o martire della pace. Sette cori di musica accompagnano l’arca dell’alleanza nel suo cammino trionfale, e David canta le lodi di Dio sette volte al giorno: inni eterni dei santi, riuniti intorno a Dio, e salvati dai sette doni dello Spirito Santo. – Sette anni sono impiegati nella costruzione del tempio; cosi la chiesa edificata dallo Spirito dei sette doni, lungo la durata del settenario, che appellasi il tempo. Sette consiglieri dirigono il re di Persia, che invia Esdra a ricostruire il tempio di Gerusalemme; parimente i sette doni dello Spirito Santo riposanti su Nostro Signore, mandato dal Padre suo per ricostruire il vero tempio della vera Gerusalemme. Sette Angeli stanno in piedi dinanzi al trono di Dio, e sette colonne sostengono il palazzo della Sapienza: due figure del pari trasparenti dei sette doni dello Spirito Santo, sostegni della Chiesa e principi delle eterne adorazioni. Sette occhi sono scolpiti sulla pietra angolare delle mura di Gerusalemme; così sette doni dello Spirito Santo su Nostro Signore, pietra angolare della Chiesa del tempo e della Chiesa dell’ eternità. Sette pastori condurranno il divino ovile », allorché il Redentore l’avrà formato; del pari sette doni dello Spirito Santo conduttori degli abitanti della Città del bene. – Sette anni di’follia e di dimora fra le bestie, sono inflitti a Nabuccodonosor punizione adeguata dei sette peccati capitali.- Sette leoni sono nella fossa, dove è gettato Daniele: sette peccati capitali intorno al cristiano nella valle delle lacrime. Il Vangelo nomina sette cattivi demoni: sette spiriti dei peccati capitali. Sette pani nutriscono quattro mila uomini nel deserto: i sette doni dello Spirito Santo, cibo spirituale del mondo intero. [“Septem panes signifìoant septiformem operationem Spiritus sancti; quatuor millia hominum, Ecclesiam sub quatuor evangeliis constitutam. Septem sportae fragmentorum perfectionem Ecclesiae, hoc enim numero saepissime perfectio commendatur”. S. Aug., Serm. 95, n. 2, p. 728]. – Gli Apostoli diretti dallo Spirito Santo stabiliscono sette diaconi: universalità delle opere di carità spirituale e corporale. San Giovanni indirizza l’Apocalisse a sette chiese: numero della totalità. Il figlio di Dio gli appare nel cielo circondato da sette candelabri d’oro: i sette doni dello Spirito Santo, raggiante dal Verbo incarnato. La grande bestia ha sette teste con sette occhi: sette peccati capitali con la loro terribile potenza sul mondo fisico e sul mondo morale. Sette Angeli suonano di continuo la tromba; sette fortissime voci si fanno udire, e prima di spirare, il mondo colpevole è colpito da sette piaghe: tenibili profezie dell’universalità dei segni di morte, e dei flagelli riserbati agli ultimi giorni. – E tempo di terminare questo schizzo della scienza dei numeri, e di farne l’applicazione diretta al cristiano. Esso è la costruzione dello Spirito Santo, e noi conosciamo i ricchi materiali di cui si compone. Dipendendo da un architetto infinitamente abile, questi materiali, nessuno ne può dubitare, sono stati messi in opera, dietro un piano prestabilito. Ogni piano riposa su calcoli, e su proporzioni; per conseguenza su tanti numeri. Una simile verità è certissima. Da un lato l’universo intero depone, che è stato fatto con numero peso e misura, cioè dire in proporzioni geometriche di una precisione e di una armonia perfetta. Dall’ altro lato, il cristiano è il capo d’opera dello Spirito Santo ; fa d’uopo eludere a fortiori, che calcoli ammirabili di giustezza hanno presieduto alla sua costruzione. – Quali sono i calcoli, o meglio, i numeri speciali secondo i quali è stato costruito il cristiano, su’ quali riposa, essendo come l’armatura dell’edificio e la misura delle sue proporzioni? Il cristiano è stato fatto con i due numeri più sacri, cioè il sette e il dieci. Egli sussiste per via di essi: il mondo finirà, allorché la somma di questi due numeri misteriosi, combinati insieme e moltiplicati per mezzo della Trinità, sarà completa. In prova di ciò ricordiamo il bel passo di sant’Agostino: « Lo Spirito, autore dei doni santificatoli, è designato dal numero sette, e Dio autore del decalogo, mediante il numero dieci. Per fare un cristiano, bisogna riunire queste due cose. Se voi avete la legge, senza lo Spirito Santo, voi non adempirete ciò che è stato comandato. – Ma quando, aiutato dallo Spirito Santo dei sette doni, voi avrete conformato la vostra vita al decalogo, sarete costruito e apparterrete al numero diciassette. Appartenendo a questo numero, voi vi innalzate sommando al numero 153. Quando giungerà il giudizio, sarete alla destra per essere coronato, non alla sinistra per essere condannato. [Serm. 250, c. VII et VIII, t. V, p. I, p. 1502, 1503].