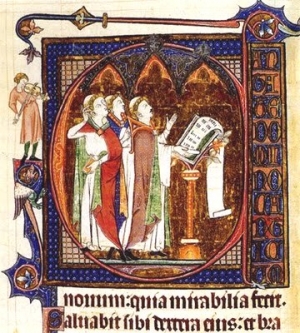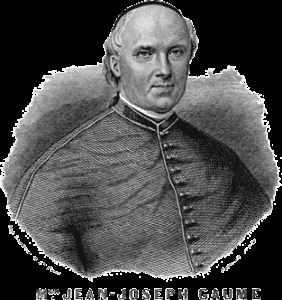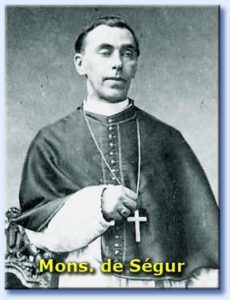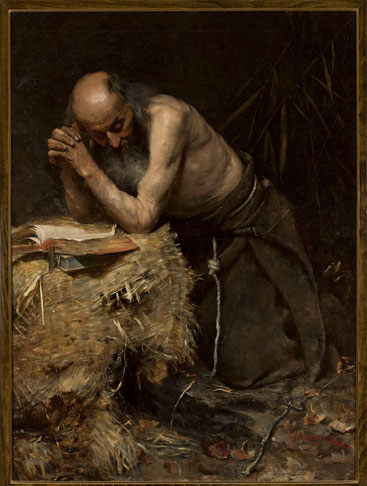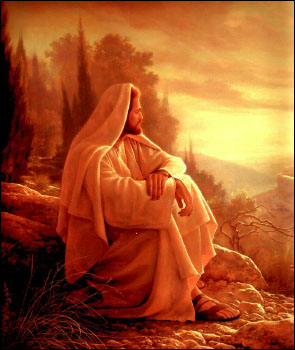In questi venerdì di quaresima, si ricordano gli strumenti della Passione di Cristo e le sue ferite: 1° venerdì: La corona; 2° venerdì: i chiodi e la lancia; 3° venerdì: il sacro lenzuolo, 4° venerdì: le piaghe di Gesù-Cristo; 5° venerdì: il suo Preziosissimo sangue. Oggi ci occuperemo della Santa Croce e degli Strumenti della Passione.
DEVOZIONE ALLA SANTA CROCE
ISTRUZIONE.
La storia dell’Invenzione e dell’Esaltazione della S. Croce su cui, per opera di Gesù Cristo, fu compita la redenzione di tutto il genere umano, è troppo interessante per essere passata sotto silenzio. Facciamone dunque qualche cenno.
Invenzione della Santa Croce.
Costantino, detto il grande, figlio di Costanzo Cloro e di S. Elena, dopo essere stato presente alla morte del proprio padre nella Gran Bretagna, fu dichiarato imperatore in suo luogo, il giorno 25 luglio 306. Investito della suprema autorità, cominció a regnare nell’Inghilterra, nelle Gallie e nella Spagna, ch’erano ì paesi dominati da Costanzo, quando da Diocleziano fu associato all’Impero. Ma dopo qualche anno, sentendo che Massenzio in Roma cercava di usurpargli il trono, mosse dal Reno contro di lui, e sapendo che il suo nemico era assai maggiore di forza, dacché non aveva meno di duecentomila uomini, chiama in soccorso il Dio dei Cristiani, pei quali aveva gran propensione. La sua speranza non lo tradì, che anzi, il giorno innanzi alla battaglia, trovandosi alle porte di Roma qualche ora dopo il mezzogiorno, a vista di tutto il suo esercito, non che di lui che ne era a capo, apparve nel cielo una Croce, più luminosa del sole, e intorno alla quale si leggevano queste parole — Con questa bandiera tu vincerai. — “In hoc Signo vinces”. La notte seguente Gesù Cristo gli apparve in sogno, e mostrandogli di nuovo la Croce apparsa nel cielo il giorno avanti, gli comandò di farne subito costruire una in tutto simile a quella che gli era mostrata, e di usarla come stendardo di guerra, che avrebbe certissima la vittoria. Appena svegliato l’imperatore, diede gli ordini opportuni per fare questa nuova bandiera tanto famosa sotto il nome di Labaro, la quale consisteva in una lunga picca tutta coperta di oro traversata in alto da un altro legno che formava una Croce dalle cui braccia pendeva un velo tessuto d’oro, e di pietre preziose. Al sommo della Croce brillava una ricca corona d’oro, nel cui mezzo stavano le lettere greche indicanti il nome di Cristo. Con questa nuova bandiera che veniva portata dai veterani più distinti per valore e per pietà, si avanzò Costantino verso Massenzio, e al Ponte Mìlvio, detto ora il Ponte Molle, lo sconfisse per modo che il tiranno preso la fuga e si annegò nel Tevere il 28 Ottobre del 312. Questa è quella grande vittoria che determinò Costantino a dichiarare la Religione Cristiana libera in tutto l’impero; il che fece con formale decreto sottoscritto in Milano nell’anno 313; tanto più che, vinto Massenzio, trionfò anche di Licinio Imperator d’Oriente persecutore fierissimo del Cristianesimo, e cosi divenne egli solo padrone del mondo conosciuto a quei tempi. Pochi sono i fatti che abbiano tante prove quante ne vanta l’apparizione della Croce a Costantino. – Eusebio ci assicura d’averlo sentito dalla bocca stessa dell’Imperatore. Lattanzio che scrisse prima di Eusebio ne parla come di fatto innegabile: cosi fan pure Filistorgio nei suoi frammenti, Socrate e Sozomeno nelle loro storie, nonché Gelasio di Cizico negli Atti di s. Artemio martirizzato sotto Giuliano, oltre l’essere attestato da infinite iscrizioni e medaglie che si riferiscono a quell’ epoca, non che dalla statua che il Senato fece erigere a Costantino, nelle cui mani fu posta come strumento di sua vittoria, la Croce. – Risoluto Costantino di far trionfare la Croce in tutte le parti del suo impero, comandò prima di tutto di abbattere quei tempii profani che l’imperatore Adriano aveva fatto innalzare sopra del Santo Sepolcro, dopo di averlo riempito di terra e nascosto alla vista comune con un pavimento di pietra. Datone l’ordine a Draciliano governatore di Palestina e partecipatene la notizia a s. Macario vesc. di Gerusalemme, Elena, madre dell’Imperatore, quantunque fosse già sugli 80 anni, volle prendere personalmente la direzione, e pose ogni suo studio nel ricercare la santa Croce. Dopo un lungo scavare, si giunse a scoprire il Sepolcro, e in sua vicinanza tre croci della stessa grandezza e della stessa forma, per cui non si poteva distinguere quale fosse quella del Salvatore, tanto più che il titolo ordinato da Pilato, e portante le parole “Gesù Nazareno Re de’ Giudei”, era confuso tra ì vari legni. – Nell’impossibilità di ben conoscere quale delle tre croci fosse quella che si cercava, s. Macario suggerì all’imperatrice portarle tutte e tre alla casa di una gentildonna che era moribonda. Fatta una fervida preghiera, e portate le croci alla casa della ammalata, si provò a toccarla con esse; ma mentre nessun effetto si ebbe dalle due prime, al tocco della terza l’ammalata si vide perfettamente guarita. Alcuni altri riferiscono che la Santa Croce sia stata riconosciuta per la istantanea risurrezione di un morto che sopra di essa fu steso, mentre niente era avvenuto applicandolo alle altre due croci! – Riconosciuta la vera Croce, si fondò una Chiesa nel luogo in cui fu trovata, ed ivi la si depose in una grande custodia di sommo valore. Una porzione però fu da s. Elena mandata al suo figlio in Costantinopoli, ed un’altra fu spedita alla Chiesa da lei fondata in Roma e che ora si conosce sotto il nome di Santa Croce di Gerusalemme, alla quale regalò anche il titolo della croce, che venne posto al sommo di un’arcata ove fu trovato nel 1492 chiuso in una cassetta di piombo. – Costantino per ispirare a tutto il mondo gran rispetto alla Croce, comandò che in tutta l’estensione dei suoi domini non si adoperasse mai più la croce per supplizio dei malfattori, il che fu praticato in progresso da tutti ì suoi antecessori. – La parte più considerabile della Croce fu fatta chiudere da s. Elena m un astuccio d’argento, e lasciata a Gerusalemme sotto la custodia del vescovo S. Macario [di cui oggi 10 marzo festeggiamo la memoria –ndr.-] che la depose nella magnifica chiesa costrutta sul santo Sepolcro. – Da tutte le parti concorsero sempre i fedeli a venerare sì gran Reliquia, ed è pur rimarcabile il fatto che da s. Paolino è riferito nella sua lettera a Severo, cioè che per quanti pezzetti ne fossero staccati, dessa non veniva mai a scemarsi, producendosi a misura che veniva tagliata come fosse 1egno ancor vivo. S, Cirillo di Gerusalemme, che viveva 25 anni dopo la Invenzione della santa Croce, protesta che dopo essersene distribuiti tanti pezzetti da trovarsene in ogni parte del mondo, la Croce era ancora della stessa grandezza, e grossezza, come non fosse mai stata toccata da alcuno, e paragonava questo fatto ai pani moltiplicati nel deserto per satollare 5 mila persone.
ESALTAZIÓNE DELLA SANTA CUOCE.
Come l’apparizione della Croce a Costantino, e la scoperta del sacro legno fatta da s. Elena diede occasione alla festa dell’invenzione della S, Croce, che però, al dir del Baronio, non si rese universale che nel 720, così il riacquisto di sì santo strumento, fatto da Eraclio, diede nuovo lustro alla festa della Esaltazione, che già si celebrava dai Greci e dai latini nel sesto secolo, e anche nel quinto. Cosroe II, re di Persia, sotto pretesto di vendicare l’imperatore Maurizio trucidato da Foca, si mosse con grande esercito contro quest’ultimo, e in poco tempo si impadronì della Siria e della Palestina, mettendo a fuoco ed a sangue tutto l’Oriente. – Eraclio figliuolo del governatore dell’Africa, animato dai voti del popolo che stanco della tirannide di Foca, lo proclamava imperatore, approda con un’armata navale a Costantinopoli, ove sconfisse le truppe nemiche, e, impadronitosi del tiranno, gli fece troncare la testa. Non ottenne appena questa vittoria, che cercò di fare la pace con Cosroe, affinché, senza spargere altro sangue, si ritirasse nei proprii stati, cioè nel regno di Persia. Cosroe, superbo delle prime conquiste, rifiutò ogni condizione, fece nuove scorrerie, strinse d’ asilo Gerusalemme, e presala nell’anno 625, portò seco nella Persia, coi principali della città e il vescovo Zaccaria, i più preziosi tesori che vi poté trovare, e fra questi la vera Croce su cui era morto il Salvatore. Allora Eraclio risolvette di farla finita; e, confidando nella protezione del cielo, parti colle sue truppe per la Persia. La sua marcia fu un continuo trionfo, e sconfitti tutti i Persiani che d’allora in poi non riacquistarono mai più il loro primitivo splendore, costrinse alla fuga il loro Re, che fu poi fatto morire dal proprio figlio Siroe, com’egli a colpi di bastone aveva fatto morire il proprio padre Ormisda. – Debellati così tutti i nemici, Eraclio cedette alle istanze di Siroe che domandava la pace; e la prima condizione che gli impose fu quella di restituire tutto quello che Cosroe avea rubato in Palestina, e specialmente la Santa Croce. Fu allora che questa nel 628, fu portata trionfalmente, fra le acclamazioni e gli ossequi di tutto il popolo a Costantinopoli. L’anno seguente l’imperatore si imbarcò per portarla in Gerusalemme. E giuntovi felicemente, la volle portare egli stesso nei tempio fabbricato da Costantino sopra’il Calvario. Ma arrivato alla porta che serve di introduzione al sacro monte, si sentì impediti i suoi passi da una forza invisibile e irresistibile. Allora il patriarca Zaccaria, che lo accompagnava, lo avvisò che ciò proveniva dall’essere egli vestito pomposamente, e quindi in modo non proprio per imitar Gesù Cristo nel portare la croce. – Depose subito l’imperatore le regie insegne; si vestì di abito penitenziale, e trovò di poter procedere liberamente, come procedette difatti al compimento dei propri voti. E cosi la santa Croce fu nel 629 riposta per mano di Eraclio in quel luogo medesimo da cui 14 anni prima era stata rubata da Cosroe. Siccome ciò avvenne nel 14 Settembre, in cui molti eran già soliti festeggiare la Santa Croce, cosi fu universalmente stabilita in tal giorno la solennità della sua Esaltazione.
DEGLI ALTRI STRUMENTI DELLA PASSIONE.
Veduto quello che diede origine alle due feste della Santa Croce, tornerà molto caro il conoscere che cosa avvenne degli altri strumenti della Passione, che furono da s. Elèna trovati nel luogo medesimo della Croce, essendo antico costume di seppellire presso il tumulo dei giustiziati tutti gli strumenti che avean servito al loro supplizio.
I SANTI CHIODI.
Presso la Croce del Redentore s. Elena trovò ì Chiodi che avevan servito alla sua crocifissione. Né durò fatica a riconoscerli, perché, a differenza degli altri, che erano tutti coperti di ruggine, questi conservavano ancora la primitiva lucidezza. In quanto al numero, è insegnamento di s. Gregorio di Tours, seguito dal papa Innocenzo III che fossero quattro i Chiodi che erano stati a contatto colle mani e coi piedi del Redentore, senza parlare di quello che aveva servito pel titolo o cartello, che stava al sommo della croce, e di altri che si rendevano indispensabili per connettere al legno diritto il legno trasversale. Dei quattro Chiodi che penetrarono nelle carni divine del Redentore, uno fu da s. Elena calato riverentemente nel mare Adriatico per calmare una tempesta violentissima che minacciava la di lei vita, per render più sicuro quel golfo che per la sua voracità si chiamava la voragine dei naviganti. Acquietatosi il mare a quel contatto s. Elena regalò quel chiodo alla chiesa di Treveri, di cui era allora arcivescovo s. Agrizio. Gli altri tre furono mandati a Costantino, il quale se ne servì per garantire da ogni sinistro la propria persona, mettendone uno nel suo diadema più ricco, ossia l’elmo di parata, e collocando gli altri due nella briglia e nel morso del suo cavallo, onde gli servissero di scudo impenetrabile fra ì tanti pericoli delle battaglie. Questi chiodi si conservarono in Costantinopoli fino all’epoca dell’imperatore Giustiniano, imperocché si sa che il pontefice s. Vigilio, che si trovava in quella città per la famosa condanna dei tre Capitoli nel 555 giurò per la virtù dei santi Chiodi e del santo freno che ivi si conservava. Nell’anno poi 586, dall’imperatore Costantino Tiberio, furono regalati a s. Gregorio Magno, nell’occasione che ritornava a Roma, dopo aver sostenuto presso la corte di Costantinopoli l’impegno di Apocrisario, ossia legato del Papa, che era s. Agapito. Fu allora che il Santo Chiodo, già allogato nel diadema di Costantino, fu dato in dono alla basilica della Santa Croce m Roma, un altro venne donato alla chiesa di s. Giovanni in Monza, ove fu poscia incastrato nella parte interiore della celebre Corona Ferrea, che serve anche attualmente per l’incoronazione dei Re. Quello inserito da Costantino nel freno de! suo cavallo fu regalato alla Metropolitana di Milano, ove si conserva tuttora in una specie di magnifica cappella costruita nella parte superiore della volta del coro. – Non deve poi far meraviglia che molte altre chiese si vantino di possedere sì preziosa reliquia, dacché per soddisfare alla pietà dei fedeli desiderosi di tanto tesoro, si sa che fu limato uno dei veri chiodi, specialmente quello che era a Roma, e che appunto per questo ora non ha più punta. E questa limatura si è rinchiusa in altri Chiodi fatti alla foggia dei veri, e così si sono in certa guisa moltiplicati. Si e pur trovato altro modo di farne molti, col mettere a contatto del chiodo vero, degli altri appositamente preparati a sua somiglianza. S. Carlo Borromeo, cosi scrupoloso in fatto di Reliquie aveva molti Chiodi fatti a somiglianza di quello che si venera in Milano, e, dopo averli ad esso accostati li distribuiva ai distinti personaggi che voleva regalare; ed uno di questi fu da lui donato qual reliquia preziosa a Filippo II Re delle Spagne. Di una somigliante devozione si trovano le tracce nei secoli i più remoti. S. Gregorio Magno, ed altri papi, diedero, come grande reliquia, un po’ di limatura delle catene di s. Pietro, che poi mettevasi in altre catene fatte a somiglianza di quelle. Nelle opere del P. Onorato di s. Maria, che è uno dei critici più giudiziosi, si legge un fatto che conferma quanto si è detto, ed è un miracolo autentico operatosi per mezzo di un taffetà fatto a somiglianza del cuore della gran vergine santa Teresa.
LA SANTA LANCIA.
Trovata da s. Elena, cogli altri strumenti della Passione di Cristo, la lancia che gli aperse il costato, fu posta nella debita venerazione. Ma in progresso di tempo, temendosi l’invasione dei Saraceni, fu segretamente sotterrata in Antiochia, ove fu trovata nel 1098, nella cui occasione accaddero molti miracoli. Allora da Antiochia fu trasportata a Gerusalemme, e di lì a poco a Costantinopoli. L’imperatore Balduino II ne mandò la punta alla Repubblica di Venezia in pegno d’una somma di danaro che dessa gli aveva prestato. S. Luigi Re di Francia pagò ai Veneti la somma per cui era impegnata quella reliquia, e la fece trasportare a Parigi, ov’è custodita nella Santa Cappella. Il rimanente della Lancia rimase a Costantinopoli anche dopo che i Turchi se ne furono impadroniti. – Nel 1492, il Sultano Bajazette, per mezzo di un suo ambasciatore, la mandò in regalo al Papa Innocenzo XII, rinchiusa in una ricchissima custodia, facendogli dire nel tempo stesso che la punta della sacra Lancia era in mano del Re di Francia.
LA SANTA SPUGNA.
Quando Cosroe spogliò delle cose le più preziose la chiesa del santo Sepolcro in Gerusalemme, il patrizio Niceta, per mezzo di un amico di Sarbazara, Generale dei Persiani, giunse a sottrarre alla nemica invasione la santa Spugna cui fu presentato l’aceto al Salvator Crocifisso, non che la Lancia che gli aveva ferito il Costato. – Queste due reliquie furono mandate a Costantinopoli, e depositate nella cattedrale, la santa Spugna al 14 Settembre dello stesso anno 628 , e la santa Lancia al 20 ottobre: e ciascuna esposta per due giorni alla venerazione dei Fedeli. La santa Spugna che da Balduino II fu consegnata colla punta della Lancia ai Veneziani, per pegno del prestito che gli aveva fatto, fu di là trasportata da s. Luigi nella santa Cappella in Parigi, onde poi fu mandata a Roma, ove si conserva ancora nella chiesa di san Giovanni Laterano, e si vede ancora tinta di rosso sanguigno.
LA SANTA CORONA.
L’imperatore Balduino II vedendo che la città di Costantinopoli stava per cader nelle mani dei Saraceni e dei Greci, donò la corona di spine a s. Luigi suo parente, per ricompensarlo di tanti sacrifici che aveva fatti per la difesa dell’impero d’Oriente e della Palestina. S. Luigi fu gratissimo a quesdono che gli venne per la via di Venezia; i n segno di rinoscenza, pagò spontaneamente un grosso prestito che l’impero aveva contratto colla Repubblica. Questo prezioso tesoro, rinchiuso in una cassetta suggellata, fu da Venezia portato in Francia da Religiosi specchiatissimi per santità. S. Luigi gli andò incontro 14 miglia di là di Sens, col corteggio della madre, dei fratelli, dei primi principi, e dei primi Prelati: ed egli stesso con Roberto d’Artois, suo secondo fratello, camminando a piedi nudi, volle portare la santa Corona nella cattedrale di Sens, donde poi con gran solennità, fu trasportata a Parigi, e deposta in una cappella magnifica espressamente per lei fabbricata, ed officiata da un apposito Capitolo, e questa è quella che si chiama la Santa Cappella. – Dalla santa Corona si sono staccate alcune spine per farne dono ad altre chiese: ma se ne sono anche fatte molte ad imitazione delle vere, e, come si è detto dei Chiodi, col contatto delle vere Spine che sono quasi tutte lunghissime, si resero venerabili tutte le altre che furono fatte in progresso a loro somiglianza.
LA SANTA COLONNA.
La colonna a cui fu legato Gesù Cristo quando fu sottoposto alla flagellazione, per testimonianza dei due SS. Gregorio, il Nazianzeno ed il Turonese, non che di s. Prudenzio e s. Girolamo, fu religiosamente custodita in Gerusalemme insieme alle altre reliquie della Passione. Ma, per opera del cardinale Giovanni Colonna, legato del papa Onorio II, in oriente, fu trasportata a Roma nell’anno 1221, e collocata in una piccola Cappella della chiesa di santa Prassede, ove si vede tuttora a traverso di una grata di ferro. Essa è di marmo grigio, lunga un piede e mezzo; nella base ha un piede di diametro, ma nella parte superiore non ha che otto pollici. Vi si vede ancora un anello di ferro, che è quello a cui s’attaccavano i colpevoli. Alcuni credono che questa non sia che una parte della Colonna che servì alla Passione di Cristo, ma siccome non si vede alcuna frattura, cosi si ritiene che sia intera.
IL SANTO SEPOLCRO
Era costume fra gli Ebrei di seppellire i loro morti non in una fossa di terra, ma bensì i n un sasso scavato a modo di piccola stanza che veniva nell’estrema sua parte coperta con una grossa Lastra di pietra. Di tal natura fu pure il sepolcro già preparato sul monte Calvario per un grande della Giudea, qual era Giuseppe d’Arimatea, e che da lui fu ceduto al Nazareno fatto cadavere perché avesse una sepoltura possibilmente conveniente alla sua dignità. Questo luogo santificato dalla dimora che vi fece per circa tre giorni Gesù Cristo defunto, e reso gloriosissimo per i miracoli che accompagnarono la sua Risurrezione, non poteva non divenire un oggetto di somma venerazione per i Cristiani. Presa però dall’Imperatore Tito nell’anno 70, cioè 37 anni dopo la morte di Cristo, la città di Gerusalemme, fu ridotta, secondo la profezia evangelica, a un mucchio di rovine. Più tardi, cioè nel 134 sotto l’imperatore Adriano ne furono cacciati tutti i giudei che l’avevan in gran parte rifabbricata, e la città fu rovinata in modo da divenire inabitabile. Tre anni dopo, lo stesso Principe la fece ricostruire sotto il nome di Elia Capitolina, e, per cancellarvi ogni traccia di Cristianesimo, fece collocare la statua di Venere sul Calvario nel luogo preciso della Crocifissione del Nazareno, e la statua di Giove sul suo sepolcro. Finalmente nell’anno 327, dopo che Costantino ebbe abbracciato il Cristianesimo, l’imperatrice Elena sua madre vi fece abbattere ogni avanzo di idolatria, vi cercò e vi trovò la vera croce ove erasi consumato il sacrificio della nostra salute, poi fece innalzare una bellissima chiesa sul Sepolcro ov’era stato deposto il divin Redentore. Questa chiesa, che è coperta da una gran cupola, e unita ad altre due chiese anch’esse coperte di cupole di minor mole, forma con esse un solo tempio, la cui gran nave è illuminata dalla maggior cupola che si innalza sopra del santo Sepolcro. – Ben tosto quel luogo fu frequentato dai Cristiani che vi andavano in pellegrinaggio da tutte le parti del mondo. S. Geronimo nella lettera a s. Paola dice che questa santa vedova era entrata nel s. Sepolcro, baciandone per rispetto la terra. E S. Agostino (De Civit. Dei, c, 22, c, 8) racconta che fedeli ne raccoglievano la polvere, e la conservavano come preziosissima, operandosi con essa molti miracoli. La vista del santo Sepolcro venne in seguito disturbata dai Saraceni che, impadronitisi della Palestina nell’anno 639, vessavano orribilmente i Cristiani che vi si portavano in pellegrinaggio. Queste vessazioni sdegnarono per modo le nazioni cristiane, che si risolvette di farla finita con quei barbari persecutori degli Innocenti. Quindi i Principi d’Europa, capitanati dal francese Goffredo di Buglione, incominciarono quelle famose spedizioni di truppe Cristiane in Asia che si celebrarono sotto il nome di Crociate, perché in tal circostanza tutti i soldati portavano per distintivo una croce rossa sul petto. Per l’opera di questi valorosi, Gerusalemme fu riconquistata dai Cristiani l’anno 1099, ma sgraziatamente questo dominio non durò che 88 anni, in capo ai quali, cioè nel 1187, Gerusalemme con tutta la Terra Santa, cadde in potere di Saladino sultano di Egitto e di Siria, i cui successori la tennero sino al 1517 in cui furono soggiogati dai Turchi, che sono anche attualmente i padroni di tutta la Palestina. – Malgrado però queste vicende, il Santo Sepolcro colla relativa chiesa fu sempre rispettato; e mediante il pagamento di un certo tributo, fu concesso ai Religiosi Francescani di stabilirsi la propria dimora in un vicino convento da loro fabbricato anche allo scopo di alloggiarvi i Pellegrini che recansi alla visita dei Luoghi Santi, Non è pero a tacersi che la devozione dei Cristiani visitanti il santo Sepolcro deve essere pagata a caro prezzo, perché i Turchi che ne sono i padroni, esigono un fisso tributo per ogni volta che si entra nella chiesa del santo Sepolcro. Onde è che si trovano dei pellegrini che per non pagare un nuovo tributo sortendo dopo la prima visita, stettero in essa dei mesi interi, senza mai sortire, ricevettero il vitto quotidiano da una piccola finestra destinata a questo scopo, sebbene traversata da una sbarra di ferro. Non saranno dunque mai abbastanza lodati quei santi Francescani Religiosi che ne tengono la custodia, e che malgrado le più grandi persecuzioni non abbandonarono mai quella santissima impresa. Come non sarà mai abbastanza raccomandato ai fedeli di largheggiare nella elemosina che, specialmente in Quaresima si raccoglie pei Luoghi Santi, dacché dessa serve non solamente a mantenere quei religiosi che ne sono i custodi, a pagare gli annui tributi che loro sono imposti dai Turchi, ma ancora a supplire alle spese occorrenti per la custodia di tutti gli altri santi Luoghi di Palestina, non che pel mantenimento dei pellegrini che vi sono alloggiati, e dei ragazzi d’ambo sessi, che, raccolti in apposite case, vi sono santamente allevati, onde servano un qualche giorno di apostoli nelle loro famiglie, e cosi santifichino gli altri nell’atto stesso che sempre più vanno santificando sé stessi. – Nel 1811 un incendio rovinò il magnifico tempio di s. Sepolcro. Però le fiamme risparmiarono il sepolcro di Gesù-Cristo, il vicino convento cattolico, e le cappelle delle otto nazioni del cristianesimo. Quel tempio fu nel 1812 riedificato a spese dei monaci Greci, creduti gli autori di quel disastro. – Nel 1834 nuove sciagure immersero nella più desolante costernazione la citta santa, poiché oltre la sventura della presenza degli Arabi che cola portavano i l sacco e la fame, uno spaventevole terremoto, che durò per ben tre minuti, scoppiò nel giorno 23 Maggio di detto anno, in conseguenza del quale il tempio marmoreo del s. Sepolcro fu scosso a segno che minacciava l’estrema rovina. Fortunatamente però desso stette ancor saldo, e se nel 1865 la gran cupola di detto tempio minacciava di andare in isfascio, diverse potenze, cioè la Porta, la Russia, e specialmente la Francia, gareggiarono nell’impegno di ripararne subito tutti ì danni. – A proposito del s. Sepolcro è molto edificante ciò che scrive ve di sè stesso nel suo Itinerario di Palestina, il grande autore del Genio del Cristianesimo Chateaubriand: « Forse i lettori mi domanderanno quali sentimenti io abbia provato entrando in luogo così santamente formidabile. A tal domanda io non saprei cosa rispondere, tanti furono i sentimenti che si impossessarono del mio animo in un sol colpo. Dirò solo che entrato nella piccola camera del s. Sepolcro, vi restai per circa mezz’ora in ginocchio come assorto, senza poter levar ì miei occhi dalla pietra su cui fu depositato Gesù Cristo defunto. Un dei due religiosi che mi servivano di guida stava presso di me colla fronte prostrata al marmo, l’altro tenendo in mano l’Evangelio leggeva al fiocco lume della lampada, i passi relativi al santo Sepolcro. Tutto ciò che io posso assicurare si è che alla vista di quel sepolcro trionfale io non sentiva che la mia debolezza: e quando la mia guida gridó con s Paolo, dov’è o Morte, la tua vittoria? ov’è il tuo pungolo? mi pareva di sentire all’orecchio la voce della morte rispondere “Io sono stata vinta ed incatenata in questo monumento dal glorioso Autor della vita! » – Ecco i sentimenti che deve in noi risvegliare la memoria del santo Sepolcro.
ORAZIONE ALLA SANTA CROCE.
Con tutto le forze del mio cuore, vi amo, vi lodo, vi benedico, vi adoro, o vera Cattedra di sapienza, per tutti i popoli della terra, o Arma debellatrice di tutte le infernali potenze, o strumento inestimabile della comune redenzione, santissima Croce di Gesù Cristo. Voi, nobilitata dal sangue dell’Agnello divino, siete divenuta tutt’assieme la speranza dei peccatori, il conforto de’ penitenti, la consolazione dei giusti, e il carattere distintivo di tutti i discepoli del vero Dio. I più potenti Re della terra si recano sempre ad onore il farvi ossequio, e, piantandovi in mezzo alle lor corone, vi dichiarano pubblicamente per la loro difesa, per la lor gloria. Deh, apprenda io una volta quelle divine lezioni di umiltà, di pazienza, di mansuetudine, di carità, di costanza che ci diede morendo sopra di voi l’Autore di nostra fede, il Consumatore della nostra salvezza! Colla contrizione la più sincera io detesto tutto quel tempo in cui ho ricusato di conformare ai vostri insegnamenti la mia condotta: e colla risoluzione la più ferma, protesto di volere per l’avvenire portarvi con santo coraggio e con edificante allegrezza, mortificando in ogni maniera gli affetti sregolati del mio cuore, i sensi sempre ribelli del mio corpo, e sopportando con pazienza e con gioja, tutte quelle traversie con che l’amoroso mio Salvatore si compiacerà di provarmi, onde, dopo essere stato con Lui compagno degli obbrobri e delle pene che soffrì disteso sulle vostre braccia, possa partecipare con Lui alla beatitudine di quel regno di cui voi siete la chiave. 3 Pater all’agonia di Gesù.
[da: Manuale di Filotea, del sac. G. Musso, XXX ed. Milano 1888]