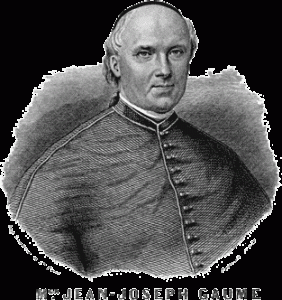LE BEATITUDINI
[da J.-J. Gaume: “Trattato dello Spirito Santo”: Capp. XXXIV, XXXV, XXXVI]
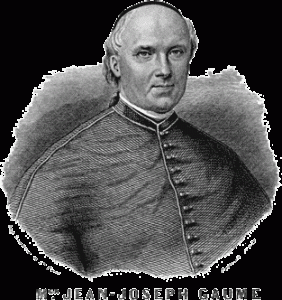
Il nostro studio dei doni dello Spirito Santo può riassumersi nelle seguenti verità; i doni dello Spirito Santo sono i principi deificatori dell’uomo e della società; il mondo deve loro tutto ciò che vi è di veramente bello e di veramente buono. Al dono di timor di Dio, deve i suoi veri grandi uomini; al dono di pietà, i suoi innumerevoli asili per tutte le miserie; al dono di scienza, le sue affermazioni certe e i suoi più celebri dotti; al dono di consiglio, quelle turbe di vergini e tutti gli innumerevoli servizi gratuiti di carità; al dono d’intelligenza, la sua superiorità intellettuale sulle nazioni che non sono cristiane o che cessano d’esserlo; al dono di sapienza, quei pazzi sublimi che si chiamano i santi: lume, gloria e salute dell’umanità. [“Nos stulti propter Christum”. I Cor., IV, 10. — “Placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes”. Id., I, 28]. – Ai doni dello Spirito Santo sono opposti i sette peccati capitali, principi corruttori dell’uomo e del mondo, questi doni satanici producono degli effetti in relazione con la loro natura; ad essi devono attribuirsi tutte le vergogne e tutti i delitti dell’umanità. Dovendo l’uomo e il mondo vivere sotto l’influenza dello Spirito del bene o dello Spirito del male, risulta che dopo la sua caduta l’umano genere obbedisce a un impulso settiforme. Quest’impulso è settiforme e deve esserlo. Da un lato, lo Spirito Santo è inseparabile dai suoi doni, come satana è inseparabile dai suoi. Dall’altro, quest’impulso deve raggiungere tutte le facoltà dell’uomo e determinare, come di fatto esso determina, tutte le loro operazioni buone o malvagie. Tal’è il doppio principio movente dell’umanità. Il mondo diretto dal soffio dello Spirito Santo, è una nave che fa rotta verso il porto; spinto dall’alito dello spirito maligno, è una nave che si allontana dalla spiaggia e che finisce infallibilmente per perdersi. Se dunque vogliamo predire l’avvenire di un regno o di un’epoca, basta vedere a quale impulso essi obbediscono. – Con tutto ciò la deificazione dell’ uomo cominciata col Verbo e continuata con lo Spirito Santo, non ha ancora raggiunto la sua perfezione. I sette doni divini non sono in noi forze dormienti; ma sono altrettanti principi attivi che debbono manifestarsi con delle operazioni in rapporto con la natura e con l’oggetto di ciascuno. Cosi è che l’albero, il cui umore è messo in moto dal calore del sole, deve produrre delle foglie, fiori e frutti, secondo la sua specie. Il paragone evangelico che di già ci ha reso sensibile la differenza delle virtù e dei doni, ci farà altresì comprendere la differenza dei ‘doni e delle beatitudini. – Che cosa si dee intendere per le beatitudini? Donde viene il loro nome? Qual’è il loro numero, quali i loro rapporti con la felicità di ciascun uomo? Come procurano il benessere delle società? Qual è la loro superiorità sulle virtù? Qual è il loro ordine gerarchico? Quali sono i loro rapporti con i doni dello Spirito Santo? Tali sono i quesiti che ci sembrano abbracciare, nell’insieme, un soggetto altresì poco noto e non meno interessante, come i doni dello Spirito Santo. – 1° Che cosa si ha da intendere per le beatitudini? Le beatitudini sono i doni dello Spirito Santa in azione. [“Beatitidines distinguuntur a donis et virtutibus, sicut actus ab habitibus”. Vig., c. XIII, p. 418]. – Accade ad un cristiano lo stesso effetto che ad un albero. Allorché nel battesimo egli ha ricevuto la vita divina e con essa le virtù infuse; quando, con i sette doni lo Spirito Santo é venuto a dare il moto a tutte queste virtù, come il calore all’umore, così il cristiano può e deve praticare certi atti di una perfezione soprannaturale, che s’incamminano al suo ultimo fine. [Non c’è bisogno di dire ‘che tutto ciò si fa nel tempo stesso e con una sola operazione]. – Questi atti sono detti beatitudini, cioè beatificanti. Essi differiscono dalle virtù e dai doni, come l’effetto differisce dalla causa, il rivo dalla sorgente, il fiore dall’albero; o per parlare il linguaggio della teologia, come la facoltà in atto, differisce dalla facoltà in potenza. « Le beatitudini, dice san Tommaso, differiscono dalle virtù e dai doni, come gli atti differiscono dalle abitudini. » [“Beatitudines distinguuntur quidem a Virtutibus et donis, non sicut habitus ab eis distincti, sed sicut actus distiaguuntur ab habitibus” la, 2ae, q. 49, art. 1. Corp]. – Così le beatitudini non sono, come il loro nome sembrerebbe indicare, abitudini o stati permanenti; ma atti transitori, prodotti da abitudini permanenti, chiamati doni dello Spirito Santo. – 2° Donde viene il loro nome? II nome cosi dolce e cosi poco inteso di beatitudine significa felicità perfetta, riposo finale. « La beatitudine, dice un gran teologo, è il supremo bene, il fine ultimo; tutti convengono in questa definizione. Noi chiamiamo supremo bene, ciò che ha tutte le qualità del bene, e che non ha nessuna qualità del male, a cui nulla manca ed a cui non si può niente aggiungere. Tutti convengono altresì che questo bene supremo è uno, e che è Dio, bene perfetto, e fonte di ogni bene; il quale unendosi per adozione gli Angeli e gli uomini, gli rende partecipi della sua beatitudine infinita.» [Vig. t. c. XIV]. – Ora, la beatitudine è il fine ultimo della vita umana.22 ]”Beatitudo est ultimus finis humanae vitae”. S. Th., 1a 2ae, q. 69, art. 1, corp.]. -Questa verità è talmente certa, che l’uomo può ben falsare la legge che lo spinge alla ricerca della felicità, ma non può sottrarvisi. Sapendolo o no, col peccato o con la virtù, notte e giorno ei lavora per la felicità. Tranquillo e contento s’ei la trova; inquieto e infelice se ei la ricerca invano. Quest’ è l’ago calamitato il quale, sottomesso ad un’attrazione misteriosa, gravita di continuo verso il polo, né diventa immobile che dopo essersi messo in rapporto diretto con quel punto del cielo. – La beatitudine essendo la felicità perfetta, e la felicità perfetta essendo il pieno possesso di Dio, tre cose sono evidenti. La prima, che rapporto all’uomo, la beatitudine è insieme imperfetta e perfetta. Imperfetta sulla terra, dove non vediamo Dio, il supremo Bene, se non che attraverso le ombre della fede, e non Lo possediamo che in un modo imperfetto. Perfetto nel cielo, dove noi vedremo Dio faccia a faccia, e Lo possederemo senza timore di perderLo giammai. La seconda, che l’uomo non arriva tutt’ad un tratto al suo fine. La terza, che il suo fine o la beatitudine, non è né può essere di questo mondo. – In queste verità di logica e di buon senso si trova, per dirla di passata, la prova assoluta di tre verità fondamentali: l’esistenza d’un’altra vita, la libertà umana, l’obbligo per l’uomo, per tutta la durata del suo passaggio quaggiù, di tendere al suo fine, mediante continui progressi. Il tempo non gli è stato dato per un altro uso. Questi progressi, essendo un avviamento verso la beatitudine, sono la beatitudine incominciata. Di qui viene che nel suo linguaggio profondamente filosofico, il Vangelo chiama beatitudini, certi atti della vita presente, che conducono più direttamente alla beatitudine dell’altra. – Spiegando il testo sacro, la teologia cattolica aggiunge che si dà loro il nome di beatitudini per due ragioni. La prima, perché ci rendono beati quaggiù. È un fatto di universale esperienza, che la maggior somma, di contenti, anche in questo mondo, è per il cristiano fedele, il praticare i sette atti sublimi, ai quali il Verbo incarnato ha giustamente dato il nome di beatitudini. – La seconda, perché ci conducono più direttamente alla beatitudine finale, per cui ci fanno godere vivendo in isperanza. Cosi di una persona dicesi che ha ottenuto l’oggetto dei suoi voti, allorquando ha la speranza fondata di ottenerlo. Lo stesso Apostolo non ha egli scritto: Noi siamo salvi in isperanza. Ora la speranza d’ottenere il nostro ultimo fine é fondata su qualche cosa, che ci dispone e ci avvicina a quello. Questo qualche cosa, consiste nelle operazioni dei doni dello Spirito Santo. Da ciò né segue che esse sono appellate beatitudini, ovvero atti beatificanti. [S. Th. la, 2ae, q. 69, art. 1, corp.]. – Spiegando i rapporti di ciascuna beatitudine col dono corrispondente, noi giustificheremo in un modo sensibile questo nome di beatitudine. Lo faremo, a fine di mostrare che le cose dalle quali il Vangelo fa dipendere la felicità, non sono la fonte di una semplice felicità mistica– 3° Qual è il numero delle beatitudini.? Con i concili e con san Tommaso noi contiamo sette beatitudini, l’ottava, espressa da san Matteo, non è che la conferma e la manifestazione delle altre. Infatti, appena Che l’uomo è confermato nella povertà spirituale, nella dolcezza e nelle altre beatitudini, la persecuzione é impotente a staccarlo da questi beni inestimabili.11 Octava beatitudo est quaedam confìrmatio et manifestatio est confirmatus in paupertate Spiritus et mititate, et aliis sequentibus, provenit quod ab bis bonis propter aliquam persecutionem non recedit. Unde oetava .beatitudo quodammodo ad septem praecedentes pòrtinet. S. Th. ibid., art. 3 ad 4. — Tale è pure il sentimento di sant’Agostino, di sant’Antonino, del Concilio di Vaures, c I, an. 1868, ec.]. — Quanto alle ragioni di questo numero sette, esse si rivelano da se medesime. Da una parte sette beatitudini bastano per costituire la felicità. Meno, sarebbe stato troppo poco; più sarebbe inutile. D’altra parte, le beatitudini o atti beatificanti, non essendo che le operazioni dei doni dello Spirito Santo, o meglio, quei doni messi in attività, non possono essere che nel numero di sette. Inoltre, secondo profondi teologi, queste sette beatitudini sono in rapporto con le sette età della vita del’uomo, come queste sette età medesime sono in armonia con le sette età del mondo, e queste con i sette giorni della creazione. [S . Anton.j IV p., tit. VII, c. V]. – 4° Quali sono i rapporti delle beatitudini con la felicità di ciascun uomo? «La vita presente, dice sant’Antonino, si divide in sette età, durante le quali il Verbo incarnato si è fatto, per mezzo delle sette beatitudini, nostro regolatore universale. Queste beatitudini che non sono che tanti atti virtuosi, l’uomo deve averli tutti e sempre; ma a datare ciascuna in particolare all’età in cui egli è. Ivi si trova il principio della sua felicità.2 » [“Vita praesens distinguitur per septem aetates, in quibus omnibus regulat nos Cbristus per septem beatitudines. Omnes istas quae aliud non sunt quam actus virtuosi, debet quilibet habere simul habitualiter. Licet quaelibet per se adaptari possit uni astati hominum. Ubi supra. — Questa divisione settennaria della vita è probabilmente in rapporto con la rivoluzione climaterica, che ha luogo in noi tutti i sette anni, della quale l’antica fisiologia teneva seriamente conto. – La prima età, è l’infanzia che si estende dalla nascita fino ai sette anni. Debolezza, umiltà, distacco, semplicità, candore, sono le virtù e gli incanti di questo periodo della vita. Se il fanciullo le possiede, esprime in se medesimo la rassomiglianza del Dio infante. Egli cammina verso il fine per cui è stato creato: è felice! Questa è la prima beatitudine e evidentemente quella che conviene meglio alla prima età : Beati paperes spiritu. La seconda età si estende da’ sette a quattordici anni. Praticare la dolcezza, l’obbedienza, l’amabilità, che unita al candore ed alle grazie nascenti, guadagnano tutti i cuori: ecco dunque il dovere proprio di questa bella parte dell’esistenza. Il fanciullo che l’adempie disegna di nuovo l’immagine del Verbo incarnato; cammina verso il suo fine; è felice. Quest’è la seconda beatitudine, e evidentemente quella che è la meglio appropriata a questa età: Beati mites. – La terza età abbraccia da’quattordici anni ai ventotto. Il periodo diviene doppio, a cagione dello sviluppo fisico e morale dell’uomo, L’adolescenza è l’età pericolosa. Il mondo che sorride, le passioni che si svegliano, i sensi che parlano, tutto diviene occasione di lotte incessanti. È allora appunto che l’uomo ha bisogno di mortificazione, di vigilanza, di sante tristezze della penitenza, e di noie salutari dell’esilio. Se egli lo comprende, e che la sua condotta corrisponda alla sua fede, è felice. Quest’è la terza beatitudine: Beati qui lugent. – La quarta età va dai venti ai quarantadue anni. Questa età in cui la gioventù strabocca, è ardente nelle faccende, avida di danaro, di onori, di posizioni sociali, e spessissimo poco delicata intorno ai mezzi di ottenerli. Perciò, o giovine, se tu vuoi evitare la lebbra di Gezi, e l’eterna sete del ricco malvagio, eccita in te la sete ardente, la fame continua della giustizia. – A questo prezzo solamente tu sarai felice. Quest’è la quarta beatitudine; essa è fatta per te. Beati qui esuriunt. La quinta età si estende dai quarantadue ai cinquantasei anni. Quest’ è l’età di virilità e altresì il cominciamento del declinare. Dietro sé l’uomo vede la vita che se ne fugge, davanti a sé l’eternità che si avanza. In una simile situazione che può egli fare di più savio? Aver pietà dell’anima sua: cioè a dire? Da una parte, riparare le perdite che ha fatto peccando; dall’altra, mettere la sua fortuna in sicurezza, facendola trasportare dai poveri nel luogo della sua eterna dimora. -S’egli si conduce in tal modo, diviene beato, felicità propria a questa età; pratica cosi la quinta beatitudine. “Beati misericordes”. La sesta età comincia a’ cinquantasei anni e finisce ai settanta. Età della vecchiezza, veneranda po’ suoi capelli bianchi e per là sua esperienza, può e deve esserlo ancor più per la santità dei costumi. A meno che non sia di quegli invecchiati nel delitto, di cui parla il profeta Daniele, niente è più facile al vecchio d’evitare le lordure del peccato. I suoi sensi sono indeboliti, alle rose del volto subentrano le rughe, il fuoco della concupiscenza ha perduto i suoi ardori. Approfitti egli di questa decadenza dell’uomo esteriore per abbellire con la purità della sua condotta l’uomo interiore. Con questa innocenza che gli rende in parte gli incanti dell’infanzia, diviene per la gioventù un consigliere obbedito, un modello rispettato; per tutto ciò che lo circonda un centro di attrazione, di dove irradia il buon odore di Gesù Cristo. Egli è felice della beatitudine che è in armonia con la sua età. Quest’è la sesta: “Beati mundo corde”. – La settima età, parte dai settanta anni e si prolunga sino alla fine della vita. Quest’è l’età della decrepitezza, l’età degli anni che non piacciono, come parla la Scrittura. – L’indebolimento dei sensi, l’infermità degli organi, la necessità di cure sconosciute, le infermità, i patimenti, la dipendenza da altri, l’allontanamento degli amici ed anche dei parenti, l’oblio e il disprezzo del mondo, i rimorsi del passato, le tristi previsioni dell’avvenire, tutti questi nemici ed altri ancora, assediano il vecchio. Se non lo rendono il più disgraziato degli uomini, lo costituiscono, certo, nella necessità di cercare la sua pace dentro se medesimo, e di praticarla circa a tutto ciò che lo Circonda. Perciò la sapienza infinita gli ha riserbata la settima beatitudine: “Beati pacifici”. E per incoraggirlo in mezzo ad elementi che congiurano per condurlo alla sua distruzione finale, essa aggiunge subito: Beati coloro che soffrono persecuzione per essersi conformati alla volontà di Dio.11 [S. Anton., ubi supra]. – 5° Come le beatitudini evangeliche procurano la felicità delle nazioni? È stabilito che le beatitudini sono la sorgente della felicità individuale; la conseguenza inevitabile dunque è che esse procurano la felicità delle società. Le società sono fortunate allorché stanno nell’ordine: esse sono nell’ordine, allorché, conoscendo il loro ultimo fine, cioè la loro felicità, vi camminano con un passo sicuro. Ora, trascinati dalla loro corruzione naturale, la maggior parte dei figli di Adamo, popoli o individui, cercano la felicità nelle creature. Allontanando l’uomo dal suo fine, questo deviamento cieco, è la sorgente di tutti i mali, i quali meritano, cento volte alla terra il nome di valle di lacrime. – Quando il genere umano é zimbello dell’angelo delle tenebre, cerca la felicità per tre vie differenti: via degli onori, via delle ricchezze, via dei piaceri. Con una autorità sovrana, le tre prime beatitudini rettificano questa funesta tendenza. Beati, dicono esse, quelli che sono umili separati; quelli che sono uniti e quelli che piangono. Perchè beati?Perchè sono al coperto dal fascino generale che forma l’infelicità degli altri. Beati, perché non ponendo che un debole pregio al possedimento dei beni terreni, essi gli acquistano senza passione, gli posseggono senza inquietudine e gli perdono senza rincrescimenti superflui. Beati, perché ogni atto di umiltà, di distacco, di dolcezza e di tristezza cristiana gli avvicina alla felicità suprema. Beati, perché hanno in prospettiva i beni dell’eternità, magnifica ricompensa del loro disprezzo pei beni temporali. – Praticare il distacco cristiano dalle cose caduche non è nulla per la felicità del mondo? In questo appunto consistono le tre prime beatitudini. Le due seguenti: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia; beati i misericordiosi, sono un secondo passo verso la felicità. Distaccando l’uomo dalle creature; le tre prime beatitudini fanno che egli si unisca al supremo bene, imperocché il suo cuore non può restar vuoto. Così esse lo costituiscono nell’ordine per rapporto a Dio, vale a dire nella pace con Dio. – Le due seconde procurano la pace col prossimo. L’uomo è in pace col prossimo, allorché compie i doveri di giustizia e di carità. Egli gli adempie con una rara perfezione, quando da una parte, le sue parole e le sue opere, fanno testimonianza ch’egli è animato dall’amore, il che non basta; poiché è divorato dalla fame e dalla sete della giustizia in tutto e rispetto a tutti; ei l’adempie d’altro lato quando egli mostra per il prossimo, anche per i suoi nemici, una carità indulgente, che scusa le colpe o le intenzioni; compassionevole, che soccorre tutti i bisogni; misericordiosa; che perdona le offese. – Pace con Dio, pace col prossimo: tali sono gli effetti delle cinque prime beatitudini. Per completare la felicità anche temporale- dell’uomo e della sociètà che cosa rimane se non la pace con sé medesimo? Essa risulta dalle due ultime beatitudini: Beati quelli che hanno il cuor puro; beati i pacifici. Col farci praticare la purità di cuore, con la mortificazione, la vigilanza e la preghiera; la prima mantiene la subordinazione necessaria della carne, rispetto allo spirito, e ci costituisce nell’ordine. – Con la dolcezza e la pazienza, la seconda ci fa manifestare nelle nostre relazioni di famiglia e di società, l’ordine che regna nel nostro interno, e ci dà il diritto di chiamarci figli di quel Dio, che da sé medesimo si è chiamato il Principe della pace, “Princeps pacis”. Che ve ne pare? Il cristiano che pratica le sette beatitudini, o i sette atti beatifici per eccellenza, non gode egli altro che una beatitudine mistica? Se l’Europa attuale, se il mondo intero, possedessero questa felicità, pretesa immaginaria, sarebbero essi forse infelici? Insensati che sono! Gli uomini ed i governi attuali hanno l’aria di credere che le beatitudini evangeliche non siano nulla nella felicità temporale delle società; ed è appunto la mancanza di questi elementi, sociali eminentemente, che cagiona le rivoluzioni, delle quali siamo stati, siamo e saremo le vittime. – 6° Qual’è la superiorità delle beatitudini sulle virtù? In quella guisa che i doni dello Spirito Santo sono come elementi santifìcatori, superiori alle virtù morali, così le loro operazioni sono più perfette di quelle delle virtù. Ecco perché esse meritano per eccellenza il nome di beatitudini o atti beatifici. La virtù fa che l’uomo usi con moderazione degli onori e delle ricchezze: il dono fa che ei li disprezzi. Con questo sublime disprezzo il cristiano diventa l’essere il più libero, il più santamente indipendente, per conseguenza il più felice che vi sia al mondo: “Beati pauperes”. – La virtù impedisce all’uomo di seguire, contrariamente alla ragione, i moti dell’ira. Il dono fa meglio: ei lo libera da ciò. Essiccando nel fondo dell’anima la sorgente del fiele e dell’impeto, stabilisce il cristiano in una dolcezza inalterabile che attrae a sé i cuori: “Beati mites”. La virtù regola il nostro affetto per la vita del tempo. Il dono va più in là; ei vi sostituisce le sante tristezze dell’esilio: “Beati qui lumen”. La virtù ci fa esercitare la giustizia rispetto a Dio e rispetto al prossimo. Il dono la sorpassa, perché ci fa rendere a Dio ed agli altri quel che gli dobbiamo, non solamente con esattezza, ma con premura ed affezione. – Secondo la parola del Vangelo, esso ci riempie, per la giustizia e per i nostri doveri di giustizia, di un ardore incomparabile a quello che prova per il cibo, colui che ha fame, per l’acqua, colui che ha sete: “Beati qui esuriunt”. – La virtù ci fa esercitare la carità corporale e spirituale verso coloro che la ragione designa ai nostri benefizi; i nostri amici e nostri parenti. Il dono s’innalza più alto. Egli vede il bisogno, nient’altro che il bisogno; la ferita, nient’altro che la ferita; il cencio, nient’altro che il cencio; e per 1’amore di Dio dona, rasciuga, solleva senza distinzione parenti, stranieri, amici o nemici, Greci o barbari: “Beati misericordes”. – Da queste cinque beatitudini fedelmente praticate risulta una purità d’affetti e di pensieri assai più perfetta di quella di cui la semplice virtù é la fonte e la regola: “Beati mundo corde”. Rendendoci simili a Dio tre volte santo, questa purità ci dà un diritto particolare a chiamarci figli di Dio : “Beati pacifici”. « Di qui deriva, dice san Tommaso, che le due ultime beatitudini sono presentate non come tanti atti meritori ma come tante ricompense. » [“Vel sunt ipsa beatitudo, vel aliqua inchoatio ejus : et ideo non ponuntur in beatitudinibus tanquam merita, sed tanquam praemia. Ponuntur autem tanquam merita effectus activae vitae, quibus homo disponitur ad contémplativam vitam”, l a, 2ae, q. 49, art. 8, corp.]. -Esse sono insieme il cominciamento della beatitudine perfetta, e il legame che unisce le beatitudini ai frutti, dei quali parleremo tra poco. Frattanto questo semplice saggio che ci mostra la superiorità delle beatitudini, anche circa le virtù’ soprannaturali, ci aiuta a misurare 1’elevazione del cristiano al di sopra dell’uomo onesto, e del sapiente pagano. – Come mai non prendere sin d’ora compassione de’ nostri pretesi moralisti del XIX secolo? Caduti dall’altezze dell’ordine soprannaturale, in cui il battesimo gli aveva posti, questi superbi ignoranti, “superbus nihil Sciens”, osano porre a parallelo la perfezione cristiana con la perfezione pagana; la morale di Socrate con la morale di Gesu Cristo. Bestemmiatori e spergiuri, essi non temono di appellare la prima: la morale di questo mondo e della gente onesta; la seconda: la morale dell’altro mondo e dei mistici: poi, sotto pretesto che essi non sono vaso d’elezione, non ne praticano nessuna. – 7° Qual’è l’ordine gerarchico delle beatitudini? Come i doni dello Spirito Santo che gli producono, così le beatitudini si incatenino le une con le altre in un ordine gerarchico, i cui gradi innalzano il cristiano sino alla perfezione dell’essere divino, e per conseguenza fino al colmo della felicità: lo mostreremo più tardi. In questo momento, abbiamo da studiare due cose degne della sapienza; la quale fa tutto con misura numero e peso. La prima é la relazione che esiste tra ciascuna beatitudine e la sua ricompensa; la seconda, la gradazione nella ricompensa in se medesima. – La ricompensa. Senza dubbio, il cielo o la felicità perfetta é la ricompensa comune di tutte le beatitudini; ma questa ricompensa è presentata sotto un aspetto differente, in armonia col genere particolare di merito ottenuto da ciascuna beatitudine. Se è vero dunque che il peccatore è punito dovunque pecca, è del pari vero che il giusto è ricompensato dovunque egli merita. – Che cosa di più proprio di questa divina equazione, a eccitare il nostro zelo, ed a sostenere il nostro coraggio, nelle vie differenti che conducono alla felicità? – Così per quelli che si fanno piccoli e poveri, il cielo è il potere, l’opulenza, la gloria: “Regnum coelorum”. – Per quelli che sono miti, il cielo è l’impero dei cuori nella terra dei viventi : “Possidebunt terram”. – Per quelli che piangono, il cielo è la consolazione e la gioia pura e senza fine: “Consolabuntur”. – Per quelli che hanno fame della giustizia, il cielo è l’appagamento perfetto: Saturabuntur. – Per i misericordiosi, il cielo è la misericordia con le sue ineffabili tenerezze: “Misericordiam consequentur. – Per i mondi di cuore, il cielo é la chiara vista di Dio nello splendore della sua bellezza e nelle magnificenze delle sue opere: “Deum videbunt”. – Per i pacifici, il cielo è il nome glorioso e il privilegio incomparabile di figli di Dio: “Filli Dei vocabuntur”. – A questa armonia se ne aggiunge un’ altra: la gradazione nella ricompensa. Un po’ d’attenzione basta per scorgerla. La prima ricompensa è di avere il cielo. Questa è la felicità comune a tutti i santi, ma non eguale per tutti; imperocché vi sono più gradi nella beatitudine, come vi sono parecchie mansioni nella casa del Padre celeste. – La seconda è di possederlo. Ora, possedere il cielo dice più che averlo. Vi sono molte cose che si possono avere senza possederle in un modo tranquillo e permanente. – La terza é d’essere consolato. Essere felice nel possesso del cielo, è più che averlo e possederlo. Quante cose gradevoli, che noi non possediamo senza dolori! – La quarta è d’essere sazio. Sazio è più che essere consolato. La sazietà implica l’abbondanza della consolazione, è il riposo nella gioia. – La quinta è di essere l’oggetto della misericordia. – La felicità del cielo non sarà misurata, né sopra i nostri meriti, né sopra i nostri desideri, ma sulle ricchezze infinite dell’infinita misericordia. Chi può comprendere ciò che un simil favore aggiunge a tanti altri?– La sesta è di vedere Dio. Questa nuova felicità sorpassa le precedenti. Vedere Dio è più che tutto il resto, ed annunzia una maggior dignità. Vedere il re intimamente e quando si vuole, è più che abitare il suo palazzo e godere i suoi benefici. – La settima è di essere figlio di Dio. Non vi è null’altro al di là. Alla corte dei re, la maggiore sublimità è quella dei loro figli, eredi del loro trono. Cosi di gradino in gradino, condurre l’uomo fino alla dignità suprema di figlio di Dio, di fratello e di coerede del Verbo incarnato, è l’ultima parola di tutte le beatitudini e di tutte le operazioni dello Spirito Santo.11 [V. S. Th., la, 2ae, q. 69, art. 4, corp., et ad 3]. – Quando il misterioso lavoro di deficazione è compiuto, lo Spirito d’amore manda appunto il sonno della morte. – Al suo risvegliarsi, questi si trova tutte le beatitudini che egli ha praticate, riunite, immortalate e magnificamente ingrandite in una sola, il cielo, la beatitudine per eccellenza. Tali sono i gradini della scala per i quali, dal fondo della valle del pianto, noi ascendiamo sino alla vetta della montagna della felicità: « Discendendo sopra lo Dio uomo, dice sant’Agostino, lo Spirito Santo comincia, con la sapienza e finisce col timore, a fine di abbassarlo sino a noi. Nello scendere sull’uomo destinato a diventare Dio, egli comincia col timore per innalzarlo sino al Verbo incarnato, l’eterna sapienza. Abbiamo dunque dinanzi agli occhi queste gloriose ascensioni; affrettiamoci a salire i gradini che ci conducono al Signore. Portiamo coraggiosamente il peso della vita. Attraversiamo con un passo fermo e con l’occhio fisso sul fine, le seduzioni e le tribolazioni passeggere del tempo; a termine del viaggio è la pace purissima e senza fine. A questo dunque ci esorta l’ottava beatitudine, conclusione di tutte le altre: Beati quelli che soffrono persecuzione, imperocché il regno dei cieli appartiene ad essi. » [Serm 847, n. 3, opp. t. V, p. 1988, ediz. noviss.]. – 8° Quali sono i rapporti delle beatitudini con i doni dello Spirito Santo? L’abbiamo già indicato: questi rapporti sono di quelli che esistono tra l’effetto e la causa, tra il frutto e l’albero che lo porta. Le beatitudini sono i doni dello Spirito Santo in opera. Ora, tutto ciò che é stato detto per far comprendere la bellezza, la concatenazione, la necessità di questi elementi santificatori, e per conseguenza beatificatori – Affinché sia ben dimostrato che lo Spirito del cenacolo continua ad essere con la Chiesa, sdegneremo i nostri esempi negli annali contemporanei del cattolicismo. Una eccezione sarà fatta in favore di san Francesco d’Assisi, la cui vita dovrebbe essere il manuale del nostro tempo. Il primo dono dello Spirito Santo si traduce con la prima beatitudine, e dà luogo a degli atti meravigliosi d’umiltà, di pentimento e di orrore per il peccato. – Un giorno d’ inverno san Francesco d’Assisi si portava da Perugia a Santa Maria degli Angeli, con un freddo rigorosissimo. Via facendo chiama fra Leone suo compagno di viaggio: « Fra Leone, gli dice, cara pecorella del buon Dio, se i frati minori parlassero la lingua degli angeli, se essi conoscessero il corso degli astri, la virtù delle piante, il segreto della terra e la natura degli uccelli, dei pesci, degli uomini e di tutti gli animali, degli alberi, delle pietre e dell’ acqua, rifletti bene, che in ciò non è la gioia perfetta. » – E un po’ più sotto : « O fra Leone, quando i frati minori convertissero con le loro prediche tutti i popoli infedeli, stai bene attento che quella non è la gioia perfetta. » E continuò a parlare così per lo spazio di parecchie miglia. – Finalmente fra Leone, maravigliato, gli domandò: « O Padre, vi prego in nome di Dio, ditemi in che consiste la gioia perfetta. » San Francesco rispose : « Quando noi arriveremo a Santa Maria degli Angeli ben molli, ben infangati, intirizziti di freddo, morenti di fame e che battendo alla porta, il portinaio ci dirà: — Chi siete voi? risponderemo: — Noi siamo due dei vostri fratelli. — Voi mentite, dirà egli, siete due vagabondi che correte il mondo e togliete l’elemosina ai veri poveri: partite di qui. – « Ed egli rifiuterà di aprirci e ci lascerà alla porta tutta la notte, esposti alla neve, al freddo e morenti di fame. Se noi soffriamo questo trattamento con pazienza, senza turbamento e senza mormorare, se altresì noi pensiamo umilmente e caritatevolmente che il portinaio ci conosce bene per quelli che noi siamo, e che é per permissione di Dio che egli parla così contro di noi, o frate Leone, credi pure che in ciò consiste la gioia perfetta. – « Se noi seguitiamo a battere alla porta e che il portinaio infuriato ci caccia via come bighelloni importuni, ci ricopre d’ingiurie, di schiaffi e ci dice: — Non partite ancora di qui, miserabili marioli? Andate allo spedale: non vi é nulla da mangiare qui per voi. — Se noi sopportiamo questi cattivi trattamenti con gioia e con amore, o frate Leone! credilo bene, in ciò consiste la gioia perfetta. – « Se infine, in questo estremo, la fame, il freddo, la notte ci costringono a fare istanza con lacrime e con grida per entrare nel convento, e che il portinaio irritato esce fuori con un grosso bastone nodoso, ci tira per il cappuccio, ci getta nella neve e ci dà tante bastonate da ricoprirci di piaghe; e noi sopportiamo tutte queste cose con gioia, a pensare che noi dobbiamo partecipare alle umiliazioni del nostro benedetto Signore Gesù Cristo, o frate Leone, credilo, quivi si trova la gioia perfetta. E ora ascolta la conclusione, o fra Leone: di tutti i doni dello Spirito Santo, il più considerevole é di vincere sé medesimo, e di soffrire volentieri per amor di Gesù, le pene, le ingiurie e gli obbrobri. » [Fioretti, c. VIII.] – Allo spettacolo di questa ammirabile umiltà non resta che alzare gli occhi al cielo e ripetere le parole della Sapienza eterna. “Io vi ringrazio, o Padre, che avete nascosto queste cose ai sapienti ed ai prudenti,. e che le avete rivelate ai semplici. – Vediamo il dono di timore, riguardo al peccato. Una madre non risente tanto dolore della morte di suo figlio, quanto l’anima ispirata dal dono di timore ne risente pei suoi piccoli errori. Il frate Alfonso Rodriguez era ripieno di questo dono divino. Ogni volta che egli passava in un certo canto della casa si gettava in ginocchio chiedendo perdono a Dio piangendo; si faceva vivi rimproveri e si strappava i capelli, e ciò continuò a fare parecchi anni. Aveva egli forse commesso in quel luogo qualche peccato enorme? No, egli si era permesso una piccola leggerezza di sguardi, per la quale egli credeva avere offeso Dio. [Pergmayer, Meditaz. sopra i sette doni, ecc., p. 11]. – Lo stesso Spirito di timore che ispira pentimento del peccato, ne ispira anche orrore. Nel 1841 un Mandarino fa arrestare parecchi cristiani e gli stimola ad apostatare. – Alla fermezza della loro risposta capisce l’impossibilità di riuscirvi. L’incatenarli tutti, era fare più chiasso e vittime che non voleva. Nella sua stizza si limita a descrivere con un bastone un cerchio intorno ad una giovinetta, che era in ginocchio dinanzi a lui, poiché era usanza in China di stare in ginocchio dinanzi al giudice che vi interroga. «Se tu esci da questo cerchio, dice, sarà una prova che tu sei apostata. » E partì. Dopo di lui ciascuno si ritirò dal pretorio, fuorché la giovine, che il timore di abiurare la sua fede fece rimanere in ginocchio immobile nello stretto spazio in cui la verga del mandarino l’aveva rinchiusa. Il segretario di quel magistrato, curioso di sapere qual partito avrebbe preso l’innocente prigioniera, tornò indietro, e trovandola ancora nello stesso luogo, nella stessa attitudine, la invitò ad alzarsi ed a uscire. « No, rispose ella, piuttosto morirò che fare un passo. — Badate; il mandarino non l’ha detto sul serio. — Non importa, io ho inteso le sue parole e non conosco le sue intenzioni. » – Il segretario insisté lungo tempo senza ottenere risposta. Allora cancellò lui stesso il cerchio fatto dal suo padrone e ne trasse via la giovane. [Annali della Propagazione della fedet n. 83, p. 804.] — Vedi altresì il passo di san Basilio, Godescardo, 14 giugno]. – Citiamo un ultimo fatto che ci mostrerà lo Spirito di timore di Dio, e lo Spirito contrario che si disputano un’anima in una lotta terribile. Nel corso dell’anno 1840 il governatore del Tonchino, di nome Trinh-Quang-Kanh, fece arrestare un catechista, chiamato Toan, della età di 74 anni. Consegnato a terribili supplizi il disgraziato vecchio ebbe la debolezza di apostatare. Alcuni giorni dopo, il governatore lo fece ricondurre al pretorio con alcuni altri rinnegati e disse a tutti loro: « Poiché avete ascoltato ragione, il re vi perdona ed io pure. — Gli altri ti ringraziano, risponde il vecchio pentito, ma io che deploro il mio fallo, rimango qui in prigione per espiarlo. » – A queste parole il mandarino, preso dalla collera, vomita contro di lui mille ingiurie e le accompagna con una forte bastonata. Siccome la fermezza del martire non pare scossa, ordina ai soldati di rinchiuderlo in una cloaca spaventosa per farlo decidere, non importa con quali modi, a ritornare sulla sua ritrattazione. Due giorni dopo lo richiama al suo tribunale. «Ora, gli dice, sei tu disposto a calpestare la croce? — No, mandarino, è già troppo l’avere una sol volta oltraggiato il mio Dio. — Ascolta: tu disprezzi i miei ordini; forse gusterai tu meglio i consigli di coloro che hanno partecipato ai tuoi errori, se t’abbandono al loro zelo. Se essi ti riconducono a migliori sentimenti, farò loro grazia come a te; se no, voi salirete tutti sul patibolo. » – I rinnegati non entrarono che troppo nelle viste del tiranno. Essi s’ingegnarono a cimentare la pazienza della loro vittima. Gli uni lo ricoprivano di maledizioni, gli altri gli graffiavano il viso. Tutti divenuti eloquenti per vigliaccheria, lo stimolavano ad obbedire, se non per conservare la sua vita, per salvare almeno dal supplizio dei padri di famiglia, la cui sorte era compromessa per la sua ostinazione. Per quattro giorni egli fu posto a questa orribile prova; il quinto, quando era già mezzo vinto, il governatore lo fece condurre al pretorio e torturare con tanta violenza, che l’infelice soccombé di nuovo. – La sua recidiva fu accolta da scoppi di risa del mandarino. « Va a riposarti, gli dice, aspettando che tu abbia la forza di godere la tua libertà. » I soldati lo felicitarono alla lor volta. Ma i rimorsi del colpevole lo rendevano sordo a tutti questi elogi. La notte la passò nelle lacrime e nei singulti, che pareva disperato. Per fortuna si trovava nella prigione un sacerdote, onorato di poi della palma del martirio. Lo sfortunato vecchio, tutto ricoperto di piaghe, si getta ai suoi piedi, gli fa con inconsolabili gemiti la confessione dell’ ultima sua caduta, e si rialza doppiamente fortificato dalla parola del sacerdote e dalla virtù del sacramento di penitenza. – II giorno dopo il governatore lo fa comparire, a fine di assicurarsi con nuove profanazioni della sincerità della sua apostasia. « Né i tormenti, né la morte mi faranno oramai abiurare la fede, disse al persecutore: col mio pentimento io spero avere recuperata l’amicizia del mio Dio; è ben tempo che io Gli resti fedele. » Questa volta le torture non hanno più limiti. La vittima, stesa per terra, viene rifinita a forza di bastonate; coi piedi e polsi legati, lo strascinano nella sala d’udienza opprimendolo con una grandinata di colpi: gli pongono al collo una ganga armata di ferro; lo gettano in prigione, e viene tirato fuori per esporlo agli ardori cuocenti del sole; lo spogliano dei suoi abiti, gli attaccano un crocifisso a ciascun piede e viene legato ad una colonna. – Le sue braccia distese in forma di croce, sono legate alle due estremità della ganga fissata attraverso alle sue spalle e lo lasciano cinque giorni e cinque notti in quella orribile posizione. Finché dura questo supplizio, i soldati l’insultano, gli sputano in faccia, gli danno degli schiaffi, gli strappano la barba. Infine lo riconducono in prigione semivivo e come paralizzato in tutte le sue membra. Il mandarino ordina di lasciarlo morire di fame. – La sua agonia durò parecchi giorni. Allorché venne un individuo a visitarlo, approfittò della sua presenza per umiliarsi delle sue colpe: « Io ho traviato, diceva: ho avuta la debolezza di imitare l’apostasia dei capi del mio villaggio; ma al presente sono ritornato sinceramente a Dio, e voglio morire nel suo amore. Io vi scongiuro di pregare per me. » Sentendo avvicinarsi la sua fine, lascia le sue vesti ad un sotto ufficiale che gli aveva dato alcuni pezzi di pane; egli promette, come quel militare lo pregava, di ricordarsi di lui in paradiso: egli cade svenuto, porta le dita alla bocca come per succhiarle, tanto era spinto dalla sete, e pochi istanti dopo spira vittorioso nell’ultimo combattimento. [Annali della Propag. ec., n. 85, p. 429 e seg.]. – Tali sono gli effetti del dono del timore di Dio, e le vestigia che i santi hanno lasciate, ritornando nella patria: [Haec sunt vestigia quae sancti quique nóbis reliquerunt in patriam revertentes]. – Al dono di timore di Dio succede il dono di pietà. Il principio d’amore figliale si traduce con la seconda beatitudine, i cui atti respirano la tenerezza ed il rispetto verso Dio e tutto ciò che gli è consacrato; verso il prossimo, e tutto ciò che gli appartiene nell’ordine spirituale, come nell’ordine temporale. Vediamolo diffondersi nei giovani cristiani d’oltremare. – « Tutto il tempo che abbiamo passato a Wallis, scrive un missionario, é stato un tempo di festa per noi e per gli abitanti. Noi vi siamo rimasti un mese e mezzo. Quanto siamo rimasti edificati e confusi nel vedere la pietà di questi buoni isolani! A tutte le ore del giorno e della notte, siamo sicuri di trovare degli adoratori dinanzi al Santo Sacramento. Ogni mattina, preghiera in comune e concorso alla santa Messa, durante la quale il canto dei cantici non cessa. Verso il tramonto, o per parlare come gli indigeni, allorché la cicala ha cantato, si riuniscono di nuovo ai piè degli altari per la preghiera della sera. Allora i fedeli vanno a casa. Ma appena che la famiglia è riunita, che in tutte le case, niuna eccettuata, incomincia la recita del rosario seguita dal canto dei cantici e dalla ripetizione del catechismo. – In questo momento non si sente più in tutta quanta l’isola altro che un concerto di lodi, durante il quale é impossibile non si sentire commossi e inteneriti fino alle lacrime. » [Annali della Propag. ec., n. 120, p. 346, an. 1848]. – Qualche anno prima il viaggiatore, smarrito per l’isola, non avrebbe ascoltato all’istess’ora altro che voci di antropofagi che facevano ritorno dai loro orribili banchetti. – L’amore figliale di cui questi recenti cristiani sono innamorati di Nostro Signore, rinchiuso nel tabernacolo, si manifesta altamente quando esce fuori : « Come vi sareste edificato, scrive il missionario di Futuna, allorquando, in questa cristianità nascente, il santo Viatico fu portato per la prima volta a un infermo! Mentre il sacerdote camminava all’ombra dei fichi, dei cocchi, e degli alberi a pane, dei devoti neofiti lasciavano le loro case e venivano rispettosi e raccolti, ad inginocchiarsi sui canti delle vie per dove passava il Santo Sacramento. » [Annali della Propag. ec., n. 96, p. 369. an. 1841]. – La stessa devozione per tutto ciò che riguarda religione. « L’affluenza al tribunale della penitenza è cosi grande, che dal bambino che incomincia a balbettare, sino al vecchio di già vicino alla tomba, tutti vogliono confessarsi…. Hanno un cosi grande rispetto per il tribunale di penitenza, che un giorno un padre di famiglia venne piangendo a domandarmi se sua figlia, che aveva avuta la curiosità d’aprire un confessionale della valle, si era resa molto colpevole. » [Id. id]. – Il cristiano che ama Dio, ama la casa di Dio, come un figlio ama la casa di suo padre. A questo amore figliale la vecchia Europa fu debitrice dei magnifici edifici che la coprivano come di un mantello di gloria. Presso i popoli nuovamente convertiti, lo stesso amore produce miracoli. « Il lavoro principale, scrive l’apostolo Di Mangaréva, quello che mette in moto tutta la popolazione, è la costruzione di una chiesa. Poiché l’isola non fornisce pietra, la maggior parte dei padri di famiglia sono occupati per lungo tempo a trasportare degli isolotti di scogli, situati presso a cinque leghe in mare. – « Una volta depositate le pietre sulla spiaggia, vengono ruzzolate a forza di braccia fin sotto la mano degli operai. I giovani si dividono le diverse comandate,, di modo che una popolazione dà la muta all’altra ogni otto giorni. Chi va a pescare il corallo per fare della calce, chi reca, dalla distanza di mezza lega, la rena necessaria; le donne stesse sospendono le loro occupazioni abituali per andare a cercare sulla montagna le canne destinate ad alimentare il fuoco della fornace di calcina. Di più, aiutate da dei fanciulletti, fanno con i filamenti del cocco le corde di cui gli operai hanno bisogno. – « Il re ha fatto un appello alla generosità del suo popolo. Bisognava molto legname per le travi e per l’arte del legnaiolo, e quelle isole producono appena l’albero a pane, prezioso vegetale da cui la popolazione trae la sua sussistenza. Nondimeno non vi fu alcuno che non si mostrasse disposto a dare più che non si volesse ricevere. – « Se noi dicessimo a questi: la tua terra è troppo piccola; a quegli: il tuo albero é troppo bello; non lo prenderemo. — Che cosa importa, rispondevano, tagliate pure perché è per il nostro buon Dio. Non è esso che ce li ha dati? Così pure ce ne darà degli altri. Abbiamo dovuto vegliare acciocché la generosità di questi buoni e cari cristiani non recasse loro pregiudizio. – Voi non sapreste farvi un’idea dell’ardore con cui essi proseguivano la loro intrapresa. Il re ed i capi alimentavano a loro spese tutti i nostri lavoranti. I pescatori si sono incaricati di fornire del pari tutti i giorni del pesce agli operai, per tutto quel tempo che saranno occupati in ciò che essi chiamano, il lavoro del Signore. » [Annali della Propag., ec., n. 83, p. 316, an. 1842]. – « Quegli che è di Dio, ascolta la parola di Dio, dice il Salvatore del mondo; la ragione per cui voi non l’ascoltate, è che voi non siete di Dio. » [Joan., VIII, 47]. – Amare la parola di Dio, scritta o parlata, è dunque un nuovo effetto del dono di pietà. Per incoraggiarci e confonderci, ammiriamolo nei nuovi cristiani. « Ciò che mantiene negli abitanti di Wallis (continuano gli annali) il sentimento e l’amore del dovere, egli è che essi sono avidissimi della parola di Dio. Oltre le istruzioni dei missionari, vi è in ogni villaggio e in ogni piccolo casale dei catechismi d’uomini, di donne e di fanciulli. I più istruiti insegnano agli altri: ciascuno si confessa e si comunica all’incirca tutti i mesi. Da per tutto si recita la sera il rosario in comune, seguito da un inno alla SS. Vergine. » [Annali della Propag., ec., n. 104, p. 14, an. 1846]. – Lo stesso ardore sotto i ghiacci dell’ America settentrionale. « I nostri selvaggi non potevano essere più avidi della santa parola. I catecumeni soprattutto si distinguono per zelo di istruirsi, a fine di anticipare il felice momento in cui, mediante il battesimo, sarebbero finalmente ammessi nel numero dei fedeli. Noi gli teniamo in chiesa più di sei ore al giorno. La maggior parte di questo tempo era destinata al catechismo e a delle istruzioni familiari, dove tutti assistevano. Invece l’essere stanchi di questi esercizi, non appena erano usciti dalla cappella, cercavano, riunendosi in diversi gruppi, di rendersi conto tra loro delle cose che avevamo dette e ciò per delle ore intere, qualche volta miche molto inoltrati nella notte. Nei loro dubbi venivano essi a consultare i missionari. Allora, ancorché fossimo a letto o no, addormentati o svegli, bisognava dar loro udienza e rispondere a tutte le loro domande. [Id.% n. 100, p. 269]. – Continuando i suoi divini insegnamenti il Verbo Incarnato diceva dei suoi apostoli e dei suoi preti: «Colui che vi ascolta, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me; chi vi riceve, riceve me; e colui che riceve me, riceve colui che mi ha mandato.» [Luc., x, 16; IX, 48]. – Questa parola ha attraversato i secoli. Oggetto di venerazione e di tenerezza figliale dalla parte dei veri cristiani, tale è stato, tale è, e tale sarà sempre il sacerdote. Su questo punto due fatti tra mille, rappresentano tutta la tradizione. – Nel secolo decimosesto viveva a Napoli la venerabile Orsola Benincasa, fondatrice delle Teatine e istitutrice ispirata dell’abito dell’Immacolata Concezione. Sin dalla più tenera età, questa pia fanciulla aveva un tal rispetto per i preti, che vedendoli, essa si poneva in ginocchio e gli abbracciava i piedi, facendosi benedire da essi, e baciando perfino le orme dei loro passi. Tale era la gioia che le cagionava la loro presenza, che spesso si metteva alla finestra, solamente per vederli passare. Tostoché ella li scorgeva, si chinava profondamente, e dava tutti i segni della più affettuosa venerazione, come se questa fosse stata la persona stessa di nostro Signore. – Più tardi ella diceva ingenuamente al suo confessore: « Quand’io era piccina, desiderava con impazienza i giorni di festa per due ragioni: la prima perché non lavorando, io poteva attendere liberamente a tutti i miei esercizi di pietà, la seconda, perché io poteva, a tutto mio agio, starmene alla finestra a veder passare i preti per la strada. Io gli considerava come tanti angeli del paradiso, mentre gli altri uomini mi dispiacevano oltremodo. » Tale era la sua stima per i preti, che aggiungeva: « Quand’io vedessi coi miei propri occhi cadere un prete in qualche colpa, piuttosto che crederlo, crederei che i miei occhi m’ingannassero. » [Vita, ec., p. 282]. – Ascoltiamo ora uno degli apostoli delle isole Gambier: « Un giorno io stara seduto sopra un masso, in fondo ad una larga baia, intento ad istruire della gente in età piuttosto avanzata. Alcuni isolani s’accorsero che era lungo tempo che io era là, e giudicarono che dovessi aver fame. Essi ordinarono tosto a un fanciullo di andare a cogliere un cocco. Il fanciullo era molto piccolo, e gli alberi di questo frutto sono molto elevati. Immaginatevi un fusto perfettamente diritto, in cima al quale un grosso gruppo di foglie di quindici piedi di lunghezza, si distende in forma di ombrello.. Questi buoni selvaggi mi dissero: — Prega, padre, prega, perché abbiamo timore che il bambino non cada e non si uccida. — Quando il cocco fu preparato, me lo presentarono dicendomi: — In qualunque luogo tu sia, o padre, se tu hai fame di’: Io ho fame, e noi ti daremo da mangiare…. – « Mi è impossibile di dare un’ idea .del rispetto che si ha per noi e delle attenzioni di cui siamo l’oggetto. Alla più piccola parola che si pronunzi, voi vedete una premura universale. Se abbiamo bisogno di andare da un’isola all’altra, dei rematori sono subito pronti. Se noi gli facciamo osservare che il viaggio cagionerà loro un’assenza di qualche giorno, e che temiamo d’impicciarli: — No, no, rispondono, parlate padre, e noi faremo. — Questa deferenza dei nostri neofiti è 1’effetto naturale dell’amor figliale, col quale rispondono all’amore veramente paterno che noi sentiamo per essi. [Annali della Propaga ec., n. 56, p. 195, an. 1888].» – Queste dimostrazioni non sono vane formule. Riguardando con ragione il missionario come loro padre, e il migliore amico, i nuovi cristiani sanno, al bisogno, imporsi in suo favore i più grandi sacrifici. « Due missionari del Tong-kin si trovavano riuniti in una casa. – La nuova giunse all’orecchie dei persecutori. Arriva tosto il sindaco del comune, seguito da tre satelliti armati di bastone. — Chi siete voi, dice al padre Lac che incontrò il primo, certamente un maestro di religione. — E senza attendere da lui risposta : — Dov’è il capo dei cristiani? Domandò egli entrando nel presbiterio per arrestare il padre Thi. Si raccomandarono che Andrea Lac fuggisse, ma il santo padre immobile e rassegnato, si contentò di rispondere: — Che la volontà di Dio sia fatta! se piace loro di arrestarmi, sarà la seconda volta che io sarò in prigione per Gesù Cristo. « Il sindaco fece salire i due confessori nella sua barca e gli condusse nella sua abitazione. Alcuni cristiani seguivano, supplicandolo di rilasciare i suoi innocenti prigionieri. — Io vi acconsento, disse loro, purché voi mi rechiate sei barre d’argento. — Subito quei buoni neofiti vanno a casa loro, vuotano la loro borsa, si fanno prestare da’ loro vicini e ritornano con tutto ciò che essi hanno potuto raccogliere, sessanta legature e tre grandi marmitte, che valevano presso a poco i due terzi della somma richiesta. — Ecco tutto quel che noi possediamo; esclamarono, depositando il loro tesoro ai piedi del sindaco; rendeteci almeno il padre Lac. Ei gli rese tutti due, e i nostri cristiani si ritirarono, troppo felici d’avere salvato i loro pastori a prezzo della loro fortuna. » [Annali, ec., n. 85, p. 4=12, an. 1842]. – Lo Spirito di pietà, abbiamo detto, fa versare il cuore in effusioni di carità per il prossimo. Agapi, cure dei’ poveri e degli infermi, avvertimenti caritatevoli, tutte le meraviglie che esso operava nei primitivi cristiani ei gli rinnova fra gli idolatri nuovamente convertiti. – Passiamo sotto silenzio tutte le opere di misericordia corporale per citare un tratto di misericordia spirituale. – « La persecuzione infieriva nel Tong-kin. Un vecchio di circa 69 anni, fu gettato in prigione con un gran numero di altri cristiani. Fra questi ultimi c’era il suo genero, giovine nel vigore dell’età. Tremante qualche volta alla vista della morte, questo buon vecchio dovette il suo coraggio invincibile alle esortazioni del suo genero. – « O padre mio, gli diceva questi, considerate la vostra età. Due specie di morti sono poste vicino a voi; l’una naturale, le cui conseguenze sono incerte; l’altra data dai persecutori, della quale una eternità di contenti è la ricompensa. Come fare a decidere nella scelta, dove il miglior partito è cosi facile a conoscere? Se fosse permesso di rimpiangere la vita in una tale circostanza, converrebbe a me, giovine ancora e vigoroso; però voi vedete che io l’abbandono con allegrezza per Iddio. – Io lascio la mia sposa nel fiore dell’ età, con quattro bambini ancora incapaci di guadagnare la loro vita; ma Dio che me li ha dati, saprà provvedere ai loro bisogni. – Che è forse il dolore delle verghe che vi spaventa? Non temete nulla, o padre mio; io riceverò in vostra vece quel che i mandarini vi destineranno; siamo dunque contenti e coraggiosi. – « Quando i giudici ricorsero alle battiture, l’ammirabile giovine si distendeva per terra, per ricevere da prima quelle che gli erano destinate; e allorquando si preparavano a battere suo suocero, egli si rialzava tutto insanguinato, e diceva ai mandarini : — Mio padre è di età e debole, vi prego d’aver pietà, e di permettere che io sia battuto in suo luogo. — Allora egli si buttava giù di nuovo dinanzi ai mandarini, e subiva una seconda flagellazione con un eroico coraggio. – «Mentre il futuro martire sosteneva suo suocero, egli stesso riceveva da parte dei suoi, incoraggiamenti e molte dolci consolazioni. Sua moglie venne a. vederlo parecchie volte col suo ultimo bambino ancora a petto, lo esortò a non darsi punto pensiero di lei, ed a starsene tranquillo sulla sorte dei suoi quattro piccini; aggiungendo che, con la grazia di Dio, ella sperava potere nutrirli ed educarli ancorché sola. Veramente questa donna forte si è mostrata degna sposa di un martire, e la sua figlia, degna figlia di sua madre. Questa giovinetta, dell’età di undici anni, scappò un giorno di nascosto dalla casa paterna per andare a vedere il santo confessore nella sua prigione. Essa fece da sé sola una mezza giornata di cammino, attraversò senza timore i soldati e le guardie, e giunse fino a suo padre, che essa incoraggiò a morire, piuttosto che calpestare la croce. Alcuni giorni dopo i coraggiosi atleti ricevettero la corona del martirio. » [Annali, ecc., n. 73, p. 518, an. 1840]. Nell’ordine ascendente, il terzo dono dello Spirito Santo, è il dono di scienza. Al primo grado della nostra stima, il dono di scienza c’insegna di mettere la nostra anima e quella del prossimo. A che serve all’uomo guadagnare il mondo, se egli viene a perdere l’anima sua? Questa verità capitale si afferma con gli atti della terza beatitudine. Un sol giorno dei secoli cristiani ha prodotto più affermazioni eroiche, che il mondo pagano non ne avesse viste per due o tre mila anni. Ciò che è stato fatto, continua a farsi. – « In Francia, scrive un missionario della China, si sarebbe più che maravigliati, se si vedessero poveri infermi che non hanno più di due o tre giorni di vita, venire in barca da quindici, venti, trenta leghe per ricevere gli ultimi sacramenti. Qui è la cosa più comune. Un giorno me ne furono recati nove di differenti luoghi nella stessa cappella; era un vero spedale. Udii le loro confessioni, io gli comunicai, diedi l’estrema unzione a parecchi di loro, e gli rimandai tutti pieni di consolazione; ma la mia contentezza era molto più grande di quella di questi buoni neofiti. Che cosa direbbero di questo pietoso costume i cristiani indifferenti d’Europa, soprattutto se si aggiungesse che questi eroici fedeli muoiono spessissimo nelle loro barche a mezzo del loro viaggio? – « Un piccolo fatto, avvenuto or son pochi giorni, vi farà meglio ammirare la fede dei nostri cristiani. Io era stato chiamato da un infermo a una delle estremità del mio distretto. Dopo la Messa vidi entrare due corrieri che mi pregarono d’andare a visitare un infermo, in una cristianità, lontana dieci leghe; presto mi pongo in via con essi. Cammin facendo ci incontriamo in una barca; erano fedeli che mi recavano un infermo. Non riconoscendo essi il marinaro che mi conduceva, continuarono a dirigersi verso la parrocchia da me lasciata, intantoché io mi recava in un’altra, vicina alla loro. – Quella povera gente, dopo avere remato tutta la giornata, arrivano finalmente verso sera bene affaticati: non trovano nessun missionario; che fare? Si ripongono in viaggio, sperando raggiungermi prima della mia partenza, nuovo disinganno; io mi era portato più lontano, dopo aver detto la santa Messa; le nostre barche s’incontrarono un’altra volta, ma questa volta i nostri rematori si riconobbero. – « L’infermo mi fece compassione ancor più della sua gente. Non potendo tornare indietro, mi esibii di ascoltare la sua confessione nella sua misera barca, e poi di amministrargli l’estrema unzione. Ma questo brav’uomo mi rispose, che da moltissimo tempo non aveva avuto la fortuna di comunicarsi, e che, trovandosi a me vicino, non mi abbandonerebbe senza essere stato munito di tutti i sacramenti. Fu costretto dunque a ritornar fino alla nostra cappella, e fare con me da circa otto leghe. » [Annali, ec., n. 116, p. 58, an. 1848]. – Allo stesso grado di stima del nostro, il dono di scienza pone l’anima del prossimo, e soprattutto di quelli che ci sono uniti con legami di sangue. Mentre oggi presso i cristiani degeneri della vecchia Europa, il matrimonio pare non sia, per gli sposi, che una scuola di scandalo reciproco, una specie d’impresa, di dannazione a spese comuni; tra. i fedeli, di fresco convertiti, la grande preoccupazione del marito è la salute della sua moglie, e reciprocamente. Mercé lo spirito di scienza, essi comprendono quanto è meschina una unione di alcuni giorni, che la morte dovrebbe rompere in eterno, o rendere eternamente disgraziata. – « Nel 1840 fu arrestato nel Tong-kin occidentale un virtuoso padre di famiglia per nome Martino Tho. Fino dal primo giorno del suo arresto, non era parso che si fosse occupato d’altro che del suo sacrificio, benché lasciasse una sposa e otto figli. Ammirabile famiglia tutta animata dello spirito del suo capo, lungi dal cercare di ammollire il suo coraggio, essa faceva voti perché egli rimanesse fedele. « Quattro o cinque giorni dopo che si fu tolto loro il padre, i figli chiesero alla loro madre il permesso d’andare a vederlo in prigione. — Figli miei, disse ella, vostro padre è sul campo di battaglia; non si sa ancora se sarà felice bastantemente per confessare il Vangelo. – L’idea sola dei tormenti che gli si preparano, sono più che sufficienti per le sue prove, senza che voi vi aggiungiate altro. Se andate a visitarlo, forse la vista dei suoi figli, la memoria della sua casa, gli cagionerebbero una emozione funesta alla sua fede, forse la sua tenerezza per voi gli farebbe dimenticare la gloria che lo attende. Pur tuttavia se qualcuno di voi vuol penetrare nella sua prigione, io non mi vi oppongo, purché egli vada prima a consultare il catechista del gran padre Doari: s’egli si adatta alla vostra domanda, io ve lo permetto; se egli la trova imprudente, ritornerete. – «Ma quando si ebbe inteso che il santo confessore aveva trionfato di tutte le sue torture, questa buona madre disse allora ai suoi figli: — Vostro padre, con la grazia di Dio, ha gloriosamente confessato il nome del Signore; or dunque andate a vederlo, consolatelo nelle sue pene, incoraggiatelo a soffrire per amore di Dio. — I due maggiori, maschio e femmina partono subito; l’eroe cristiano stringendoli nelle sue braccia. — O miei figli, gli disse, vostro padre tra poco va a morire. Per voi, questa è l’ultima mia raccomandazione, e la ridirete in mio nome a tutti i vostri fratelli : ricordatevi che non avete che un’anima; pregate Dio che vi faccia la grazia di rimanere fedeli alla vostra religione: soprattutto conservatevi puri dal contagio del mondo.1 »1 [Annali, ec., n. 83, p. 263, an. 1842 – I preziosi Annali della Propag. della fede sono ripieni d’esempi che provano, presso i nostri fratelli d’Asia, d’Africa e d’Oriente la pienezza del dono di scienza, applicato, sia al disprezzo dei falsi beni, sia alla stima della povertà, ossia al discernimento della verità e dell’errore, che produce per risultato la fermezza nella fede e la concordia nelle famiglie.]. – La fortezza è il quarto dono dello Spirito Santo : operare e patire sono i. suoi due obbietti. Esso si manifesta con la quarta beatitudine, vale a dire con atti d’incrollabile amore per la giustizia, per 1’espulsione di Satana dai domìnii ch’egli ha usurpati, e per lo stabilimento del regno del Verbo redentore, sia in noi stessi, che negli altri. In fatto d’impresa eroica, io non so’ se yì è nulla di paragonabile all’ introduzione di uno dei nostri missionari nella penisola di Corea. – Da parecchi anni il sig. Maistre tentava invano d’entrare per terra o per mare in quel paese idolatra. Respinto da tutte le parti, ma non scoraggiato, egli formò l’audace progetto di farsi gettare sulla costa con una vecchia guida, e di aspettare dal cielo l’esito del suo generoso disegno. Ma il piano era più facile a concepire che ad eseguire. In mancanza di giunca o di nave, ci voleva una barca e non ve n’erano punte; un pilota parimente mancava. Chiesto con insistenza agli uomini che si vantavano d’essere intrepidi, barca e pilota, gli furono ricusati. Lungi da lasciarsi abbattere, il missionario raddoppiò di fiducia in Dio; né fu ingannato. – Un padre Gesuita, missionario in China, che aveva qualche cognizione nautica, venne ad offrirsi per pilota in quella deficienza generale. Si giunse a trovare un piccolo giunco pagano e alcuni rematori. Per proteggere, quanto era possibile, la piccola spedizione, il console di Francia a Chang-hai, rimise al padre Helot, stabilito comandante della flotta, una commissione d’andare a visitare gli avanzi del naufragio di una nave francese, affondata sulle coste di Corea. Essendo tutto in tal modo organizzato, la piccola giunca levò la sua ancora di legno, spiegò le sue vele di paglia, e veleggiò pel mare giallo, versò l’isola sconosciuta del campo francese. Appena preso il largo, si sollevò a un tratto una furiosa tempesta. Satana l’aveva sollevata per sventare la santa impresa. Per lungo tempo la barca lottò contro i flutti, i quali con uno spaventevole ruggito, s’accumularono a lei dinanzi, per sbarrargli il passo e inghiottirla. – Dopo inutili sforzi, bisognò girare di bordone andare a cercare un riparo dietro un’isola vicina. – Lungi dall’abbattere il coraggio dei due missionari, divenuti piloti, questo terribile contrattempo non servì che ad accrescerlo. Quarantott’ore dopo, il fragile scafo rimise alla vela. Di già la spiaggia era scomparsa, ed era prudente di assicurarsi della direzione da tenere. S’interrogarono gli strumenti che non diedero certa risposta. Otto giorni erano scorsi, e nulla ancora sull’orizzonte era venuto a rallegrare gli inquieti sguardi degli intrepidi navigatori. Finalmente il nono giorno, si trovarono davanti un piccolo gruppo d’ isole, verso il quale si dirizzò allegramente la barca. I missionari scesero nel villaggio fabbricato sulla costa, per abboccarsi con gli abitanti. – Tutt’ad un tratto ecco il mandarino del luogo che arriva, egli pure per fare agli stranieri delle interrogazioni imbarazzanti; gli si accorda un appartamento a bordo. Il padre Helot che riunisce le funzioni di pilota a quelle di capitano e d’incaricato d’affari, si affretta di’ prendere la parola per il primo, e di presentare le sue lettere al mandarino, pregandolo di indicargli il luogo del naufragio. L’astuto magistrato ricusa di rispondere. Gli si dice di partire, e appena ha voltate le spalle si rimette alla vela. Qualche altra ora di dimora, tutto avrebbe compromesso. Dopo una navigazione in mezzo a pericoli d’ogni sorta, si scopre il punto desiderato di sbarco. Allorché la notte fu giunta, il signor Maistre rivestì in fretta il suo povero costume coreese, in mezzo al religioso stupore della gente dell’equipaggio; dopo di che egli scese con la sua vecchia guida in un piccolo canotto, avendo un bambu per albero e una treccia di paglia per vela. Portando sulle sue spalle una piccola valigia delle cose più necessarie, l’intrepido missionario si pose a calcare il sentiero scosceso dei monti, dietro i quali disparve ben tosto, per andare, con pericolo della sua vita, a sacrificarsi agli imminenti pericoli dell’ apostolato. [Annali, n. 148, p. 233 e seg., an. 1863. — Il signor Maistre è diventato uno degli illustri martiri di Corea]. – Affrontare la morte sopra un campo di battaglia, vuol dire essere bravo, benché si sia circondati da migliaia d’altri uomini che l’affrontano del pari, e che si sia provvisti di tutte le armi necessarie per difendersi. Ma che nome dare a quello che solo e senza armi va ad affrontarla in mezzo ad un intero popolo, la cui felicità sarà d’immolarlo e di nutrirsi del suo supplizio? Lo spirito di fortezza, può solo operare un simile prodigio. La prova è che il mondo pagano antico non l’ha mai visto, nemmeno lo scisma o l’eresia. Soffrire è ancor più eroico, ed è un nuovo miracolo dello spirito di fortezza. – Due esempi ancora di questa sovrumana fortezza, nelle prove e in mezzo alle più violenti tentazioni. – « Nella Cocincina, due piccole figlie di un cristiano, chiamato Nam, una di 14 anni, l’altra di 10, erano state condotte alla prefettura con la loro madre e padre e nonno. Sul loro rifiuto di apostatare, il mandarino ordinò di batterli sui piedi e sulle gambe, per farli andare a camminare sulla croce. Questo supplizio crudele deluse l’aspettativa del mandarino. Le due fanciulline si lasciarono orribilmente martoriare piuttosto che fare un passo innanzi. Prese e poste a forza sull’ istrumento della loro salute, esse non cessavano di protestare contro la violenza che era stata lor fatta, e si scusavano di questa involontaria profanazione con le testimonianze del più profondo rispetto. Il giudice non poté resistere a coraggio cosi eroico, e le rinviò con la loro madre. » [Id., n. 73, p. 555, an. 1840]. – Lo Spirito di fortezza opera lo stesso miracolo in China, facendo due eroine di due piccole Annamite, naturalmente tanto timide: « Ecco alcuni particolari intorno la costanza della quale una giovine chinese per nome Anna Kao, ha fatto prova nella persecuzione. Sorpresa nel momento in cui ella faceva la sua preghiera, fu arrestata dai satelliti che le proposero di scegliere tra l’apostasia e la morte. Essa non esitò a risponder loro con fermezza, che preferiva morire. La condussero dunque al tribunale per farla comparire davanti ai grandi mandarini. Questi le ordinarono di mettersi in ginocchio sopra una catena di ferrò; due soldati snudarono le loro sciabole, e gliele posero sul collo per spaventarla. In questo stato, gli si comandò di calpestare la croce: essa resisté a questa nuova prova con la stessa costanza. Allora i mandarini che sapevano che essa era sfinita dalla fame, le fecero presentare del cibo e le dissero di mangiare, in segno di apostasia. Essa tosto rispose: “Se voi ritenete per apostasia il mangiare, io vi dichiaro che morrò di fame, ptuttostoché prendere il più piccolo nutrimento; ma se voi non vi vedete che una azione ordinaria e indifferente; io mangerò”. Il mandarino confuso, le disse con ira: “Tu sei una ostinata, smangia pure se ti piace”. La famiglia e la figlia del mandarino, mosse a compassione per la vergine cristiana, unirono le loro istanze a quelle dei giudici, e l’esortarono vivamente a rinunziare alla fede; ma essa resisté a questa nuova tentazione, come aveva resistito alle minacce. Condotta nella città, sostenne a più riprese gli stessi combattimenti, e sempre con ima costanza imperturbabile: costei è tuttora in prigione. » [Annali, n. 76, p. 261, an. 1841]. – In confronto a simili prove, che cosa sono le nostre se non giuochi da fanciulli? Se noi soccombiamo, è perché ci manca il dono di fortezza. Questo dono allorché è nella nostra anima, opera ciò che ammiriamo e ciò che dice un pio autore: «Il legno rincollato si rompe, piuttosto altrove che nel punto della saldatura. Così è dell’anima unita a voi, o mio Dio, pel dono di fortezza: testimoni i martiri. È più facile separare il piede dalla gamba e il capo dal collo, che separarli dal vostro amore. In essi il timore aveva formato questo doppio cordone della carità, difficile a rompere. Essi vi amavano di tutto cuore senza errore; con tutta la loro anima, senza resistenza, con tutto il loro spirito, senza oblio. Signore, concedetemi un simile amore, affinché io non sia giammai separato da voi. » [Idiotae contemplat, c. XIV] – Al quinto gradino della misteriosa scala che ci conduce a Dio noi troviamo il dono di consiglio; il quale si cambia nella quinta beatitudine. Farci correre con ardore dove la voce di Dio ci chiama, cercare tutti i mezzi di conoscerla, di liberarci, per quanto le condizioni dell’esistenza terrena lo permettono, da tutti gli ostacoli alla nostra perfezione, e per ciò, non indietreggiare dinanzi a qualunque sacrificio: tali sono gli atti beatifici che rivelano in un’anima la presenza dello Spirito di consiglio. Noi lo vediamo risplendere nella condotta dei primi cristiani. Siccome il mondo pagano lo ammirava, or sono diciotto secoli, nella condotta dei nostri padri, cosi il mondo moderno, ridiventato pagano, è forzato a riconoscerlo in quella dei nostri giovani fratelli della China e dell’Oceania. – Per conseguenza desiderare ardentemente di ricevere lo Spirito Santo è di già un effetto del dono di consiglio. – Era animata da questo desiderio la giovinetta di cui parlano i nostri preziosi Annali della Propagazione della fede. « La mia seconda missione, scrive uno degli apostoli della China, fu del pari benedetta. Mi ricordo con piacere di avervi incontrato una fanciullina di dieci anni, benissimo istruita della sua religione, il che, a. quell’età, è estremamente raro presso i chinesi. – « Questa bambinetta desiderava con ardore il Sacramento della cresima, che io esitava nonostante ad accordarle, perché la trovava troppo giovane. Io volli assicurarmi se il suo coraggio eguagliava la sua intelligenza, e le dissi: — Dopo che tu sarai stata confermata, se il mandarino ti mette in prigione e che egli ti interroghi sulla tua fede, che cosa gli risponderai? — Io risponderò che sono cristiana per la grazia di Dio. — E se ti domanda di rinunziare al Vangelo, che cosa farai? — Io risponderò: no, giammai. — Se egli fa venire i carnefici e ti dice: Tu apostaterai, altrimenti ti taglieremo il capo, quale sarà la tua risposta? — Io gli dirò: Taglia! Incantato di vederla così ben disposta e così fortemente risoluta, l’ammisi con gioia al sacramento, che formava l’oggetto di tutti i suoi voti. » [Annali, n. 95, p. 804, an. 1844]. – La vera religione essendo la strada regia dalla terra al cielo, uno dei primi effetti del dono di consiglio è di farci ricercare e usare tutti i mezzi di ben conoscerla. Che cosa di più savio dell’informarsi della sua strada? … non è forse la prima cura del viaggiatore in paese straniero? … e poi, quanto meglio si conosce la religione, tanto più la si ama, e più siamo disposti a fare tutti i sacrifici che essa domanda, e a realizzare il sublime distacco segnato dal dono di consiglio. Sotto questo rapporto, vediamo che cosa esso ispira ai giovani cristiani Annamiti in mezzo anche alla persecuzione. – « I miei catechisti, scrive un missionario della Cocincina, mi avevano spesso parlato di un concorso generale intorno al catechismo che aveva avuto luogo tutti gli anni a Hè-sin, allorché i fedeli godevano una libertà perfetta. Tutte le cristianità vicine erano invitate a prendervi parte. Quella che non avesse risposto all’appello si sarebbe ricoperta di un obbrobrio incancellabile. « Un giorno io dissi ai catechisti: — Bisogna fare un concorso. — Padre, non è possibile. — Io so che un gran concorso come quelli d’una volta, non è possibile; ma un piccolo concorso dove saranno chiamate alcune cristianità soltanto, e che avrà luogo durante la notte, è facilissimo, e quel che più importa, io conto d’assistervi. La domenica seguente si annunziò pubblicamente nella chiesa, la prossima apertura di un concorso sul catechismo. Fu una febbre d’entusiasmo fra tutta la gioventù. Avevano un mese per prepararsi. Se non fossi stato testimone, non mi sarei mai fatto un’idea di una simile emulazione. Tutte le sere, i ragazzi da un lato, le femmine dall’ altro, si riunivano a piccoli gruppi, nelle case dei capi principali incaricati d’insegnare le parole del catechismo. La recita si prolungava fino alle undici, e qualche volta più tardi. – Se aveste attraversato, per caso, la cristianità di Hé-Sin, sareste stato assordito da un frastuono di pie canzoni, che non mancavano di una certa armonia. – Gli Annamiti recitano, cantando, il catechismo, come tutte le loro preghiere. Durante il giorno, era lo stesso strepito nelle case particolari, nei campi e perfino per le strade, dove quelli che si preparavano al concorso ripassavano, interrogandosi a vicenda la lezione della sera antecedente; e la domenica aveva luogo nella chiesa una ripetizione generale, alla quale tutti i catechisti assistevano. Ciascuno dei candidati riconosciuto dal consiglio del suo villaggio, capace di sostenere la prova dell’esame, aveva dato il suo nome. « Il primo concorso ebbe luogo durante un’intera notte nella cappella di Hè-Bang. Questa chiesa sebbene fosse abbastanza vasta non poté contenere la folla degli spettatori. Io dovetti contentarmi d’ essere semplice assistente. Io fui introdotto furtivamente nella chiesa, e nascosto dietro le cortine del grand’altare, dove si era praticata una piccola apertura, per cui potevo veder tutto senza esser visto. Uno de’nostri padri Annamiti, uomo grave e rispettabilissimo tra quei cristiani, presiedé il concorso. Se ne stava seduto magistralmente sopra una poltrona, posta sulla predella dell’altare, mentre in basso sedevano da’ ambo i lati, i capi delle differenti cristianità: gli esaminatori scelti tra i primi letterati di ciascun villaggio, erano nel mezzo: un gran colpo di tamtam annunziò l’apertura della seduta. – « Dopo una solenne invocazione allo Spirito Santo, un personaggio vestito di una lunga toga cerimoniale, trasse fuori da un’urna i nomi dei due primi concorrenti, chiamandoli con una voce stentorea. Un secondo personaggio, adorno dello stesso costume, tirò da un’altra urna un biglietto sul quale erano indicati i capitoli del catechismo che dovevano formare la materia dell’esame, che egli proclamò pure ad alta voce; e il concorso incominciò. I due candidati s’interrogavano e rispondevano alternativamente, in mezzo a un silenzio profondo, interrotto qualche volta da un piccolo rullo di tamburo; ciò accadeva quando qualcuno di loro sbagliava qualche parola. Allora essi si fermavano finché gli esaminatori non avessero giudicato se l’errore doveva essere considerato come uno sbaglio o no. Vi erano solamente due gradi: quello che recitava imperturbabilmente e senza punti errori la parte che gli toccava in sorte, otteneva il primo grado. Una sola parola pronunziata con esitanza, faceva passare al secondo grado. Ai tre sbagli, non si meritava né biasimo, né lodi; ai quattro si era censurati. I due personaggi con la lunga veste proclamavano i nomi dei vincitori, i quali condotti in processione e al suono di musica, all’altare della Madonna vi facevano omaggio a Maria del loro trionfo, si consacravano a Lei con una speciale preghiera, e se ne ritornavano al loro posto in mezzo ad una sinfonia musicale. – « Il concorso che aveva durato sino al mattino fu terminato con una Messa di ringraziamento, seguito da una larga distribuzione di croci, di medaglie e di abitini. Ma questa moltitudine aveva fame; né si poteva rimandarli digiuni. D’altronde, presso gli Annamiti, una festa religiosa non sarebbe completa, se essa non avesse terminato con un pasto. Io non volli derogare all’usanza. – Ma fu invano quando, dietro i miei ordini, si invitò al banchetto i disgraziati vinti; essi si nascosero così bene che non vi fu modo di trovarli. Essendo la festa terminata con soddisfazione generale, ogni gruppo se ne ritornò allegro al suo villaggio, ed io rientrai nella mia prigione. » [Annali, ec., n. 146, p. 20 e seg., an. 1858]. – Al racconto di questi devoti concorsi, i nostri grandi dottori d’Europa balbetteranno certamente la parola puerilità, e sorrideranno di compassione. Serbino pure i loro sorrisi per sé e per i loro concorsi agricoli ove non fanno altro che presiedere insieme ad altri gravi personaggi alla mostra di buoi, vacche, cavalli, muli, asini e maiali, poi dare premi ai più bei prodotti, in vista di procurare il miglioramento di tutte le razze di bestie, asinina, bovina, caprina e porcina; quest’esercizio utilissimo è proprio degno di loro. Essi chiameranno ciò un glorioso progresso del secolo dei lumi! E agli occhi di questi stessi uomini sarà puerile esercitare, con una nobile emulazione, anime immortali alla conoscenza profonda delle verità, che sono la condizione della loro felicità e la base stessa della società? Voi parlate di puerilità: dite da qual lato ella si trovi. Se voi l’ignorate, tanto peggio per voi. Questo è un segno che siete scesi al livello dei vostri concorrenti.11 [“Homo cum in honore esset non intellexit; comparatus est jumentis insipientibus et similis factus est illis”. Ps. 48.— “Animalis homo”. I Cor., II, 14]. – Frattanto i frutti del dono di consiglio si manifestano presso i nostri giovani fratelli, come presso i nostri avi. Conservare con la terra meno rapporti che sia possibile, a fine di camminare di un passo fermo e rapido verso la patria eterna; rompere anche per questo se bisogna, i legami più cari della natura: tali sono gli esempi che essi ci danno. – Ascoltiamo uno dei loro apostoli ; « Non potendo più rimanere nella Nuova Caledonia, senza respingere la forza con la forza, annunziai ai. nostri neofiti, venuti da dieci leghe di distanza, la nuova della nostra partenza. Essi avevano la scelta o di tornarsene a casa, oppure di venire a Futuna, ove troverebbero i missionari. – A questa notizia, tutti si misero a piangere; era la fede che produceva questo effetto. — E mio padre, diceva uno: e mia madre, diceva l’altro, non saranno dunque mai cristiani? Così si sforzava il loro dolore. Io non potei reggere a questo spettacolo e mi allontanai per lasciar loro agio di consultarsi. « Dopo pochi istanti ritornai e feci cessare i loro singulti, chiedendoli che partito avevano preso. — Seguirvi dovunque voi andrete, risposero. — Ma se noi ritorniamo in Europa, là fa freddo e morirete ben tosto. — Tanto meglio; adesso noi non desideriamo altro che la morte. – Il loro unanime parere fu di trasferirsi in un’isola molto lontana, dove vi sarebbero dei missionari, a fine di non più udir parlare d’una patria, ch’essi consideravano come riprovata per sempre. Sciogliemmo dunque le vele, e durante la traversata che fu di un mese, i nostri carissimi cristiani erano cosi edificanti, che il capitano e l’equipaggio, sebbene tutti protestanti, mi hanno domandato più volte d’invitare i nostri neofiti a fare la loro preghiera sul ponte, per avere il piacere d’esserne testimoni. – « Noi gettammo l’ancora a Futuna una domenica mattina. Il porto epa deserto. — Dove sono gli abitanti di questo villaggio, mi ripetevano di continuo il capitano e i marinari? Essi ignoravano che gli indigeni di Futuna, ferventi cattolici, erano tutti andati alla Messa. Le case erano abbandonate, perché in quell’isola convertita, non si sapeva che cosa fosse furto. Dopo un’ora d’aspettativa, udimmo risuonare da tutte le parti il cantico dei cantici. Erano gli isolani che ritornavano dalla chiesa benedicendo il Signore. I nostri padri si affrettarono di venirci a ricevere, ed i primi cristiani della Nuova Caledonia perseguitati per la loro fede dai loro compatrioti, erano ricevuti come tanti fratelli dai nuovi fedeli di Futuna. » [Annali, ec., n. 188, p. 388 e seg., an. 1851]. Abbandonare la via del cielo, lasciare il suo paese e la sua famiglia, è un tratto evidente del dono di consiglio, ma abbandonare se stesso è ancor più evidente. – « A Vallis, scrive un Missionario, dove ho esercitato per cinque mesi il santo ministero, ho avuto molte consolazioni: tra le altre, quella di vedere tre giovani, figlie dei più grandi capi dell’isola, chiedermi con istanza il permesso di consacrarsi a Dio in un modo speciale, mediante il voto di castità. Questo pensiero, esse l’avevano avuto di suo, per la sola ispirazione della grazia. Lo Spirito Santo aveva loro insegnato che questo era un consiglio evangelico, il cui libero adempimento piace al Signore. » [Annali, ec., n. 96, p. 398, an. 1844]. – Non é solamente sulle spiagge inospitali dell’Oceania, che lo Spirito Santo fa germogliare i fiori della verginità; ma essa si estende ancora nel suolo tanto profondamente solcato della China e della Cocincina. Lasciamo parlare un apostolo deil’Impero Celeste: «Noi abbiamo in ciascuna cristianità un certo numero di persone, le quali senza essere legate da voti religiosi, fanno professione di custodire la verginità. Possiamo con verità chiamarla il fiore della missione, e questa specie di fiore forma la gloria del giardino della Chiesa. – È un bel vedere il ceppo della verginità risplendere qui in mezzo al fango dell’idolatria. Non ci si può immaginare mai quanto sia grande la licenza dei costumi in paese infedele; ma l’eccesso del vizio serve, nei disegni di Dio, a far risaltare lo splendore della più pura delle virtù; e non ci vorrebbe di molto, ad occhi chiaroveggenti, riconoscere la sua celeste origine. Nel mio distretto che conta circa nove mila anime, vi sono più di trecento vergini. Tutto quel che fanno in Europa le Suore di san Vincenzo de’ Paoli, lo fanno altrettanto quelle vergini Chinesi. » Id. n. 116, p. 44, an. 1848. – Sono queste tante figlie di antropofagi, o di idolatri abbrutiti, divenute tutt’ad un tratto tante vergini cristiane, cioè dire tutto ciò che vi ha di più bello, di più sublime, di più angelico! 1 1 [Abbiamo a Parigi tra le suore di san Vincenzo dePaoli una ragazza parente di Àbdel-Kader!]. – Alla vista di questo miracolo mille volte ripetuto, che cosa direbbe il mondo pagano, esso che sotto Augusto, non può trovare sette vestali nell’impero dei Cesari? Uno meno incredulo degli empi moderni, esclamerebbe: “Il dito di Dio è qui”. “Digitus Dei est hic”! e avrebbe ragione. – Il sesto dono dello Spirito Santo è il dono d’intelletto. Gli atti ch’egli produce e che formano la sesta beatitudine, sono degli atti rivelatori di una cognizione chiara delle verità cristiane, di magnanimità nella fede, di conformità sostenuta tra la pratica e la credenza, in una parola, il regno effettivo del soprannaturale nell’ uomo e nella società. « Si può dire, scrive un missionario dell’Oceania, che Io Spirito Santo si è fatto in Persona il catechista del fanciullo, del quale ora parleremo. Ho trovato a Tonga un piccolo prodigio, al quale voi durerete fatica a credere. – È un bambino di cinque anni, e tuttavia sì abbastanza istruito, che non mi‘è riuscito a imbrogliarlo, interrogandolo in tutti modi intorno al catechismo. Quest’angioletto ci ha domandato il permesso d’insegnare la dottrina cristiana ai suoi parenti, i quali fuorché sua madre e suo padre, sono ancora tutti nel paganesimo. E un catechista tanto più eccellente, poiché nulla si può ricusare alla sua innocente semplicità. – «Egli stesso dice il Benedicite e le Grazie in famiglia. Appena ha visto celebrare la Messa cinque o sei volte che già ne imita tutte le cerimonie. Una foglia di banano gli serve da corporale; una conchiglia di mare gli tien luogo di calice. Quando sarà grande, ripete egli, vuol dirla davvero. Piaccia a Dio che questa vocazione si confermi, e che un di l’Oceania lo conti nel numero de’ suoi apostoli. » [Annali della Propag. ec., n. 104, p. 36, an. 1846]. Il dono d’intelletto che apre cosi meravigliosamente lo spirito del fanciullo, produce nell’uomo fatto, una specie d’intuizione della verità, di modo che la fede, sciolta dai suoi oscuri veli, diviene imperturbabile. In questo genere nulla supera l’esempio dato dal re di Bongo al Giappone. La sua conversione fece la gioia della Chiesa. In seguito, oppresso da avversità e da umiliazioni, nel momento in cui tutto pareva congiurato per turbare la sua fede, ei pronunziava solennemente queste belle parole: « Io giuro alla vostra presenza, o Dio potente, che quando tutti i Padri della Compagnia di Gesù, per il cui ministero Voi mi avete chiamato al Cristianesimo, rinunziassero essi medesimi a quel che mi hanno insegnato; quando io fossi assicurato che tutti i cristiani d’Europa avessero rinnegato il vostro nome, io vi confesserei, riconoscerei e adorerei, ancorché mi dovesse costare la vita siccome io vi confesso, riconosco e adoro per il solo vero e potente Dio dell’universo.1 » [Annali, ec., n. 125, p. 225, an. 1849]. – Il dono d’intelletto, illuminato dallo spirito, opera sulla volontà, e gli dà l’intelligenza della vita. Ora, siccome la vita é una prova, la penitenza è la sua legge. «Un gran numero de’ nostri cristiani, scrive un missionario dell’India, digiunano il sabato, cioè non fanno che un pasto solo, verso il tramontar del sole. Quante volte nelle mie escursioni, non ho io inteso il mio compagno di viaggio rispondere a coloro che gli domandavano se aveva mangiato in quel giorno : — Eh! non sapete voi che oggi è sabato? — E nonostante, quel povero cristiano mi aveva seguitato tutta la mattinata, portando sul suo capo un grosso fardello. Egli era rifinito dalla stanchezza, per agevolare il successo del mio ministero! Vi sono molti paesi dove questa pratica è quasi che universale, anche tra gli operai. Parecchi tra essi, soprattutto quando sono padroni di sé, preferiscono non lavorare che metà della giornata, a fine di potere differire sino alla sera il loro unico pasto. – « Questo spirito di mortificazione mi fornisce spesso l’occasione di edificarmi al santo tribunale. Perciò, se mi accade per esempio d’imporre per penitenza qualche digiuno nel sabato. — “O padre mio, rispondono una quantità di neofiti, io digiuno tutti i sabati”. — Ciò basta, rispondo. Ma di rado se ne contentano; se io indico il mercoledì o il venerdì, io trovo spesso il secondo posto di già preso, per un altro digiuno di devozione. Ultimamente io aveva prescritto una buona opera simile. – La mia penitente parve molto imbarazzata. Che v’è egli accaduto ? — “O padre mio, da tre anni io non mangio che una volta al giorno. Come farò io per adempire al digiuno che m’imponete”? Io lo ripeto; questi esempi non son rari tra i nostri cristiani. » [Annali, ec., n. 87, p. 87, an. 1848]. – Impariamo! questi cristiani, nati di ieri, potrebbero essere i giudici degli antichi seguaci della fede. Comunque sia, ammiriamo la Provvidenza che scelse questi fedeli dell’Oriente per fare, con le sante loro austerità, il contrappeso al sensualismo d’Occidente. – Il settimo dono dello Spirito Santo, nell’ordine ascendente, è il dono di sapienza. Come ultimo grado di luce e d’amore dinanzi alla visione beatifica, esso apre alla verità gli occhi dello spirito e soprattutto l’orecchio del cuore. Ei fa vedere Dio, fa gustare Dio, trasforma in Dio, compiendo la nostra filiazione divina. Volete voi vederlo in atto? Studiamo la settima beatitudine, vale a dire gli atti beatifici con i quali si manifesta! Pigliamo per esempio un indifferente, un incredulo, uno di quegli uomini, la cui stirpe oggi è tanto numerosa, che ha occhi e non vede niente; che ha un cuore e non sente nulla delle cose soprannaturali, un uomo infine, come il capitano, del quale adesso parleremo: sottoponetelo all’azione del dono di sapienza, e voi vedrete un miracolo. – Durante la traversata che gli conduceva alfa loro missione, alcuni dei nostri missionari impiegavano i loro ozi a catechizzare i giovani marinai del bastimento, all’oggetto di prepararli alla prima comunione. Per essi la Messa era detta ogni domenica; ma il capitano non si era dato premura di assistervi. Giammai un segno né una parola che annunziasse, se egli era cattolico. Tutt’ad un tratto, in conseguenza di una buona lettura, ei lasciò sfuggire poche parole che rivelavano i combattimenti della sua anima. Lo spirito di sapienza veniva a toccarlo. « Iddio ci ispira di cominciare una novena per ottenere la sua conversione; e questa terminava il 3 giugno. Ebbene! il giorno stesso a ore nove di sera, nel momento in cui uno dei missionari passeggiava sul ponte, il capitano l’osserva, e con voce commossa gli dice: — Signore, ho un gran favore da chiedervi. — Eccomi pronto per voi, risponde il missionario. — Io voglio confessarmi, non questa sera, perché un giorno non mi basta per prepararmi, ma non più tardi di domani. – Poi la conversazione s’impegna e si prolunga fino a notte inoltrata. L’indomani il capitano assiste alla Messa, benchè non fosse domenica. L’equipaggio tutto rimase stupito. Noi avevamo fissato la prima comunione alla festa della SS, Trinità. Ma il capitano avendo manifestato il desiderio di comunicarsi, se era possibile, coi suoi marinari, e volendo avere più tempo per prepararsi a questo atto cosi augusto, ci arrendemmo di buon cuore a’ suoi desideri. Frattanto la vita del capitano diveniva quella d’un apostolo. Egli predicava con la voce delTesempio. Una sera essendo uscito da confes sarsi, avvicina uno dei missionari e gli parla del buon Dio in un modo così commovente, che il nostro caro confratello era rapito nel sentirlo. Finalmente entrarono a discorrere delle possessioni del demonio. — Credete voi, dice il capitano, che esistano tuttora di questa sorta di possessioni? “Senza dubbio; esse sono abbastanza frequenti nei paesi infedeli”. — Infatti, riprese il capitano, mi è accaduto di fargli un brutto scherzo, tanto egli deve digrignare i denti ili fondo all’inferno. – Dicendo queste parole, gli scappò dai suoi occhi una grossa lacrima, che andò ad inumidire i suoi mustacchi. – « Finalmente giunse il 19 giugno. Quel giorno fu senza alcun dubbio uno dei più belli della nostra vita. – Vi fu comunione generale. Il ponte della nave era diventato una chiesa. Semplici tende artisticamente tese, formavano il tetto e le mura; l’interno era addobbato di bandiere; stuoie chinesi ricoprivano il pavimento; immagini, quadri ornavano l’altare improvvisato; la nostra chiesa ondeggiante era, se non magnifica, almeno passabilmente bella: ma incomparabilmente più bello era lo spettacolo che presentava l’equipaggio. Marinai, ufficiali, capitano, tutti erano là coi loro abiti da festa, in atteggiamento rispettoso. La dolce gioia del cielo raggiava su tutti i volti. « Quando tutto fu finito, venne il capitano a gettarsi al collo del suo confessore dicendo : — Gli istanti più beati della vita sono sempre misti a qualche amarezza; ma per oggi il cuore è contento del tutto. — Voi avreste pianto di gioia sentendo i nostri marinai fare parimente le loro riflessioni. — Vedete, diceva uno dei più vecchi, se io facessi ora in .questo momento naufragio, il morire mi parrebbe lo stesso che mangiare un pezzo di pane. — Terminata che fu la cerimonia con una perfetta calma, la brezza cominciò a soffiare, e la nave a solcare rapidamente le onde. — È forse sorprendente, esclamò il timoniere, questo andare cosi presto? … è perché la nave è scarica di un immenso peso. Io, aveva più peccati del peso che ha il bastimento, ed ora tutto ciò è passato attraverso le cannoniere. » [Annali, ecc., n. 105, p. 102 e seg.]. – Di un cristiano indifferente ed incredulo fare un devoto neofita, un apostolo ardente, inondare di splendori e di delizie un cuore chiuso a tutti gli impulsi della grazia, e ciò in un istante, ecco senza dubbio un miracolo del dono di sapienza. Di un antropofago fare un uomo, di quest’uomo un figlio d’Àbramo, rinnovando il suo essere da cima a fondo, sino al punto di fargli detestare tutto ciò che amava, amare tutto quello che detestava, e questo con una invincibile costanza, è un altro miracolo uguale, se non superiore al primo. – « Nel loro amore per la loro giovine fede i nostri neofiti di Mangarèva cantano dappertutto sopra un ritmo assai grazioso, i severi dogmi del cristianesimo, come anticamente i Rapsodi cantavano le finzioni d’Omero, e i pescatori italiani i versi del Tasso. Ogni anno, quando sono vicini alla festa del Redentore, gli abitanti di ciascuna delle isole compongono al loro modo una specie di racconto espositivo dei luoghi del Vangelo che gli hanno colpiti. Tutti, tanto uomini che donne, contribuiscono alla redazione di questa compilazione letteraria, secondo il loro grado d’intelligenza o di memoria. Compiuto questo lavoro, l’isola intera l’impara a mente, per mezzo di ripetizioni in comune, cantandolo sopra un’aria inventata espressamente. Poi, venuto il dì solenne, tutti gli abitanti dell’arcipelago si riuniscono a Mangarèva, e cantano il loro peï all’ombra degli alberi e sotto la presidenza degli anziani di ciascun’isola. – Tutti gli abitanti cosi raccolti proclamano l’idea che ha riportata la vittoria. Questi sono i giochi floreali di Mangarèva. « Questo popolo che adesso, per l’innocenza dei suoi costumi, forma l’ammirazione di tutti gli ufficiali di marina, è però quello stesso che, prima dell’arrivo dei missionari, accoglieva ostilmente le navi che venivano a visitarlo. – Gli abitanti erano in guerra continua e si scannavano tra di loro. Essi erano antropofagi sino al punto, che una volta, dopo una lotta sanguinosa tra ambe le parti, essendo stata alzata un’enorme massa di cadaveri, i vincitori, in luogo di sotterrare quelle vittime gli divorarono in un gran banchétto che durò otto giorni. Parecchi vecchi attestano altresì questo fatto, e mostrano il luogo dove erano ammassati i cadaveri. – « Non sono ancora tre anni che viveva una donna che aveva mangiato due suoi mariti, morti uno dietro l’altro, in tempo di carestia. I loro costumi erano dissoluti, come quelli di tutti gli Oceanici. Essi erano ladri, sino al punto d’involarsi a vicenda le loro raccolte di datteri, e che essi tentavano di portar via sino sulle navi che erano ancorate alle loro spiaggie. Oggi i loro costumi sono diventati altrettanto puri quanto quelli del villaggio di Francia il più religioso. Il furto cosi radicato nel cuore di ciascuno oceanico, è completamente estirpato di mezzo ad essi. Parecchi capitani di navi mercantili hanno voluto farne la prova. Percorrendo un’isola lasciavano cadere, come per svista, delle pezzuole di seta e dei colletti. Sempre gli oggetti erano fedelmente riportati dal primo abitante che gli incontrava.1 » 1 Annali, ecc., n. 143, p. 298 ecc.]. – Ecco come questo popolo è stato trasformato dal dono di sapienza. [Intorno ai rapporti dei doni con le beatitudini, vedi S. Aug., De serm. Dom. in monte, lib. I, n. 8-14 opp. t. III, p. 1498, ecc., ediz. Novissima]. –

Se lo Spirito del bene ha la sua scala di deificazione, la grande scimmia di Dio, Satana, ha altresì la scala di degradazione. Noi conosciamo la prima; importa conoscere la seconda. Come in pittura l’ombra é necessaria per far risaltare i colori, così nell’ordine morale, l’errore e il male servono a porre in rilievo il vero e il bene. – In quella stessa guisa che egli ha i suoi doni, ha eziandio le sue beatitudini. Entrando esso in un uomo, mediante il peccato mortale, gli comunica i primi; e il disgraziato pratica gli atti pretesi beatifici che ne derivano. Il primo dono di Satana è l’orgoglio, principio di ogni peccato, come l’umiltà è il principio di ogni virtù. – L’ultima parola dell’orgoglio, è Amanno, appeso a una ghigliottina di cinquanta cubiti; Nabuccodonosor, mutato in bestia. Rendersi odioso a Dio e agli uomini, questo è il termine a cui fa capo la prima beatitudine satanica. – Il secondo dono di Satana é l’avarizia. Il suo capo d’opera, è il ricco malvagio che muore e che è sepolto nell’inferno; è Giuda che vende il suo maestro e che s’impicca. Fare dell’uomo il più insensato e il più scellerato degli uomini è l’ultima parola della seconda beatitudine satanica. Il più scellerato: « Non vi è uomo più scellerato dell’avaro, dice lo Spirito Santo; per esso ogni cosa è da vendere anche l’anima propria.» [Eccl. X, 10]. – Il più insensato; la vita che gli era data per guadagnare il cielo, ei la consuma a fabbricare delle tele di ragno, fragili tessuti che non possono nemmeno servire di lenzuolo. [Is. LIX, 5, 8]. – Il terzo dono di Satana, è la lussuria; messa in azione, va a finire attraverso mille lordure con Salomone e con Sardanapalo, affogati nella cloaca dei loro bestiali costumi. Ignominia di tutto quanto l’uomo, accecamento dello spirito, insensibilità del cuore, morte nell’impenitenza: tale è nei suoi effetti generali la terza beatitudine satanica. – Il quarto dono di Satana, è la gola. L’epicureo coronato di rose che canta il vino e il piacere per prepararsi alla morte; Baldassarre che riempie Babilonia del frastuono dei suoi festini, mentre i Medi sono alle porte della città, sono la traduzione vivente della quarta beatitudine satanica. – Il quinto dono di Satana, è l’invidia. Vogliamo noi vederlo in azione? Caino che uccide suo fratello, ed i farisei che fanno morire il Figlio di Dio: ecco il termine glorioso della quinta beatitudine satanica. – Il sesto dono satanico, è l’ira. La iena con i crini irti, la leonessa alla quale vengon portati via i suoi leoncini, l’ istrice armato delle sue trecce, deboli tipi ai quali l’uomo diviene simile, praticando la sesta beatitudine satanica. – Il settimo dono di Satana, è la pigrizia. Il Chinese di cui parlano i nostri missionari, e per il quale il mondo soprannaturale è come se non fosse, indifferente a tutto, eccetto a quattro verità: bere molto, mangiar bene, digerire e dormir bene; esso non darebbe .una sapequa per conoscere un domma di più, e che tiene per suprema sapienza la sua indifferènza stupida in materia di religione. [“Impius, cum in profundum peccatorum venerit, contemnit”. Prov., XVIII, 8]. – Tale é la personificazione della settima beatitudine satanica. – Così lo Spirito del male viene a prender l’uomo beatificato a suo modo, di mezzo a questo marasma vergognoso e colpevole; in cui a poco a poco lo ha condotto, per trasportarlo nel soggiorno della sua beatitudine eterna.