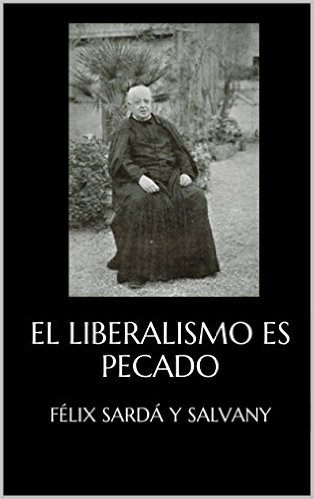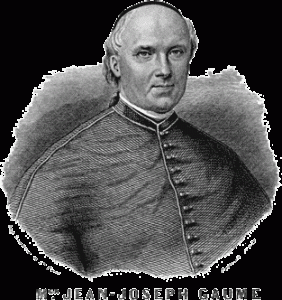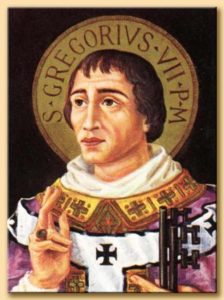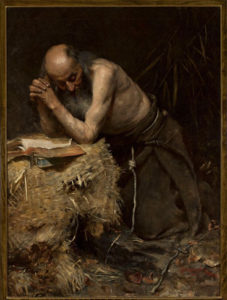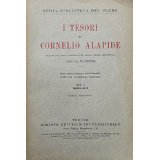
1.-Vi è un doppio amore. — 2. Necessità d’amare Dio. — 3. Motivi d’amare Dio ricavati da Lui medesimo, ossia dalle infinite sue perfezioni. — 4. Motivi d’amare Dio, ricavati dall’amor suo verso gli uomini. — 5. Amore infinito di Dio nella creazione e nel modo di comunicarsi all’uomo. — 6. Come il Padre ci ha dato prova del suo amore nell’Incarnazione e nella Redenzione di Gesù Cristo. 7. Quanto ci ha amati il Figlio facendosi uomo e morendo per noi. — 8. Eccellenza dell’amor di Dio — 9. L’amore ci fa imitatori di Dio. — 10. L’amore ci unisce a Dio, e ci fa vivere di Gesù Cristo e per Gesù Cristo. — 11. Amare Dio è un amare se stesso. — 12. L’amor di Dio unisce gli uomini tra di loro. — 13. L’amor di Dio rende invincibile. 14. L’amor di Dio scaccia i Demoni. — 15. L’amor di Dio distrugge il peccato. — 16. L’amor di Dio ci fa disprezzare tutto il resto. — 17. L’amor di Dio scaccia la tiepidezza. — 18. L’amor di Dio illumina. — 19. A chi ama Dio ogni cosa si volge in bene. — 20. Dolcezza e felicità d’amare Dio. — 21. A chi ama, tutto è facile e leggero. — 22. L’amor divino racchiude tutti i beni. — 23. Per amare Dio bisogna osservare la sua legge. — 24. Diversi gradi dell’amor divino. — 25. Qualità dell’amor divino. — 26. Rammarico di non aver amato Dio. — 27. Quanto sia disgraziato chi non ama Dio. — 28. Come bisogna amare Dio. — 29. Mezzi di amare Dio.
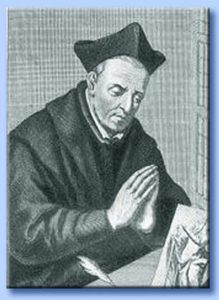
1. Vi è un doppio amore. — L’amore dell’uomo verso Dio è di due specie: cioè l’amore di concupiscenza, o imperfetto; e l’amore di pura carità, ossia perfetto. Con l’amore di concupiscenza noi studiamo di piacere a Dio, affinchè ci dia per ricompensa la vita eterna; questo amore è buono, ma piuttosto che un atto di carità si deve chiamare un atto di speranza. L’amore perfetto poi, col quale noi ci adoperiamo di piacere a Dio e fare quello che gli è gradito, consiste nell’amarlo esclusivamente per se stesso, senz’avere di mira la ricompensa; questo amore è propriamente quello che si chiama carità perfetta.
2. Necessità d’amare Dio. — « Tu amerai il tuo Signore Iddio con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima, con tutte le facoltà tue » (Beuter. VI, 5). Questo precetto dava Dio agli Ebrei, e perché fossero ben persuasi dell’alta sua importanza, soggiungeva che scolpissero queste parole dentro il proprio cuore, e le meditassero in casa ed in viaggio, la notte e il giorno, le ripetessero e insegnassero ai figli, le legassero come un ricordo ai polsi e le tenessero scritte innanzi gli occhi; e le scrivessero su le porte della casa (Ib. 7-9). Quest’obbligo ripeteva e inculcava Gesù Cristo nella nuova legge, riportando le medesime parole dell’antica, e avvertiva essere questo il primo ed il più eccellente dei comandamenti (Matth. XXII, 27-28). « Ama, aveva detto anche l’Ecclesiastico, a tutto tuo potere Colui che ti ha creato » (Eccli. VII, 32); ed in altro luogo: « Ama Dio per tutta la tua vita, ed invocalo per la tua salute » (Ib. XIII, 18). Il motivo che ci deve spingere ad amare Dio, è che Dio forma l’anima e la vita dell’anima nostra. Ora non è giusto che l’anima renda a Dio quel che il corpo rende all’anima, e che noi facciamo tutto per amor di Dio? Niente più teme il corpo che d’essere separato dall’anima, niente più deve temere l’anima, che d’essere separata da Dio: quindi l’Apostolo S. Giuda ci fa un obbligo di conservarci nell’amor di Dio (Iud. 21). Il cavallo è nato per correre, ed è questo il suo fine, come il fine dell’uccello è il volare, quel del bue l’arare, quel del cane l’abbaiare, quel del fuoco lo scaldare, quel dell’acqua il dissetare…; l’uomo è nato per amare Dio: questo è il suo ultimo fine. « Quand’io parlassi le lingue degli uomini e degli Angeli scriveva S. Paolo a’ Corinzi, se non ho la carità, sono come un bronzo sonante o un cembalo squillante. E quando avessi la profezia e intendessi tutti i misteri, e tutto lo scibile; e avessi tutta la fede, talmente che trasportassi le montagne, se non ho la carità, sono un niente. E se pure distribuissi in nutrimento ai poveri tutte le mie facoltà, e quando sacrificassi il mio corpo ad essere bruciato, se non ho la carità, nulla mi giova » (1 Cor. XIII, 1-3). Il medesimo Apostolo dice ancora : « La carità di Cristo ci spinge » (II Cor. V, 14). « Gesù Cristo è morto per tutti, affinché quelli che vivono, non vivano più per se stessi, ma per Colui che è morto e risuscitato per loro » (Ib. V, 15). L’amor di Dio è così grande cosa, dice S. Agostino, che a colui che ne è privo, niente giova possedere tutto il resto; e chi ne è fornito, non difetta di nulla. E aggiunge in altro luogo: «Può la fede trovarsi senza la carità, ma non può, senza la carità, essere nè fruttuosa, nè utile ». Udite anche S. Bernardo: « La castità senza la carità è una lampada senz’olio; togliete l’olio e la lucerna, non fa lume; togliete l’amor di Dio e la castità perde il suo pregio ».
« Lo scopo de’ comandamenti è la carità, », dice S. Paolo a Timoteo (I Tim. 1, 5) : e nel precetto dell’amor di Dio tutto si riassume, secondo la parola di Gesù Cristo, la legge e la profezia (Matth. XXII, 40). « O anima mia, esclama S. Agostino, creata a imagine di Dio, riscattata col sangue di Gesù Cristo, sposa della fede, dotata dallo Spirito, ornata di virtù, fatta pari agli Angeli, ama Colui che tanto ti ha amato; pensa a Colui che di te non mai si dimentica; cerca Colui che ti cerca; dònati tutta quanta a Colui che si dona a te tutto intero. Questo gran Dio non si occupa che di te, e tu non occuparti di altri che di Lui; Egli lascia in certo modo ogni cosa per te, e tu ogni altro affare lascia per Lui; Egli è la santità per essenza, e tu sii santa; Egli, è la purità in persona, e tu sii pura… Deh! che il cielo, la terra e tutto quanto in essi è contenuto non cessano un istante dal gridarmi, che ami Voi, mio Dio; e quello che dicono a me, lo predicano senza posa a tutti, affinchè essi siano inescusabili se non V’amano ».
3. Motivi d’amare Dio ricavati da Lui medesimo, ossia dalle infinite sue perfezioni. — Bisogna amare Dio, anzitutto perché Egli è sommamente amabile. Dio è tutto amore, dice S. Giovanni (I Episl. IV, 8); Dio è una fornace ardente che tutto infiamma, predica San Paolo (Hebr. XII, 29); « Che cosa è Dio? soggiunge S. Bernardo; Dio è la volontà onnipotente, la virtù amorosissima, il lume eterno, l’immutabile ragione, la suprema beatitudine ». Dio è l’eternità, la misura, l’ordine, la causa, il fine di tutte le cose. Egli è il principio e il termine di tutte le creature: è il sommo, l’immenso, l’increato bene… Ah! sì! esclama S. Agostino, è povertà e indigenza ogni abbondanza e ogni ricchezza, che non sia il mio Dio. Infinito nella sua essenza, Dio è pur tale nei suoi divini attributi, ed in ciascheduno di essi. Dio ha una santità infinita, una potenza infinita, una sapienza infinita, una misericordia infinita, una scienza infinita, una bontà infinita, e così via di ogni altro attributo. Dio sorpassa all’infinito non solo tutto ciò che esiste, con tutte le sue perfezioni e qualità, ma ancora tutte le cose possibili ed immaginarie; e le sorpassa non di cento, non di mille, non di milioni, di gradi, ma infinitamente al disopra di ogni calcolo. Contemplate finché potete la sapienza, la potenza, la bontà, la bellezza, la ricchezza, ecc…, e spingete coll’immaginazione queste perfezioni all’infinito; quando sarete arrivati a quel punto, sappiate che tutti i vostri pensieri e i vostri calcoli, nè solo i vostri, ma tutti i pensieri e i calcoli di tutti gli uomini e di tutti gli Angeli, non si sono avvicinati e’un passo all’infinità delle perfezioni di Dio: sappiate che tutt’altro che aver raggiunto l’essere divino, voi ve ne trovate tuttavia ad una distanza infinita. Si tacciano, esclama Isaia, tutti gli spiriti, ammutoliscano le lingue e le voci tutte, si velino per riverenza e s’annientino i Cherubini. e i Serafini… perché tutti gli Angeli insieme riuniti, con tutte le loro fiamme d’amore, non sono capaci né d’intendere, né tanto meno di penetrare il più basso grado della vostra gloria, o mio Dio… Esclamiamo anche noi col Salmista: « Grande è il Signore e al di sopra d’ogni lode; la sua grandezza non conosce confini » (Psalm. CXL1V, 3). E col Profeta Baruch: « Dio è grande, eterno, elevato, infinito » (Baruch III, 25).
4. Motivi: d’amare Dio, ricavati dall’amor suo verso gli uomini. — Bisogna in secondo luogo amare Dio perché Egli ci ha sommamente amati, come già aveva detto il Signore per bocca di Geremia: « Io v’ho amati d’un amore eterno, perciò vi ho a me attirati nella mia misericordia » (Ier. XXXI, 3); e ci ripete S. Giovanni: «Amiamo dunque Iddio, perché Egli ci ha amati per il primo » (I Ioann. IV, 13). Nell’amore infinito che Dio porta all’uomo, noi dobbiamo ammirare : 1° l’amore ch’Egli nutrì per noi da tutta l’eternità, senza che avesse bisogno di noi, perché possiede in se stesso tutte le cose; 2° considerare che non ci ama per qualche necessità, ma affatto liberamente e liberalmente; 3° che Egli ci ama senza utilità veruna a suo riguardo; 4° che Egli ama l’uomo prima che questo abbia la ragione, o qualche merito e dignità che possa cattivarne l’amore; anzi lo ama quando lo vede carico di molti e gravi demeriti per i quali si meriterebbe non amore, ma odio; 5° ch’Egli ha amato anche coloro i quali previde che sarebbero divenuti a Lui ingrati e nemici; 6° questo amore di Dio verso gli uomini non proviene dall’- Ma qual saviezza vi può essere in Dio, ripiglierete voi, nell’amare gli uomini miserabili e peccatori? non è questo per certo un oggetto amabile in se stesso. Ma in Dio, la ragione di amare non proviene, come negli uomini, dall’amabilità dell’oggetto, ma da Dio medesimo. E in vero Dio ci ama per sé, perché è infinitamente buono; perciò vuole spandere sopra di noi la sua liberalità e i suoi benefizi, non ostante l’indegnità nostra. La bontà infinita di Dio è dunque la base e la ragione del suo amore per gli uomini, della comunicazione de’ suoi doni e di se stesso. In Dio vi è una volontà infinita e un desiderio immenso di comunicarsi, i quali nascono dalla perfezione e dalla pienezza infinita della sua essenza, e questa è tale che lo porta a donarsi, e per grandi che siano le sue larghezze, Dio non perde nulla della sua pienezza. Egli è come una sorgente da cui sgorgasse del continuo tant’acqua, quanta se ne attingesse… Dio è per le cose spirituali quello che è il sole per le corporali, dice S. Gregorio Nazianzeno. Come il sole irradia i suoi raggi benefici per ogni parte, per illuminare, scaldare, vivificare, fecondare la natura; così Dio spande sopra tutte le creature, ma specialmente su gli Angeli e su gli uomini, i raggi divini della sua beneficenza, per illuminarli col lume della sua sapienza, scaldarli col fuoco del suo amore, vivificarli con la vita della grazia e della gloria (Distich.), Questa larghezza di benefizi da parte di Dio è immensa e ci apparisce meravigliosa se consideriamo: 1° la maestà di Colui che ama, di Colui che dona; 2° la condizione di coloro ai quali Egli dona, perché se ne osservate la natura, sono uomini e tengono l’ultimo grado tra le intelligenze; se ne considerate le qualità dell’anima, essi sono peccatori, nemici di Dio, orgogliosi, ingrati, carnali, fiacchi nel bene, ardenti nel male; se ne guardate il corpo, sono mortali, acciaccosi, vili, ributtanti e destinati a pasto dei vermi.
5. Amore infinito di Dio nella creazione e nel modo di comunicarsi all’uomo. — Dio poteva lasciarci nel nulla… Creandoci, poteva lasciarci allo stato de’ minerali, de’ vegetali o de’ bruti… Eppure no; ma ci ha creati ragionevoli, fatti a sua immagine, capaci di conoscerlo, di servirlo, d’amarlo… Ci ha creati immortali e destinati all’immortalità beata… Egli si compiace e si diletta di conversare tra gli uomini (Prov. Vili, 31) : 1° perchè si prende specialissima cura di tutti e di ciascuno, vedendo in essi la sua viva immagine e il suggello della divinità; per loro ha creato il mondo e quanto il mondo contiene; 2° perché non ad altri fa parte della sua sapienza se non all’- E notate, prima di tutto, che Dio si comunica agli uomini noni come a servi, a schiavi; ma come a figli chiamati suoi eredi e coeredi di Gesù Cristo. In secondo luogo la sua bontà ha trovato il mezzo di discendere fino al debole, di guarire l’infermo, di raccogliere il derelitto, d’innalzare colui ch’era piccolo, di arricchire abbondantemente il mendico, e di soccorrerci tutti. Dio ha dimostrato d’essere la bontà e l’amore per essenza, scrive S. Bernardo, creando gli spiriti, perché godessero di Lui; dando la vita, per far sentire e comprendere il suo amore; attraendoci, affinché Lo desideriamo; dilatando l’uomo, perché alberghi Dio; giustificandolo, perché meriti la grazia e la gloria; infiammandolo, per portarlo allo zelo; fecondandolo, acciocché produca frutti di vita; dirigendolo verso la giustizia; informandolo alla beneficenza; moderandolo, affinché divenga saggio; fortificandolo, affinché acquisti la virtù; vivificandolo, per consolarlo; illuminan-dolo, perché vegga; conservandolo, per l’immortalità; riempiendolo, per bearlo di felicità; circondandolo, perché abiti in sicurezza (Serm. in Cantic.). In terzo luogo Dio ci si comunica moltissime volte prima che noi pensiamo a Lui, Lo desideriamo, Lo cerchiamo. Così fa in tutte le grazie prevenienti, per eccitarci a sollecitare le grazie conseguenti le quali sono poi anche esse, come osserva S. Ambrogio, sempre più abbondanti di quello che noi abbiamo domandato. Oh sì, quante volte non vi è accaduto di aver chiesto a Dio una grazia speciale, ed Egli ve l’abbia concessa, ma accompagnata da tante altre da voi punto domandate? Il re Ezechia implora soltanto la sanità; Dio gliela concede e vi aggiunge quindici anni di vita, una vittoria miracolosa e la strage di cento ottantacinque mila Assiri (Isai. XXXVIII). Salomone chiede la sapienza; l’ottiene, ed ha per di più ricchezze immense e sfolgorante gloria (III Reg. III). Daniele supplica per la liberazione del popolo schiavo in Babilonia; Dio l’esaudisce e gli fa inoltre la promessa della venuta del Messia, che deve riscattare il mondo intero dalla schiavitù del Demonio (Dan. IX, 14). Davide domanda un figlio e questo figlio è il Messia (lI Reg. VII, 12).
6. Come il Padre ci ha dato prova del suo amore nell’Incarnazione e nella Redenzione di Gesù Cristo. — « Dio ha talmente amato il mondo, dice S. Giovanni, che ha dato il Figliuol suo Unigenito — (Ioann. IlI, 16). Talmente, cioè ha amato il mondo d’un amore così grande, così eccessivo che non esitò a dargli l’Unigenito Figliuol suo. Non è un re, né un Angelo quegli che tanto ci ha amati il primo e gratuitamente, senza che noi, non solo non abbiamo meritato, ma neppure desiderato così gran dono. Egli ha amato il mondo, suo capitale nemico, il mondo degno dell’eterna riprovazione, e l’ha amato al punto di dargli non uno straniero, non un figlio qualunque adottivo, ma il suo proprio Figlio: e Figlio non scelto fra molti, ma Unigenito. Gliel’ha dato non a prezzo d’oro o d’argento, ma gratuitamente : non gliel’ha dato perché salisse un trono o menasse trionfi, ma perché fosse condannato a morte e crocifisso. Così ha fatto non per proprio vantaggio o per utile del Figliuol suo, ma affinché la morte di quest’unico Figlio renda a noi la vita e ci sollevi a misura delle umiliazioni patite da Gesù Cristo, e dell’annientamento a cui soggiacque, per colmarci di ricchezze, di beni immensi e finalmente d’una gloria eterna. « No, soggiunge ancora l’evangelista S. Giovanni, Dio non ha inviato quaggiù il Figliuol suo, affinché condanni il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo dell’Unigenito di Dio » (Ioann. IlI, 17). Ah! esclama il grande Apostolo in uno slancio d’amore e di riconoscenza, se Dio Padre non ha risparmiato il suo proprio Figlio, e l’ha consegnato alla morte per noi, che cosa non possiamo aspettarci da Lui dopo un tanto dono? (Rom. Vili, 32). Sì, ripiglia l’Apostolo prediletto, « in questo si vide manifesta la grande carità di Dio verso di noi, che ha mandato l’Unigenito suo nel mondo, affinché noi viviamo per Lui » (I Ioann. IV, 9).
7. Quanto ci ha amati il Figlio facendosi uomo e morendo per noi. — Qui si trova la lunghezza, la larghezza, l’altezza, la profondità dell’amor divino; qui dobbiamo esclamare con S. Paolo: — O altitudo! — O mistero impenetrabile del più sublime e del più grande amore! Un Dio si fa uomo (Ioann. I, 14); muore su la croce; ed è il suo amore che lo spinge ad incarnarsi e a morire. O amore!… Dio ci ha amati da tutta l’eternità, ma per questo non gli bisognò che un pensiero; ci ha amati nella creazione, ma gli bastò una parola; nella Redenzione ci ha amati fino a morire per noi. Calcolate la potenza e l’immensità del suo amore dalla sua Incarnazione, dalla vita sua di patimenti e di dolori, dalla sua morte. Il Figlio di Dio ci ha amati del più tenero, del più efficace amore, che non si dimostrò in parole, ma in fatti. Spinto da quest’amore Egli ha volontariamente e liberamente donato non ricchezze terrene a fratelli od amici suoi, ma ha donato se stesso a noi peccatori suoi nemici, per pagare i nostri debiti, espiare i nostri misfatti, distruggere la morte e darci la vita. « La grazia di Nostro Signore ha sovrabbondato », dice S. Paolo (I Tim. I, 14). Ah! diciamo anche noi con Zaccaria: «Benedetto sia il Signore Iddio d’Israele, perché ci ha visitati ed effettuato la liberazione del suo popolo. Ha inalberato lo stendardo della salute, ci ritolse ai nostri nemici, e dalle mani ci strappò di coloro che ci odiavano. Dio, spinto dalla sua misericordia è disceso dall’alto e ci ha visitati » (Luc. I, 67-78).
Gli effetti dell’amor divino a nostro riguardo, amore perfetto ed evidente, sono la sua Incarnazione nel seno d’una Vergine, le sue predicazioni, i suoi viaggi, i suoi travagli, le sue umiliazioni, i suoi miracoli, la sua passione, la sua morte, i suoi Sacramenti, la discesa dello Spirito Santo, la cura tutta speciale Ch’Egli si prende della Chiesa e di ciascun fedele. Sapete, dice Teodoreto, dove sta il più eccelso, il sommo grado della bontà divina, dell’ineffabile misericordia, della immensa clemenza, dell’inenarrabile carità dell’autore e consumatore d’ogni bene? Sta in ciò, che il Creatore e Signore di tutte le cose, il Principe sovrano, il Dio forte, l’Essere immutabile abbia liberato dalla morte e dalla schiavitù del Diavolo quell’atomo, quell’essere soggetto alla morte, corruttibile, ingrato, inutile, che si chiama l’uomo; che gli abbia dato tal libertà, per cui fu assolutamente e completamente affrancato e se lo adottò in figlio; che sia infine divenuto l’amico degli uomini, loro pane, loro vino, loro vita, loro porta, loro via, loro luce, loro risurrezione (In Evang.).
Oh! ben possiamo dire con la Sposa de’ Cantici: «Voce del mio Diletto: ecco ch’Egli viene saltellando pei monti, valicando i colli. Ecco che il mio Diletto mi parla: Sorgi: affrèttati, o mia Diletta, colomba mia, bella mia, e vieni: — Il Diletto mio che si pasce fra i gigli, è tutto a me ed io tutta a Lui » (Cantic. II, 8, 10, 16). – Più si considera l’amore infinito di Gesù Cristo, e più si trasecola per lo stupore. L’oggetto, il motivo dell’amore è il bene, e gli uomini s’inducono ad amare gli uomini perché sono belli, savi, ricchi, delicati, nobili, e veramente buoni. Ora che avete voi, o Salvatore divino, trovato di buono o di bello in noi che abbia potuto guadagnare il vostro amore? Noi poveri, abbietti, mendichi, stolti, miserabili, corrotti, ributtanti? Ah! io ho amato, mi pare di udirvi rispondere, la tua laidezza, per assorbirla e renderla bellezza; ho amato de’ nemici, per farmene degli amici; degli stolti per farne de’ saggi; de’ miseri, per nobilitarli; degli accattoni, per arricchirli; degli infelici, per renderli beati e gloriosi. La grandezza dell’amore dì Gesù Cristo, che vince ogni amore creato, si deduce specialmente da questo, che non si volge su un oggetto amabile, ma lo rende amabile amandolo. Egli ama, per comunicare le sue grazie ai miserabili, chiamarli a parte del suo amore, farne suoi amici, e più ancora che amici, figli ed eredi. Il Verbo eterno, che è la Sapienza del Padre, ha voluto farsi uomo per salvare l’uomo, e insegnargli a parole ed a fatti la vera sapienza: desiderando egli ardentemente di possederci, s’è incarnato, per riposare nelle nostre anime, per dimorarvi come nel suo tempio e tabernacolo; per innestarvi e farvi germogliare le sue virtù, i suoi meriti, il frutto de’ suoi preziosi lavori, acciocché imitandolo meritiamo di vederlo e possederlo. La grandezza dell’amore di Gesù Cristo ha cangiato in miele tutto il fiele delle miserie umane, in delizie tutti i dolori e le croci. Egli s’è addossato tutte le nostre miserie, eccetto il peccato, per colmarci di tutti i suoi beni. L’amore di Gesù Cristo, il quale ha trovato le sue delizie nel dimorare con noi, ha operato questo prodigio di convertire in nostra felicità la fame, la sete, il lavoro, il patimento, il dolore, la morte, e le sofferenze tutte. Studiate i Martiri e ne avrete le prove… Se voi osservate, dice S. Bernardo, venite a conoscere come Gesù Cristo, la gioia per essenza, si rattrista e si conturba; che Egli, nostra salute, soffre; che Egli, forza suprema, è debole; che Egli, nostra vita, muore. E, cosa non meno prodigiosa, la sua tristezza produce la gioia; il suo timore, la forza; la sua passione, la salute; la sua debolezza, il coraggio; la sua morte, la vita. Perciò Gesù Cristo s’è volenteroso e lieto sottoposto alle nostre sciagure, perché la sua felicità divenisse nostra delizia (Serm, in Epiph.). – « Gesù Cristo, soggiunge il Crisologo, è venuto a provare le nostre infermità, per armarci della sua forza; a vestire l’umanità, per parteciparci la divinità; a ricevere gli oltraggi, per renderci degni degli onori; a sopportar le noie, per meritare a noi la pazienza; perché il medico che non compatisce le infermità, non sa guarirle, e chi non sa, essere infermo coll’infermo, non può guarirlo. « O dolcezza, o grazia, o forza dell’amore di Gesù Cristo! esclama San Bernardo; il più grande di tutti gli esseri s’è fatto il più piccolo, l’ultimo di tutti. Chi ha operato meraviglie tali? l’amore di Gesù Cristo, amore non curante della dignità, pieno di misericordia, potente in affezione, efficace in persuasione. Vi è forse qualche cosa di più forte dell’amore, il quale trionfa di Dio medesimo? L’amore trionfa di Dio, per trionfare di noi e sforzarci a ripagare amore con amore, a consacrarci tutti interi all’amore di Cristo, come Gesù Cristo s’è dato tutto quanto al nostro amore ». Per quali ragioni mai Gesù Cristo ama meglio dimorare con gli uomini piuttosto che con gli Angeli? Eccovene due: 1° Egli ha vestito non l’angelica, ma l’umana natura. 2° Siccome la virtù è cosa più ardua e penosa agli uomini, a cagione della loro natura degradata, Esso li fortifica con le sue consolazioni e grazie, li sostiene affinché la pratica della virtù torni loro facile e gradita. Così Egli ha cangiato per S. Pietro e S. Andrea la croce in delizia; S. Lorenzo trovò la sua felicità su la graticola ardente; le frecce portarono refrigerio e dolcezza a S. Sebastiano; tutti i generi di tormenti furono dilettevoli per S. Vincenzo e le stigmate care a S. Francesco d’Assisi, ecc. Qual gioia non ha provato Gesù Cristo ne’ suoi più grandi Santi, in un San Paolo, per es., in un S. Antonio, in una S. Agnese, o Cecilia, o Agata, o Caterina da Siena, o in tanti altri Vergini e Martiri! L’amore di Gesù Cristo per gli uomini l’inebria. E non è forse ebbro d’amore, quando discende dal Cielo nel seno d’una Vergine; quando dal seno di Maria passa a riposare in una greppia, e da questa ascende al Calvario? Non è forse un amore spinto fino all’ebbrezza, quello che gli fa percorrere i borghi ed i villaggi, le città e le capanne per predicare il regno di Dio; soffrire la fame, la sete, il freddo, il caldo, gli insulti, le maledizioni, le derisioni, e le bestemmie per la salvezza degli uomini? E su la croce, non è forse più l’amore che non il dolore quello che lo tormenta? Egli consente di essere creduto un infame, si lascia insultare, spogliare, coprire di piaghe e di sangue, appendere al supplizio de’ ladri come un furfante; incontra finalmente la morte de’ scellerati! Che cosa si può trovare di più forte? L’amore trionfa d’un Dio. Dio è nostro padre, l’umanità di Gesù Cristo è nostra madre; come una madre porta il suo ragazzo nel seno, gli fornisce gli elementi della vita, lo dà alla luce, lo nutrisce, lo leva, lo corica, lo lava, lo diverte, l’istruisce non senza continue e gravi pene, e ne forma un uomo perfetto; così Gesù Cristo, nostra madre, s’è dato, per corso di trentatré anni, a penosi e continui lavori; ha sofferto atroci dolori, principalmente su la croce, e in questa guisa ci ha concepiti, generati alla vita della grazia, allattati, nutriti e allevati. Ecco perché Gesù Cristo nel farsi uomo ha voluto non dover ad altri il suo corpo che ad una madre: perché tutto in Lui fosse viscere materne. Che cosa trovare di più forte? L’amore trionfa di un Dio.
« Avendo Gesù Cristo amato i suoi, dice S. Giovanni, li amò fino alla fine » (Ioann. XIII, 1): e infatti lava loro i piedi, stabilisce il Sacramento eucaristico in cui si dona per nutrimento a’ suoi discepoli prima di morire per essi e per l’universo intero. Contemplate principalmente l’amore di Gesù Cristo su la croce. La croce è la cattedra da cui risuona l’insegnamento della bontà e dell’amore di Gesù Cristo: Ah! voi mi avete amato, ed infinitamente amato, o mio Salvatore; ancorché io vi dessi mille anime e mille vite, che sarebbe mai questo a confronto della vostra vita, ch’è la vita d’un Dio? « Imparate da Gesù ad amare Gesù », esclama S. Bernardino da Siena; « e pensa, soggiunge il Crisostomo, che Egli ti ha dato tutto, nulla per sé riservando »; e San Bernardo dice: « Dònati tutto quanto a Lui, giacché Egli, per salvarti, ha dato tutto quanto se stesso ». « Non ritenete un filo per voi, suggerisce S. Francesco d’Assisi, affinché Gesù Cristo il quale nulla ha riservato per se stesso, vi riceva tutt’interi » (S. Bonaventura, In Vita). Quindi S. Agostino esclamava : « Fate, o Signore, ch’io muoia a me stesso, affinché Voi solo viviate in me ». Ci fu poi tempo in cui questo Dio abbia cessato di amarci? No, mai. « Poveri orfani, Egli disse, state certi ch’io non v’abbandonerò mai, ma verrò a voi » (Ioann. XIV, 18). Non abbandoniamolo dunque mai, neppure noi e diciamo con l’Apostolo: «Chi o che cosa avrà forza da strapparmi dall’amore di Gesù Cristo? Forse le afflizioni, le angosce, la fame, la nudità, i pericoli, le persecuzioni, la spada? Ah no! Né la morte, né la vita, né gli angeli, né i principati, né le potestà, né le cose presenti, né le future, né la violenza, né ciò che v’ha di più alto o di più profondo, né creatura alcuna potrà mai separarmi e farmi rinunziare all’amore di Dio in Gesù Cristo mio Signore » (Rom. VIII, 35-39).
8. Eccellenza dell’amor di Dio. — « Solo l’amore, scrive S. Agostino, fa distinguere i figli di Dio dai figli del Demonio; questo è l’unico segnale al quale si possono riconoscere. Quelli in cui è la carità, son nati da Dio; non viene da Lui chi non lo ama. La carità è la più vera, la più piena e assoluta giustizia ».
Il medesimo S. Agostino chiama l’amor di Dio « la cittadella di tutte le virtù », e con lui fanno a gara a magnificare l’eccellenza della carità gli altri santi Padri. S. Basilio la chiama « radice di tutti i comandamenti ». S. Gregorio Nazianzeno la dice « punto capitale della dottrina cristiana » (Epl. XX), e Tertulliano, « il segreto supremo della fede, il tesoro del nome cristiano » (De patient.). S. Gerolamo la chiama « madre », S. Efrem « colonna di tutte le virtù ». Per S. Prospero la carità è la più potente di tutte le inspirazioni, è invincibile in tutte le cose, è la regola suprema delle buone azioni, la salvaguardia dei costumi, il fine de’ precetti divini, la morte de’ vizi, la vita delle virtù (De vit. Contemp. lib. IlI, c. 13). San Gregorio la proclama «madre e custode di tutti i beni»; S. Bernardo l’esalta come « la madre degli Angeli e degli uomini, la pa-ciera del Cielo e della terra ». Ascoltate ancora il Crisostomo che vi predica: che chi arde di amore per Gesù Cristo, vive come se fosse solo su la terra. Egli non s’inquieta né della gloria, né dell’ignominia. Disprezza le tentazioni, i flagelli, le carceri quasi che soffrisse in un corpo non suo, ma di un altro, o in una carne di diamante. Se la ride de’ piaceri del secolo e non ne prova maggior solletico di quello che ne proverebbe un morto. A quella guisa che le mosche fuggono il fuoco, così le sensazioni della carne e della concupiscenza s’allontanano da chi ha la carità (Hom. LII in Act. Apost). Nell’amor di Dio vi sono tutti i tesori; fuori di quest’amore non vi è nulla. Da lui dipende e in lui consiste la felicità dell’uomo in questo mondo; esso è l’unica via che mette al Cielo: esso fa e farà in eterno la suprema beatitudine degli eletti. « Se voi avete la carità, dice S. Agostino, voi possedete Dio, e quando si possiede Dio, si hanno tutte le ricchezze ». Ed altrove soggiunge che « l’amor di Dio è il colmo della felicità, il sommo grado della gloria e della gioia, che uguaglia tutti i beni » (De Civ. Dei). Desiderate voi, dice S. Anselmo, d’essere re nel Cielo? Amate Dio e voi sarete tutto quello che bramate (Epist.). La carità è la massima tra le virtù; e di quanto l’oro sopravanza gli altri metalli, il sole vince le stelle, i Serafini superano gli Angeli, di tanto la carità è superiore alle altre virtù. Nessuna virtù è là dove non v’è carità, tutte si trovano dove questa si trova; la carità è una regina a cui tutte le altre virtù formano corteo. Essa è l’oro prezioso e purgato col quale si compra il Cielo; è un fuoco celeste che infiamma i cuori; è un sole che rischiara, feconda e vivifica ogni cosa. È una virtù angelica che cangia gli uomini in Serafini. Ne volete di più? Udite. 1° La carità è la guida, la direttrice, la regina delle virtù. 2° È la lor nutrice che le mantiene, le fortifica, le conserva, come scrive S. Lorenzo Giustiniani (Lib. arbitri. vitae). 3° La carità forma d’ognuno di noi altrettanti amici e figli di Dio, suoi eredi, coeredi di Gesù Cristo, templi dello Spirito Santo, 4° È il distintivo tra gli eletti ed i riprovati. 5° È l’anima delle virtù le quali da lei ritraggono il merito loro : ed è perciò che S. Agostino sostiene che solo la carità conduce a Dio (In Psalm.). 6° È il vincolo che intimamente ci lega a Gesù Cristo. « La nostra conformità col Verbo per mezzo della carità, dice S. Bernardo, congiunge a Lui l’anima nostra come sposa a sposo ». 7° È un fuoco inestinguibile che ammollisce il macigno, e squaglia i cuori più duri, perché l’amore sorpassa tutto, trionfando perfino di Dio. La carità comanda all’odio, alla collera, al timore, alla cupidigia, al fascino de’ sensi, ecc. e tutto dirige verso Dio. 8° Come l’aquila fissa la pupilla nel sole, così, afferma S. Agostino, quegli che ha la carità, contempla Dio, e librato su due ali di fuoco, che sono l’amore di Dio e del prossimo, vola alla volta del Signore (De Morib. Manich.). Osservate di grazia quello che la carità opera in S. Paolo: è San Giovanni Crisostomo che ce lo dice. A quel modo che il ferro posto nel fuoco diventa anch’esso fuoco, così Paolo, infiammato d’amore, diventa tutt’amore. Ora colle epistole, ora di viva voce, tal volta con preghiere, tal altra con minacce, qua in persona, là per mezzo dei discepoli, adoperava tutti i mezzi per incoraggiare i fedeli, tener saldi i forti, rialzare i fiacchi e i caduti nel peccato, guarire i feriti, rianimare i tiepidi, ribattere i nemici della fede : eccellente capitano, intrepido soldato, abile medico, egli bastava a tutto. Oh! se i nostri cuori amassero Dio come l’amava Paolo, noi vedremmo meraviglie non mai più udite (Serm. in Laud. Paul.). «L’amore ed il timore di Dio guidano a tutte le opere buone, lasciò detto S. Agostino, come l’amore ed il timore del mondo menano a tutti i peccati ». La carità è cosa tanto preziosa, che vince il prezzo d’ogni altra; per ottenerla dobbiamo impiegarvi tutte le nostre forze, i nostri sudori, la vita medesima… Un’opera eccellentissima fatta senz’amore di Dio, ha poco o niun pregio, ed una ancorché comunissima, un bicchier d’acqua, per es., dato ad un povero, se fatta per spirito di carità, l’ha grandissimo agli occhi di Dio. Dio pesa gli spiriti, dicono i Proverbi (Prov. XVI, 2). Ora il peso dell’anima e del cuore è l’amor di Dio. Quanto più adunque l’anima ama Dio, tanto più ella ha peso nelle bilance di Dio; l’amore le dà il peso ed il valore. Di che cosa è capace l’amor di Dio? Che cosa non merita la carità, sorgente e principio d’ogni merito? Come mai il Signore abbandonerebbe colui che l’ama? Come potrebbe non amarlo egli medesimo?… L’anima fedele e santa si trova, rispetto all’amore divino, in quella condizione in cui trovasi un generoso soldato in mezzo ad una battaglia, o un erudito in mezzo ad una biblioteca, o un medico in mezzo – ad una munitissima farmacia, o un legista armato della legge, o un lavoratore munito d’ogni attrezzo per la coltura de’ campi, o un orefice padrone d’immensa quantità d’oro. L’amore divino è per quest’anima la sua spada, il suo libro, il suo farmaco, il suo codice, il suo campo, la sua ricchezza, la sua arte, il suo lavoro. Per mezzo dell’amore noi ci tuffiamo in Dio, oceano senza sponde, e vi ci troviamo ad agio come il pesce nell’acqua e l’uccello nell’aria. Ah! riceviamo Dio con un cuore infiammato di amore: Dio lo penetri, come i raggi del sole penetrano l’aria; vi si rifletta, come si riflette su tersissimo specchio la fisionomia dell’uomo. « Non il prezzo dell’offerta guarda Iddio, dice Salviano (lib. II, ad Cler.), ma l’animo, ossia l’amore con cui si porge ». « Il vero amore, soggiunge S. Bernardo, non cerca il premio, ma se lo merita; e questo premio è quel Dio medesimo che si ama ». « Signore, datemi che vi ami, diceva S. Ignazio di Loyola, ed io sarò ricco fuori misura » (In Vita).
9. L’amore ci fa imitatori di Dio. — San Paolo scrive agli Efesini: « Siate imitatori di Dio, come figli carissimi » (Eph. V, 1). Ma come mai, o grande Apostolo, una misera creatura, qual è l’uomo, può imitare Dio? Com’è possibile ciò? Eccovi il mezzo: «Camminate nell’amor di Dio» (lb. 2). Dio è tutto amore; dunque colui che ama di tutto cuore, imita Dio. Dio è tutto amore per noi: siamo tutt’amore per Lui, e noi saremo suoi imitatori.
10. L’amore ci unisce a Dio, e ci fa vivere di Gesù Cristo e per Gesù Cristo. — Per mezzo dell’amore noi ci uniamo a Dio così intimamente da formare, in certo modo, una sola cosa con Lui: l’amore ci divinizza. Come il ferro nella fornace si cangia in fuoco pure conservando la sua natura, così chi ama Dio si trasforma in Dio. Per mezzo dell’amore divino si effettua in noi la parola di Gesù Cristo al Padre : « Padre santo, custodisci nel nome tuo quelli che hai a me consegnati; affinché siano una sola cosa come noi… Io sono in essi, e tu in me, affinché siano consumati nell’unità » (Ioann. XVII, 11, 23). Il fine dell’amore, commenta S. Bernardo, è dunque la consumazione, la perfezione, la pace, la gioia nello Spirito Santo, il silenzio nel Cielo (Serm. in Verb. Ev.). L’amore trasforma l’amante nell’amato: l’anima abita più in colui ch’ella ama che nel corpo a cui dà vita. Dio, per mezzo della grazia, si comunica e si dà all’uomo giusto e con questa comunicazione lo innalza fino a sé, se l’unisce, lo divinizza. Sì, noi per mezzo dell’amore, come dice S. Pietro, diventiamo « partecipi della natura divina » (II Pietr. I, 14). L’amore divino trasforma colui ch’esso riempie; lo fa aderire così intimamente a Dio, che forma, diremo, una sola cosa con lui, affinché egli viva, senta, goda della vita, dei sentimenti, della gioia di Dio. Questo appunto provava S. Paolo in se medesimo, quando diceva: Io vivo, però non sono più io, ma è Gesù Cristo che vive in me (Galat. II, 20). Chi ama Dio, si separa interamente da se stesso; passa a Dio e a Dio si congiunge e non pensa, non comprende, non sente altro che Dio vivendo solo di Dio, perché il bene è comunicativo di sua natura e tende ad espandersi; ora, siccome Dio è il bene supremo e per essenza, non può a meno che comunicarsi ed espandersi al più alto grado. La Sposa dei Cantici gustava le dolcezze di tale unione quando esclamava: « Ah! il mio Diletto è tutto a me, ed io son tutta a Lui » (Cantic. II, 16). Io che sono il puro e il perfetto amore, disse un giorno Iddio a S. Geltrude, ti ho scelta per me, e per quanto l’uomo desidera vivere e respirare, io desidero che tu ti unisca a me d’indissolubile legame; io ti ho accolta nel seno della mia paterna bontà, affinché tu ottenga da me tutto ciò che puoi desiderare. La mia vita, la causa della mia vita è Gesù Cristo, esclama San Paolo (Philipp. I, 21); e questo per tre motivi: 1° Gesù Cristo è la causa efficiente della mia vita spirituale, e me la conserva; 2° è il principio della mia vita per i suoi esempi; 3° ne è lo scopo finale. « Io sono, disse Gesù Cristo, la via, la verità, la vita» (Ioann. XIV, 6); e per conseguenza chi ama Gesù Cristo, possiede la via, la verità e la vita, ossia, come spiega Teofilatto, Gesù Cristo è il suo spirito, la sua luce, la sua vita sì naturale che soprannaturale e beata. « Ognuno di noi, scrive S. Agostino, è quale è il suo amore; ami tu la terra? tu sarai terra; ami Dio? sarai Dio » : perciò S. Paolo scriveva ai Galati: « Io sono crocifisso con Gesù Cristo » Gal. II, 19).
11. Amare Dio è un amare se stesso. — È sentenza di S. Agostino, che la città di Dio si fonda, s’innalza, si compie per mezzo dell’amor di Dio, e si mantiene con l’odio verso se stesso; mentre la città del Diavolo comincia con l’amore di se stesso e cresce fino all’odio di Dio. Amare se stesso è un odiarci. Io non so darmi ragione come altri possa amar sè invece di Dio; perché chi non può vivere con la sua forza, certamente muore se ama se stesso; al contrario quando si ama colui che solo dona la vita e si ha in odio se medesimo, allora è un vero amare se stesso. Si deve amare Dio affinché con l’aiuto del suo amore possiamo dimenticare noi medesimi. Amare Dio è un amare se medesimo: è chi preferisce sé a Dio, costui non ama né Dio, né se medesimo. Non si ama poi Dio, se non per Dio e con Dio.
12. L’amor di Dio unisce gli uomini tra di loro. — « Vi sono tante anime e tanti cuori, quanti sono gli uomini; dice S. Agostino; ma quando si congiungono a Dio per l’amore, non hanno più tra tutti che un cuor solo ed un’anima sola ». E tale è il sublime esempio lasciatoci dai primi cristiani. Giacché non possiamo fare nulla per rendere felice Iddio, adoperiamoci almeno con la carità al bene del prossimo che è immagine di Dio : seminiamo tra i nostri fratelli la sapienza, la grazia, il buon esempio e tutti i doni che abbiamo ricevuto da Dio. La limosina spirituale vince in pregio la corporale, e più noi largheggeremo col prossimo, più largamente noi riceveremo da Dio. Quanto più una sorgente emette acqua, tanto più ne riceve; ma se la polla non potesse zampillare fuori, o, riempiuto il bacino, più non avesse uscita, allora ben presto l’acqua si disperderebbe per altri canali, e il fonte disseccherebbe. Così avviene dei predicatori e di coloro che fanno in qualche modo la limosina spirituale, ecc. ; più aiutano il prossimo, e più Dio aiuta loro e li colma di grazie.
S. Paolo che fu martire della carità prima di essere martire della spada, scriveva a quei di Corinto:- « Io muoio ogni giorno per la vostra gloria, o fratelli, che è mia in Cristo Gesù Signor nostro » (1 Cor. XV) « Chi è infedele a Dio, dice S. Agostino, non può essere fedele all’uomo; e la pietà è la salvaguardia dell’amicizia ». L’amor di Dio e l’amor del prossimo non vanno disgiunti; non formano che un comandamento…
13. L’amor di Dio rende invincibile. — Una viva pittura dell’invincibile forza dell’amor divino ci fu lasciata dal grande Apostolo in quelle parole ai Romani — Chi ci strapperà dall’amore di Gesù Cristo? forse l’afflizione, o l’angoscia, o la fame, o la nudità, o i pericoli, o le persecuzioni, o la spada? Ah no! io sono sicuro, certus sum, che né la morte, né la vita, né gli angeli, né i principati, né le potestà né le cose presenti, né le future, né la violenza, né creatura alcuna, sia pure dei Cieli o dell’Inferno non potrà mai staccarci dall’amore di Dio in Gesù Cristo (Rom. VIII, 35-39). Ammaestrata dall’Apostolo, la vergine e martire S. Agata usciva anch’essa in questi accenti : Io sono così ferma ed incrollabile nell’amore del mio Signore Gesù, sono così fermamente risoluta a mantenere saldo il voto di verginità a Lui fatto, che spero, mercé la grazia sua, di veder mancare la luce al sole, il calore al fuoco, la bianchezza alla neve, piuttosto che tentennare nella volontà e nei proponimenti miei (Surio, In Vita). « Niente v’è di così duro, soggiunge S. Agostino, che non ceda al fuoco dell’amor divino (29) ». Sta scritto nei Cantici che « l’amore è forte come la morte; che le molte acque non poterono estinguere la carità, né le fiumane la soverchieranno » (Cantic. Vili, 6-7). Sì, l’amore è forte come la morte; 1° perché come la morte doma tutto, è padrona di tutto, e nessun vivente può evitarne il colpo, così l’amore di Gesù Cristo ha trionfato delle battiture, de’ chiodi, delle spine, dei dolori, della croce, degli affronti, della fame, della sete, delle nudità, in una parola di tutte le avversità e di tutti gli ostacoli. Chi ama Gesù Cristo è pronto a soffrire per Lui ogni cosa. 2° L’amore di Gesù Cristo è forte al pari della morte : poiché quest’amore l’ha vinta, l’ha soggiogata, l’ha uccisa, come dice il profeta Osea: « O morte, io sarò la tua morte » (XIII, 14). 3° L’amore è forte al par della morte : poiché l’amore prova, e risente in sé tutti i mali dell’oggetto amato. Se questo muore, l’amante muore anch’esso d’angoscia.
L’amore è forte come la morte. È impossibile, nota S. Agostino, esprimere in più bello, e splendido, e ricco, e gagliardo modo la potenza dell’amor divino: che cosa infatti resiste alla morte? Si resiste al fuoco, all’acqua, al ferro, al potere, ai re; ma viene la morte, e non importa sotto quale sembianza, e dov’è chi possa tenerle fronte? Essa è padrona di tutto. Ecco perché la potenza dell’amore è paragonata a quella della morte : e infatti l’amor di Dio uccide e distrugge in noi quello che noi siamo, per trasformarci in quello che non siamo. È una morte, la morte cioè del peccato, ma è ad un tempo la risurrezione e la vita. « Come la morte uccide, scrive S. Gregorio, così l’amore della vita eterna ci fa morire alle cose di questo mondo. L’amor di Dio produce sulle passioni dell’anima lo stesso effetto che la morte sul corpo; ci porta, vale a dire, a calpestare ogni terreno affetto: e a defunti di questo genere l’Apostolo diceva: « Voi siete morti, e la vita vostra è nascosta con Gesù Cristo in Dio» (Coloss: III, 3). La carità è forte come la morte, soggiunge S. Ambrogio, perché la carità uccide e fa scomparire tutti i peccati. Si muore a’ vizi, quando si ama il Signore (In Psalm. CXVIII, serm. XV). E poiché la morte non si stanca mai, né mai si riposa finché vi sia vita d’uomo da mietere, il nostro amore anch’esso duri fino a tanto che abbia estirpato in noi le passioni e i vizi tutti quanti. – L’amore è forte al par della morte. Ci fa morire al mondo, al demonio, a noi stessi, per non vivere che di Gesù Cristo; ci fa desiderare la morte e sacrificar la vita : perché chi ama davvero, non risparmia né ricchezze, né figli, né se medesimo. L’amor divino fa vivere l’anima pel tempo e per l’eternità; l’amore del mondo uccide l’anima pel tempo e per l’eternità. L’anima viene dal celeste amore siffattamente innalzata, dice il Crisostomo, che tiene in conto di suprema sua gloria trascinare le catene di Gesù Cristo, ed essere per Lui perseguitata. Ella si spoglia di ogni affetto terreno, come l’oro nel crogiuolo si purga di ogni scoria. Dove l’amor di Dio è grande, si vedono prodigi di coraggio. Purtroppo che queste verità non ci colpiscono, non ci dànno gusto, perché siamo tiepidi e freddi. S. Agostino, parlando della castità di Giuseppe, esprime questo bel pensiero: Chi ama Dio, non può esser vinto dall’amore di una donna: le lusinghe della gioventù non allettano punto un’anima casta, la quale non si arrende nemmeno alla influenza d’un amore appassionato. Giuseppe è grande, perché schiavo rifiuta d’obbedire; amato, rifiuta d’amare; scongiurato, non si piega; afferrato, fugge (De Civ. Dei, CXXIII). L’amor di Dio mi brucia, mi divora, va gridando S. Francesco d’Assisi: io ho risposto all’amore con l’amore: l’amor divino trionfa nel mio cuore dell’amore che l’uomo naturalmente prova per se stesso. Né le tempeste, né le fiamme, né la spada non me lo rapiranno mai. Oh Signore! muoia io d’amore per Voi, giacché Voi siete morto d’amore per me! « Cercate il Signore per mezzo della carità e voi sarete fortificati » dice il Salmista (Psalm. CIV, 4).
14. L’amor di Dio scaccia i Demoni. — A quel modo che vedete le mosche scostarsi dall’acqua bollente e fermarsi su quella tiepida dove depongono semi di vermiciattoli, così i Demoni fuggono da un’anima avvampante d’amor divino, e si stringono attorno alle tiepide e le tempestano, e le trasformano in sentine di corruzione. Il Demonio soffre di più dentro di sé vedendo l’amor divino in un cuore, che patendo il fuoco dell’Inferno. Questo amore è nelle mani del cristiano un’arma con cui egli si difende dalle astuzie del serpente antico, e gli mozza il capo. Con questo amore si trionfa dell’Inferno e delle passioni tutte.
15. L’amor di Dio distrugge il peccato. — Inspirato certamente da quelle parole di Gesù Cristo alla Maddalena: «Le sono rimessi molti peccati, perché ha molto amato » (Luc. VII, 47). S. Agostino proferì questa sentenza che « l’amor di Dio è la morte de’ vizi e la vita delle virtù ». Tutta la ruggine del peccato viene divorata e tolta via dal fuoco dell’amor divino; e più esso avvampa in un cuore, e più il peccato vi sì trova annientato. « Il vostro Dio è un fuoco che consuma », sta detto nel Deuteronomio (Deuter. IV, 24) : « Dio è chiamato fuoco che consuma, commenta qui S. Gregorio, perché rende netta e pura d’ogni peccato l’anima ch’Egli riempie del suo amore ». « Non ombra di malvagità rimane in un cuore che brucia del fuoco della carità », dice S. Cesario d’Arles. L’amor di Dio rende come impeccabile; e in questo senso S. Agostino sentenziava: «Ama, poi fa quello che t’aggrada ». Quegli infatti che ama Dio, non consentirà giammai ad offenderlo, ad oltraggiarlo, a violar la sua legge, ecc…
16. L’amor di Dio ci fa disprezzare tutto il resto. — Ogni cosa mi pare fango, scriveva il grande Apostolo ai Filippesi, se la paragono alla scienza del mio Signore Gesù Cristo, per il cui amore sono determinato a disprezzare ogni cosa, purché giunga a possederlo (Phil. IlI, 8). « La sanità stessa del corpo ha poco pregio, soggiunge S. Gregorio, per quell’anima che è trafitta dalle frecce dell’amore divino ». Può amare il mondo corrotto, colui che ama Dio incorruttibile? Ah! egli esclama piuttosto con S. Francesco : « Come la terra mi compare brutta, se volgo lo sguardo al Cielo ».
17. L’amor di Dio scaccia la tiepidezza. — « È impossibile, dice San Bonaventura, che l’accidia ed il languore s’impossessino di un’anima che dal desiderio di amare Dio è spinta ad avanzarsi di giorno in giorno per la via della perfezione ». Il cuore di colui che ha la carità, è come un pezzo di cera, che nel fondere prende l’impronta di Dio; mentre il cuore di chi ne è privo, è come il fango che s’indurisce al sole. Eppure è il medesimo calore del sole che opera su la cera e sul fango!
18. L’amor di Dio illumina. — S. Paolo augurava agli Efesini, che Gesù Cristo abitasse in loro, affinché essendo ben radicati e fondati nell’amore fossero in grado di comprendere con tutti i Santi quanta sia l’ampiezza e la larghezza, l’altezza e la profondità dell’edificio di Dio, amore che sopravanza ogni intendimento, affinché ne fossero riempiti seconda tutta la pienezza di Dio. Nessuno è tanto vicino a Dio, quanto colui che l’ama; e quanto più si ama Dio, tanto più gli si è dappresso: ora Dio è la luce delle luci, la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo (Ioann. I, 9). Ah sì! o mio Dio, « coloro che vi amano, risplendono come il sole al suo levarsi » (Iudic. V, 31).
19. A chi ama Dio ogni cosa si volge in bene. — « Noi sappiamo, dice l’Apostolo, che per coloro i quali amano Dio, tutte le cose tornano a bene » (Rom. VIII, 28). L’amor divino rende facile ogni cosa…, dà valore ad ogni benché minima cosa, ai patimenti, alla povertà, ecc.
20. Dolcezza e felicità di amare Dio. — Rallegratevi con Gerusalemme, esclama il profeta Isaia, tripudiate d’allegrezza con lei, voi tutti che l’amate. Voi sarete riempiti delle sue consolazioni, innondati dal torrente delle sue delizie, su voi si rifletterà lo splendore della sua gloria. È parola del Signore, che la pace scenderà sopra di voi come le onde di un fiume e la gloria delle nazioni come le acque d’un torrente. Voi sarete portati tra le braccia e tenuti su le ginocchia come pargoletti. Io vi consolerò come madre che vezzeggia il bimbo (Isai. LXVI, 11-13). Gesù Cristo prodigando alle anime fedeli il delizioso vino del suo amore, le inebria di amore, poiché, come dice S. Dionigi, l’amore perfetto produce l’estasi ed una santa follia (De celest. Hierar.). Niente vi è di più bello, di così dolce, di così attraente come Dio. « Io li trascinerò, dice il Signore, coi legami che seducono gli uomini, coi vincoli dell’amore » (Osea XI, 4). Io me li incatenerò per mezzo dell’amore che dimostrerò loro, di grazie segnalate, della dolcezza e della grazia. Ed è ciò per l’appunto che ha provato S. Agostino dopo la sua conversione. « O come dolce mi seppe in su l’istante vedermi privato delle gioie fallaci, delle vane delizie!, egli diceva, e quello che in su le prime io temevo di perdere, mi riempiva di gioia dopo averlo perduto. Siete Voi, o mio Dio, Voi la vera e suprema soavità, che avete allontanato dalle mie labbra il calice di quelle dolcezze avvelenatrici e Vi siete sostituito ad esse, Voi più dolce di tutti i piaceri del mondo (Confess.) ». Chi non si avvede da queste parole che l’amor divino è un vigoroso dardo con cui Dio trapassa il cuore? Ah! ve ne persuade ancora S. Paolo che esclama infiammato di amore: « Io possiedo ogni cosa, mi trovo nuotare nell’abbondanza; nulla mi manca » (Philipp IV, 18). Ascoltate Origene che mirabilmente commenta quelle parole dei Cantici: « Io sono ferita d’amore» — Vulnerata charitate ego sum. — « Quanto bella, quant’onorevole cosa è ricevere la ferita dell’amore divino! Chi espone il petto ai dardi dell’amore carnale, chi a quelli del’avarizia; ma voi esponetevi ai dardi deliziosi dell’amore divino, poiché Dio è un arciere, e fortunato chi da Lui è ferito ». Ne erano alla prova S. Efrem, quando diceva: « Fermate, o Signore, il torrente delle vostre dolcezze, perché non posso reggere »; e S. Francesco Saverio, il cui grido era questo: «Basta, o Signore, basta »; e l’Apostolo Paolo che diceva in mezzo alle sue tribolazioni: « Strabocchevole è la gioia che m’inonda il petto » (II Cor. VII, 4). – Ogni bene, ogni dovere dell’uomo, tutta la sua felicità, il fine e la perfezione sua consistono nell’amor di Dio. L’amore trasforma l’uomo in Dio. « E ben giusto, o Signore, esclama S. Agostino, che chi cerca la sua felicità altrove, fuori di Voi, Vi perda. Deh! fate che ogni cosa di quaggiù mi riesca amara, affinché Voi solo riusciate dolce all’anima mia, Voi che siete la dolcezza ineffabile e che rendete soave ogni asprezza ».
«Beati coloro che vi amano, o Signore», diceva già Tobia (Tob. XIII, 18). Niente si trova nelle cose umane, al dire di S. Bernardo, che possa appagare una creatura fatta ad immagine di Dio, se non il Dio carità, il quale solo è maggiore di essa. Se io amo qualche oggetto perché è buono, dice S. Anselmo, io devo a molto maggior ragione amare ciò ch’è infinitamente buono. Perché dunque vai tu, o uomo, qua e là cercando beni per la tua anima e per il tuo corpo? Ama il solo bene che è tutto il bene, e questo basta. In Dio solo è il mare di ogni bene; fuori di Lui non scorrono che ruscelletti. L’apice e la perfezione della sapienza, della felicità, della virtù e dell’uomo e dell’Angelo, sta in Dio; sta nell’indirizzare a Lui ogni pensiero, ogni intenzione, ogni opera nostra: sta nell’amarlo in tutte le creature, e amare le creature in Lui. L’anima colpita dai raggi del suo Creatore ed infiammata dal suo amore, l’anima che a Dio si unisce in dolcissimi abbracciamenti, tutto dirige verso di Lui, tutto vede in Lui e Lui solo vede in ogni cosa: con Lui e dopo di Lui sospira e respira dicendo: Tutti i miei respiri e sospiri sono per Voi e in Voi, o mio Dio. Ecco perché, in qualunque luogo ella sia, qualunque cosa ella faccia, sempre mira Colui ch’ella ama ed opera per Colui che l’ama; ella vive, si riposa e muore in Lui per l’amore e la contemplazione. Questa pace, questo riposo, questa gioia, questa felicità provava Geremia allorché diceva: « Si è acceso nelle mie interiora, come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa, ed io svenni, non potendolo sopportare » (Hier. XX, 9). Dio ha messo nel cuore dell’uomo un desiderio dell’infinito, che niuna cosa limitata può saziare. « Per Voi ci avete fatti, o Signore, esclama S. Agostino, ed inquieto sarà il nostro cuore fino a tanto che in Voi non si riposi ». Desiderate voi delle ricchezze? Dio le possiede tutte. Cercate una sorgente d’acqua viva? e qual acqua più pura che l’acqua della sua grazia? sebbene sia vero che Dio prova quaggiù gli eletti con l’aridità perché la felicità costante è riservata in Cielo. La Sposa dei Cantici se ne lagnava con queste parole : « Io mi alzai per aprire al mio Diletto, gli apersi; ma Egli si era sottratto e allontanato. L’ho cercato e non lo trovai; l’ho chiamato e non mi rispose ». Dio ci mette alla prova; assoggettiamoci: le prove sono un pegno d’amore e noi sforzandoci di obbedire alla sua santa volontà, l’ameremo sempre. Niente è tanto dolce e casto, ed insieme ardente, quanto l’amor di Dio : esso consuma le viscere e il cuore: inebria l’anima fino all’oblio di se medesima.
21. A chi ama tutto è facile e leggero. — Da questa dolcezza, da questa felicità di amare Dio, sorge naturale la facilità di amarlo. « Ogni comandamento di Dio pare leggero a chi ama, e dov’è amore, ivi non è fatica », dice S. Agostino; « anzi è soavità e dolcezza », aggiunge S. Bernardo; cosicché « l’amante, ripiglia S. Agostino, non trova niente di difficile, niente d’impossibile ». L’anima amante s’eleva di tratto in tratto alla celeste Gerusalemme, ne percorre l’ambito: visita i Patriarchi ed i Profeti; saluta gli Apostoli; ammira l’esercito dei Martiri e dei Confessori; contempla i cori delle Vergini e di tutti i Santi. O uomini! esclama S. Agostino, che vi logorate a servire l’avarizia, il vostro amore vi crocifìgge, mentre Dio si ama senza fatica. La cupidigia vi impone lavori, pericoli, angherie, stenti, e voi le obbedite : ed a qual fine? per riempire i vostri scrigni e perdere la pace. Più sicuri e più tranquilli voi eravate quando non possedevate ancora nulla che non adesso che avete ammassato ricchezze senza fine. Avete i granai che riboccano, ma il cuore agitato per timore dei ladri : avete incassato dell’oro, ma perduto il sonno. Dio si acquista e si possiede senza fatica, quando si ama. Traeteci, diceva la Sposa dei Cantici, e noi correremo dietro a Voi all’odore dei vostri aromi (Cant. I, 4). Sì, amate, soggiunge il citato Padre, e voi sarete attratti. Né vogliate credere che la violenza fatta all’anima da Dio sia grave e penosa; essa è anzi dolce e soave, è, dirò meglio, la soavità medesima che v’incatena. Non è forse attratta la pecora che ha fame, quando le si mostra dell’erba? Non è sforzata, ma si eccitano i suoi desideri. E voi ancora venite a Gesù Cristo: non vi spaventi la lunghezza del cammino, perché a Cristo si va amando, non navigando. L’amore è, secondo il medesimo Dottore, una leva così potente, che innalza i più gravi pesi, perché l’amore è il contrappeso di tutti i pesi. « Il mio amore è il mio peso; da lui son tratto dovunque mi porto ». La leva dell’anima è la forza dell’amore il quale la solleva al di sopra del mondo e la fa toccare il Cielo, scrive S. Gregorio (Homil. in Ev.); ed a lui fa riscontro S. Bernardo che dice: « La mia fatica dura appena un’ora; durasse pur più lungo tempo, non me ne accorgerei, perché amo ». Gesù Cristo ha superato con la forza del suo amore tutto il peso della sua Passione e della sua croce. L’amore rende facile e leggero quanto v’ha di più spossante e penoso.
22. L’amor divino racchiude tutti i beni. — Se Dio abita in un’anima fedele per mezzo del suo amore, vi produce i seguenti mirabili effetti : 1° la monda delle terrene cupidigie, affinché non brami e non gusti che le cose celesti. 2° Questo amore volge a Dio tutti i sentimenti, le facoltà, gli atti, le affezioni dell’anima, acciocché non pensi che a Dio, non veda e non cerchi altro che Dio. E che cosa andrebbe cercando al di fuori, se Dio è in lei? Ella s’immerge e si sprofonda in Lui, sorgente d’ogni bene. 3° L’amore spinge l’anima a desiderare di far cose eroiche per Iddio, di soffrire per Lui, e ritrarre in sé Gesù crocifisso. 4° La fa crescere ogni giorno nella grazia. 5° La porta a comunicare a quanti può, e se fosse possibile, al mondo intero, il fuoco di cui ella è accesa. Poiché l’amore, dice S. Bernardo, non è altro se non una gagliarda volontà per il bene; e perciò chi non ha zelo, non ha punto d’amore, conchiude il citato Padre. 6° L’anima per mezzo dell’amore comanda a Dio medesimo; ottiene tutto ciò che domanda, ed acquista una certa quale onnipotenza. 7° Dio se l’unisce, se l’assimila, le fa parte delle sue virtù divine, le comunica i suoi secreti, le rivela lo stato dei cuori, le dà conoscenza di quello che altrove avviene e perfino dell’avvenire, come ai Profeti ed agli Apostoli. 8° Le dona la tranquillità e la serenità, la rischiara, affinché imperterrita, contenta, lieta nelle avversità e nelle prosperità, sempre gioisca nel Signore, Lo lodi e Lo ringrazi cantando col Salmista: «Io benedirò il Signore in ogni istante, su le mie labbra suoneranno del continuo le sue lodi » (Psalm. XXXIII, 1); e con Giobbe: « Il Signore me l’avea dato, il Signore me l’ha tolto; avvenne come a Lui piacque; sia benedetto il suo santo Nome » (Iob. I, 21). Finalmente l’amante di Dio soccombe, come la benedetta Vergine Maria, vinto dal peso dell’amor di Dio. L’arte di amare Dio è l’arte delle arti, dice S. Bernardo; essa fa tendere all’amore tutti i pensieri dello spirito e volge al desiderio dell’eternità tutti i movimenti del cuore. L’uomo che ama Dio, si compiace del suo amore, vi si adagia e se ne bea: ben presto, non potendo più contenere i sentimenti dai quali è rapito, si solleva al di sopra di se medesimo, tocca l’estasi intellettuale, e penetra nel pensiero di Dio per imparare a non preoccuparsi più d’altro che di Lui, a non riposare altrove fuorché in Lui. L’amore di Gesù si ruba tutte le sue affezioni; trascurando e dimenticando se stesso, egli non altro ormai più sente che Gesù e ciò che riguarda Gesù. A questo punto, il suo amore è perfetto; ed in tale stato la povertà non è più per lui che un incomodo; non sente le ingiurie, si ride degli oltraggi, non bada alle perdite, guarda la morte come un guadagno; anzi non crede di morire, perchè sa che passerà dalla morte alla vita eterna (S. Bernardo, De natura divini amoris, c. II). Chi consacra l’amore alle cose terrene, vili, vergognose, diventa simile ad esse; l’anima, al contrario, che ama Dio e che a Lui solo s’attacca, diviene simile agli spiriti, agli Angioli, a Dio medesimo. Allora, dice S. Ambrogio, il Verbo divino la circonda, la rischiara, rinfiamma, la benedice; essa non forma più che una cosa con Lui (Serm. II). L’amor divino scalda, infiamma, fonde il cuore, e lo cangia del tutto: non avete che a dare uno sguardo a S. Paolo… L’amor divino dà refrigerio, lume, conforto all’anima, e le fa desiderare il possesso di Dio; porta ristoro e pace; rende paziente nelle tribolazioni, toglie il timore, insinua la confidenza, assicura la salute. È questo il Paradiso, dove ci è dato di entrare senza che ci partiamo dalla terra. « Chi ascende a Dio per mezzo dell’amore, ci va come portato da agilissime ali », dice S. Agostino.
23. Per amare Dio bisogna osservare la sua legge. — « Se veramente mi amate, datene prova, dice Gesù Cristo, con l’osservare i miei comandamenti » (Ioann. XIV, 15) : poiché « la prova dell’amore, dice S. Gregorio, sta nella dimostrazione delle opere ». « Chi mi ama, ripete ancora Gesù Cristo, osserverà la mia parola e il Padre mio l’amerà : e noi verremo a lui e in lui faremo dimora » (Ib. XIV, 23). S. Agostino così commenta queste parole: « Il Padre e il Figlio venendo ad abitare in un’anima, le donano il loro amore, e infine le doneranno il Cielo. Essi vengono a noi quando noi andiamo a loro : essi vengono col soccorrerci, con l’illuminarci, con l’arricchirci; noi andiamo a loro con l’obbedire, col guardare, col ricevere ». « Chi non mi ama, dice ancora Gesù Cristo, non tiene conto delle mie parole » (Ib. XIV, 24). E S. Giovanni soggiunge che dimostra di avere carità perfetta colui che custodisce la parola di Dio : (I, II, 5); poiché la carità, dice il medesimo Apostolo, « consiste nel camminare per la via dei divini precetti » (II, 6). Ora il primo dovere della carità è di obbedire agli ordini di Dio, sottomettervisi, e avere confidenza nelle promesse divine. « Quelli che amano Dio, sta scritto nell’Ecclesiastico, si riempiranno della sua legge », vale a dire, la studieranno, la conosceranno, la praticheranno (Eccli. II, 19).
24. Diversi gradi dell’amor divino. — Il Padre Alvarez trattando della contemplazione indica quindici gradi nell’amore divino : 1° intuizione della verità; 2° raccoglimento; 3° silenzio spirituale; 4° riposo; 5° unione; 6° udire il linguaggio di Dio; 7° sonno dello spirito; 8° estasi; 9° rapimento; 10° apparizione corporale di Gesù Cristo; 11° apparizione spirituale di Gesù Cristo, e dei Santi; 12° visione intellettuale di Dio; 13° visione di Dio a traverso le nubi; 14° manifestazione positiva di Dio; 15° visione chiara e intuitiva di Dio, come l’ebbe, al dire di S. Agostino e di altri Dottori, S. Paolo quando fu rapito al terzo Cielo.
25. Qualità dell’amor divino. — L’amor di Dio dev’essere: 1° inseparabile; 2° insaziabile; 3° invincibile; 4° soave; 5° pieno di desideri; 6° anelante a Dio, che procura di raggiungerlo, lo contempla nelle creature ed è impaziente di possederlo; 7° animato dal desiderio di morire, non per noia della vita, ma per essere con Gesù Cristo, e godere di Lui; 8° liberale; 9° intero.
26. Rammarico di non aver amato Dio. — « Troppo tardi io Vi ho amato, o bellezza sempre antica e sempre nuova; ah! troppo tardi Vi ho amato! andava sospirando, col cuore pieno di tristezza, S. Agostino. Deh! fosse scancellato dal numero dei giorni quel tempo in cui non Vi ho amato! Ahi me misero, me infelicissimo se mai cessassi di amarvi; amerei meglio non essere, che essere senza, o fuori di Voi». Facciamo nostri i lamenti e il pianto di Agostino…
27. Quanto sia disgraziato chi non ama Dio. — « Chi non ama il nostro Signor Gesù Cristo, sia anatema », dice S. Paolo (I Cor. XVI, 22). Ossia, come si esprime l’Apostolo S. Giovanni: «Chi non ama Dio, non lo conosce, perché Dio è carità, e rimane nella morte » (Epl. I, IV, 8) : — “Qui non diligit manet in morte” (7, III, 16); e prima di lui già aveva espresso questo sentimento l’autore dei Proverbi in quelle parole : « Chi non ama me, ama la morte » (Prov. VIII, 36). E da essi trasse S. Agostino quella sentenza: « Chi non ama Dio, cessa di vivere ». « Strappate, ci dice il medesimo Dottore, il vostro cuore dall’amore alla creatura per conservarlo al Creatore: poiché, se abbandonate Colui che vi ha creati e vi abbracciate a ciò ch’Egli ha creato, siete adulteri ». Tremino quindi, conchiude S. Gregorio, quelli che non amano Dio e pensino, soggiunge S. Bernardo, che perfino il linguaggio loro è barbaro e straniero. L’amor di Dio verso gli uomini è così grande, che non solamente si presenta a quelli che lo cercano, ma cerca quelli che non lo cercano, va dietro a quei medesimi che lo fuggono, l’odiano, lo perseguitano : esso li invita, li attrae, e dolcemente li trascina. Quanto non sono adunque disgraziati, ingrati, perversi coloro che non si curano d’amare Dio che tanto li ama! Che suprema sventura per loro il disprezzarlo e combatterlo! Eppure, oh! come grande è il numero di quelli che non amano Dio! Quanti possono dire con S. Pietro : « Voi, o Signore, che tutto conoscete, sapete bene quanto io vi ami? » (Ioann. XXI, 17). Chi oserà esclamare col Profeta: «L’anima mia sta attaccata a voi, o Signore?» (Psalm. LXII, 8). Ah! piangiamo la triste sorte di coloro che non amano Dio.
28. Come bisogna amare Dio. — Gesù Cristo c’insegna il modo di amare Dio con quelle parole: «Voi amerete il Signore vostro Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze vostre » (Matth. XII, 37). Con tutto il cuore, cioè voi consacrerete la vostra memoria a ricordarvi i suoi benefizi, ecc. Con tutta l’anima, cioè applicherete la vostra intelligenza a meditare com’Egli è amabile in se stesso, e quanto vi ha amati. Con tutte le forze, cioè con tutta la volontà. Udite S. Agostino : Allorquando Iddio ci dice : Voi amerete di tutto cuore, di tutta l’anima, di tutto lo spirito vostro, Egli non ci permette di dimenticarci di Lui un solo istante e di godere di qualche altra cosa (Homil. ad pop.). Amare Dio importa: 1° dare a Lui il nostro cuore tutt’intero e niente al demonio, né al peccato; 2° avere Dio per scopo di tutte le nostre azioni, di preferirlo a tutto come nostro sommo bene ed unico fine; 3° obbedirLo in tutto e sempre… Tutti quelli che hanno dato il loro cuore a Dio, dice S. Bernardo, si rallegrino e gioiscano nelle pene, nelle ambascie, nelle tribolazioni, nella fame, nella sete, nella nudità, nel disprezzo, tra le beffe, le calunnie, le maledizioni, gli insulti, e le persecuzioni fino alla morte (Serm. in Psalm.).
29. Mezzi di amare Dio. — S. Tommaso indica tre mezzi d’unirsi a Dio con l’amore: ci vuole il coraggio dello spirito, ossia l’energia; una grande severità contro le cupidigie; la bontà verso il prossimo (1a p. 9, art. 13). Un quarto lo troviamo accennato in quelle parole di S. Gregorio: « Se non moriamo al mondo non siamo atti a vivere di amore per Iddio ». Altri mezzi ci suggerisce S. Bernardo e sono: le letture devote, le quali eccitano l’amore divino; la meditazione, la quale lo nutrisce; l’orazione, che lo illumina e lo conforta. – Eccellenti mezzi sono questi per acquistare e mantenere l’amore di Dio in un’anima. Ne volete altri? Eccoveli. Date orecchio alla voce di Dio. « Non ci ardeva il cuore in petto, mentre per istrada ci parlava, e ci svelava le Scritture? » (Luc. XXIV, 32), andavano dicendo i discepoli di Emmaus. « Il mio cuore s’infiamma di amore e sento un fuoco avvamparmi in petto quando io medito », asserisce di sé il Salmista (Psalm. XXXVIII, 3). La purità del cuore è un mezzo adatto di amare Dio. « Il mio Diletto si delizia tra i gigli», diceva la Sposa dei Cantici (Cant. II, 16). Essa ci indica pure come tale, ed efficacissimo a far nascere e mantenere in noi l’amor divino, il desiderio che se ne mostra, in quelle altre sue esclamazioni : « Io vi scongiuro, o figlie di Gerusalemme, d’annunziare al mio Diletto, se Lo incontrate, che io languisco e vengo meno di amore per Lui… oh! chi mi darà ch’io ti trovi e t’abbracci, o mio Diletto? oh! allora nessuno oserà più insultarmi! » (Ib. V, 8) (Ib. VIII, 1). Il timore del Signore è un mezzo sicuro per giungere ad amarlo. Difatti, come osserva S. Basilio, è necessario che il timore preceda per introdurre la pietà, e a lui terrà dietro l’amore; il quale, al dire di S. Agostino, guarisce le ferite che ha fatto il timore, il cui effetto è di spronare. La fede ci porta ad amare Dio. « Al presente, dice S. Agostino, noi amiamo credendo quello che vedremo; poi nel Cielo ameremo vedendo quello che avremo creduto ». Ma se l’anima trova Dio con la fede e la speranza, lo possiede con la carità: se è assente, lo trova col desiderio; se presente, lo ritiene con la gioia: lo scopre e lo conserva con la pazienza: lo possiede con la consolazione. Finalmente si arriva con ogni certezza a Dio perseverando nel cercarlo e nel desiderio di amarlo. « Cercate il Signore, dice il real Profeta, e voi sarete rassodati e forti, ma cercatelo sempre » (Psalm. CIV, 4). « Sì, Iddio va cercato senza fine, sentenzia S. Agostino, perché Egli dev’essere amato senza fine ». Desideriamo noi davvero d’avere la carità? volgiamoci a chiederla allo Spirito Santo che è il Dio-Amore; poiché la carità, al dire di S. Paolo, fu sparsa nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci fu dato (Rom. V, 5).