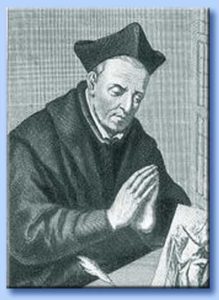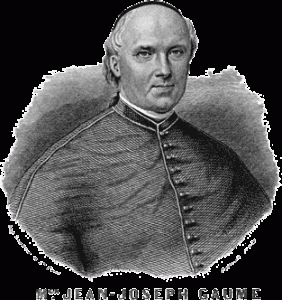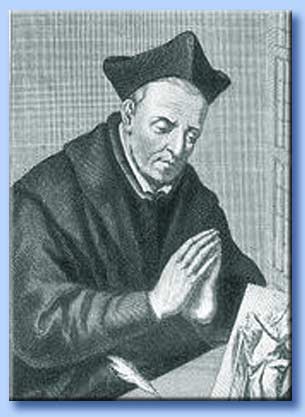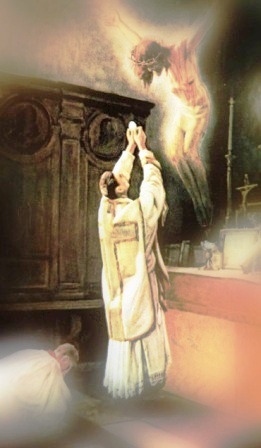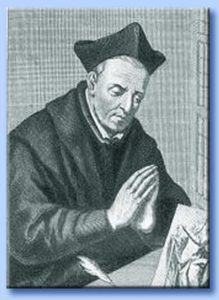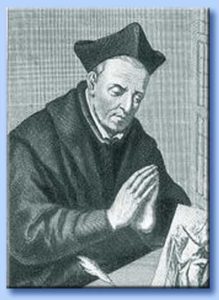
Necessità di servire Dio da giovani.
[E. Barbier: I Tesori di Cornelio Alapide, vol. II, S.E.I. ed. Torino, 1930- impr.]
– 1. Quanto è stimabile chi serve Dio da giovane. — 2. È facile servire Dio dalla giovinezza. — 3. Vantaggi del servire a Dio dalla giovinezza. — 4. Motivi di servire Dio nella gioventù: 1° perché questa età passa presto; 2° Perché quale è la gioventù, tali sono le altre età; 3° Perché questa età è la più esposta al male; 4° Perché questa età appartiene in modo speciale a Dio. — 5. È cosa vergognosa sciupare la giovinezza. — 6. Castighi minacciati a quelli che non servono il Signore da giovani. — 7. Mezzi per servire Dio dalla giovinezza.
1 . QUANTO È STIMABILE CHI SERVE DIO DA GIOVANE . — « Chi piace a Dio (dalla giovinezza) diventa il suo prediletto », dice il Savio: — Placens Deo factus est dilectus (Sap. IV, 10). A somma lode di Tobia la Sacra Scrittura dice che egli non fece mai nessuna azione da ragazzo, mentre pure era il più giovane di tutta la sua tribù: — Cumque esset iunior omnibus, nihil tamen puerile gessit in opere (TOB. I, 4). E perché aveva temuto e obbedito Dio fino dai più teneri anni, la Scrittura dice che egli non mormorò contro Dio perché lo avesse colpito di cecità; ma stette saldo nel timore del Signore che egli ringraziava ogni giorno: — Cum ab infantia sua semper Deum timuerit, et mandata eius custodierit, non est contristatus contra Deum, quod plaga cœcitatis evenerit ei; sed immobilis in Dei timore permansit, agens gratias, Deo omnibus diebus vitæ suæ (TOB. II, 13-14). – Leggiamo nel 2° libro dei Maccabei, al capo VII, l’esempio di coraggio e di fermezza nel proprio culto, che fra acerbe torture diedero i sette fratelli, perché avvezzi dalla prima età ad obbedire e servire Dio … E quanti altri batterono la medesima via! … Che spettacolo più dolce e più bello può offrirsi agli occhi di Dio, degli Angeli e degli uomini, che quello di un giovinetto o di una fanciulla i quali passano la giovinezza nella modestia, nella purità, nella saviezza, nella prudenza, nell’umiltà, nella pietà, nella preghiera! – O spettacolo che tanto più innamora, quanto più è raro! Volesse il cielo, che di molti dei nostri giovani si potesse fare l’elogio che di S. Malachia fece l’abate di Chiaravalle: « Benché tenerissimo di anni, non mostrava nulla della petulanza giovanile, ma si diportava in tutto con costumi degni della gravità di un vecchio (In morte B. Malach.) ». Volesse il cielo che della nostra società si potesse ripetere col medesimo dottore: « Noi vediamo tuttodì molti giovani più assennati che i vecchi, mostrare provetta età nei loro costumi; anticipano il tempo coi loro meriti e compensano con le virtù quello che manca ai loro anni (Serm. in Ps.) ». Ecco a questo proposito una sentenza di S. Agostino, degna di essere scritta a lettere d’oro: « La vostra vecchiezza tenga della puerizia, e nella puerizia traspiri la vecchiaia: cioè la vostra saggezza senile sia senza alterigia e la giovanile timidità sia accompagnata dalla saviezza, affinché lodiate Dio ora e nell’eternità (Sent.) » .
2. È FACILE SERVIRE DIO DALLA GIOVINEZZA. — Il tempo e le circostanze più adatte all’innesto sono la primavera e il vento caldo del mezzogiorno. L’innesto spirituale riesce mirabilmente nella primavera della vita, nell’età in cui i sentimenti sono sul fiorire e lo Spirito Santo spira su l’anima ancora tenera il sacro e ardente soffio del suo amore. Infatti la gioventù somiglia a un ramo novello, per la sua flessibilità e la facilità con cui riceve l’innesto divino il quale, nutrito del succo della grazia, forma un albero fruttifero, l’albero della vita. Udite, o giovani, che cosa vi dice il Signore: « Ascoltatemi, o frutti divini, e fruttificate come il rosaio piantato lungo le sponde di fresco ruscello; spandete un odore balsamico come il Libano; portate i fiori che siano, nel candore e nel profumo, come i gigli, adornatevi di verde fogliame, cantate inni di lode e benedite il Signore nelle sue opere. Magnificate il suo nome e rendetegli testimonianza con le parole della vostra bocca » — Obaudite me, divini fiuctus, et quasi rosa piantata super rivos aquarum fructifìcate; quasi Libanus odorem suavitatis habete; florete flores quasi lilium, et date odorem, et frondete ingratiam, et collaudate canticum et benedicite Dominum in operibus suis. Date nomini eius magnifìcentiam, et confitemini illi in voce labiorum (Eccli. XXXIX, 17 -20). « Mentre ero ancora giovinetto, narra di sé l’autore dell’Ecclesiastico, ho cercato la sapienza con le mie preghiere; la domandava a Dio nel tempio e diceva: io le terrò dietro fino alla fine di mia vita; ed essa fiorì in me, come vite che dà frutto precoce, e il mio cuore trovò in lei la sua letizia. I miei piedi camminarono per la strada retta; dai primi anni io mi misi in traccia di lei: ho abbassato l’orecchio, e l’ho ricevuta » (Eccli. LI, 18 – 21), Ecco l’esempio da imitarsi dai giovani i quali sono disposti più che ogni altra età, ad accogliere prontamente e praticare facilmente i dettami della divina sapienza, perché la giovinezza è l’età più prossima all’innocenza, la più atta a ricevere le buone impressioni e la più pronta a fare una buona azione; è l’età più cara a Dio. « Lasciate che i fanciulli vengano a me », diceva il Maestro divino: — Sinite parvulos ad me venire (MATTH. XIX, 14). S. Benedetto ammetteva nel suo ordine specialmente i giovani, affinché si avvezzassero presto alla disciplina monastica. Anzi la storia ci dice che nei primi tempi del Cristianesimo vi era l’uso di disporre i ragazzi, i giovani e le fanciulle ai tormenti e al martirio. Cari modelli ce ne forniscono la madre dei Maccabei e Santa Felicita le quali, nell’educazione dei loro figli, non tralasciarono d’insinuarvi l’amore al martirio e, giunto il tempo, ve li condussero. Così leggiamo che fece, sotto il tiranno Dunaano, re di Arabia, una pia madre la quale aveva istruito e preparato al martirio un suo bimbo. Ora avvenne che il fanciullo, all’età di cinque anni, vide un giorno strapparsegli la madre, per ordine del tiranno, ed essere condannata ad ardere viva. A quella vista, mosso dal desiderio del martirio, il ragazzino cominciò a piangere e sospirare dietro la madre: avendogli Dunaano domandato se amasse meglio essere con lui in un bel palazzo, ovvero con la madre in una caldaia infocata: Preferisco, rispose, starmene con la mamma, affinché ella mi prenda e conduca con sé al martirio. — E sai tu che cosa è il martirio? riprese Dunaano. — E il bambino a lui: — Il martirio è morire per Gesù Cristo per vivere di nuovo. — Chi è Gesù Cristo? replicò il tiranno. — Venite alla chiesa, soggiunse il bambino, e ve lo farò vedere. Ma non cessando il tiranno di sollecitarlo con lusinghe e promesse, quel mirabile fanciullo finì col dirgli: — Taci, o mostro; non cerco né voglio te, ma la madre mia. — Riunito a lei, si strinse al suo petto e ricevé con essa la corona del martirio (Stor. Eccl.).
3. VANTAGGI DEL SERVIRE A DIO DALLA GIOVINEZZA. — « Coloro che mi cercano di buon mattino, mi troveranno », dice il Signore: — Qui mane vigilant ad me, invenient me (Prov. VIII, 17). Chi giunge a buona vecchiaia, gode i frutti raccolti nel tempo della giovinezza, che sono la saggezza, l’autorità, il diritto di dare consigli, l’onoratezza, la speranza dell’eternità beata. Ha dei figli e dei nipoti saggi, prudenti, gravi e onorati… Chi al contrario ha fatto cattivo uso degli anni giovanili, raccoglie nella tarda età dispiaceri, malinconia, disonore, disperazione, sia per conseguenza della vita malvagia che ha menato, sia per la mala condotta dei figli e dei nipoti. « Figlio mio, dice il Signore, se avrai l’animo saggio, il mio cuore ne gioirà con te » •— Fili mi, si sapiens fuerit animus tuus, gaudebit tecum cor meum (Prov. XX II, 15). « Ricevi, figlio mio, l’istruzione nei tuoi primi anni, e otterrai la sapienza fino alla vecchiaia. Avvicinati a lei e aspettane i buoni frutti in pazienza, come colui che ara e semina il terreno, aspettando la messe; in questo lavoro poco avrai da faticare e ti nutrirai ben presto de’ suoi prodotti » — Fili, a iuventute tua excipe doctrinam, et usque ad canos invenies sapientiam. Quasi is qui arat et seminat, accede ad eam, et sustine bonos fructus illius; in opere enim ipsius exiguum laborabis, et cito edes de generationibus illius (Eccle. VI, 18-20). Cercate la virtù nel tempo della vostra giovinezza, e la troverete come un frutto precoce; sarete colmi di felicità (Eccli. LI, 18 – 20). « Io mi sono ricordato di voi, dice il Signore; ebbi pietà della vostra giovinezza e del mio amore per l’anima vostra, sposa mia » — Recordatus sum tui, miserans adolescentiam tuam, et caritatem desponsationis tuæ (IEREM. II, 2). Io mi sono ricordato, anima infedele, ed ho richiamato alla tua memoria la tua prima età, durante la quale io, tuo Dio, non già per riguardo alla bellezza, o alla sapienza, o alla ricchezza, o ad altro tuo merito, ma per pura mia misericordia ho preso te in mia sposa, te debole, povera, inferma; ti ho tratta a me e protetta e dotata del battesimo, della scienza cristiana, della grazia, ecc.; ti ho vestita di abiti preziosissimi e ornata di splendentissimi brillanti, affinché tu mi serbassi la fedeltà che le spose devono ai loro sposi… « È vantaggioso per l’uomo, dice Geremia, ch’egli porti il giogo del Signore fino dall’adolescenza » — Bonum est viro cum portaverit iugum ab adolescentia sua (Lament. III, 27). Portare il giogo del Signore, vuol dire obbedire alle sue leggi e ai suoi precetti, accettare gli obblighi che importa il servizio di Dio; essere umile, dolce, paziente nelle contrarietà. Colui che si è sottoposto al giogo del Signore fino dai primi anni, e che ha diretto, col freno di una savia moderazione, la sua giovinezza, riuscirà, dice S. Ambrogio, a vincere le proprie passioni: dominerà i suoi sensi, e terrà in freno le concupiscenze della carne; saprà discernere e sradicare le cattive inclinazioni del proprio cuore, godrà tranquillità e pace. Il giogo potente e amabile del Signore porta a desiderare Dio e cercarlo; se la gioventù, quasi indomabile, si mette sotto questo giogo, tutto le diventa facile, dolce e piacevole (In Psulm. CXVIII, serm. IX). Per mezzo del giogo del suo servizio, Dio doma la gioventù, la mantiene in piedi, la preserva dalle cadute pericolose, la rende dolce, l’informa al bene e finalmente la perfeziona. Egli suole alleggerire il suo giogo e far sì che vi si gusti la vera felicità, colmando di grazie e di consolazioni quelli che lo portano, secondo la parola di Gesù Cristo medesimo: « Dolce è il mio giogo, soave il mio peso — Iugum meum suave est et onus meum leve (MATTH. XI, 30). Quanto saggia e generosa è l’anima la quale fu educata di buon’ora alla scuola di Gesù Cristo, e volle conservarsi veramente libera, sottoponendosi al giogo divino, oppure geme di aver passato alcuni giorni fuori di questa disciplina, che è principio di vita e di forza! Quest’anima eroica è ferma nel proposito di sottoporsi e consacrarsi fino alla morte al servizio del Signore nel silenzio, nella pazienza, nella rassegnazione; senza mai scuotere il suo giogo e astenendosi da ogni mormorazione; poiché l’anima la quale cerca di liberarsi di questo giogo, lo porta a malincuore, lo trascina e lo abborre; e allora essa ne è schiacciata, e perde ogni merito… Buona cosa è avvezzarsi da giovani alla disciplina, alla mortificazione, all’austerità, alla pazienza, alla pratica della virtù, in una parola al servizio di DIO. È questa la via che conduce alla salute eterna e a grande perfezione. Dalla loro infanzia Sansone e Samuele si astennero dal vino e da ogni bevanda fermentata e furono consacrati Nazarei. In età tenerissima, S. Giovanni Battista si ritirò nel deserto, vestì il cilizio, si cibò di locuste, e meritò di essere il precursore e il martire di Gesù Cristo. Il Salvatore divino cominciò dal presepio a praticare la povertà e l’obbedienza, a menare una vita di stenti e a prepararsi alla croce. Egli di se stesso diceva, per mezzo del profeta: « Menai vita travagliata e povera fin dai giorni della mia giovinezza » — Pauper sum ego et in laboribus a iuventute mea (Psalm. LXXXVII, 16). Gesù ama l’infanzia che lo serve, dice S. Leone, quell’infanzia ch’egli assunse nell’anima e nel corpo suo. Gesù ama l’infanzia che è un modello di umiltà, d’innocenza, di dolcezza. Gesù ama l’infanzia, secondo la quale informa i costumi ed a cui riconduce la vecchiaia, e che propone per esempio a quelli che chiama a entrare nel regno dei cieli (Serm. in Ephiph. n. 7). Dove trovare utilità eguali a quelle che s’incontrano nel servizio di Dio accettato fin dalla giovinezza? Sapete che cosa vuol dire servire Dio dalla gioventù? Vuol dire conservare la propria innocenza e purità; essere nelle grazie di Dio, avere Dio in noi stessi, i suoi favori, le sue benedizioni; vuol dire non perdere mai il prezioso tesoro del battesimo e rimanere fedeli ai sacri impegni quivi contratti; vuol dire avanzare di virtù in virtù e aumentare ogni anno, ogni giorno, ogni ora, i propri meriti e la propria corona; vuol dire conservare la pace del cuore e prepararsi ineffabili conforti, assicurare la propria salvezza, restare tempio dello Spirito Santo, ornato di tutti i suoi doni; mostrarsi degno membro di Gesù Cristo, riuscire vincitore dell’inferno, del mondo, di noi medesimi; vuol dire cominciare su la terra la vita degli Angeli, e gustare un saggio anticipato delle ineffabili delizie della città celeste; vuol dire essere la consolazione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, di Maria, degli Angeli, dei santi, della Chiesa, della società, della famiglia; spargere dappertutto il buon odore di Gesù Cristo e invitare col proprio esempio, gli altri a fare lo stesso, a schivare il peccato,, a praticare la virtù e a santificarsi. Felice nel tempo e nell’eternità quel giovane che serve al Signore con tutto il cuore e con tutta l’anima e con tutte le forze e che persevera in questo dolce e salutare servizio!
4. MOTIVI DI SERVIRE DIO NELLA GIOVENTÙ: 1° perché questa età passa presto. — Che cosa è la gioventù? un’età che passa come il fiore sbocciato la mattina, appassito la sera; come leggero vapore, o goccia di rugiada al comparire del sole; come sogno, o baleno, o volò di uccello… Che cosa sono tutte le età, prese ad una ad una? Che cosa è la vita intera, paragonata all’eternità? Per quanti poi la giovinezza è l’ultima età della vita? Quanti devono dire con Ezechia, re di Giuda: Sul fine dei miei anni discendo nel sepolcro… La mia vita fu tolta e piegata ad un tratto, come la tenda di un pastore: fu troncata come la tela del tessitore. Mentre io era tuttavia sul crescere, la mano del Signore mi ha reciso; dal mattino alla sera i miei giorni ebbero fine. Speravo di vedere ancora l’aurora del giorno seguente, ma il male stritolò come leone le mie ossa (ISAI. XXXVIII, 10, 12 – 13)? Oh, di quante persone si può dire quello che Geremia diceva del popolo di Gerusalemme: « Il sole tramontò per lui, mentr’era ancora giorno alto » — Occidit ei sol, eum adhuc esset dies (XV, 9)! – Se volete sapere perché mai una morte prematura abbia colpito quel giovane virtuoso, aprite la Sapienza al capo IV, e vedrete che siccome egli piaceva a Dio, perciò Dio lo amò più degli altri e lo tolse di mezzo ai peccatori fra cui viveva, affinché la malizia non gli traviasse l’intelletto e l’illusione non gli guastasse il cuore. Poiché molto facilmente avviene che l’uomo semplice e aperto sia colto al laccio della frivolezza dei beni e dell’incostanza dei desideri terreni. Consumato in pochi giorni, tuttavia visse molto e perché la sua anima piaceva a Dio, egli si affrettò a toglierlo dalle iniquità del secolo. Ma la gente vede e non comprende; non pensa che la grazia e la misericordia del Signore piovono sopra i suoi santi, e il suo sguardo si posa su di loro. Il giusto morto condanna gli empi vivi; ed una santa gioventù rapidamente trascorsa è rimprovero alla vecchiezza del malvagio (Sap. IV, 10-16). Perché poi altre volte la morte abbatte, non meno prematuramente, quel giovane corrotto ed empio? Sebbene siano impenetrabili i segreti di Dio, che noi dobbiamo adorare e non scrutare, ci è però lecito asserire che questo avviene: 1 ° in punizione della sua rea condotta…; 2 ° perché non prolunghi di più la catena delle iniquità e non accresca di più il già troppo terribile conto che ha da rendere a Dio … ; 3 ° per mettere un fine agli scandali che semina …; 4° perché serva d’esempio ai suoi coetanei; ai savi affinché perseverino, ai dissipati perché si convertano…; 5 ° perché era maturo per l’inferno. Ah! la brevità della giovinezza grida ad alta voce ai giovani la necessità di consacrare quest’età al servizio del Signore.
2° Perché quale è la gioventù, tali sono le altre età. — « La vostra vecchiezza ricopierà gli anni della vostra gioventù », dice i l Signore: — Sicut dies iuventutis tuæ, ita et senectus tua (Deuter. XXXIII, 25). «L’adolescente, dice il Savio, continuerà la strada per la quale si è messo e non ne uscirà nemmeno da vecchio » — Adolescens iuxta viam suam, etiam cum senuerit non recedet ab ea (Prov. XXII, 6). « Le ossa dell’empio, scrive Giobbe, saranno penetrate dei vizi della sua giovinezza, e se li porterà con sé nella polvere della tomba » — Ossa eius implebuntur vitiis adolescentiae eius, et cum in pulvere dormient (XX, 11). Un vaso di terra, come nota S. Gerolamo, mantiene a lungo, ed alcune volte anche per sempre, dice il poeta, l’odore del liquore di cui fu riempito l a prima volta.
3° Perché questa età è la più esposta al male. — Chi negherà che la gioventù sia un’età piena d’ignoranza, d’inesperienza, di debolezza, di presunzione? Quattro motivi spingono il demonio a muovere più accanita guerra alla gioventù, che non alle altre età, e sono: 1) perché sa che Dio ama di speciale amore la gioventù pia e costumata; perciò egli si adopera mani e piedi per rubare al Signore l’incantevole fiore dell’età e della virtù; 2) perché con questo mezzo egli trascina incatenate per la strada del peccato, tutte le età seguenti…; 3) perché è più facile adescare i giovani … 4) perché quando sono caduti nel vizio, i giovani vi si immergono perdutamente… Anche il mondo e la carne fanno ai giovani guerra più crudele che non agli altri, come l’esperienza c’insegna. « La gioventù, scrive S. Basilio, è molto leggera e assai proclive al male; ora sono concupiscenze indomite e sfrenate, ora collere bestiali e crudeli. Maldicenza di parole, petulanza di tratto, arroganza di risposte, boria e fasto figlio dell’orgoglio, uno sciame insomma di vizi ronza continuamente attorno, e assale e morde l’età giovanile (Homil. in Psalm.) ». Ora se i giovani sono esposti a tanti pericoli e scogli, a tante tentazioni e passioni, ed hanno poco o nulla di esperienza, non è forse cosa estremamente utile e necessaria che si consacrino al servizio di Dio, se vogliono scampare a certo naufragio?
4° Perché questa età appartiene in modo speciale a Dio. — Certamente tutte le età appartengono al supremo padrone di tutte le cose, ma per titolo specialissimo a Lui appartiene la giovinezza che rappresenta le primizie della vita dell’uomo e ognuno sa che le primizie furono in ogni tempo e luogo offerte al Signore… I bei fiori di primavera e principalmente i primaticci, sono sempre i più belli, i più graditi, i più preziosi, i più ricercati, e noi preferiamo questi quando vogliamo fare un regalo a persona cara. Ora l’età giovanile è il più eletto fiore del giardino del Signore; a Lui dunque bisogna consacrarla… Sul fiore dell’età, Gesù Cristo diede la sua vita per la salute del mondo; a questo pensiero, chi non consacrerà al divin Redentore questa parte della sua vita? … La gioventù non ci appartiene; toglierla o negarla a Gesù Cristo, è un furto che noi gli facciamo.
5. È COSA VERGOGNOSA LO SCIUPARE LA GIOVINEZZA. – La maggior parte dei giovani si avviano per una cattiva strada e vanno dicendo: Darò la mia gioventù al piacere e la vecchiaia alla penitenza; la gioventù concederò all’ozio ed alle passioni, la vecchiezza al lavoro e alla virtù; sacrificherò la giovinezza alla carne, al mondo, al demonio, la vecchiaia consacrerò all’anima e a Dio … Che insulto a Dio, che vergogna per l’uomo è mai questa, di dare al diavolo il fiore e il frutto della vita, serbando a Dio il gambo fatto strame! Dove trovare insensatezza più stupida che questa, di sciupare nell’ozio e nella mollezza un’età atta al lavoro, e costringere ad una fatica troppo pesante, l’età fatta per il riposo! Come si regola l’uomo prudente, negli affari del secolo? Egli dice: bisogna che cerchi, nel vigore dell’età, a procacciarmi dei mezzi per passare tranquillo i miei ultimi giorni. Ora perché non si fa altrettanto, trattandosi dell’affare dell’anima?… Che spaventoso pericolo non è quello di chi si abbandona al disordine, nella vana e incerta speranza, prima di una lunga vita, poi di avere il tempo necessario alla penitenza!… Alla gioventù tocca preparare, dice Seneca, alla vecchiaia godere: — Iuveni parandum, seni utendum (Prov.). – Grave imprudenza e mostruosa ingratitudine è abbandonare e offendere Dio nella giovinezza. A chi si diporta in tale maniera, sono diretti quei rimproveri di Geremia: « Tu hai dunque abbandonato il Signore Dio tuo nel tempo in cui ti guidava per la strada. Ed ora che cosa ti giova l’aver lasciato la sorgente di acqua viva, per bere il fango delle passioni e del mondo? La tua malizia insorgerà ad accusarti e la tua avversione si leverà a rimproverarti. Vedi una volta e comprendi quanto sia per te funesta e amara cosa l’esserti allontanato dal Signore Dio tuo e non avere più il suo timore. Tu hai rotto le mie catene, hai spezzato il mio giogo, gridando: Non servirò! » (IEREM. II, 17-20). – E non sono pochi, purtroppo, questi giovani che furono divorati dal fuoco delle passioni, che deviarono dal retto cammino fin dalla prima età e s’impigliarono nell’errore fino dall’infanzia: — Iuvenes comedit ignis (Psalm. LXXVII, 63). — Alienati sunt peccatores a vulva, erraverunt ab utero (Id. LVII, 3). Della maggior parte dei giovani si può dire con Baruch, che videro il lume, eppure vissero di vita carnale; ignorarono la strada della sapienza, non ne conobbero il sentiero: la rigettarono, ed essa si allontanò da loro (III, 20-21). – « O giovani, dice il Signore, e fino a quando amerete voi le fanciullaggini? fino a quando gli insensati brameranno quello che loro è nocevole, e gli imprudenti volgeranno il tergo alla scienza? » — Usquequo, parvuli, diligitis infantiam? et stulti ea, quæ sibi sunt noxia, cupient, et imprudentes odibunt scientiam? (Prov. I , 22). Fino a quando avrete voi in uggia la scienza della virtù e della salute, e farete buon viso alle frivolezze, ai giuochi, all’ozio, all’infingardaggine, al peccato, alla morte?… « Credete voi di trovare, domanda. VEcclesiastico, nella vostra vecchiaia, quello che non avrete raccolto nella giovinezza? » — Quæ in iuventute tua non congregasti, quomodo in senectute tua invenies? (XXV, 5). Dove sono, ahimè! i giovani che abbiano conservato la loro innocenza? dove trovare giovani umili, modesti, casti, docili, saggi, edificanti? Come ne è piccolo il numero! come grande, al contrario, è la folla di quelli che perdettero così bella virtù!…
6. CASTIGHI MINACCIATI A QUELLI CHE NON SERVONO IL SIGNORE DA GIOVANI. — « Godi pure, o giovane, nei giorni della tua adolescenza, sfoga ogni tuo capriccio, ma sappi che di tutte queste cose Dio ti chiederà conto » — Lætare, iuvenis, in adolescentia tua, ambula in viis cordis tui, et in intuitu oculorum tuorum; et scito quod prò omnibus his adducet te Deus in iudicium (Eccle. X I , 9). « I ragazzi, lamenta Geremia, furono trascinati in schiavitù dinanzi alla faccia del dominatore » — Parvuli ducti sunt in captivitatem, ante faciem tribulantis (Lament. I, 5), cioè innanzi al demonio, come spiegano gli interpreti. E il profeta Baruch: «Non presero la via della sapienza, perciò perirono » — Neque viam disciplinæ invenerunt, propterea perierunt (III, 27). Ecco finalmente come lo Spirito Santo descrive, per bocca di Giobbe, i castighi che seguono una giovinezza colpevole: « Signore, voi mi avete amareggiato sino al fondo dell’anima, e mi avete fatto vittima dei trascorsi della mia adolescenza. Voi avete posto ai miei piedi degli intoppi, e avete notato tutti i mei procedimenti; io sarò divorato come corpo roso da cancro, come veste consumata dalla tignuola » (IOB. XIII, 26-28). – Da queste parole della Scrittura si deduce che Dio minaccia alla gioventù viziosa i seguenti castighi: 1° l a peggiore fra le schiavitù, quella del diavolo; 2° l’amarezza del rimorso; 3° una rovina totale; 4° una morte spaventosa; 5° un giudizio terribile … Che disgrazia perdere l’innocenza, la bella età, la virtù, l’anima e Dio! … Che tremendo castigo essere venduto al vizio e al demonio!…
7. MEZZI PER SERVIRE DIO DALLA GIOVINEZZA. — Sono molti i mezzi che ci conducono a servire Dio e a correggerci dei nostri difetti dalla giovinezza.
1° L’osservanza della legge divina. « In qual modo può mai la gioventù emendare i suoi costumi? », domanda il Salmista, e risponde: « Con l’osservare i precetti del Signore » — In quo corrigit adolescentior viam suam? in custodiendo sermones tuos (Psalm. CXVIII, 9).
2° Il ricordo di Dio. « Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza », leggiamo nell’Ecclesiaste: — Memento Creatoris tui in diebus iuventutis tuæ (XII, 1).
3° Il timore di Dio. Tobia insegnò al suo figliuolo a temere Dio dall’infanzia e ad astenersi da ogni peccato: — Filium ab infantia timere Deum docuit, et abstinere ab omni peccato (TOB. I, 10).
4° La prudenza. « Uscite dall’infanzia e vivete e camminate per le vie della prudenza », si legge nei Proverbi: — Relinquite infantiam, et vivite; et ambulate per vias prudentiae (IX, 6).
5° L’istruzione cristiana. « Figlio mio, dice il Savio, ricevi l’istruzione dai tuoi primi anni, e troverai la sapienza fino agli ultimi » — Fili, a iuventute tua excipe doctrinam, et usque ad canos invenies sapientiam (Eccli. VI, 18).
6° Preporre Dio ad ogni cosa, e ricordarsi che l’anima è il più prezioso tesoro affidato alla custodia dell’uomo…
7° Amare di cordiale e tenero affetto la Beata Vergine Maria, raccomandarsi a lei tutti i giorni e non lasciarne passare un solo, senza prestarle qualche particolare omaggio.
8° Non tenere mai sulla coscienza un peccato mortale; ma pentirsi ogni giorno delle colpe commesse e confessarsene al più presto.
9° Pensare sovente alla morte e considerare che, dopo morte, chi fu morigerato da giovane sarà eternamente felice con Dio e con i santi; che al contrario chi dimentica Dio nell’aurora della sua vita, ha tutta la ragione di temere di perdersi eternamente…
10° Rispettare se medesimo e in pubblico e in privato.
11° Fare tutte le azioni come se fossimo sotto gli occhi di rispettabili persone.