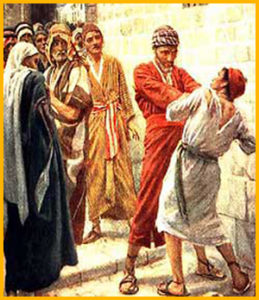Omelia della Domenica VI dopo l’Epifania
[Del canonico G. B. Musso – Seconda edizione napoletana, Vol. I -1851-]
(Vangelo sec. S. Matteo XIII, 31-35)
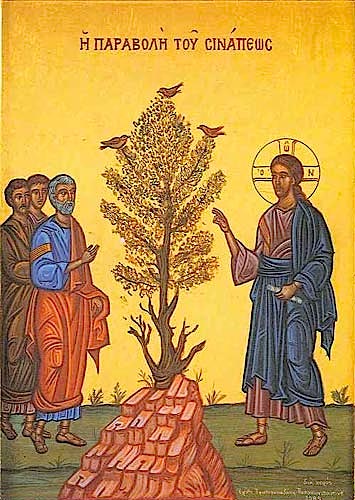
La Santa Chiesa.
Il regno dei cieli è simile ad un grano di senapa, che sebbene fra i semi ordinari, pure seminato in buon terreno, massime nella fertile regione della Palestina, spunta in germoglio, cresce in albero, si estende in rami sì robusti e frondosi, che volano ad abitarvi gli uccelli dell’aria. “Simile est regnun coelorum grano sinapis … quod minimum est omnibus seminibus”, con quel che segue nell’odierno Vangelo. Or perché mai al grano più picciolo viene paragonato il regno de’ cieli? E che va inteso per regno de’cieli? “Regnum coelorum”, risponde il magno Gregorio, “praesentis temporis Ecclesia dicitur” (Hom. 11 in Evang.), regno de’ cieli, si chiama la Chiesa da Gesù Cristo fondata nel tempo presente, e che durerà fino alla consumazione dei secoli: e si paragona ad un piccolo granello di senapa cresciuto in una gran pianta, per significare l’umile principio, e poscia l’ingrandimento della medesima Chiesa. L’umile principio della Chiesa nascente fa vedere la mano di Dio, che la fondò: l’esaltamento della Chiesa in ogni tempo fa conoscere la mano dì Dio, che la difese. Due riflessioni, signori amatissimi, su cui penso intrattenere la vostra pietà. Si tratta di un argomento in cui vedremo le divine qualità che caratterizzano la Chiesa nostra madre per vera sposa di Gesù Cristo, da Lui fondata, da Lui difesa: argomento interessante, che tutto deve richiamare l’attenzione de’ veri suoi figliuoli.
I . La difficoltà dell’opera, la debolezza dei mezzi fan conoscere quanto umile, quanto abbietto, secondo le umane vedute, fosse il principio della Chiesa nascente, e quanto la mano di Dio vi risplendé. – Viene Gesù Cristo al mondo, e si propone ed annunzia un disegno il più strano, il più inaudito. In tutta la terra regna l’idolatria. Le passioni più vergognose, i vizi più abominevoli sono autorizzati dal culto superstizioso di falsi dèi, infetti anch’essi, e celebri per ogni sorta d’iniquità. Gesù Cristo altamente dichiara esser venuto a rovesciar ogni idolo, ed atterrar ogni tempio a loro consacrato: esser venuto a confondere la scienza de’ filosofi, la superbia dei grandi, gli errori di tutti: esser venuto ad abolire le superstizioni, a togliere i vizi, a riformare i costumi, ed a piegar tutti i popoli ad una nuova credenza, e riunirli sotto una medesima legge. In formar questo disegno non ignora nulla esservi di più difficile, che il cambiamento di religione, e allora più, quando una religione radicata da secoli, una religione comoda, confacente alla corrotta natura, che, lungi dall’opporsi, autorizza e consacra le più vili passioni, e le più sfrenate dissolutezze. Tutto sa, tutto prevede, e a vista di tanti ostacoli non si arresta dal concepito disegno. – Convien dire, o essere impossibile la riuscita, o Colui che la si promette, abbia in mano dei mezzi straordinari, possenti, da sperarne felice succedimento. Appunto, i mezzi sono in sua mano; ma oh quanto diversi da quel che l’umana sapienza avrebbe creduto adoperare! I mezzi più disadatti, più contrari all’intento furono gli scelti da Gesù Cristo. Nato egli in un angolo della Giudea in una capanna da povera Madre, reputato figlio di un fabbro, dimorante fino ai trenta anni in una vile bottega, esce dalla sua vita nascosta per cominciar la grand’opera della riforma del mondo. Chiama in aiuto all’ardua impresa dodici plebei senza credito, senza scienza, dodici poveri pescatori, e lor fa intendere che nel seguirlo non cesseranno di esser poveri; che anzi, se voglion essere suoi discepoli, dovranno rinunziare per fin la speranza di ogni bene terreno. Lungi dall’allietarli con qualche umana promessa, si spiega loro chiaramente, che altro non potranno aspettarsi, che persecuzioni, catene, tormenti e morte. Sono ben dolci e lusinghiere siffatte promesse! e pure si uniscono a Lui questi uomini, e fedelmente lo seguono fino alla morte. – Muore Gesù, e colla morte dell’autore doveva naturalmente perire un’opera cominciata da sì pochi anni, sì poco avanzata, e sostenuta sì poco. Muore Gesù, e di qual morte? Muore come un seduttore, come uno scellerato, ed è sepolto. – Chi non direbbe che il suo gran progetto è insieme con Lui seppellito. Così all’umana vista doveva comparire, così si lusingava la perfida Sinagoga; ma no, il grano della senapa sepolto sotterra spunterà fra poco, e crescerà in pianta perfetta. I dodici pescatori rivestiti di una virtù che viene dall’alto, e di una forza invincibile alzanp la voce nelle piazze di Gerosolima, nelle contrade della Giudea e della Samaria, si spargono in tutte le parti dell’universo, predicano Gesù Cristo crocefisso e risorto, confermano coi miracoli la verità del suo risorgimento, la divinità di sua Persona, la purità di sua dottrina ed ecco la faccia della terra tutta cangiata. La luce del Vangelo ha aperto gli occhi alle nazioni sedenti in tenebre ed ombre di morte. La pagana superstizione fugge come la notte allo spuntar del sole, gl’idoli sono infranti, i templi sono distrutti, i vizi sbanditi, i costumi riformati, la Cristiana Religione riconosciuta la vera, il suo Fondatore adorato, la sua Croce esaltata, e dal luogo de’ supplizi passata ad ornare la corona e la fronte dei re e degl’imperatori. “A locis suppliciorum ad frontes imperatorum” (S. Agost. In Ps. XXXVI, ver. 2). – Or io domando, chi ha cambiato l’umano intelletto, chi l’à fatto piegare a credere dogmi inauditi, dogmi che sembrano rivoltare l’umana ragione? Chi ha cambiato il cuor dell’uomo corrotto dalle più sozze passioni, e gli ha fatto abbracciare una Religione sì severa, che esige la più grande purezza di opere, di affetti e di pensieri? Che proibisce uno sguardo men puro, un desiderio men retto? La mano di Dio, che nella elezione degli Apostoli ha impiegati i mezzi più deboli, più inetti, ma resi idonei e forti nella possente sua grazia a propagare e stabilir la sua fede, e a suggellarne la testimonianza col proprio sangue: la mano di Dio, che per tal mezzi ha voluto stampare in fronte alla sua Chiesa i più luminosi caratteri della verità. Ed ecco la pianta della Chiesa, nata da sì picciolo seme, che ha estesi i suoi rami dall’uno all’altro confine del conosciuto mondo. Ed oh su questi rami, quanti dal gentilesimo, quanti dall’ebraismo sono volati! Quanti eroi della fede vi han posta loro dimora, quanti fiori di martiri hanno abbellita pianta sì degna, quanti fiori di vergini l’anno adornata, quanti frutti di santi dottori, di confessori, di pontefici l’hanno arricchita! È vero che questa pianta dalle persecuzioni de’ tiranni, dall’odio de’ pagani, dal furore degli eretici, come da tanti turbini è stata in ogni tempo agitata e sconvolta; ma quel Dio che la piantò, quel Dio a cui ubbidiscono il mare e i venti e le procelle, ha sempre stesa la sua mano a difenderla, per modo che le porte di averno mai prevalessero ad atterrarla; anzi, geloso dell’onor della sua Sposa, scaricò in tutti i tempi con esemplare vendetta i colpi tremendi della sua destra sopra chiunque ardì di farli oltraggio. Aprite le storie, saggi ascoltanti, e vedrete l’esaltazione della Chiesa nella depressione dei suoi nemici, nemici i più potenti del secolo, gli imperatori idolatri. Ed è ben giusto a gloria della nostra madre rammentare i castighi di chi l’oltraggiò. – Nerone (Tacit. Sveton. Eutrop.), il cui solo nome presenta un’idea della più mostruosa crudeltà, il primo e forse il pessimo fra i persecutori della fede di Cristo, venuto in odio al senato, al popolo romano, al mondo tutto, cercato a morte, fugge travestito, e per non cader nelle mani di quei che l’inseguono, da se stesso si uccide. Non poteva trovare miglior carnefice. Domiziano (Sveton. Philostr.) anch’esso da tutti odiato per la sua barbarie, più non si soffre sul trono, e vien ucciso. Ne esulta il senato romano, e fa gettar a terra le sue statue, e cancellare dovunque ogni sua memoria: il suo cadavere si lascia in man de’ becchini, che lo sotterrano con contumelie a foggia d’infame gladiatore. Ascrive Massimino (Victor. Iul. Capitolin. et alii) ai cristiani la cagione de’ fulmini, de’ tremuoti e di tutte le disavventure dell’impero, e ne fa strage; e strage fanno di lui e di suo figlio i suoi soldati. Le loro teste son poste sulla punta di un’asta, i loro corpi gettati alle fiere. Si accende d’ira Decio (Sextus Aurelius) ed infierisce contro la religione cristiana in vederla tanto più dilatata, quanto più oppressa; e in una battaglia contro i Goti spinge il cavallo in una palude, vi resta sommerso, e più non se ne trova il cadavere. Valeriano (Costant. Magnus in orat. ad s. coetum c. 24) quanto zelatore dei culto dei falsi dèi, tanto nemico di quello di Cristo, dopo tre anni di fiera persecuzione, vinto in guerra, cade in potere di Sàpore re dei Persiani, che per avvilirlo all’estremo si serve della sua schiena ogni volta che monta a cavallo. – Sparse Aureliano (Voscus et Eusebius in Chron. Costant. ut supra) a torrenti il sangue dei fedeli; e del suo sangue si videro sparse le strade, trucidato dai suoi familiari. Chiuso da stretto assedio nella città di Marsiglia l’empio e sanguinolento Massimiano Erculeo (ibid.), disperato si sospende ad un laccio. Sotto l’impero del crudelissimo Diocleziano (Victor apud Baonium) in un sol mese si miete la vita di sette mila martiri, ed egli in vedere per tanta strage aumentarsi vie più il numero dei cristiani, divorato da diabolico livore, ha in odio la vita e se la toglie con potente veleno. Che diremo finalmente dell’apostata Giuliano? (Theodoretus lib. 4 hist. c. 25) Quest’empio restauratore del paganesimo, protettore degli ebrei da lui animati a riedificare Gerusalemme per render vana la profezia di Gesù Cristo, dopo lunga tirannia si protesta voler distruggere dai fondamenti la chiesa santa di Dio; ma nella guerra contro i Persiani, dalla prima saetta scoccata a colpo incerto, vien trafitto nel petto e nel polmone, e preso un pugno del proprio sangue, gettandolo verso il cielo, confessa esser vinto da Cristo, che per insulto chiamava il Galileo, “Galilee, vicisti”. – Vani furono dunque gli sforzi delle potestà d’ogni secolo contro l’opera del Signore. Perirono, e periranno i nemici della religione e della Chiesa, come fumo in faccia al vento: essa non perirà giammai. Della sua stabilità tien solenne promessa dall’infallibile verità del divino suo Capo. La religione cristiana porta in volto caratteri così sensibili e luminosi della protezione dell’Altissimo, che bisogna esser ciechi per non conoscerli. Se questo edificio fosse stato fabbricato sull’arena, in forza cioè d’umane opinioni e raggiri, come avrebbe potuto tenersi saldo all’impeto furibondo di tanti turbini, che da ogni lato l’hanno spinto colla maggior violenza di cui è capace l’odio, il furore, la nequizia, la prepotente empietà! Se la religione, disse già sensatamente Gamaliele, dottor della legge, ai capi dell’ebraismo radunati in concilio, se la religione che predicano questi scalzi pescatori, è opera d’uomini, e fanatismo di mente alterata, svanirà fra pochi dì da sé stessa. Se ella è opera di Dio, i vostri ostacoli per impedirla non serviranno che a promuoverla. Così avvenne, e così avverrà sino alla consumazione de’ secoli. Le opinioni degl’increduli, i sofismi degli atei, dei deisti, dei sedicenti filosofi, saranno in ogni tempo come i flutti d’un mare spumoso che si rompono a piè di scoglio saldissimo; saranno come le acque del diluvio portanti in alto l’arca di Noè; saranno come venti e tempeste, che possono bensì agitare la navicella di Pietro, ma non hanno forza di sommergerla. Dorme talora, e par che dorma Gesù; e l’empietà per qualche tempo minaccia naufragio, ma poi si sveglia, e ad un suo cenno tacciono i venti, svanisce la procella, ed il protetto naviglio galleggia sull’umiliato mare. E un prodigio di tal natura, manifesto, stupendo non l’han veduto gli occhi nostri? Rammentiamolo così di volo, fedeli amatissimi, a gloria di Dio e della sua Chiesa. Spogliata questa del temporale suo regno, fatto prigioniero il suo Gerarca, minacciata di guai sempre nuovi e sempre peggiori, oltre ogni umana speranza, l’abbiamo veduta deporre le vesti di lutto, e rivestirsi degli abiti di giocondità e di letizia. Motivi per noi, uditori miei, di stima, di attaccamento, di fedeltà, d’ubbidienza alla nostra Madre la Chiesa santa, di cui siam figli, Chiesa ora militante, soggetta a guerra, ma sempre vincitrice, e poi trionfante nel regno eterno nel divino suo sposo.