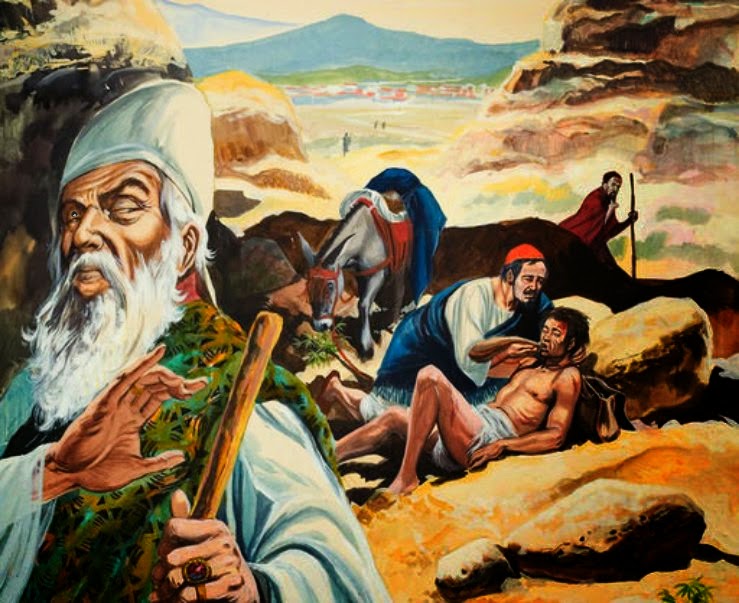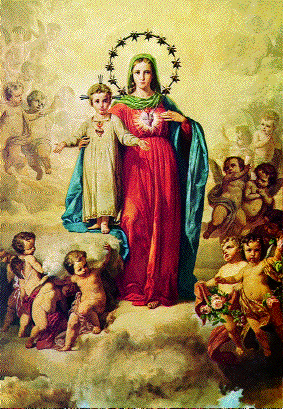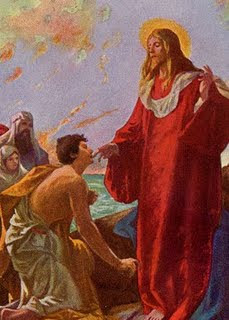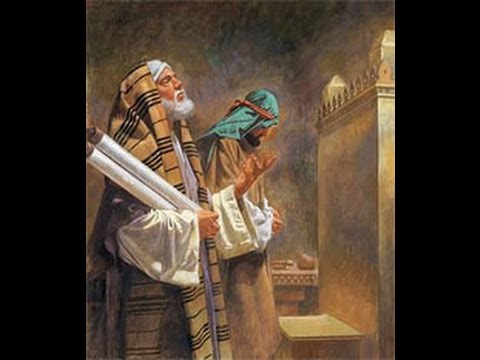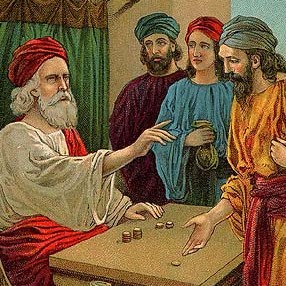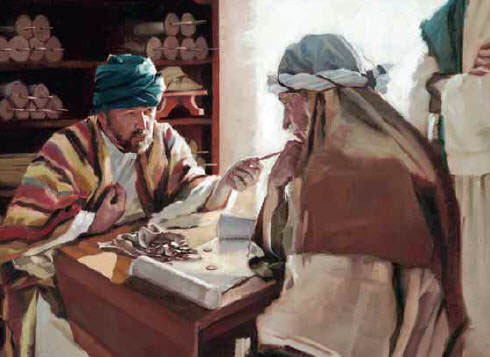
XIV DOMENICA DOPO PENTECOSTE (2022)
(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R. Berruti & C. Torino 1950)
Le Lezioni dell’Officio di questa Domenica sono spesso prese dal Libro dell’Ecclesiastico (Agosto) o da quello di Giobbe (Settembre). Commentando il primo, S. Gregorio dice: « Vi sono uomini così appassionati per i beni caduchi, da ignorare i beni eterni, o esserne insensibili. Senza rimpiangere i beni celesti perduti, i disgraziati si credono felici di possedere i beni terreni: per la luce della verità, non innalzano mai i loro sguardi e mai provano uno slancio, un desiderio verso l’eterna patria. Abbandonandosi ai godimenti nei quali si sono gettati si attaccano e si affezionano, come se fosse la loro patria, a un triste luogo d’esilio; e in mezzo alle tenebre sono felici come se una luce sfolgorante li illuminasse. Gli eletti, invece, per cui i beni passeggeri non hanno valore, vanno in cerca di quei beni per i quali la loro anima è stata creata. Trattenuti in questo mondo dai legami della carne, si trasportano con lo spirito al di là di questo mondo e prendono la salutare decisione di disprezzare quello che passa col tempo e di desiderare le cose eterne ». — Quanto a Giobbe viene rappresentato nelle Sacre Scritture come l’uomo staccato dai beni di questa terra: « Giobbe soffriva con pazienza e diceva: Se abbiamo ricevuti i beni da Dio, perché non ne riceveremo anche i mali? Dio mi ha donato i beni, Dio me li ha tolti, che il nome del Signore sia benedetto ». — La Messa di questo giorno si ispira a questo concetto. Lo Spirito Santo che la Chiesa ha ricevuto nel giorno di Pentecoste, ha formato in noi un uomo nuovo, che si oppone alle manifestazioni del vecchio uomo, cioè alla cupidigia della carne e alla ricerca delle ricchezze, mediante le quali può soddisfare la prima. Lo Spirito di Dio è uno spirito di libertà che rendendoci figli di Dio, nostro Padre, e fratelli di Gesù, nostro Signore, ci affranca dalla servitù del peccato e dalla tirannia dell’avarizia. « Quelli che vivono in Cristo, scrive S. Paolo, hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e bramosie. Camminate, dunque, secondo lo Spirito e voi non compirete mai i desideri della carne, poiché la carne ha brame contro lo Spirito e lo Spirito contro la carne: essi sono opposti l’uno all’altra » (Ep.). Nessuno può servire a due padroni, dice pure Gesù, perchè o odierà l’uno e amerà l’altro, ovvero aderirà all’uno e disprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio e alle ricchezze ». « Chiunque è schiavo delle ricchezze, spiega S. Agostino – e si sa che sono spesso fonte di orgoglio, avarizia, ingiustizia e lussuria – è sottomesso ad un padrone duro e cattivo. (« Forse che questi festini giornalieri, questi banchetti, questi piaceri, questi teatri, queste ricchezze, si domanda S. Giovanni Crisostomo, non attestano l’insaziabile esigenza delle tue cattive passioni? » – 2° Nott., V Domenica di Agosto che coincide qualche volta con questa Domenica). Dio non condanna la ricchezza ma l’attaccamento ai beni di questa terra e il loro cattivo impiego) Tutto dedito alle sue bramosie, subisce però la tirannia del demonio: certamente non l’ama perché chi può amare il demonio? ma lo sopporta. D’altra parte non odia Dio, poiché nessuna coscienza può odiare Dio, ma lo disprezza, cioè non lo teme, come se fosse sicuro della sua bontà. Lo Spirito Santo mette in guardia contro questa negligenza e questa sicurezza dannosa, quando dice, mediante il Profeta: Figlio mio, la misericordia di Dio è grande » (Eccl., V, 5 ),— (Queste parole sono prese dal 1° Notturno della V Domenica di Agosto, che coincide qualche volta con questa Domenica: « Non dire: la misericordia di Dio è grande, egli avrà pietà della moltitudine dei miei peccati. Poiché la misericordia e la collera che vengono da Lui si avvicinano rapidamente, e la sua collera guarda attentamente i peccatori. Non tardare a convertirti al Signore e non differirlo di giorno in giorno: poiché la sua collera verrà improvvisamente e ti perderà interamente. Non essere inquieto per l’acquisto delle ricchezze, poiché non ti sopravviveranno nel giorno della vendetta ») – … ma sappi che « la pazienza di Dio t’invita alla penitenza » (Rom., II, 4). Perché chi è più misericordioso di Colui che perdona tutti i peccati a quelli che si convertono e dona la fertilità dell’ulivo al pollone selvatico? E chi è più severo di colui che non ha risparmiati i rami naturali, ma li ha tagliati per la loro infedeltà? Chi dunque vuole amare Dio e non offenderlo, pensi che non può servire due padroni; abbia egli un’intenzione retta senza alcuna doppiezza. Ed e così che tu devi pensare alla bontà del Signore e cercarlo nella semplicità del cuore. Per questo, continua egli, io vi dico di non avere sollecitudini superflue di ciò che mangerete e del come vi vestirete; per paura che forse, senza cercare il superfluo, il cuore non si preoccupi, e che cercando il necessario, la vostra intenzione non si volga alla ricerca dei vostri interessi piuttosto che al bene degli altri » (3° Nott.). Cerchiamo dunque, prima di tutto il regno di Dio, la sua giustizia, la sua gloria (Vang., Com.); mettiamo nel Signore ogni nostra speranza (Grad.), poiché è il nostro protettore (Intr.); è Lui che manda il suo Angelo per liberare quelli che lo servono (Off.) e che preserva la nostra debole natura umana, poiché senza questo aiuto divino essa non potrebbe che soccombere (Oraz.). L’Eucarestia ci rende Dio amico (Secr.) e, fortificandoci, ci dà la salvezza (Postcom.). Cerchiamo, dunque, prima di tutto di pregare nel luogo del Signore (Vers. dell’Intr.) e di cantarvi le lodi di Dio, nostro Salvatore (All.); poi occupiamoci dei nostri interessi temporali, ma senza preoccupazione.
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Confíteor
Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.
S. Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.
R. Amen.
S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.
R. Amen.
V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.
R. Et plebs tua lætábitur in te.
V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
R. Et salutáre tuum da nobis.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Introitus
Ps LXXXIII: 10-11.
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super mília.
[Sei il nostro scudo, o Dio, guarda e rimira il tuo Consacrato: poiché un giorno passato nel tuo luogo santo vale più di mille altri].
Ps LXXXIII: 2-3
V. Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini.
[O Dio degli eserciti, quanto amabili sono le tue dimore! L’ànima mia anela e spàsima verso gli atrii del Signore].
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super mília.
[Sei il nostro scudo, o Dio, guarda e rimira il tuo Consacrato: poiché un giorno passato nel tuo luogo santo vale più di mille altri].
Kyrie
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
Gloria
Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu ✠ in glória Dei Patris. Amen.
Oratio
Orémus.
Custódi, Dómine, quǽsumus, Ecclésiam tuam propitiatióne perpétua: et quia sine te lábitur humána mortálitas; tuis semper auxíliis et abstrahátur a nóxiis et ad salutária dirigátur.
[O Signore, Te ne preghiamo, custodisci propizio costantemente la tua Chiesa, e poiché senza di Te viene meno l’umana debolezza, dal tuo continuo aiuto sia liberata da quanto le nuoce, e guidata verso quanto le giova a salvezza.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas.
Gal V: 16-24
“Fratres: Spíritu ambuláte, et desidéria carnis non perficiétis. Caro enim concupíscit advérsus spíritum, spíritus autem advérsus carnem: hæc enim sibi ínvicem adversántur, ut non quæcúmque vultis, illa faciátis. Quod si spíritu ducímini, non estis sub lege. Manifésta sunt autem ópera carnis, quæ sunt fornicátio, immundítia, impudicítia, luxúria, idolórum sérvitus, venefícia, inimicítiæ, contentiónes, æmulatiónes, iræ, rixæ, dissensiónes, sectæ, invídiæ, homicídia, ebrietátes, comessatiónes, et his simília: quæ prædíco vobis, sicut prædíxi: quóniam, qui talia agunt, regnum Dei non consequántur. Fructus autem Spíritus est: cáritas, gáudium, pax, patiéntia, benígnitas, bónitas, longanímitas, mansuetúdo, fides, modéstia, continéntia, cástitas. Advérsus hujúsmodi non est lex. Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixérunt cum vítiis et concupiscéntiis.”
[“Fratelli: Camminate secondo lo spirito e non soddisferete ai desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito contrari alla carne: essi, infatti, contrastano tra loro, così che non potete fare ciò che vorreste. Che se voi vi lasciate guidare dallo spirito non siete sotto la legge. Sono poi manifeste le opere della carne: esse sono: la fornicazione, l’impurità, la dissolutezza, la lussuria, l’idolatria, i malefici, le inimicizie, le gelosie, le ire, le risse, le discordie, le sette, le invidie, gli omicidi ecc. le ubriachezze, le gozzoviglie e altre cose simili; di cui vi prevengo, come v’ho già detto, che coloro che le fanno, non conseguiranno il regno di Dio. Frutto invece dello Spirito è: la carità, il gaudio, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, la mansuetudine, la fedeltà, la modestia, la continenza, la castità. Contro tali cose non c’è logge. Or quei che son di Cristo han crocifisso la loro carne con le sue passioni e le sue brame”].
C’è una lotta, una guerra formidabile, una battaglia che si combatte fieramente e dappertutto e sempre: si combatte in ciascuno di noi. Per un misterioso congegno, noi, siamo due in uno e uno in due. Siamo, lo sanno tutti, anima e corpo, ma corpo e anima pur insieme uniti come sono a formare un sol uomo, rappresentano ciascuno tendenze diverse, addirittura contrastanti. La materia ci trascina nel torbido mondo dei piaceri più bassi: mollezza, ozio, dissipazione, egoismo e poi crudeltà se occorre. La materia ci trascina verso il mondo animale, anzi un mondo animale degenere e corrotto. È un fatto che noi possiamo sperimentare, che sperimentiamo anzi, senza volerlo, in noi stessi. Lo sperimentiamo con un altro fatto, del pari innegabile. Ed è che dentro di noi, contro di noi, contro questi travolgimenti passionali, queste degenerazioni brutali, qualche cosa, qualcheduno protesta; come se si trovasse, perché si trova, a disagio, nel trionfare di queste basse voglie. Questo qualcuno è lo spirito che, dice San Paolo « concupiscit adversus carnem ». Veramente, questa concupiscenza dello spirito, è una frase ardita. La realtà si è che lo spirito ha delle sue voglie, delle sue tendenze, che non sono quelle della carne. E noi sentiamo in noi, nelle ore migliori della vita, una sete di purezza, di sobrietà, di laboriosità, di sacrificio, di dominio della bestia: sogni angelici ci traversano l’anima e ce la attirano verso il cielo. Istinti angelici da quanto sono brutali quegli altri. Istinti che si rafforzano dentro di noi, colla educazione, coll’altrui buon esempio, colla saturità cristiana dell’ambiente in cui siamo chiamati a vivere. Ma istinti ai quali contrasta e maledice il corpo, proprio come contro quelli del corpo eleva l’anima l’istintivo suo veto. In questa lotta è la tragedia della nostra vita morale. È il segreto della nostra debolezza. È per questo che facciamo spesso quello che non vorremmo, che quasi non vogliamo e non facciamo quello che vorremmo. Quanti uomini vorrebbero essere fedeli alle loro mogli, vorrebbero dare esempi luminosi di buon costume ai loro figli… vorrebbero; e intanto, pur riconoscendo che fanno male, che amareggiano il cuore di una povera donna, che dànno cattivo esempio ai figlioli, profanano il santuario domestico e cercano fuori di esso illecite gioie. Quanti giovani si vergognano, si pentono della vita materiale, animalesca che conducono, e intanto non hanno forza di troncarla: « vident meliora, probantque, deteriora sequuntur ». Ma se in questo congegno di lotta interna è il segreto della nostra debolezza, v’è anche quello della nostra gloria. Abbiamo una bella battaglia da vincere. Essere un po’ sulla terra, ancora sulla terra « sicut angeli Dei in cœlo.» Andare verso l’alto, verso il cielo malgrado questa palla di piombo, che, ahimè, portiamo al piede. Gli Angeli nascono Angeli, lo sono: noi dobbiamo diventarlo. – Il Cristianesimo è stato e rimane il grande alleato dello spirito nella lotta contro la carne, Gesù è venuto apposta tra noi per dare man forte allo spirito. E da Lui in poi, e grazie a Lui, la vittoria nonché possibile, è diventata frequente tra i suoi discepoli. L’umanità vede oggi a frotte i cavalieri autentici dello spirito, gli uomini che collo spirito hanno mortificato, compresso i fasti della carne, e si rivelano in questa trionfale spiritualità di vita, si rivelano guidati dallo Spirito di Dio. Aggreghiamoci alla falange dei vincitori, non accodiamoci, codardi, alle orde dei vinti.
P. G. Semeria: Le epistole delle Domeniche, Op. naz. Per il mezzogiorno d’Italia, Milano, 1939.
(Nihil obstat sac. P. De Ambroggi – Imprim. P. Castiglioni vic. Gen. Curia Arch, Mediolani, 1-3-1938)
Graduale
Ps CXVII:8-9
Bonum est confidére in Dómino, quam confidére in hómine.
[È meglio confidare nel Signore che confidare nell’uomo].
V. Bonum est speráre in Dómino, quam speráre in princípibus. Allelúja, allelúja
[È meglio sperare nel Signore che sperare nei príncipi. Allelúia, allelúia].
Alleluja
XCIV: 1.
Veníte, exsultémus Dómino, jubilémus Deo, salutári nostro. Allelúja.
[Venite, esultiamo nel Signore, rallegriamoci in Dio nostra salvezza. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum S. Matthæum.
Matt VI: 24-33
“In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nemo potest duóbus dóminis servíre: aut enim unum ódio habébit, et álterum díliget: aut unum sustinébit, et álterum contémnet. Non potéstis Deo servíre et mammónæ. Ideo dico vobis, ne sollíciti sitis ánimæ vestræ, quid manducétis, neque córpori vestro, quid induámini. Nonne ánima plus est quam esca: et corpus plus quam vestiméntum? Respícite volatília coeli, quóniam non serunt neque metunt neque cóngregant in hórrea: et Pater vester coeléstis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum cógitans potest adjícere ad statúram suam cúbitum unum? Et de vestiménto quid sollíciti estis? Consideráte lília agri, quómodo crescunt: non labórant neque nent. Dico autem vobis, quóniam nec Sálomon in omni glória sua coopértus est sicut unum ex istis. Si autem fænum agri, quod hódie est et cras in clíbanum míttitur, Deus sic vestit: quanto magis vos módicæ fídei? Nolíte ergo sollíciti esse, dicéntes: Quid manducábimus aut quid bibémus aut quo operiémur? Hæc enim ómnia gentes inquírunt. Scit enim Pater vester, quia his ómnibus indigétis. Quaerite ergo primum regnum Dei et justítiam ejus: et hæc ómnia adjiciéntur vobis”.
[“In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Nessuno può servire due padroni: imperocché od odierà l’uno, e amerà l’altro; o sarà affezionato al primo, e disprezzerà il secondo. Non potete servire a Dio e alle ricchezze. Per questo vi dico: non vi prendete affanno né di quello onde alimentare la vostra vita, né di quello onde vestire il vostro corpo. La vita non vale ella più dell’alimento, e il corpo più del vestito! Gettate lo sguardo sopra gli uccelli dell’aria, i quali non seminano, né mietono, né empiono granai; e il vostro Padre celeste li pasce. Non siete voi assai da più di essi? Ma chi è di voi che con tutto il suo pensare possa aggiuntare alla sua statura un cubito? E perché vi prendete cura pel vestito? Pensate come crescono i gigli del campo; essi non lavorano e non filano. Or io vi dico, che nemmeno Salomone con tutta la sua splendidezza fu mai vestito come uno di questi. Se adunque in tal modo riveste Dio un’erba del campo, che oggi è e domani vien gittata nel forno; quanto più voi gente di poca fede? Non vogliate adunque angustiarvi, dicendo: Cosa mangeremo, o cosa berremo, o di che ci vestiremo? Imperocché tali sono le cure dei Gentili. Ora il vostro Padre sa che di tutte queste cose avete bisogno. Cercate adunque in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia; e avrete di soprappiù tutte queste cose”].
Omelia
(G. Colombo: Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi; VI ediz. Soc. Ed. Vita e pensiero – Milano)
FIDUCIA IN DIO
Le parole più rasserenanti del Vangelo forse sono queste che Gesù ora ci rivolge: « Non angustiatevi, come fanno quelli che non han fede, dicendo: cosa mangeremo o cosa berremo o di che cosa ci vestiremo? Il Padre vostro sa quello che vi bisogna ». Com’è consolante sapere che dietro la gigantesca macchina dell’universo, c’è Dio nostro Padre che tutto guida e intanto non distoglie mai da noi suoi figli la dolce mano paterna! Alla sua affermazione Gesù aggiunse tre argomenti perché la nostra convinzione fosse profonda. a) « La vita non vale più del pane e il corpo non vale più del vestito? Se Dio, senza alcun merito o sforzo da parte vostra, vi ha dato la vita e il corpo, a maggior ragione vi darà il cibo e le vesti. b) « E poi guardate gli uccelli dell’aria che non seminano né mietono: sono mantenuti dal Padre celeste. Se mantiene i passeri, trascurerà voi che valete infinitamente di più?… Guardate anche i gigli del campo come crescono senza filare né tessere: sono vestiti dal Padre celeste con un raso bianco che farebbe sfigurare il manto del re Salomone. Se veste i gigli, lascerà voi ignudi, o gente di poca fede? c) « Inoltre, coll’affannarvi, potete forse prolungare d’un giorno la vostra vita al di là del limite stabilito? Come non siete capaci di prolungare la vita, così non siete capaci di mantenerla, se il Padre non provvede per voi ». Infine, Gesù pose la condizione essenziale per ottenere i favori della Provvidenza: « Cercate anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia; e avrete ogni altra cosa per soprappiù ». Eliminiamo subito un’idea erronea che potrebbe già essere nata ascoltando questo brano evangelico: se io ho fede in Dio e nella sua Provvidenza, è dunque inutile lavorare? Provvidenza non significa pigrizia: bisogna industriarci come se tutto dipendesse da noi, ma con tale serenità come se tutto dipendesse da Dio. Dio vuole che lavoriamo, che guadagniamo il nostro pane con il sudore della nostra fronte, ma vuole che questo lavoro sia senza inquietudine e lasci lo spirito libero e sollecito, prima d’ogni altra cosa, della gloria di Dio e della salvezza dell’anima. C’è pure da ricordare che la fiducia nella Provvidenza divina poggia su tre punti: 1) credere che esiste un Dio amorosissimo e padre; 2) credere che questo Dio Padre ci vuol condurre alla felicità eterna; 3) credere che i mezzi e le vie con cui Dio Padre ci conduce al nostro fine sono tutti per il nostro meglio, anche se li sentiamo dolorosi e incomprensibili. Quest’ultimo è il punto difficile dove si riconoscono i veri figli di Dio che lo amano e pongono in Lui fiducia piena, serena. – 1. FIDUCIA PIENA. Si racconta di un Santo eremita di nome Paolo che, abbandonate le molte ricchezze che possedeva, si ritirò nel deserto, pensoso unicamente della propria santificazione e della gloria di Dio. Ogni giorno un corvo discendeva a lui con nel becco un mezzo pane, quanto bastava per il suo quotidiano sostentamento. Una volta veni’ a trovarlo S. Antonio abate, e mentre s’intrattenevano in devoti colloqui, ecco discendere il corvo con un pane intero. « Provvidenza del buon Dio! — esclamò commosso Paolo . — Sono anni e anni che ricevo un mezzo pane: ma oggi ne occorreva il doppio. Vedi che non è mancato! ». Sembrerebbero leggende che forse potevano accadere ai tempi antichi dei Padri del deserto. Eppure, leggete la vita del Santo Cottolengo che è dei tempi nostri, andate a Torino a visitare la « Piccola Casa della Divina Provvidenza », e vedrete le cose più meravigliose di un corvo con un pezzo di pane nel becco. Son migliaia di lire che occorrono ogni giorno: e ogni giorno non mancano. Sono quintali e quintali di farina e di carne che occorrono ogni giorno: e ogni giorno non mancano. Non si sa da che parte arrivino; ma infallibilmente arrivano, anche se non li porta un corvo. Oh Provvidenza di Dio, come sfolgori vicina a noi! ma i nostri occhi sono chiusi e non ti possono vedere. C’è troppa gente di poca fede a cui trema il cuore quando dovrebbe abbandonarsi alla Provvidenza, e mentre chiama aiuto con una mano, con l’altra s’attacca al fango in cui affonda. Costoro non hanno fiducia piena nella Provvidenza. Facciamo alcuni esempi, per essere pratici. V’ha di quelli che nella preghiera affidano a Dio i loro bisogni, e poi si lamentano, lo insultano, sparlano di Lui come se fosse un addormentato, un distratto, un ritardatario, un ingiusto, un crudele. Altri fanno accendere il lumino in chiesa o anche fanno celebrare una Messa, ma poi s’arrangiano con furberie illecite, con falsità e imbrogli e furti, più o meno gravi. Altri ancora vanno in chiesa, ma poi lavorano anche di festa temendo quasi che l’aiuto di Dio sia insufficiente. Ci sono di quelli che ascoltano e leggono il Vangelo, invocano il Signore che li illumini, ma la loro fiducia è così scarsa da lasciare il posto alla superstizione. Interrogano la fattucchiera che fa il gioco delle carte, si fanno leggere il destino sulle mani, chiedono la spiegazione dei sogni, fanno ballare i tavolini spiritici. Farò un ultimo caso di questa gente che non vorrebbe arrischiar nulla: non perdere l’appoggio del mondo, ottenere gli aiuti di Dio. È il caso di quei coniugi che illudono di conciliare la devota pratica dei primi venerdì d’ogni mese per ottenere le grazie del Sacro Cuore, e poi con la scusa della miseria, della salute, dell’età violano la legge sacrosanta del matrimonio. A tutti costoro io debbo per dovere ripetere l’ammonimento del Signore: « Nessuno può servire a due padroni. Non potete servire a Dio ed a Mammona ». – 2. FIDUCIA SERENA. Una tempesta selvaggia sconvolgeva l’oceano ed il naviglio era sballottato sulla schiuma rabbiosa come un guscio di noce. I passeggeri sembravano impazziti dalla paura: non avevano più colore, né voce. Soltanto un fanciulletto correva avanti e indietro: ridendo a trilli per le cadute e il barcollamento a cui era costretto: era il figlio del pilota. Quando, come a Dio piacque, la nave uscì dalla tempesta e tutti si sentirono rifluire la vita al cuore, qualcuno prese in braccio il fanciulletto e gli disse: « Ma tu, piccolo folletto, non avevi paura di andare ai pesci? ». Rispose: « Paura? è mio padre che guida la nave ». Ah se ciascuno di noi, nei momenti trepidi, riuscisse a ripetere con tutta l’anima le parole del figlio del pilota: « Paura di che? mio padre è al timone! »; oppure sapesse dire l’espressione del Vangelo: « Io non sono solo perché il Padre è con me » (Giov., XVI, 32); oppure quell’altra che è nei Salmi: « Il Signore è la mia guida: non mancherò mai di nulla… quand’anche camminassi per una valle d’ombre mortali, non temerò perché voi siete con me » (Salmi, XXII, 1-4); dimostrerebbe davvero una filiale e serena fiducia nella Provvidenza. Non ignoro le obbiezioni e le difficoltà contro questa serena fiducia: ho pregato tanto, ho gridato a Lui dal profondo del mio cuore e non m’ha ascoltato; gli sono stato fedele tutta la vita e ora un bacillo divora i miei polmoni implacabilmente; ho patito calunnie e ingiustizie e non m’ha difeso di fronte all’iniquità; dov’è la Provvidenza se un fulmine ha privato cinque orfanelli del padre, se l’inondazione ha devastato il campo dei buoni, se l’epidemia ha travolto bambini ed innocenti? Se una di queste prove ci fosse riserbata nella vita, Cristiani, preghiamo Iddio che ci trovi radicati fortemente nella fede. Ma fin d’ora ricordiamoci: a) le vie del Signore non sono come le nostre; ma poiché Egli è Padre, certamente sono per il nostro maggior bene; b) il dolore ha una funzione di castigo, e allora accettandolo scamperemo dal castigo eterno; di purificazione, e allora ci rende migliori liberandoci dalle scorie terrene; di prova, e allora se resteremo fedeli a Dio ci serberà meravigliose ricompense; c) i Santi non hanno perso la serena fiducia in casi più terribili dei nostri, e Dio li ha confortati. Giuseppe: è tradito dai fratelli e venduto ai mercanti d’Egitto: ma da schiavo diventerà viceré. Tre fanciulli sono buttati nella fornace ardente, ma le ali invisibili d’un Angelo li difendono dalle voraci fiamme. Il profeta Elia è perseguitato a morte e fugge; ma un Angelo gli porta da mangiare un pane ristoratore. San Paolo Apostolo aveva fiducia serena e incrollabile in mezzo ad ogni traversia. « Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?… Chi mi separerà dall’amore di Cristo? La tribolazione o l’angoscia; la persecuzione o la fame, o la nuda miseria; il pericolo o il pugnale?… No: né la morte né la vita, né le cose presenti né le future, né alcuna creatura, mi potrà mai separare dall’amore di Dio in Cristo Gesù (Rom., VIII). Persuadiamoci di questo: per quelli che cercano anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia tutte le cose si risolvono in bene. – Nell’ultima cena, nell’ora delle intimità, Gesù disse ai suoi Apostoli: « Quando v’inviavo in missione senza bastone, né sacco, né argento, né tunica di scorta, se vi è forse mancato qualche cosa?». Risposero: « Nulla ». (Lc., XXII, 35). Da allora in poi quanti Cristiani vivono sulla parola del Signore, con una fiducia nella Provvidenza, piena e serena! S. Giovanni Crisostomo. nel secolo IV diceva ai suoi uditori: « Non crediate che questi comandamenti del Signore siano superiori alle forze umane, perché vì sono molti che li praticano. Che tu l’ignori, non è cosa che debba stupire: anche Elia credeva d’essere solo a servire Dio e invece erano in più di settemila. Tu non vuoi credere, perché non li vuoi imitare ». Ebbene, io vi dico che oggi, dopo venti secoli, quelli che si fidano del Signore sono ancora di più. — IL MONDO. Racconta S. Agostino, nel suo libro sulla città di Dio, che il Senato Romano aveva deciso d’innalzare una statua a Gesù Cristo: « di divinità la repubblica ne ha già parecchie, — pensavano quei bravi senatori, — ed aggiungerne una ancora non fa certamente male a nessuno ». Ma la cosa non andò così liscia come si sarebbe potuto immaginare. Innalzata che fu la statua di Nostro Signore nel Pantheon di Agrippa in mezzo a tutti gli altri simulacri, per due o tre mattine di seguito la trovarono sola e diritta nel tempio deserto, mentre le statue d’ogni altro idolo, sfracellate, giacevano fuori di quel tempio. Il significato del prodigio non è oscuro, anzi ce lo manifestano splendidamente le parole stesse di Gesù nel brano evangelico di questa domenica. « A due padroni non si può servire: o l’uno o l’altro bisogna amare, o l’uno o l’altro bisogna odiare ». In uno stesso tempio non ci può stare l’immagine di Cristo e quella di Bacco. In uno stesso cuore non c’è posto per Dio e l’Avarizia, per il Signore e il mondo, insieme. Press’a poco queste parole diceva Gesù sopra una collina solitaria, emergente dalla sponda destra del lago di Tiberiade. Da lontano appariva nel sole la città di Cafarnao. Il declivio verdissimo di erbe nuove s’ingemmava allora di gigli. Stormi di uccelli volteggiavano nella tranquillità azzurra dell’aria (F. Didon, Gesù Cristo, volume I, c. IV). Qualcuno degli ascoltatori pensava in suo cuore: « Va bene fuggire l’avarizia: ma chi mi mantiene, chi mi veste? Bisognerebbe trovarsi ne’ panni miei e poi, altro che il tempo di servire il Signore!… ». « Guardate, guardate gli uccelli nel cielo! — proruppe Gesù. — Come sono beati! Non seminano, non mietono, eppure Dio non li lascia morire di fame. Guardate, guardate i gigli nel prato! non vanno a coltivare come gli uomini, non stanno a filare come le donne: eppure, quanto sono belli! Dio li veste così. « Ma se Dio fa questo per gli uccelli del cielo, per le erbe del prato, non siete voi da più di un uccello e da più di un’erba? Il vostro Padre celeste sa bene quello che vi abbisogna, e ve lo darà per giunta se prima cercate il regno di Dio e la giustizia ». Nemo potest duobus dominis servire. Chi sono questi due padroni? L’uno è Dio che ci presenta i beni eterni e infiniti del paradiso, l’altro è il mondo che ci presenta i beni fugaci e avvelenati della terra. « Che vi è mai di comune fra la giustizia e la nequizia, tra lo splendore e il tenebrore, tra Cristo e il mondo? » diceva S. Paolo agli abitanti di Corinto. Ed è appunto della fuga del mondo che debbo parlare a voi che vivete nel mondo. Né vi sembri strano: i frati, i religiosi di questi avvisi non ne hanno bisogno, perché già dal mondo vivono separati; non così voi a cui è facile dimenticare d’essere Cristiani per vivere come mondani. Il mondo comincia dapprima col pretesto del cibo, del vestito, della famiglia, della posizione a distrarvi dal fine eterno, e poi vi perverte. Guardatevi dunque dal mondo che distrae, dal mondo che perverte. – 1. IL MONDO CHE DISTRAE. Stanco e polveroso camminava un pellegrino con lo sguardo fisso all’orizzonte se mai sopra il biondo del grano, sopra il verde del bosco, spuntasse il cupolone del santuario a cui muoveva per sciogliere un voto. A sera giunse davanti a un albergo: dalle finestre usciva un dolce suon di musica misto a un profumo di vivande apparecchiate. Si fermò a leggere l’insegna. Subito gli venne incontro l’oste e con inchini e sorrisi e preghiere lo trasse dentro. Allora da ogni angolo della sala gli vennero accanto i camerieri lindissimi chi per un servizio, chi per un altro; chi gli portava piatti ricolmi e fumanti, chi bottiglie umide e polverose. « Desidera altro? Siamo a’ suoi cenni ». « Che luogo incantato! — diceva il pellegrino. — Che lieto vivere! peccato che non mi posso fermare ». E tutti a supplicarlo di rimanere ancora, per una notte almeno, per un mese, per sempre. « Vorrei, ma non posso… » rispose; « una inflessibile necessità mi sforza ad andare ». E s’alzò. Ma ecco improvvisamente l’oste porgergli il foglio dei conti: una enormità! Tutto gli faceva pagare, anche i sorrisi, anche le moine, a peso d’oro e di sangue. Balbettò alcune scuse, e fu invano: si trovò sulla strada, di notte, solo e senza più nemmeno il danaro per compiere l’offerta votiva. Dall’alto le stelle lo videro piangere un pianto amaro, ma inutile, e udirono il suo singhiozzo lontano disperso dai fiati del vento. Cristiano, è il santo Cardinale Bellarmino che ci suggerisce questo esempio. Sicut caupones hospitem divertentem peramanter excipiunt sed in discessu severo vultu rigorose erigunt, ita mundus (BELLARM., Conc., 17). Ogni uomo che viene al mondo è in viaggio verso il santuario eterno ove dovrà consegnare una votiva offerta di opere buone. Ma sul cammino, come un oste col suo albergo, sta il mondo con la sua lusinga. Guai a quelli che si abbandonano a lui, dimenticando la propria anima, il cammino della virtù, e il cielo che li attende! Si troveranno alla fine delusi, e con più niente nelle mani: dall’alto le stelle udranno anche il loro inutile singhiozzo dissolversi nella notte eterna. E l’osteria principale con cui il mondo riesce a distrarre dal fine molti uomini è quella appunto che oggi Gesù ci svela nel santo Vangelo: « La preoccupazione esagerata per il cibo del corpo, per le vesti della persona, per le case da abitare, per i campi da sfruttare ». Per queste cose, si dimentica di avere degli obblighi con Dio e con la propria anima; per queste cose ci sono uomini che non trovano più il tempo di pregare, di ascoltare la Messa, di comunicarsi, di istruirsi nella fede, di fare qualche opera buona: il mondo è riuscito a distrarli dall’affare più importante. Ma ditemi, se v’incogliesse una seria malattia, tutte le vostre sollecitudini d’impegni e d’affari v’impedirebbero di trovare dei giorni, delle settimane di riposo e di cura? Certamente no. E perché allora vi impediranno di curare la salute della vostra anima che forse è tanto malata? Ma neanche se aveste tutte le brighe di un Papa nel governo della Chiesa universale, vi sarebbe permesso di trascurare « il Regno di Dio e la sua giustizia! » Quando Bernardo da Pisa fu eletto, da monaco che era, al sommo pontificato, tanto s’ingolfò nelle occupazioni esteriori che accompagnano questa dignità suprema che sembrava avesse rinunciato alla preghiera e alla cura della propria anima: ma il santo di Chiaravalle, come lo seppe, non dubitò di mandargli a dire che si trovava fuori di strada. Ma neanche se aveste tutte le brighe di un re nel governo del suo regno, vi sarebbe permesso di trascurare « il Regno di Dio e la sua giustizia! » Guardate Davide ch’era pure re e guerriero: nel turbinio dei pubblici affari, trovava momenti per ritirarsi e pregare sette volte al giorno. Septies in die laudem dixi tibi (Salmi, CXVIII, 164). Ed a mezza notte sorgeva dal suo letto reale e meditava la legge del Signore. Media nocte surgebam ad confitendum tibi (Salmi, CXVIII, 62). – 2. IL MONDO PERVERTE. Dopo aver distratto gli uomini con le brighe esagerate dell’avarizia e del cibo e del vestito, il mondo ha in suo potere molte armi di pervertimento: i teatri, i balli, la moda. E noi siamo fragili. S. Gabriele dell’Addolorata, passata la prima giovinezza tra le lusinghe del mondo, si rifugiò in religione, e nei primi mesi di convento pensando al suo amico Filippo Giovannetti ch’era studente nel Liceo di Spoleto e temendo per lui che si trovava in molte tentazioni di peccato, gli scriveva così: « Hai ragione di dire che ilmondo è pieno di pericoli e d’inciampi, e che è cosa ben difficile poter salvare l’unica anima nostra: non per questo ti devi perdere di coraggio. « Ami la tua salvezza? fuggi i compagni cattivi. Ami la tua salvezza? Fuggi i teatri: ah che purtroppo è vero, e lo so per esperienza, come sia quasi impossibile entrare in essi con la grazia di Dio ed uscirne senza averla perduta o messa in gran pericolo! « Ami la tua salvezza? fuggi le conversazioni, poiché in tali luoghi tutto congiura contro l’anima nostra. Fuggi finalmente i libri cattivi, poiché è indicibile il male che essi possono fare nel cuore di tutti; ma specialmente nel cuore di un giovane… « Dimmi, poteva io pigliarmi più divertimenti e più spassi di quelli che mi son preso nel secolo? E bene, che me ne resta ora? A te lo confesso: non altro che amarezza ». (GERMANO, Vita di S. Gabriele, pag. 93). Cristiani, non chiudete il cuor vostro alla parola d’un Santo, alla parola del Vangelo: — Fuggite il mondo. Oggi S. Gabriele scrive anche a voi giovani che rincasate a notte tarda dopo lunghe serate passate chi sa dove e chi sa come, mentre la vostra mamma non patendo prender sonno piange e prega tenendo l’orecchio se mai risuoni il vostro passo su per le scale; anche a voi giovani che non conoscete più la dolcezza delle ore passate in chiesa o all’oratorio o accanto alla vostra famiglia, ma continuamente vi stordite in giuochi, in gite, in divertimenti. – Oggi S. Gabriele scrive anche a voi fanciulle e donne che, dimenticando d’essere le mistiche lampade delle case, volete essere le stupide lucciole delle strade; e senza vergogna v’aggirate di giorno e di sera per le piazze, per le vie, senza bisogno, senza modestia; anche per voi che, malvestite e peggio accompagnate, scalate montagne ed inforcate biciclette. Oggi S. Gabriele scrive a tutti i suoi consigli preziosi: perché quelle assidue visite rese principalmente a determinate persone, in determinate case e circostanze? Perché sciupare tanto tempo in quei trattenimenti di piacere, in quelle conversazioni inutili in cui si ascoltano, a spese del prossimo, tutti i rumori del mondo, in cui si apprende dagli altri ciò che dovremmo ignorare, in cui gli altri apprendono da noi ciò che essi pure non dovrebbero mai sapere? Una buona volta cessiamo d’essere schiavi del male, fuggiamo dal mondo, usciamo da questa Babilonia, terra di maledizione. Fugite de medio Babylonis! (Jer., LI, 6). Credete voi che il fuoco dell’ira di Dio s’è rovesciato tutto sulle città della Pentapoli? v’illudete forse che il braccio del nostro Signore ora sia inerme ed ognuno possa ridere della sua legge impunemente? Ricordatevi di Loth a cui Iddio mandò gli Angeli per avvisarlo che fuggisse dalla corrotta Sodoma: egli ubbidì, si ritirò sui monti solitari; e fu salvo. Chiunque non l’avrà imitato e, nonostante gli avvisi dei Santi e dei Sacerdoti, non amerà il ritiro nella sua casa e nella sua chiesa, io vi dico che verrà sepolto sotto una pioggia di fuoco ben più terribile di quella che travolse i Sodomiti. – Attendete, se non sarà così. Jeu, figlio di Josafat, entrava vittorioso nella città. Ora la perfida Gezabele, avendo saputo del suo arrivo e sperando di piacere a lui, si cerchiò gli occhi di nero, si adornò procacemente la testa e si pose alla finestra per sorridere a lui. Ed Jeu levando le pupille la vide. « Chi è colei?» domandò. Ma poi si curvò all’orecchio di quattro servi e disse: « Salite e buttatela giù ». Alcuni minuti dopo fu vista Gezabele volare dalla finestra al suolo: il muro fu imbrattato di sangue e gli zoccoli del cavallo la calpestarono. A sera quando fu mandato per seppellirla trovarono soltanto il cranio, i piedi e l’estremità: i cani l’avevano divorata (IV Re, IX, 36-37). Gezabele è simbolo dell’anima che vuol piacere al mondo. Adora il corpo, mettiti alla finestra, sorridi ai vizi che passano in trionfo: e intanto non senti dietro a te il passo fatale della morte che viene a buttarti già nella fossa del cimitero, mentre i demoni come cani famelici già dilatano le fauci per divorarti. — LA PROVVIDENZA. … Gesù ci solleva in un’altra atmosfera; non ci accorgiamo di far parte di una famiglia dove le preoccupazioni non hanno ragione di essere: nei cieli vi è un Padre che pensa a tutti. Mi sembra che in questa luce anche la vita diventi più bella! Davvero che il Cristiano è l’uomo felice, è l’uomo della vera allegria perché crede che c’è la Provvidenza verso la quale egli ha dei doveri. – 1. C’È LA PROVVIDENZA La vita di ogni Santo è un argomento per l’esistenza della Divina Provvidenza. Ricordiamo, ad esempio, la storia di S. Vincenzo de’ Paoli fatto schiavo dei musulmani. Sacerdote di fresco ordinato, s’accingeva a tornare da Marsiglia dove si era recato per un’opera d’apostolato. Un ricco e buon signore gli propose di prendere la via di mare invece che la via di terra per la quale s’era già deciso. Le condizioni erano lusinghiere: risparmio di tempo, di fatica, di denaro; ottima compagnia. Accettò la proposta, credendo d’accondiscendere al suggerimento d’un uomo mentre era la Provvidenza che lo attirava nel suo piano. Infatti, la nave fu assalita dai pirati turchi, e dopo una lotta disperata, tutti i passeggeri furono imprigionati e portati barbaramente a Tunisi. Qui S. Vincenzo fu venduto, come una bestia, sul mercato. Lo comprò un pescatore, ma trovatolo incapace e inesperto per la caccia, lo vendette a un vecchio medico il quale lo occupava a mantenere il fuoco nei fornelli su cui preparava certe strane medicine. Dov’era in quei momenti la Provvidenza? Che aiuto gli dava, se tutto il giorno era angariato senza un momento di sosta, senza che fosse mai consentita a lui Sacerdote novello la consolazione di celebrare Messa e di recitare il Breviario? Un altro al suo posto si sarebbe perso di fede e scoraggiato. Lui invece pregava incessantemente e confidava. Dov’era dunque in quei momenti la Provvidenza? Era là, vicina a lui, che vigilava e disponeva tutto secondo un amoroso e misterioso disegno che gli occhi degli uomini spesso non possono neppure intravvedere. Effettivamente le cose parevano volgere in peggio. Il vecchio medico musulmano l’aveva rivenduto a un Cristiano rinnegato che s’era accasato con una donna turca, e questi lo maltrattava e gli faceva lavorare tutto il giorno la terra. La padrona però, qualche volta, mentre egli zappava nel campo, scambiava con lui qualche parola sulla fede cristiana, e ascoltava volentieri il canto delle lodi di Dio. Passarono alcuni mesi e la grazia, a poco a poco segretamente penetrando, trionfò: non solo la padrona si convertì, ma seppe indurre il marito a riabbracciare la fede ripudiata. E dopo che entrambi furono illuminati dalla verità e accesi dalla carità di Cristo, di comune accordo diedero la libertà allo schiavo loro Vincenzo. Anzi, consapevoli che proprio da quello schiavo paziente e umile avevano ricevuto una libertà più grande e più preziosa di quella che gli donavano, la libertà dalla schiavitù dell’errore e di satana, come segno di riconoscenza lo vollero accompagnare nella via del ritorno. Due anni, due lunghi anni erano passati dal giorno in cui era caduto in mano dei pirati, durante i quali non aveva avuto nessuna notizia dei suoi cari, e del suo sacerdozio non aveva potuto vivere che il carattere scolpito indelebilmente nell’anima. Parrebbero anni perduti, anni di rovina. Eppure, senza di essi non avremmo avuto un Santo dal cui cuore sgorgò un fuoco di carità immenso. C’è dunque la Provvidenza di Dio; c’è il Signore « che ha disposto quanto esiste, in peso, numero e misura » (Sap., XI, 21), « Che governa con forza le cose dal principio alla fine e tutto dispone con soavità » (Sap., VIII, 1). « Il piccolo ed il grande è Lui che li ha fatti, ed ha cura egualmente dell’uno e dell’altro » (Sap., VI, 8). « Come l’aquila stimola i suoi piccoli al volo e stendendo le sue ali li protegge, li aiuta e nel pericolo li soccorre » (Deut., XXXII, 11) così il Signore, dopo che ci ha messi nel gran mare della vita, non cessa di vegliare sulla nostra coscienza. Se non che i pensieri e le vie della Provvidenza non sono come i nostri pensieri e i nostri disegni, ma più belli e più grandi. Bisogna credere e fidarsi. – 2. DOVERI VERSO LA PROVVIDENZA. A Torino, se passate per via Cottolengo, vi trovate davanti ad una porta stretta, con sopra un umile cartello che dice: « Piccola Casa della Divina Provvidenza ». Sia pure per curiosità, entrate dentro perché tutti dicono che è la casa dei miracoli. Non lasciatevi però ingannare dal nome perché non è una semplice casa ma una città, la cittadella del dolore. « Quelli che hanno trovato chiuse le porte di tutti gli ospedali, i veri rifiuti dell’umanità soltanto lì possono trovare un po’ di riposo. L’ha fondata un Sacerdote, San Giuseppe Benedetto Cottolengo, che non teneva mai un centesimo in tasca: anzi, una volta che gli era avanzato un po’ di denaro, lo buttò dalla finestra. E la Provvidenza non gli è mai mancata perché la sua fiducia non aveva un limite. Se all’ora del pranzo non si trovava neppure un po’ di farina: il Santo non se ne angustiava: stavolta toccava al Signore! Chiamava tutti in chiesa, cominciava il Rosario, cantava il Magnificat od il Te Deum finché non si fosse sentito bussare alla porta: c’erano uomini con carri di farina, di frumento, di pasta. Chi mai aveva mandato quegli uomini con tanta grazia di Dio? Qualcuno certamente, ma i nomi non si seppero mai. Quanti, oggi, i ricoverati? Dicono che siano ottomila, ma il numero preciso non lo si vuol sapere: a contarli e a mantenerli tocca alla Provvidenza a cui dai dormitori, dalle corsie, dai corridoi, nel lavoro, nel riposo, nel dolore, sale la voce del ringraziamento e della fiducia. In tutte le ore, di giorno e di notte, davanti al Tabernacolo ci sono sempre suore raccolte in preghiera. Cristiani, se vogliamo che Dio pensi a noi, noi dobbiamo pensare a Lui. Confidenza e fiducia! Se il Signore ha cura dei suoi nemici, vorrà abbandonare i suoi amici? Siam forse meno degli uccelli dell’aria e dei gigli del campo? « Se gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie nella loro preghiera » (Salmi, XXXIII, 16). « Speri in Lui chi lo ha conosciuto » (Salmi, XI, 11). Quando sembra che il cielo sia chiuso e nessuno più si ricordi di noi, è proprio il momento di raddoppiar la preghiera. Ringraziamento. Se non casca foglia che Dio non voglia, quel che Dio vuole non è mai troppo. Sia che ci mandi la gioia, sia che permetta il dolore, sempre diciamogli grazie. « Se abbiamo goduto — esclama Giobbe — quando ricevemmo del bene, perché mai non accettiamo anche il dolore? Il Signore ha dato ed il Signore ha tolto: sia benedetto il suo Nome nei secoli ». – In un suo viaggio verso Roma S. Ambrogio fu ospite nella magnifica villa di un gran signore. Ma quando seppe che in quella casa la sofferenza non era mai entrata: « Raccogli subito — disse al servo — raccogli subito le nostre cose e andiamo via. Non voglio stare in questa casa! Se non c’è nessun dolore è segno evidente che non c’è Iddio ». Così la pensavano i Santi! Ricordiamo queste parole quando le avversità ci vorrebbero far sospettare che Iddio ci abbia dimenticati. È proprio allora che ci è vicino.
Offertorium
Orémus
Ps XXXIII:8-9
Immíttet Angelus Dómini in circúitu timéntium eum, et erípiet eos: gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus.
[L’Angelo del Signore scenderà su quelli che Lo temono e li libererà: gustate e vedete quanto soave è il Signore].
Secreta
Concéde nobis, Dómine, quǽsumus, ut hæc hóstia salutáris et nostrórum fiat purgátio delictórum, et tuæ propitiátio potestátis.
[Concédici, o Signore, Te ne preghiamo, che quest’ostia salutare ci purifichi dai nostri peccati e ci renda propizia la tua maestà].
Præfatio
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et justum est.
… de sanctissima Trinitate
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternǽque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in majestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre quotídie, una voce dicéntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
[È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: che col Figlio tuo unigénito e con lo Spirito Santo, sei un Dio solo ed un solo Signore, non nella singolarità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Cosí che quanto per tua rivelazione crediamo della tua gloria, il medesimo sentiamo, senza distinzione, e di tuo Figlio e dello Spirito Santo. Affinché nella professione della vera e sempiterna Divinità, si adori: e la proprietà nelle persone e l’unità nell’essenza e l’uguaglianza nella maestà. La quale lodano gli Angeli e gli Arcangeli, i Cherubini e i Serafini, che non cessano ogni giorno di acclamare, dicendo ad una voce:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli esérciti I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.)
Preparatio Communionis
Orémus:
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:
Pater noster, qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:
R. Sed líbera nos a malo.
S. Amen.
Agnus Dei …
… qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
Comunione spirituale
Communio
Matt VI:33
Primum quærite regnum Dei, et ómnia adjiciéntur vobis, dicit Dóminus.
[Cercate prima il regno di Dio, e ogni cosa vi sarà data in più, dice il Signore.]
Postcommunio
Orémus.
Puríficent semper et múniant tua sacraménta nos, Deus: et ad perpétuæ ducant salvatiónis efféctum.
[Ci purífichino sempre e ci difendano i tuoi sacramenti, o Dio, e ci conducano al porto dell’eterna salvezza].
PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)