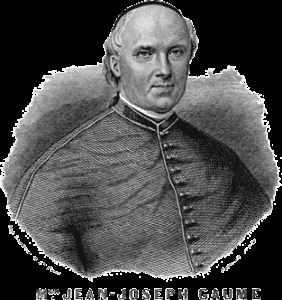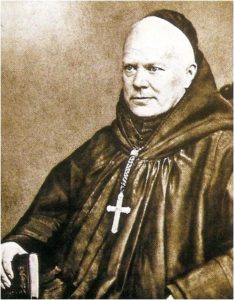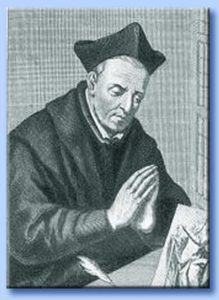18 GENNAIO
CATTEDRA DI SAN PIETRO A ROMA (1)
[Dom Guéranger, l’Anno liturgico – vol.I]
(1) [Nel III secolo si venerava in un cimitero di Roma un trofeo – cattedra di tufo o di legno – del ministero di San Pietro in quel luogo. Più tardi si venerò nel battistero di Damaso in Vaticano la sella gestatoria “apostolicae confessionis”. Sotto il nome di Natale Petrl de Cathedra era celebrata una festa il 22 febbraio; ma, a causa della quaresima, le chiese della Gallia presero l’abitudine di celebrarla il 18 gennaio. Le due usanze si svilupparono in modo parallelo; poi, finalmente, si perdette l’unità primitiva del loro signiifcato e si ebbero due feste della Cattedra di San Pietro, la prima attribuita a Roma – quella del 18 gennaio -, la seconda attribuita a un’altra sede – In definitiva a quella d’Antiochia – il 22 febbraio. – La Cattedra di San Pietro è ora conservata nell’abside della basilica vaticana, racchiusa in un grande reliquiario; nemmeno il Papa si può sedere, come usavano i Pontefici dei primi quindici secoli, sulla Cathedra Apostolica (Schuster, Liber Sacram.)].

L’Arcangelo aveva annunciato a Maria che il Figlio che sarebbe nato da lei sarebbe stato Re, e che il suo Regno non avrebbe avuto mai fine. I Magi guidati dalla Stella vennero dal lontano Oriente a cercare questo Re in Betlemme. Ma ci voleva una capitale per il nuovo Impero; e poiché il Re che doveva stabilirvi il suo trono doveva anche, secondo i consigli eterni, risalire presto al cielo, era necessario che il carattere visibile della sua regalità risiedesse in un uomo che fosse, fino alla fine dei secoli, il suo Vicario. – Per questa gloriosa reggenza, l’Emmanuele scelse Simone, cambiandone il nome in quello di Pietro e dichiarando espressamente che tutta la Chiesa sarebbe stata basata su quell’uomo, come su una roccia incrollabile. E siccome Pietro doveva anch’egli terminare con la croce la sua vita mortale, Cristo s’impegnava a dargli dei successori nei quali sarebbero sempre stati rappresentati Pietro e la sua autorità.
Regalità del Vicario di Cristo.
Ma quale sarà il segno distintivo di questa successione nell’uomo privilegiato sul quale deve essere edificata la Chiesa sino alla fine dei tempi? Fra tanti Vescovi, chi è il continuatore di Pietro? Il Principe degli Apostoli ha fondato e governato parecchie Chiese; ma una sola, quella di Roma, è stata irrorata del suo sangue; una sola, quella di Roma, custodisce la sua tomba; il Vescovo di Roma è dunque il successore di Pietro, e perciò stesso, il Vicario di Cristo. – Di lui, e non d’un altro, è detto: Su te costruirò la mia Chiesa. E ancora: Ti darò le chiavi del Regno dei cieli. E inoltre: “Ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede; …conferma i tuoi fratelli”. – E infine: “Pasci i miei agnelli; pasci le mie pecorelle”. – L’eresia protestante l’aveva compreso tanto bene che per lungo tempo si sforzò di avanzare dubbi sul soggiorno di san Pietro a Roma, credendo giustamente di distruggere, con questo ritrovato, l’autorità del Pontefice Romano, e la nozione stessa d’un capo nella Chiesa. La scienza storica ha fatto giustizia di quella puerile obiezione; e da lungo tempo studiosi della Riforma sono concordi con i cattolici sul terreno dei fatti, e non contestano più nessuno dei punti della storia meglio definita dalla critica. – Fu in parte per opporre l’autorità della Liturgia a quella strana pretesa dei Riformatori, che Paolo IV, nel 1558, fssò al 18 gennaio l’antica festa della Cattedra di san Pietro a Roma. Da lunghi secoli, la Chiesa non celebrava il mistero del Pontificato del Principe degli Apostoli se non il 22 febbraio. D’ora in poi quest’ultimo giorno è stato assegnato al ricordo della Cattedra d’Antiochia, la prima ad essere occupata dall’Apostolo. – Oggi dunque, la Regalità dell’Èmmanuele brilla in tutto il suo splendore; e i figli della Chiesa si rallegrano nel sentirsi tutti fratelli e concittadini d’uno stesso Impero, celebrando la gloria della Capitale che è comune a tutti. Allorché, guardando attorno a sé, vedono tante sette divise e sprovviste di tutte le condizioni della continuità perché manca ad esse un centro, rendono grazie al Figlio di Dio per aver provveduto alla conservazione della sua Chiesa e della sua Verità, con l’istituzione di un capo visibile nel quale Pietro continua per sempre, come lo stesso Cristo in Pietro. Gli uomini non sono più pecore senza pastore; la parola detta al principio si perpetua, senza interruzione, attraverso i tempi; la prima missione non è mai sospesa e, per il Pontefice Romano, la fine dei tempi si ricollega all’origine delle cose. « Quale consolazione per i figli di Dio – esclama Bossuet nel Discorso sulla Storia universale – ma quale convinzione della verità, quando vedono che da Innocenzo XI, che occupa oggi (1681) degnamente la prima Sede della Chiesa, si risale senza interruzione fino a san Pietro, costituito da Gesù Cristo come Principe degli Apostoli! ».
Primato della sede di Roma.
Pietro, entrando in Roma, viene dunque a compiere e amplificare i destini di questa città sovrana, recandole un impero ancora più esteso di quello che essa possiede. È un Impero che non si costituirà con la forza, come il primo: da superba dominatrice delle genti che fu, Roma, per mezzo della carità, diventa Madre dei popoli. – Ma, per quanto pacifico, il suo Impero non sarà meno durevole. Ascoltiamo san Leone Magno, in uno dei suoi più magnifici Sermoni (Serm. 82), narrare, con tutta la nobiltà del suo linguaggio, l’ingresso oscuro eppure così decisivo, del Pescatore di Genezareth nella capitale del paganesimo: « Il Dio buono, giusto e onnipotente, che non ha mai negato la sua misericordia al genere umano e che con l’abbondanza dei suoi benefici, ha dato a tutti i mortali i mezzi per giungere alla conoscenza del suo Nome, nei segreti consigli del suo immenso amore ha avuto pietà del volontario accecamento degli uomini e della malizia che li sprofondava nella degradazione, e ha inviato il suo Verbo, che è a Lui uguale e coeterno. Ora, questo Verbo, fattosi carne, ha unito così strettamente la natura divina con quella umana, che l’umiliazione della prima fino alla nostra abiezione è diventata per noi il principio della più sublime elevazione.» Ma, per spargere nel mondo intero gli effetti di quel beneficio, la Provvidenza ha preparato l’Impero romano, e ne ha esteso così lontano i confini, da fargli abbracciare nella sua cerchia tutte le genti. – Era infatti una cosa utilissima per il compimento dell’opera progettata che i diversi regni formassero la confederazione d’un unico Impero, affinché la predicazione generale giungesse più presto all’orecchio dei popoli, raccolti com’erano già sotto il regime d’una sola città. » Questa città, disprezzando il divino Autore dei suoi destini, s’era fatta schiava degli errori di tutti i popoli, nel tempo stesso in cui li teneva quasi tutti sotto le sue leggi, e credeva ancora di possedere una grande religione, perché non respingeva nessuna menzogna; ma più fortemente era tenuta legata dal diavolo e più meravigliosamente fu riscattata da Cristo. » Infatti, quando i dodici Apostoli, dopo aver ricevuto con lo Spirito Santo il dono di parlare tutte le lingue, si furono distribuite le varie parti della terra, ed ebbero preso possesso di quel mondo a cui dovevano predicare il Vangelo, il beato Pietro, Principe dell’Ordine Apostolico, ricevette in eredità la roccaforte dell’Impero romano, affinché la Luce della verità che era manifestata per la salvezza di tutte le genti, si diffondesse più efficacemente, irradiando al centro di questo Impero sul mondo intero. » Quale nazione, infatti, non contava numerosi rappresentanti in quella città? Quali popoli avrebbero mai potuto ignorare ciò che Roma aveva loro insegnato? Qui dovevano essere battute le opinioni della filosofia; qui sarebbero state distrutte la vanità della sapienza terrena; qui sarebbe stato confuso il culto dei demoni e distrutta infine l’empietà di tutti i sacrifici, in quello stesso luogo in cui una stuta superstizione aveva radunato tutto ciò che i diversi errori avevano potuto produrre. » Non temi tu dunque, o beato Apostolo Pietro, di venire solo in questa città? Paolo Apostolo il compagno della tua gloria, è ancora intento a fondare altre Chiese; e tu ti immergi in questa foresta popolata di bestie feroci, avanzi su questo oceano il cui fondo è pieno di tempeste, con più coraggio di quando camminasti sulle acque. Non hai timore di Roma, la dominatrice del mondo, tu che nella casa di Caifa avevi tremato alla voce d’un servo del sacerdote. – Il tribunale di Pilato o la crudeltà dei Giudei erano forse più temibili della potenza di Claudio o della ferocia di Nerone? No; ma la forza del tuo amore vinceva il timore, e non avevi paura di quelli che t’eri impegnato di amare. Senza dubbio avevi già avuto il sentimento di quell’intrepida carità il giorno in cui la professione del tuo amore verso il Signore fu sanzionata dal mistero della triplice domanda. Cosicché non si richiese altro alla tua anima se non che, per pascere le pecore di Colui che amavi, il tuo cuore effondesse per esse la sostanza di cui era ripieno. » La tua fiducia, è vero, doveva aumentare al ricordo dei numerosi miracoli che avevi operati, dei preziosi doni della grazia che avevi ricevuti, e delle esperienze molteplici della virtù che risiedeva in te. Tu avevi già ammaestrato i Giudei che avevano creduto alla tua parola; avevi fondato la Chiesa d’Antiochia, dove ebbe i suoi inizi la dignità del nome Cristiano ; avevi sottomesso alle leggi della predicazione evangelica il Ponto, la Galazia, la Cappadocia, l’Asia e la Bitinia; e allora, certo del progresso della tua opera e della durata della tua vita, venisti ad innalzare sulle mura di Roma il trofeo della croce di Cristo, proprio là dove i consigli divini avevano predisposto per te l’onore della potenza sovrana e la gloria del martirio » (P. L. voi. 54, c. 423-425). – L’avvenire del genere umano mediante la Chiesa è dunque fissato a Roma, e i destini di questa città sono per sempre comuni con quelli del sommo Pontefice. Diversi per razza, per lingua, per interessi, noi tutti, figli della Chiesa, siamo Romani nell’ordine della religione; questo titolo ci unisce mediante Pietro a Gesù Cristo, e forma il legame della grande fraternità dei popoli e degli individui cattolici.
Gloria della Roma cristiana.
Gesù Cristo per mezzo di Pietro e Pietro per mezzo del suo successore ci reggono nell’ordine del governo spirituale. Ogni pastore la cui autorità non emana dalla Sede di Roma, è un estraneo, un intruso. – Così pure nell’ordine della credenza Gesù Cristo per mezzo di Pietro e Pietro per mezzo del suo successore ci impartiscono la dottrina divina e ci insegnano a distinguere la verità dall’errore. – Qualunque simbolo di fede, qualunque giudizio dottrinale, qualunque insegnamento contrario al Simbolo, ai giudizi e agli insegnamenti della Sede di Roma, viene dall’uomo e non da Dio, e dev’essere respinto con orrore ed anatema. Nella festa della Cattedra di san Pietro in Antiochia, parleremo della Sede Apostolica, come unica fonte del potere di governo nella Chiesa. Oggi, onoriamo la Cattedra romana come l’origine e la regola della nostra fede. Prendiamo ancora qui le eloquenti parole di san Leone (Serm. 4) e interroghiamolo sui titoli di Pietro all’infallibilità dell’insegnamento. Impareremo da questo grande Dottore a misurare la forza delle parole che Cristo pronunciò perché fossero il principale motivo della nostra adesione per tutta la durata dei secoli. – « Il Verbo fatto carne era venuto ad abitare in mezzo a noi, e Cristo si era consacrato interamente alla riparazione del genere umano. Non c’era nulla che non fosse regolato dalla sua sapienza, o che fosse superiore al suo potere. Gli elementi gli obbedivano, e gli Spiriti angelici erano ai suoi ordini; il mistero della salvezza degli uomini non poteva non giungere ad effetto, poiché, era lo stesso Dio, nella sua Unità e nella sua Trinità, che si degnava di occuparsene. Tuttavia in questo mondo, solo Pietro è scelto per essere preposto alla vocazione di tutte le genti, a tutti gli Apostoli, a tutti i Padri della Chiesa. Nel popolo di Dio, vi saranno parecchi sacerdoti e parecchi pastori; ma Pietro reggerà, con un potere che gli è proprio, tutti quelli che Cristo stesso governa in una maniera ancora più elevata. Quale grande e meravigliosa partecipazione del suo potere Dio si è degnato di dare a quest’uomo, fratelli diletti! Se ha voluto che vi fosse qualcosa di comune fra lui e gli altri pastori, l’ha fatto a condizione di dare a questi, per mezzo di Pietro tutto ciò che non voleva loro rifiutare. » Il Signore chiede a tutti gli Apostoli quale idea gli uomini abbiano di lui. Gli Apostoli sono concordi, finche si tratta di esporre le diverse opinioni dell’ignoranza umana. Ma quando Cristo giunge a chiedere ai suoi discepoli quello che pensano essi stessi, il primo a confessare il Signore è colui che è anche il primo nella dignità apostolica. – È lui che dice : Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo. Gli risponde Gesù: Beato te, O Simone, figlio di Giona, poiché né la carne né il sangue ti hanno rivelato queste cose, ma il Padre mio che è nei cieli. – Cioè: Sì, tu sei beato, poiché il Padre mio ti ha ammaestrato; i pensieri della terra non ti hanno indotto in errore, ma ti ha illuminato l’ispirazione del cielo. Non già la carne e il sangue, ma Colui stesso del quale Io sono il Figlio unigenito, mi ha rivelato a te. Ed Io, aggiunge, ti dico: Come il Padre mio ti ha svelato la mia divinità, Io a mia volta ti farò conoscere la tua grandezza. Poiché tu sei Pietro, cioè, come Io sono la Pietra incrollabile, la Pietra angolare che unisce i due muri, il Fondamento tanto essenziale che non se ne potrebbe costituire un altro, così tu pure sei Pietro, poiché sei basato sulla mia solidità, e le cose che sono proprie a me per la potenza che in me risiede sono comuni anche a te per la partecipazione che io te ne faccio. E su questa pietra fonderò la mia Chiesa; e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa. Sulla solidità di questa pietra, io fonderò il tempio eterno; e la mia Chiesa, il cui fastigio salirà fino al cielo, s’innalzerà sulla fermezza di questa fede. » Alla vigilia della sua Passione, che doveva essere una prova per la costanza dei discepoli, il Signore disse quest’altre parole: “Simone, Simone, satana ha chiesto di macinarti come il frumento; ma Io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. Quando poi sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Il pericolo della tentazione era comune a tutti gli Apostoli; tutti avevano bisogno dell’aiuto della protezione divina, poiché il diavolo aveva proposto di agitarli tutti e di annientarli. Tuttavia il Signore prende una cura speciale per il solo Pietro; le sue preghiere sono per la fede di Pietro, come se la salvezza degli altri fosse già sicura, per il fatto stesso che non verrà abbattuto l’animo del loro Principe. È dunque su Pietro che si baserà il coraggio di tutti e l’aiuto della grazia divina sarà disposto affinché la solidità che Cristo attribuisce a Pietro sia attraverso Pietro conferita agli Apostoli» (P. L. voi. 54, c. 149-152).

L’infallibilità del Vicario di Cristo.
In un altro discorso (Serm. 3), l’eloquente Dottore ci fa vedere come Pietro vive ed insegna sempre nella Cattedra Romana. « La disposizione data da Colui che è la Verità stessa, permane dunque sempre, e il beato Pietro, conservando la solidità che ha ricevuta, non ha mai abbandonato il timone della Chiesa. Perché è tale il posto dato a lui al disopra di tutti gli altri, che, quando è chiamato Pietro, quando è proclamato Fondamento, quando è costituito Portinaio del Regno dei cieli, quando è nominato Arbitro per legare e sciogliere con una forza tale nei suoi giudizi che questi vengono ratificati anche in cielo, noi siamo in grado di conoscere, attraverso il mistero di così sublimi titoli, il legame che lo univa a Cristo. Ora egli compie con maggior pienezza e potenza la missione che gli è stata affidata; e tutte le parti del suo ufficio e del suo incarico le esercita in Colui e con Colui dal quale è stato glorificato. » Se dunque, su questa Cattedra, facciamo qualcosa di buono, se decretiamo qualcosa di giusto, se le nostre preghiere quotidiane ottengono qualche grazia dalla misericordia di Dio, è per effetto delle opere e dei meriti di colui che vive nella sua sede e vi agisce con la sua autorità. Egli ce lo ha meritato, fratelli diletti, con la confessione che, ispirata al suo cuore di Apostolo da Dio Padre, ha superato tutte le incertezze delle opinioni umane, ed ha meritato di ricevere la fermezza della Pietra che nessun assalto potrebbe scuotere. – Ogni giorno in tutta la Chiesa, è Pietro che dice: Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo, e ogni lingua che confessa il Signore è guidata dal magistero di quella voce. E questa fede che vince il diavolo, e spezza i legami di coloro che egli tiene prigionieri. È essa che introduce in cielo i fedeli quando escono da questo mondo; e le porte dell’inferno non possono prevalere contro di essa. La forza divina che la garantisce, infatti, è tale che mai la perversità eretica l’ha potuta corrompere, né la perfidia pagana sopraffarla » (P. L. voL 54, c. 146). Così parla san Leone. « Non si dica dunque, esclama Bossuet nel suo Sermone sull’Unità della Chiesa, non si dica e non si pensi che questo ministero di san Pietro finisce con lui: ciò che deve servire di sostegno ad una Chiesa eterna, non può mai aver fine. Pietro vivrà nei suoi successori, Pietro parlerà sempre nella sua Cattedra: è quanto dicono i Padri ed è quanto confermano seicentotrenta Vescovi nel Concilio di Calcedonia ». E ancora: « Così la Chiesa Romana è sempre Vergine, la fede Romana è sempre la fede della Chiesa; si crede sempre quello che si è creduto, la stessa voce risuona dappertutto, e Pietro rimane, nei suoi successori, il fondamento dei fedeli. – È Gesù Cristo che l’ha detto; e il cielo e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà ».
Pietro continuato nei suoi successori.
Tutti i secoli cristiani hanno professato questa dottrina dell’infallibilità del Romano Pontefice che guida la Chiesa dall’alto della Cattedra Apostolica. La si trova insegnata espressamente negli scritti dei santi Padri, e i Concili ecumenici di Lione e di Firenze si sono pronunciati, nei loro atti, in un modo abbastanza chiaro per non lasciare alcun dubbio ai cristiani di buona fede. Tuttavia, lo spirito di errore, con l’aiuto di sofismi contraddittori e presentando sotto falsa luce alcuni fatti isolati e mal compresi, tentò, per troppo tempo, di far cambiare idea ai fedeli d’un paese devoto del resto alla sede di Pietro. L’influenza politica fu la prima causa di quella triste scissione, che l’orgoglio di scuola rese troppo durevole. L’unico risultato ottenuto fu quello di indebolire il principio di autorità nelle regioni in cui essa regnò, e di perpetuarvi la setta giansenista, i cui errori erano stati condannati dalla Sede Apostolica. Gli eretici ripetevano, dopo l’Assemblea di Parigi del 1682, che i giudizi che avevano messo al bando le loro dottrine non erano neanch’essi irrefutabili. Lo Spirito Santo che anima la Chiesa ha infine estirpato quel funesto errore. Nel Concilio Vaticano ha dettato la sentenza solenne la quale dichiara che d’ora in poi chiunque si rifiutasse di riconoscere come infallibili i decreti emessi solennemente dal Pontefice romano in materia di fede e di morale cessa per ciò stesso di far parte della Chiesa Cattolica. Invano l’inferno ha tentato di ostacolare gli atti dell’augusta assemblea, e se il Concilio di Calcedonia aveva esclamato: «Pietro ha parlato per bocca di Leone»; se il terzo Concilio di Costantinopoli aveva ripetuto : « Pietro ha parlato per bocca di Agatone »; il Concilio Vaticano ha proclamato: « Pietro ha parlato e parlerà sempre per bocca del Romano Pontefice ». – Pieni di riconoscenza per il Dio di verità che si è degnato di elevare e garantire da ogni errore la Cattedra romana, ascolteremo con umiltà di spirito e di cuore gli insegnamenti che ne emanano. Riconosceremo l’azione divina nella fedeltà con cui questa Cattedra immortale ha saputo custodire la verità senza macchia per diciannove secoli, mentre le Sedi di Gerusalemme, d’Antiochia, d’Alessandria e di Costantinopoli hanno potuto appena custodirla per qualche centinaia di anni, e sono diventate l’una dopo l’altra le cattedre di pestilenza di cui parla il Profeta.
La Fede della Chiesa.
In questi giorni consacrati ad onorare l’Incarnazione del Figlio di Dio e la sua nascita dal seno d’una Vergine, richiamiamo alla nostra mente che dobbiamo alla Sede di Pietro la conservazione di quei dogmi che costituiscono il fondamento di tutta la nostra Religione. Non soltanto Roma ce li ha insegnati per mezzo degli Apostoli ai quali affidò la missione di predicare la fede nelle Gallie; ma quando le tenebre dell’eresia tentarono di gettare la loro ombra su così sublimi misteri, fu ancora Roma che assicurò il trionfo della verità con la sua suprema decisione. A Efeso, dove si trattava, condannando Nestorio, di stabilire che la natura divina e la natura umana in Cristo non formano che una sola ed unica persona e che di conseguenza Maria è veramente Madre di Dio; a Calcedonia, dove la Chiesa doveva proclamare contro Eutiche la distinzione delle due nature nel Verbo incarnato. Dio e uomo, i Padri dei due Concili ecumenici dichiararono che non facevano altro che seguire nella loro decisione la dottrina trasmessa loro dalle lettere della Sede Apostolica. – Questo è dunque il privilegio di Roma, di provvedere mediante la fede agli interessi della vita futura, come provvedé con le armi, per lunghi secoli, agli interessi della vita presente, nel mondo allora conosciuto. Amiamo ed onoriamo questa città Madre e Maestra, nostra patria comune, e con cuore fedele celebriamo oggi la sua gloria. Noi siamo dunque fondati su Gesù Cristo nella nostra fede e nelle nostre speranze, o Principe degli Apostoli, poiché siamo fondati su te che sei la Pietra che egli ha posta. Siamo dunque le pecore del gregge di Gesù Cristo, poiché obbediamo a te come a nostro pastore. – Seguendo te, o Pietro, siamo dunque certi di entrare nel Regno dei cieli, poiché tu ne possiedi le chiavi. Quando ci gloriamo di essere le tue membra, o nostro Capo, possiamo considerarci come le membra di Gesù Cristo stesso, poiché il Capo invisibile della Chiesa non riconosce altre membra se non obbediamo ai suoi ordini, è la tua fede, o Pietro, che noi professiamo, sono i tuoi comandi che noi seguiamo; poiché se Cristo insegna e governa in te, tu insegni e governi nel Pontefice Romano. Siano dunque rese grazie all’Emmanuele che non ha voluto lasciarci orfani, ma prima di tornare in cielo si è degnato di assicurarci, fino alla consumazione dei secoli, un Padre e un Pastore. La vigilia della sua Passione, volendo amarci sino alla fine, ci lasciò il suo corpo per cibo e il suo sangue per bevanda. Dopo la sua gloriosa Resurrezione, sul punto di salire alla destra del Padre, mentre gli Apostoli erano riuniti intorno a lui, costituì la sua Chiesa come un immenso gregge, e disse a Pietro: Pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. – In tal modo, o Cristo, assicuravi la perpetuità di quella Chiesa; costituivi nel suo seno l’unità, la sola che potesse conservarla e difenderla dai nemici esterni ed interni. Gloria a te, o divino architetto, che hai fondato sulla Pietra solida il tuo immortale edificio! Hanno imperversato i venti, si sono scatenate le bufere, l’hanno percossa rabbiosamente i marosi, ma la casa é rimasta in piedi, poiché era fondata sulla roccia (Mt. VII, 25). – O Roma, in questo giorno in cui tutta la Chiesa proclama la tua gloria e si rallegra di essere fondata sulla tua Pietra, ricevi le nuove promesse del nostro amore, i nuovi giuramenti della nostra fedeltà. – Tu sarai sempre la nostra Madre e la nostra Maestra, la nostra guida e la nostra speranza. La tua fede sarà per sempre la nostra, poiché chiunque non é con te, non è neanche con Gesù Cristo. In te tutti gli uomini sono fratelli, e non sei per noi una città straniera, né il tuo Pontefice un sovrano straniero. Noi viviamo per te della vita del cuore e dell’intelligenza; e tu ci prepari ad abitare un giorno quell’altra città di cui sei l’immagine, la città celeste di cui costituisci l’ingresso. – Benedici, o Principe degli Apostoli, le pecore affidate alla tua custodia, ma ricordati, di quelle che sono sventuratamente uscite dall’ovile. Lontano da te, popoli interi che tu avevi nobilitati e civilizzati per mezzo dei tuoi successori, languiscono e non sentono ancora l’infelicità di essere lontani dal Pastore. Lo scisma raffredda e corrompe gli uni; l’eresia divora gli altri. Senza Cristo visibile nel suo Vicario, il Cristianesimo diventa sterile e a poco a poco svanisce. Le audaci dottrine che tendono a diminuire l’insieme dei doni che il Signore ha elargiti a colui che deve farne le veci fino al giorno dell’eternità, hanno per troppo tempo inaridito i cuori di quelli che le professavano; troppo spesso esse li hanno portati a sostituire il culto di Cesare al servizio di Pietro. Guarisci tutti questi mali, o Pastore supremo! – Accelera il ritorno delle genti separate; affretta la caduta dell’eresia del xvi secolo; apri le braccia alla tua figlia, la Chiesa d’Inghilterra, e che essa rifiorisca come negli antichi giorni. Scuoti sempre più la Germania e i regni del Nord, e che tutti quei popoli si accorgano che non vi è più salvezza per la fede se non all’ombra della tua Cattedra. Rovescia il mostruoso colosso del Settentrione, che pesa insieme sull’Europa e sull’Asia, e scardina dovunque la vera religione del tuo Maestro. Richiama l’Oriente alla sua antica fedeltà, e che esso riveda dopo così lunga eclisse, le sue Sedi Patriarcali risorgere nell’unità della sottomissione all’unica Sede Apostolica. – E infine mantieni noi che, per divina misericordia e per effetto della tua paterna tenerezza, siamo rimasti fedeli, nella fede Romana, nell’obbedienza al tuo successore. Istruiscici nei misteri che ti sono affidati; rivelaci ciò che il Padre celeste ha rivelato a te stesso. Mostraci Gesù, tuo Maestro; guidaci alla sua culla, affinché dietro il tuo esempio, e senza essere scandalizzati dai suoi abbassamenti, abbiamo la fortuna di dirgli come te: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente!
# # #
Questo è pertanto un giorno straordinario di preghiera per il nostro Santo Padre in esilio, S. S. Gregorio XVIII, eletto dopo Gregorio XVII, cardinal Siri, unico e legittimo successore di Pietro, al quale dobbiamo tutto il nostro amore ed il supporto spirituale che la sua difficile situazione richiede. Per noi cattolici romani, questo è un obbligo di primaria importanza e fondamentale nell’economia della nostra salvezza perché, come Dom Guèranger ricordava, l’accesso al regno dei cieli passa necessariamente attraverso l’adesione fedele ed obbediente a Pietro, che solo ne permette l’ingresso, perché solo a lui il Cristo-Dio ha dato le chiavi che aprono le porte del Regno della eterna felicità. È Pietro che ci introdurrà nel Regno dei cieli! Beato sia Pietro, il Principe degli Apostoli.