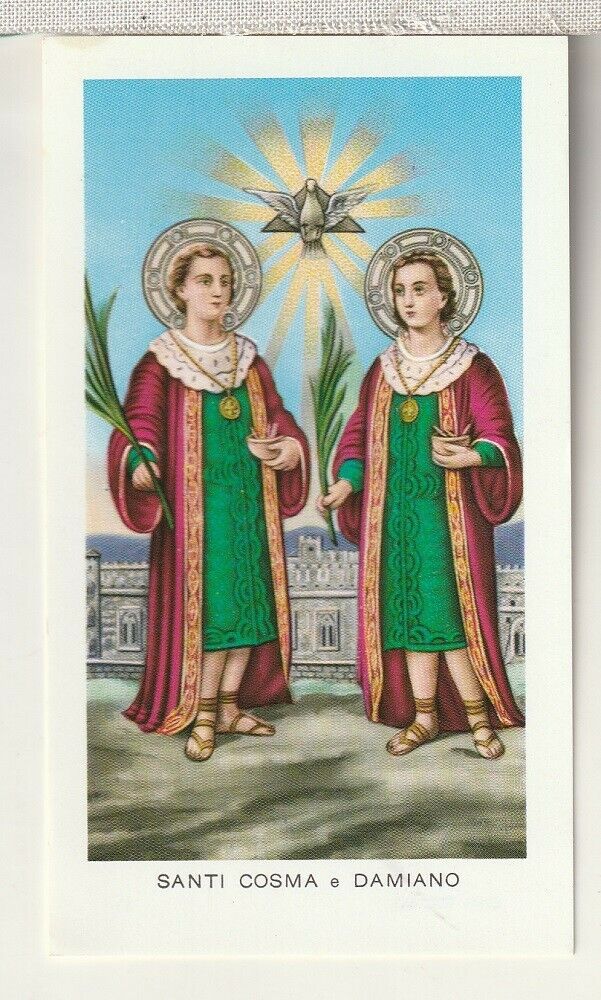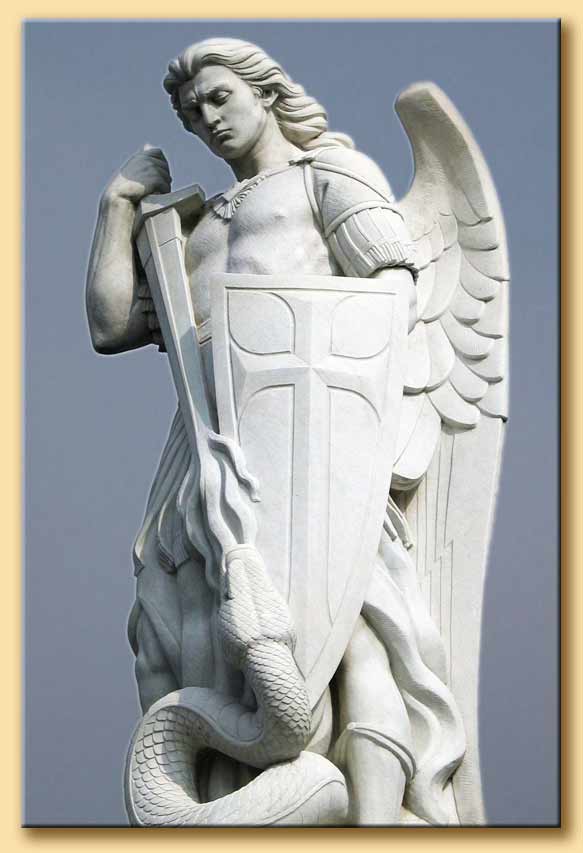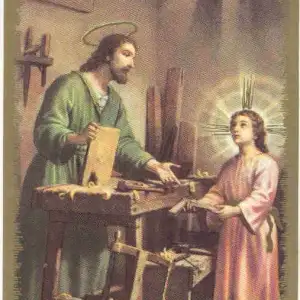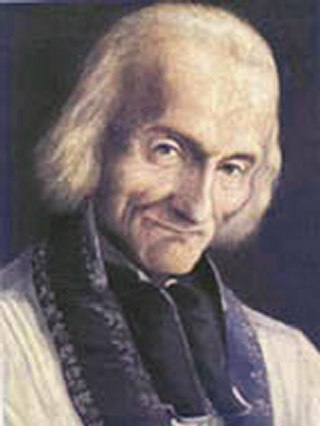S. MATTEO
Otto HOPHAN: GLI APOSTOLI
(Traduz. dal tedesco di Mons. G. SCATTOLON – Marietti ed. TORINO, 1951; Impr. Treviso, 1. x. 1949, A. Mantiero, Vescovo di Treviso.)
La Chiesa latina celebra la festa dell’apostolo ed evangelista Matteo il giorno 21 settembre, quando il giorno e la notte si succedono l’uno all’altra divisi in parti uguali: abbiamo l’impressione che questa data sia simbolica per Matteo quanto lo è per il suo collega e vicino Tommaso il giorno 21 dicembre, che è il giorno più corto dell’anno e la traiettoria percorsa dal sole è la più bassa; il posto stesso, ch’egli occupa nei quattro cataloghi degli Apostoli, ci rivela in lui l’uomo del centro, il ponte quasi, che congiunge la prima alla seconda metà dei Dodici: centro e misura d’oro caratterizzano pure la sua natura e l’opera sua. L’arte cristiana gli ha decretato per simbolo, in quanto è evangelista (*), un uomo con le ali, perché il suo Vangelo comincia con la genealogia umana di Gesù Cristo; or questo simbolo va anche più oltre, esso dice l’indole di Matteo: era una persona, che conosceva forse meglio d’ogni altro Apostolo tutti gli aspetti dell’umano, non escluso il peccato; una persona però alata, perché con l’ala della propria buona volontà e con quella ancor più robusta della grazia si elevò al di sopra dell’umano e del troppo umano.
(*) I quattro simboli: l’uomo alato, il leone, il toro e l’aquila, che nell’Antico Testamento vide il profeta Ezechiele (1, 5 ss.), furono accolti anche da Giovanni nell’Apocalisse: « Dinanzi al trono e intorno al trono v’erano quattro esseri, pieni di occhi davanti e di dietro. Il primo essere era simile a un leone, il secondo somigliava a un toro, il terzo aveva un volto come un uomo, il quarto assomigliava a un’aquila volante » (IV, 6 ss.). L’arte cristiana, sin dai tempi di Costantino, applicò questi quattro simboli ai quattro Evangelisti, sebbene in principio non sempre e ovunque uniformemente; l’attuale designazione cominciò ad affermarsi con Girolamo e dal secolo settimo è divenuta definitiva; si tenne conto dell’inizio dei quattro Vangeli; così Matteo ebbe quale simbolo caratteristico l’uomo alato = albero genealogico di Gesù Cristo, Marco il leone = predicazione del Battista nel deserto, Luca il toro = sacrificio di Zaccaria, Giovanni l’aquila, che si lancia nelle altezze = « In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Iddio, e il Verbo era Iddio ».
IL GABELLIERE
Matteo, nome derivato probabilmente dall’ebraico « mattai = dono di Dio », portava il doppio nome Matteo-Levi. Con questo secondo nome lo introducono nel Vangelo Marco e Luca; Matteo invece si chiama apertamente col suo nome conosciuto fra i Cristiani « Matteo »; di qui la questione, se il pubblicano chiamato dal Signore a Sè, che nei Vangeli di Marco e Luca ha il nome di Levi, mentre nel primo Vangelo ha quello di Matteo, sia un unico individuo o non piuttosto due. Il confronto però delle tre sezioni: Matteo 9, 9-13, Marco, 2, 13-17, Luca 5, 27-32, come pure le informazioni evangeliche, che precedono e seguono la vocazione del pubblicano, tolgono ogni dubbio sulla identità di « Matteo » e «Levi »:: si tratta della medesima persona; il contenuto infatti e la cornice dei vari racconti s’accordano perfettamente; del resto Matteo stesso sembra alludere a un suo secondo nome nella relazione della vocazione, perché si presenta come « Matthaîon legémenon » *, « il così detto Matteo », come potremmo anche rendere l’espressione greca. – Girolamo, nel suo commento al Vangelo di Matteo, ha un’ottima osservazione su questa diversa attribuzione di nome in Marco e Luca da una parte e in Matteo dall’altra: « Gli altri Evangelisti non vollero chiamare Matteo col suo nome comunemente conosciuto per venerazione e rispetto verso di lui, ma dissero “Levi”; l’Apostolo stesso si chiama ” Matteo” e ” pubblicano”: con questo egli vuol mostrare ai iettori che nessuno deve disperare della salvezza, se si converta a una vita migliore; lui stesso fu improvvisamente cambiato da pubblicano in Apostolo ». Potremmo anche pensare che Matteo, dopo la sua conversione, preferiva chiamarsi col nome significativo « Matteo = dono di Dio » anziché con quello di « Levi », che oggi ancora puzza di denaro e di affari; Isodad de Merw anzi, attingendo a un’antica tradizione orientale, può informarci che « questo cambiamento di nome avvenne consapevolmente e volutamente, perché il Signore intendeva di allontanare da Matteo il pregiudizio dei Giudei, che potevano pensarlo un truffatore e un nemico di Dio ». – L’’evangelista Marco chiama Matteo-Levi « figlio di Alfeo ». Questa precisazione ha indotto parecchi ad affermare che Matteo era fratello di Giacomo Minore, ch’era pure figlio d’un Alfeo; lo stesso San Giovanni Grisostomo ritiene i due Apostoli fratelli e tutti e due gabellieri; in tutto il Vangelo però non occorre mai un’ulteriore allusione a simile parentela; si tratta solo di uguaglianza di nomi nei due padri. Con Matteo entra nel Collegio apostolico un uomo dall’indole tutta propria, che si distanzia considerevolmente dagli Apostoli precedenti per formazione, per posizione sociale e per ricchezza. A dir vero, il Vangelo ci nega ogni notizia nei riguardi della vita precedente del nostro Apostolo; egli entra in scena, apparentemente almeno, d’improvviso, senza prima picchiare; la relazione nondimeno della sua vocazione ci consente sicure induzioni. È verosimile che Matteo superasse gli altri anche per l’età, perché un posto, quale egli deteneva, dev’essere conquistato a prezzo di lotta paziente. Egli, il primo Evangelista, li superava certamente tutti per istruzione; d’or innanzi potrà essere chiamato, come qualcuno ebbe a scrivere, « il più quotato di tutti i Dodici »; perché la sua professione di ricevitore delle tasse presuppone un eccellente tirocinio; egli dovette imparare a scrivere, a leggere e anche quello ch’è più noioso di tutto: a far di conti, a calcolare molto, soprattutto a calcolare e quasi solo a calcolare! Più tardi dovette portare pure tabelle, esporre tariffe, conoscere i prezzi, i prezzi delle biade e dell’olio, del pesce che gli portavano i figli di Zebedeo e delle perle, che anche il Signore ricordò nel Vangelo. Povero Matteo! In quei bei giorni, nei quali Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo, con i loro padri Giovanni e Zebedeo, potevano uscir fuori al sole e alle tempeste del lago, il vecchio Alfeo condannava il suo ragazzo all’aula scolastica e a starsene ricurvo sui libri e sulle carte. Non v’è dubbio che per questa via divenne avveduto e, come si suol dire, « idoneo alla vita », e che realizzò maggiori progressi che non i candidi pescatori sul lago; anche se il mestiere di costoro poté loro fruttare una discreta agiatezza, non poterono però competere con Matteo, che con i suoi affari realizzò dei vistosi guadagni, sino a raggiungere una considerevole ricchezza; all’atto della sua comparsa nel Vangelo, egli è in possesso di due case, del negozio cioè con l’esattoria alle porte della città, « al posto della dogana », e della casa privata dentro in Cafarnao; quest’ultima poi doveva essere una villa grande e spaziosa, perché in essa « poterono sedere a mensa una gran folla di pubblicani e altra gente con Gesù e i suoi Discepoli ». Proprio così: « Una gran folla di pubblicani e altra gente », poiché Matteo si distanzia dai suoi colleghi d’apostolato tanto semplici anche per le sue molte e influenti relazioni sociali; andava regolarmente alla corte principesca di Erode in Tiberiade per liquidare i conti col suo sovrano, ed ivi veniva a conoscenza degli intrighi politici e degli scandali piccoli e grossi dei grandi; chissà quanti nobili e potenti signori, che si dibattevano in difficoltà pecuniarie, furono tolti d’impaccio da lui, ed egli se n’ebbe in cambio inchini manierati o fuggevoli sorrisi di dame. Or che ne sapevan Pietro, Giovanni, Filippo di questo « bel mondo »? Matteo invece ne sapeva anche troppo! Giacché per il denaro anche i più ricchi signori ballano la loro danza. Ma qui certo comincia pure la pagina oscura della vita di Matteo. Era gabelliere, e solo Iddio sa com’era giunto a quella esecranda professione; forse l’aveva abbracciata su ingiunzione del padre, o forse per nativa inclinazione, se non forse anche per la maledetta avidità del denaro; noi del secolo ventesimo non possiamo formarci un’idea precisa di quello che fosse allora lo screditato mestiere dell’esattore, se non pensando alle esistenze più equivoche; per poter valutare quindi a dovere l’elevazione del gabelliere Matteo da parte di Cristo ci è necessario illuminare la situazione del tempo. La riscossione delle imposte nell’Impero romano non avveniva direttamente, per mezzo di impiegati, che fossero a servizio e agli stipendi e sotto… il controllo dello stato; questo invece appaltava i suoi diritti in fatto di tasse e tributi a coloro, che in cambio gli facevano le migliori offerte; ed era assai esigente nelle somme d’affitto richieste; gli appaltatori da parte loro si rendevano personalmente garanti del loro pagamento. Spesso, specialmente quando si trattava di appaltare un territorio molto esteso, la somma d’appalto richiesta era tanto ingente, che un solo individuo non se la sentiva di addossarsela; avveniva così che frequentemente gli appaltatori si univano in società, ch’era la società-azienda delle tasse. Erano questi i veri e propri appaltatori delle imposte, e spesso provenivano dal ceto della ricca nobiltà, nell’Impero romano. Per la riscossione dei tributi, essi subaffittavano il loro territorio a impiegati, esattori e gabellieri, i quali a loro volta stavano rispetto all’appaltatore in uguali rapporti di dipendenza di questi rispetto allo stato e si comprende facilmente che un simile sistema di imposte, se in realtà liberava lo stato dal fastidio della riscossione, spalancava però le porte a tutti gli abusi; v’erano le tariffe fissate dallo stato stesso, è vero, ma esse non bastavano a frenare efficacemente la cupidigia, i raggiri e le estorsioni degli appaltatori; d’altra parte un ricorso agli uffici statali era per lo più illusorio e infruttuoso, perché quegli uffici stavano in segreto accordo con gli appaltatori. Ci spieghiamo. quindi l’atteggiamento popolare nei riguardi dei ricevitori delle imposte, ch’erano visti con astio e rabbia, ritenuti quali « orsi e lupi dell’umana società »; « gabelliere » e « ladro » erano termini che si equivalevano. Cicerone scrive che il pubblico non criticava tanto le imposte in se stesse, quanto piuttosto il metodo della loro riscossione, e dice l’esattoria la peggiore di tutte le professioni. Il nostro buon Matteo esercitava proprio questa infamata professione. – Ma presso i Giudei era inerente al mestiere del gabelliere un’altra e del tutto speciale ignominia: il ricevitore delle tasse e l’impiegato della dogana riscuotevano il denaro a vantaggio del dominio pagano dei Romani, ch’era l’odiato potere di occupazione straniera; e così un giudeo succhiava fino all’ultimo un altro giudeo e per di più a favore di stranieri e pagani; non era questo soltanto una truffa e un furto, qui v’era un crimine di lesa patria e di lesa religione. Ora comprendiamo come un giudeo coscienzioso dovesse persino proporsi il problema, se gli fosse anche semplicemente lecito pagare le tasse all’imperatore, e che cosa quindi gli passasse per la testa, in tale stato d’animo, quando venivano a lui quei miserabili quei « collaborazionisti », come oggi noi diremmo con vocabolo non troppo bello, traditori della patria, e avevano l’ardire di riscuotere le tasse, per sordida fame di guadagno, dallo stesso popolo di Dio. – Il disprezzo per i gabellieri nei libri talmudici appare manifesto e implacabile in non poche disposizioni: nei processi i gabellieri non potevano fungere né da giudici né da testimoni; le loro famiglie erano tenute in disonore, e nessun giovane israelita, che menasse vita onesta, conduceva in moglie la figlia d’un pubblicano; era persino interdetto di accettare l’elemosina da un esattore o di farsi cambiare da lui il denaro, perché il giudeo onesto riteneva di macchiarsi con quel denaro, ch’era il frutto dell’ignominia; si dubitava anzi dell’affare più serio di tutti: se un gabelliere cioè fosse capace di pentimento e quindi della sua eterna salvezza. Così i pubblicani restavano esclusi, almeno di fatto, dalla comunità popolare e religiosa; dinanzi ai giudei ortodossi essi passavano come dei paria, come la quinta classe; nei loro discorsi, venivano accomunati con i delinquenti, con gli assassini, con i ladri e le meretrici; di fronte a loro tutto era permesso: era lecito abbindolarli con bugie e truffarli e derubarli; non era che la giusta vendetta del popolo, da loro ingiustamente vessato. Il disprezzo dei Giudei per i pubblicani risulta anche da non pochi testi del Vangelo: «Se uno non ascolta la Chiesa, sia per te come un pagano e un pubblicano »; « Pubblicani e meretrici persino vi precederanno, o Farisei, nel regno di Dio »; e anche Giovanni Battista s’era rivolto ai gabellieri col monito caratteristico: « Non esigete di più di quanto vi è stabilito » (Matt. XVIII, 17). – Non ci nascondiamo che per il pubblicano Matteo-Levi vale l’attenuante ch’egli non stava agli stipendi dei Romani, perché questi, al tempo del Signore, esercitavano il loro dominio diretto solo lassù in Giudea e Samaria per mezzo del governatore, mentre Matteo sedeva al posto della dogana laggiù a Cafarnao, che probabilmente era pure la sua patria, e quindi era sottomesso al monarca della Galilea, Erode; era però quell’Erode, che, nonostante tutte le adulazioni che gli tributava, il popolo giudaico respingeva con tutto il cuore quale intruso dall’Idumea, e che nella storia del Nuovo Testamento si palesa figura spregevolissima perché adultero e uccisore del Battista e dileggiatore di nostro Signore il Venerdì Santo. Non è impossibile che Matteo abbia provato almeno qualche volta un’intima nausea, quando, per la resa dei conti, sedeva a fianco di quel principe delinquente, il quale con gli occhi lascivi e avvinazzati gli faceva cenno di portare un’altra volta una borsa ancor più gonfia. Si sarà insudiciato anche il nostro Matteo con beni indebiti? Nel Vangelo non troviamo nessuna prova sicura al riguardo; di lui non leggiamo neppure quella fatale e rivelatrice — scusarsi significava accusarsi! — assicurazione, che diede al Signore il suo collega e capo dei pubblicani, Zaccheo, a Gerico: « Ecco, o Signore, la metà del mio patrimonio la do ai poveri e, se a qualcuno ho tolto troppo, glielo restituisco quadruplicato ». Matteo, d’altra parte, doveva essere pure un uomo profondamente religioso, perché dal Vangelo ch’egli scrisse più tardi, così ricco di citazioni dal Vecchio Testamento, è lecito dedurre ch’egli avesse una grande familiarità con la Parola di Dio. E tuttavia dovette essere certamente difficile per lui il conservarsi del tutto immacolato, esercitando una professione così pericolosa, circondato com’era dai cattivi esempi. Le stupende espressioni, che il Signore ebbe per gli ammalati bisognosi del medico, in occasione del convito in casa di Matteo e delle quali diremo presto, sembrano valere anche per il nostro pubblicano. Nel suo commento al Vangelo di Matteo, il Grisostomo ammette senza esitare che « i cibi imbanditi a quel convito erano stati acquistati con ingiustizia e cupidigia ». Comunque però stessero le cose nella coscienza di Matteo, il popolo da parte sua non faceva sottili distinzioni; per lui un gabelliere valeva quanto un altro, era cioè un ladro, un truffatore, un traditore; qualunque pubblicano era in cattiva fama; per questo gli evangelisti Marco e Luca, nei loro cataloghi degli Apostoli, passano sotto silenzio la precedente professione di Matteo, vogliono usargli un’attenzione, e quando ne riferiscono la vocazione dal telonio, velano il collega chiamandolo col nome di Levi. Egli dovette certo soffrire della sua condizione. Spesso, quando rincasava a sera con le tasche piene, si metteva a sedere, chinava il capo e lo posava fra le mani, e respirava affannosamente; riandava alle occhiate irate, ai pugni serrati e alle monete, che lungo il giorno gli avevan gettate sul tavolo, come le avessero gettate dinanzi a un cane; che gli giova tutto quel cumulo di denaro, se frattanto il popolo lo mette al bando? E anche un’altra parola, ch’egli più tardi consegnerà nel suo Vangelo, gli saliva dal fondo dell’anima: « E che cosa giova all’uomo guadagnare tutto il mondo, se intanto perde l’anima? che cosa può dare l’uomo come cambio per la sua anima? » (Matt. XVI, 26). La sua anima! Matteo forse pianse. Oh, potesse cominciare da capo! Quanto sarebbe contento con una povera barca e… una buona coscienza, lui, il povero uomo ricco! Ma non v’è stretta da cui ci si possa svincolare con maggiore difficoltà che quella infausta del denaro; e poi, alla fin fine, lo si terrebbe una volta per sempre quale un pubblicano e un criminale; tutti i « giusti » ormai l’hanno eternamente estromesso e condannato a vivere insieme ai colleghi di professione, autentici bricconi, per i quali il vero dio erano gli affari e i denari; gli è impossibile sottrarsi. E così la sua anima anelante svolazzava, come un uccello in gabbia con le ali scorciate. Oh, vi fosse in aiuto della sua buona volontà un’altra ala, con la quale uscir fuori e lanciarsi al di sopra di se stesso per ascendere sino alle vette! – Là, nel suo ufficio daziario, dove tutte le chiacchiere si davan convegno, s’era parlato, e gli pareva di aver capito bene, d’un nuovo profeta, di Gesù di Nazareth, e con una frequenza sempre maggiore negli ultimi mesi. « La sua fama s’era diffusa in tutta la Siria. Si portavan a Lui tutti i sofferenti, tormentati dalle infermità più disparate e da mali dolorosi, anche ossessi, lunatici e paralitici, ed Egli li guariva. Grandi folle di popolo dalla Galilea e dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e dalla Transgiordania Lo seguivano ». Da alcune settimane anzi questo Profeta nuovo, che correva per le bocche di tutti, s’era persino stabilito nella stessa Cafarnao e andava e veniva dalla casa del pescatore Simone, figlio di Giovanni; e alcuni giorni prima era accaduto quello che Matteo non potrà dimenticare mai più: quel Gesù, seguito da numerosa folla, era passato dinanzi all’ufficio doganale; come fosse avvenuto, Matteo non se lo sapeva spiegare nemmeno ora, ma di fatto Gesù e lui si trovarono d’improvviso, per un istante, l’uno di fronte all’altro; oh! quegli occhi rilucenti, come la luce del sole in una stanza polverosa, l’avevano penetrato sino nel profondo dell’anima; sì, come un sole l’avevano colpito quegli occhi, tanto erano splendidi e deliziosi; se…! – Ma che gli frulla per la testa! Egli sa troppo bene che cosa pensano e devono pensare di lui, il pubblicano, i profeti e i teologi! Proprio mentre si va svolgendo dentro di lui quest’intima lotta di sentimenti, si scuote, si mette in ascolto; il suo orecchio pratico di gabelliere ha percepito ancora una volta un rumore indistinto di passi lontani e di molte voci, che s’avvicinano. O Dio, il Profeta! Matteo, sebbene calmo, trema, si sbaglia trattando col suo cliente e confonde le monete. Ed ecco che Gesù ascende già, si ferma dinanzi a lui, lo guarda e gli rivolge due parole, due parole solamente, le quali però bastano, perché agli occhi di Matteo il mondo intero appaia in tutt’altra luce: « Segui… Me! ». Nel Vangelo, che Matteo scrisse più tardi, leggiamo alcune proposizioni, che interessano l’attività di Gesù del tempo press’a poco in cui avvenne la chiamata del pubblicano, e leggendole abbiamo l’impressione ch’esse riflettano, sebbene velatamente, un episodio personale e siano quasi l’eco riconoscente per quella chiamata del Signore, nonostante il primo Vangelo abbia come nota caratteristica l’oggettività: «Il popolo, che siede nelle tenebre, vede una luce splendida. Su coloro che abitano nella regione dell’ombra di morte s’irradia una luce ». E ancora: « Si adempì la parola del profeta Isaia, che dice: “Egli ha preso su di Sé le nostre infermità”» (Matt. IV, 16) Così scrivendo, l’Evangelista non avrà pensato a sé? Che la nostra descrizione dello stato d’animo del pubblicano Matteo, prima della sua vocazione, non sia una vuota congettura, lo prova lo stesso suo contegno al momento della chiamata. « Gesù gli disse: “SeguiMi”; e quegli s’alzò, abbandonò tutto e Lo seguì ». Con mossa subitanea e festante respinse la sedia, sulla quale stava inchiodato da anni; chiuse con forza il cassetto, tanto che la cassa risuonò; sgualcì e stracciò tutta la carta importante e inutile, che gli stava dinanzi, con mano elettrizzata dall’onda della gioia, e « seguì Lui », precisamente Lui, che non aveva nulla, che non aveva « dove potesse solo posare il suo capo » ! (Matt. VIII, 20), egli, Matteo, il ricco esattore, ch’era vissuto nell’abbondanza: un uomo e specialmente un uomo dell’età e dell’equilibrio di Matteo non avrebbe agito a quel modo, se egli non avesse sentito la chiamata alla nuova vita come una vera liberazione; doveva averla preceduta un intimo tormento, che l’aveva preparato all’ingresso della grazia. Risponde al vero l’osservazione del Grisostomo sulla grazia, che con sapienza e con pazienza attende la sua ora: « Cristo chiamò Matteo quando sapeva che sarebbe venuto; perché non lo chiamò subito fin da principio, quando l’accesso al suo cuore era ancora troppo difficile, ma solo dopo ch’Egli aveva compiuti innumerevoli miracoli e la sua fama s’era diffusa anche nelle terre lontane e quando lo sapeva più propenso a obbedire ». – La fuga fortunata dal denaro per passare al Vangelo, la felice conversione da pubblicano a discepolo del Signore riempì Matteo di tale giubilo, ch’egli festeggiò con un sontuoso banchetto il suo addio alla vita sino allora vissuta. Egli veramente nel suo Vangelo tace umilmente quella profusione lieta e pia, ma gliela divulga il buon Luca: « Levi Gli preparò nella sua casa un grande convito; una folla numerosa di pubblicani e altra gente sedevano a tavola con loro » (Luc. V, 29). Neppur Pietro o Andrea, non i figli di Zebedeo, nemmeno Filippo o Bartolomeo avevano festeggiato così solennemente la loro vocazione, come invece Matteo; certo non l’avrebbero neppure potuto, anche volendolo. Neppure alle nozze di Cana s’era giunti a tanto di splendore come a quelle « primizie » di Matteo; oh, quelle povere nozze! Il Signore non dovette far appello a dei miracoli per procurare il vino, da mettere innanzi alle folle di ospiti, che onoravano il convito nella casa di Levi. Questi sedeva a mensa felice, ultrafelice, ché il Signore l’aveva redento e redento dal denaro! Solo una mano divina può redimere un uomo, anche un uomo di buona volontà, dalla schiavitù del denaro e regalargli le ali per elevarsi verso le cime. La bella testa del Matteo del Rubens guarda commossa e riconoscente verso l’alto, come una povera anima del Purgatorio guarda all’Angelo, ch’è venuto a prenderla per introdurla in Paradiso: per Matteo il purgatorio tormentatore era stato l’esattoria, ma la mano del Signore l’aveva misericordiosamente preso e l’aveva condotto al paradiso della vita evangelica. – Strano, ma nel Collegio apostolico la cassa non la teneva Matteo, ch’era la persona abile ed esperta in campo d’affari, ed era felicissimo d’esserne stato esonerato, ma la teneva Giuda. Matteo e Giuda! Tutti e due questi Apostoli ebbero a che fare col denaro, eppure quanto diverse le vie che corsero! Matteo lascia il denaro per seguire il Signore, mentre Giuda tradisce il Signore per guadagnare del denaro, trenta monete d’argento; Matteo è unico fra gli Evangelisti, che le computi esattamente (XXVI, 15). Il suo Vangelo fa rilevare più chiaramente degli altri come il denaro divenne fatale per Giuda: dal momento di quell’esecrando commercio sino all’ora, nella quale gli ipocriti sacerdoti raccattarono dal pavimento del Tempio la borsa, abbandonata dal suo padrone, per comperare con essa un luogo di sepoltura per gli stranieri, Matteo segue con occhio attento quelle orrende monete d’argento. Che avesse previsto lui, il pubblicano, che sarebbe capitato così? Può essere che, con la profonda intuizione dell’uomo che conosce il denaro, avesse osservato la tendenza di Giuda ad esso e gli avesse pure suggerito, quasi sorvolando, qualche parola buona e seria in proposito. Matteo, a differenza Giovanni, scrive di Giuda senza veemenza; forse aveva osservata in lui, rabbrividendo, la propria sorte, qualora la misericordia del Signore non l’avesse strappato dall’ufficio della dogana; senza dubbio egli, a differenza di Giuda, aveva afferrato con immensa gratitudine quella mano tesa del Signore. – Nel suo Vangelo sta scritto più diffusamente che negli altri anche dell’uso del denaro. Il denaro è buono solo quando viene adoperato per il bene, per l’esercizio della carità e ancor prima per l’esercizio, ancor più urgente, della giustizia. Le parole, che nostro Signore ebbe a dire intorno al denaro, dovettero lasciare in Matteo un’impressione particolarmente profonda: « Quando tu dai l’elemosina, non deve sapere la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la tua elemosina rimanga nel segreto; il Padre tuo che vede nel segreto te la ricompenserà ». – « Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tarlo e ruggine li consumano, dove ladri sfondano e rubano; accumulatevi piuttosto tesori nel Cielo, dove né tarlo né ruggine li consumano, dove nessun ladro sfonda e ruba. Perché ov’è il tuo tesoro, ivi è pure il tuo cuore ». « Non potete servire a Dio e a mammona » (Matt. VI, 3). La vocazione del pubblicano Matteo ebbe però anche un altro aspetto: quello che riguardava il Signore. Quella chiamata era una grave offesa alle opinioni della società del tempo, una inaudita provocazione per tutti i « migliori » ambienti; chiamando a Sé Matteo, Gesù prese su di Sé la responsabilità d’un rischio eroico; a Voler giudicare umanamente, nessuno fra tutti i suoi Discepoli, nemmeno Giuda, era compromettente come Matteo; è lecito pensare che gli stessi Discepoli precedenti siano stati colpiti da una penosa impressione, quando il Maestro pose al loro fianco quel gabelliere; ché tutti loro erano della gente onesta, provenivano da famiglie rispettabili! I Farisei non poterono trattenere la loro sdegnosa sorpresa; erano già prima eccitati per il fatto, che aveva preceduto quella chiamata, a causa cioè della remissione dei peccati concessa al paralitico: « Egli bestemmia Iddio! Chi può rimettere i peccati se non Iddio solo? ». Ed ora Egli osa chiamare nel suo minuscolo seguito un pubblicano e peccatore, non teme anzi di sedere alla stessa mensa con quella gentaglia. I pubblicani, infatti, di tutti i dintorni, alla notizia di quel miracolo della grazia, come fiere cacciate dai loro nascondigli, erano strisciati fuori alla luce del sole; in Matteo si sentivano tutti chiamati e nobilitati. « Dissero allora i Farisei e gli Scribi indignati ai suoi Discepoli: “Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?”». E Gesù diede loro una risposta così saggia e importante, che tutti e tre i Sinottici ritennero di doverla consegnare in iscritto: « Gesù sentì questo e disse loro: “Non han bisogno del medico i sani, ma gli ammalati. Non son venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori” ». E poi una terza espressione, che solo Matteo ha ricordata: « Andate e imparate che cosa vuol dire: “Voglio misericordia, non sacrificio” ». Queste poche sentenze sono come un preludio dell’attività di Gesù, l’accordo fondamentale di tutto il Vangelo e anche l’anticipazione dell’incantevole capitolo decimoquinto del vangelo di Luca, di quella trilogia della divina misericordia, che ben a ragione è detta il cuore del Vangelo. Queste tre brevi proposizioni dissero tutto a tutti: dinanzi ai Farisei valsero a giustificare Gesù e il rifiuto dei loro principi; invitarono i pubblicani all’emendazione della loro vita, non ne diedero l’approvazione; e ai Discepoli posero in mano la norma suprema per la loro opera apostolica. La vocazione dunque del pubblicano Matteo-Levi è d’un’importanza veramente fondamentale e universale; in essa si manifesta lo spirito del Vangelo; questo gabelliere, come un glorioso monumento della divina misericordia, deve annunziare « ai pubblicani e peccatori » di tutti i tempi che nessuno, per quanto possa avere traviato, deve perdersi d’animo o, peggio, disperare, poiché il Signore « è venuto » precisamente « per i peccatori »; il senso più recondito del peccato sta proprio qui: da esso prende le mosse la misericordia e, lo si sa, qualora il peccatore vi s’opponesse, la giustizia di Dio. Parecchi mesi più tardi Gesù propose la parabola del fariseo e del pubblicano: « Due uomini salirono al Tempio; uno era un fariseo, l’altro un pubblicano. Il fariseo se ne stette e pregò fra sé: “O Dio, io ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, rapaci, truffatori, adulteri e come questo pubblicano…”. Il pubblicano invece si fermò di lontano e non osava neppure levare i suoi occhi al Cielo, ma si percuoteva il petto e pregava: “O Dio, sii propizio a me peccatore”. Io vi dico: Questi se n’andò a casa giustificato, quegli no ». Pensava il Signore a Matteo, mentre diceva questa parabola? e che cosa dovette passare per la mente di Matteo nell’udirla? I suoi occhi si sciolsero in lacrime e nel suo cuore giurò di non rendersi indegno di tanta misericordia. Dopo la sua vocazione, il Vangelo ricorda ancora Matteo un’unica volta, all’elezione degli Apostoli, che ebbe luogo non molte settimane più tardi; in quell’occasione egli, sebbene pubblicano, divenne uno dei Dodici, non solo un discepolo come cento altri, ma uno degli Apostoli, che « dovettero essere costantemente accanto a Lui (Gesù), i quali Egli voleva mandare a predicare, e che dovevano aver anche il potere di guarire malattie e di cacciare i demoni ». Il discorso, che il Signore tenne ai suoi Apostoli in precedenza alla loro prima missione, è stato riferito da Matteo più ampiamente che non dagli altri Evangelisti: « Predicate: “Il regno dei Cieli è vicino; guarite malati, risuscitate morti, mondate lebbrosi, cacciate spiriti cattivi!” ». Segue poi un’espressione, che soltanto lui, il gabelliere, ha tenuto a mente e ci fa sorridere: « Gratis avete ricevuto, gratis dovete dare! Non vogliate procurarvi nella vostra cintura nè oro né argento né moneta di rame! » (Matt. X, 7). Che discorsi si saran fatti in giro per la regione, quando quegli, ch’era stato il famoso e scaltro Levi, metteva piede sulla soglia delle case, qual pio Apostolo, e salutava: « Pace a questa casa! », proprio lui, che un giorno in passato, per amore del maledetto e vilissimo denaro, s’era reso colpevole di innumerevoli discordie e irritazioni! Eppure dovremo ammettere ch’egli abbia assolto molto bene il suo compito in quella missione condotta a titolo di saggio; giacché precisamente l’esattoria gli aveva fornita l’occasione di far molte conoscenze ed esperienze di uomini e cose, come scuola preparatoria all’apostolato non era stata meno eccellente della professione del pescatore. Osservando un po’ i cataloghi degli Apostoli, notiamo con sorpresa che Matteo era uno dei pochi isolati nel gruppo; a eccezione infatti di Tommaso e di Giuda, erano tutti legati fra di loro da relazioni di parentela o di amicizia. Il Signore forse ha messi vicini Matteo e Tommaso, perché l’uno avesse nell’altro un buon compagno e specialmente l’oppresso Tommaso nel tranquillo Matteo. Nelle loro liste apostoliche Marco e Luca collocano Matteo prima di Tommaso, Matteo invece nel suo Vangelo si mette modestamente dopo Tommaso. – Della vita seguente dell’Apostolo Matteo non abbiamo purtroppo nessuna notizia, perché gli Atti degli Apostoli non ne hanno affatto e la tradizione ne ha solo di troppo incerte; è certo soltanto, come per gli altri Apostoli, ch’egli lavorò per parecchi anni, dopo la risurrezione del Signore, fra i Giudei, ch’erano il suo popolo; non ci è possibile calcolare con esattezza per quanto tempo, essendo l’informazione trasmessaci da Eusebio abbastanza vaga; Clemente Alessandrino però direbbe per quindici anni. Questi scrive pure d’una vita del nostro Apostolo asceticamente assai rigida; non avrebbe mai mangiato carne, ma solo legumi, semi e frutta; forse qui però l’antico scrittore ecclesiastico scambia l’apostolo Matteo con l’Apostolo Mattia, che, secondo la testimonianza di Eusebio, avrebbe certamente predicato l’astinenza dalla carne; questo scambio fra i due Apostoli fu frequente in passato e lo è forse anche oggi; se Matteo, l’ospite felice, fosse poi divenuto asceta così severo, ci sembra che non avrebbe scritto nel suo Vangelo con tanta disinvoltura la parola del Signore: « Non quello che entra per la bocca rende l’uomo immondo ». Quanto alla regione, nella quale Matteo svolse la sua opera apostolica, negli Atti apocrifi leggiamo notizie così disordinate e aggrovigliate, da non poterle conciliare. (*) Ci son pervenuti il Martirio gnostico di Matteo nel Ponto; gli Atti etiopici di Matteo in Kahanat; una leggenda di Matteo partica; il Martirio di Matteo coptico (etiopico); una leggenda locale di Gerapoli; la leggenda di Matteo etiopica, in relazione con la leggenda indiana di Bartolomeo; e finalmente la « Passio Matthæi » latina. Da tutte queste leggende, spesso in contradizione fra di sé, non si può ricavare che ben poco di storico. All’apostolo Matteo è attribuito pure uno scritto: « Della nascita della Beata Vergine Maria e dell’infanzia del Redentore »; si tratta d’un’opera apocrifa del quinto secolo). – La tradizione più antica ricorda, come suo campo missionario, l’Arabia, la Persia e anzitutto l’Etiopia, l’odierna Abissinia, e per il giorno della sua festa il Breviario romano fa sua questa sentenza. La tradizione più recente lo fa Apostolo dei Parti e anche dei Macedoni. Negli Atti di Andrea si fa menzione del Ponto, dove Matteo avrebbe lavorato insieme ad Andrea e da questi sarebbe stato salvato dalle mani « degli antropofagi », che lo volevano divorare. È incerto anche il genere della sua morte; se prestiamo fede a una nota dello gnostico Eracleone, della metà del secondo secolo, che ci viene trasmessa da Clemente di Alessandria e alla quale questi aderisce, Matteo non sarebbe comparso « dinanzi ai giudici per rendere testimonianza », il che significa che non sarebbe morto martire, ma, come gli apostoli Filippo e Tommaso, di morte naturale; al contrario, le varie leggende, che non meritano d’essere qui addotte, sono prolisse spesso nel descrivere il martirio per lapidazione o abbruciamento o, ancor più spesso, per mezzo della decapitazione del nostro Matteo. Il Breviario romano ha accolto la « Passio Matthæi » latina, abbastanza tardiva, che è una dettagliata esposizione della leggenda di Matteo etiopica, secondo la quale egli avrebbe convertito, operando il miracolo della risurrezione della figlia del re, la famiglia reale e l’intero territorio; Irtaco però, il fratello e il successore del re convertito Eglippo, avrebbe fatto uccidere Matteo con la spada all’altare, durante la celebrazione dei santi Misteri, perché l’Apostolo s’era opposto al suo progetto di condurre in sposa la figlia del re precedente, Ifigenia, ch’era una vergine consacrata a Dio. Le reliquie del Martire dall’Etiopia sarebbero state trasportate prima a Pesto, città italiana nel golfo di Salerno, e nel decimo secolo nella stessa Salerno, dove sono onorate anche oggi. – Queste notizie intorno alle vicende dell’apostolo Matteo, dopo la Pentecoste, ci lasciano insoddisfatti, è vero, l’opera però, ch’egli compì e che gli sopravvisse per i secoli, è assai importante; per essa egli è asceso nella gerarchia degli Apostoli, tanto che lo si può ritenere il più grande fra i Dodici dopo Pietro e Giovanni: egli ci ha regalato il primo Vangelo, che Renan ha detto « il libro più importante della storia del mondo ». Il gabelliere, l’uomo della scrivania, inclinato per naturale disposizione e preparato dalla professione alla redazione scritta degli eventi, era quanto mai adatto per la divina Ispirazione, che voleva scrivere della vita e della dottrina di Gesù; ed egli volle prestare al Signore in giuliva riconoscenza quel servizio, al quale proprio come gabelliere era particolarmente abilitato. Così ci è dato di cogliere il misericordioso mistero della sua vocazione sotto un’altra luce e un altro significato: un giorno il pubblicano Matteo, fermo al sacro scrittoio, stenderà sulla carta le parole e le azioni, ch’egli ha visto ed ascoltato, con dignità ed esattezza, divenendo splendido modello e glorioso patrono di tutti coloro, che, per benigna provvidenza di Dio, potranno scrivere di nostro Signore Gesù Cristo.
L’EVANGELISTA
Del Vangelo di Matteo abbiamo una testimonianza esplicita dello stesso Papia, verso l’anno 110: « Matteo ha messo in ordine, in lingua ebraica, i discorsi del Signore — “tà légia” —. Ciascuno li tradusse — “herméneusen” — meglio che potè ». A questa testimonianza Ireneo aggiunge la sua, con un’indicazione cronologica veramente un po’ elastica: « Matteo pubblicò fra gli Ebrei, nella loro lingua, una scrittura del Vangelo, quando Pietro e Paolo annunziavano — oralmente — il lieto messaggio a Roma e vi fondavano la Chiesa ». Un particolare interessante conosce Panteno, il direttore e maestro della scuola catechetica di Alessandria, che verso l’anno 200 migrò nell’« India », vale a dire nell’Arabia Felice, l’odierna Arabia meridionale: « Il Vangelo scritto in lingua ebraica dall’evangelista Matteo fu portato a loro agli “Indiani” — dall’apostolo Bartolomeo ». Tracce di una cooperazione apostolica fra Matteo in Etiopia e Bartolomeo nell’« India esterna », limitrofa all’Etiopia, si riscontrano, come abbiamo già visto nel capitolo su Bartolomeo, nella leggenda etiopica di Matteo. Il coltissimo scrittore ecclesiastico Origene restringe le tradizioni intorno al Vangelo di Matteo nelle parole: « Io ho appreso dalla tradizione circa i quattro Vangeli, che soli sono riconosciuti senza discussione nella Chiesa universale di Dio, che il primo Vangelo fu scritto da Matteo, prima pubblicano e poi Apostolo di Gesù Cristo. Egli lo compose nella lingua ebraica per i Giudei convertiti alla fede ». I Padri sono unanimi nell’attestare che Matteo fu il primo dei quattro Evangelisti a scrivere un Vangelo; non è certo possibile stabilire l’anno esatto della composizione; dovette scrivere sicuramente prima dell’anno 70, che segnò il tramonto di Gerusalemme e la dispersione del popolo giudaico in tutto il mondo; un’antica tradizione orientale dichiara: «Matteo scrisse il suo Vangelo nel primo anno di governo dell’imperatore Claudio, nell’anno 42, nove anni dopo l’ascensione del Signore ». – La testimonianza di Papia addotta più sopra — « Matteo ha messo in iscritto i discorsi del Signore » — dal razionalismo è detta valere per una semplice « collezione di sentenze », che doveva essere ben diversa dall’odierno primo Vangelo; ma un pacato esame di essa mostra quanto a torto si dia questa interpretazione. Di fatto l’espressione greca «tà légia» = discorsi, sentenze, nell’uso letterario degli scrittori ecclesiastici del tempo significa tanto discorsi quanto anche fatti; lo stesso Papia, ad esempio, dichiara il contenuto del Vangelo di Marco dicendo una volta: « I discorsi e le azioni del Signore », un’altra invece dicendo brevemente « logia »; per lui « légia » è lo stesso che Vangelo. In realtà tutta l’antichità cristiana non seppe mai nulla d’una « collezione di sentenze » redatta da Matteo, diversa dal nostro primo Vangelo; d’altra parte già Ireneo e più tardi anche Eusebio intesero esplicitamente con quella espressione di Papia il Vangelo odierno di Matteo; del resto v’è anche una ragione intrinseca che autorizza di chiamare questo Vangelo « légia », discorsi o sentenze del Signore, perché contiene più degli altri Vangeli sinottici i discorsi di Gesù e fa che anche le azioni sue, in un modo o nell’altro, si concludano con la dottrina. L’originale ebraico o anche aramaico del Vangelo di Matteo andò presto perduto; e questo si comprende facilmente, poiché sulle comunità giudeocristiane, alle quali l’Evangelista aveva dedicato il suo Vangelo, ben presto infuriarono le tempeste della guerra giudaica e poi delle prime eresie, così che, tragicamente, proprio nella terra dei suoi natali il Cristianesimo non uscì mai da una breve primavera; falsificato però dalle leggende, quell’originale sopravvisse ancora sino al quinto secolo in quello, che fu chiamato « Vangelo degli Ebrei » (Il «Vangelo degli Ebrei » ebbe questo nome perché fu usato dai giudeocristiani della Palestina, che parlavano la lingua ebraica o aramaica; probabilmente era il testo originale aramaico del Vangelo di Matteo, rielaborato ed ampliato; a noi ne è giunta notizia soltanto attraverso i brevi frammenti citati da Girolamo; l’opera però era certamente sorta già prima del 150.) o anche « dei Nazarei », che il grande studioso della Bibbia Girolamo, morto nel 419 o 420, poté ancora vedere in due esemplari. In compenso di questa sorte infelice, il Vangelo di Matteo ebbe la fortuna d’un eccellente traduttore greco, che seppe trasfondere l’originale aramaico in una lingua greca sciolta ed elegante; la versione dovette essere ultimata prima del volgere del primo secolo, perché se ne incontrano tracce negli scritti ecclesiastici sorti prima che esso finisse. – Non conosciamo il traduttore greco del Vangelo aramaico di Matteo; « chi sia stato, non è sicuro », scrive Girolamo; chiunque però sia, egli poté consultare i Vangeli greci di Marco e di Luca, apparsi verso il sessanta; si comprende facilmente ch’egli li tenesse sott’occhio nel preparare la sua versione, specialmente per le parti, che avevano in comune col Vangelo, che traduceva; certe particolarità linguistiche, infatti, del Vangelo greco di Matteo accennano una dipendenza stilistica dal vangelo di Marco. Il 19 giugno 1911 la Pontificia Commissione Biblica dichiarò, con un suo decreto, che la versione greca concorda « sostanzialmente » col testo originale aramaico, e questa era già la persuasione di tutta l’antichità cristiana; i più antichi manoscritti della Bibbia, come anche tutte le sue antiche versioni, senza eccezione, attribuiscono il nostro primo Vangelo all’evangelista Matteo; numerosi suoi testi e allusioni ad esso ricorrono già nella « Didaché », dottrina dei dodici Apostoli, opera veneranda scritta verso l’anno 100, come pure nelle opere dei Padri apostolici Clemente Romano, che scrisse verso il 95, Ignazio di Antiochia, morto nel 107, del martire Policarpo verso il 156 e soprattutto dell’apologeta e martire Giustino; è un vero mosaico, che testimonia l’altissima stima, di cui godette il primo Vangelo fin dall’epoca postapostolica. Ma lo stesso Vangelo di Matteo depone a suo favore. Lo si apra in qualunque punto, anche alla prima pagina, e ci si farà incontro a ogni piè sospinto il gabelliere e calcolatore Matteo. Tradisce il suo autore anche il modo dimesso, col quale il primo Vangelo parla del nostro Apostolo: solo in questo Vangelo egli è detto pubblicano, sta dopo Tommaso, il convito è solo accennato. Inoltre, la conoscenza minuziosa delle condizioni geografiche, storiche, politiche e religiose nella Terra Santa al tempo del Signore, come la ricca conoscenza della Sacra Scrittura del Vecchio Testamento esigono come autore un giudeocristiano, contemporaneo di Gesù. È vero che la presentazione della sua vita nel nostro Vangelo è alquanto smorta e prosaica, mancante spesso di più precise indicazioni di tempi e di luoghi, senza vivaci descrizioni delle circostanze secondarie, senza riferimento di particolari interessanti; Marco scrive con maggiore perspicuità e tempra, Luca è più caldo e più intimo. Si confronti, ad esempio, la relazione della risurrezione della figlioletta di Giairo in Matteo e Marco: Matteo racconta un po’ scolorito: « Mentr’Egli parlava loro, venne un capo, cadde a terra dinanzi a Lui e disse: “Mia figlia è morta or ora; ma vieni, posa la tua mano su di lei, e vivrà” ». Marco invece descrive lo stesso episodio, che Matteo riferisce solo nella sua parte essenziale, nella cornice delle sue precise circostanze: « Quando Gesù fu partito di nuovo con la barca verso l’altra riva, radunò intorno a Lui una grande folla; giunse allora un archisinagogo di nome Giairo; questo Lo scorse, Gli cadde ai piedi e Lo pregò supplichevole: “La mia figlioletta sta agli ultimi respiri; ma vieni, e metti su di lei le mani, affinché sia salva e resti in vita” ». Oppure si confronti il racconto della fuga dei Discepoli sul Monte degli Olivi: in Matteo è detto: «Poi i discepoli Lo abbandonarono e fuggirono »; Marco invece aggiunge ancora un particolare: « Poi tutti Lo abbandonarono e fuggirono. Ma un giovanetto, che indossava sul nudo corpo soltanto un panno di lino, Lo seguiva » (Marc. XIV, 50). Questa indole del Vangelo di Matteo, poco circostanziato e molto impersonale nelle sue relazioni, ha indotto il razionalismo a sospettare; se l’autore fosse veramente un teste oculare e auricolare degli eventi, concludono i razionalisti, avrebbe redatto le notizie con più colorito e vivacità. Ma non abbiamo precisamente in questa oggettività una prova intrinseca, anche se indiretta, della genuinità del primo Vangelo? Non ogni scrittore dispone la materia con lo stesso colore e fantasia, ed è bene che sia così; lo stesso si dica degli scrittori biblici; giacché il carisma della divina ispirazione si adatta dolcemente e sapientemente al carattere dell’autore umano, senza concedergli necessariamente la perfezione naturale; e così anche a Matteo fece scrivere da Matteo: egli era stato per l’addietro un gabelliere, un uomo delle realtà fredde, un individuo dei calcoli e dei numeri; or chi non sa che di solito gli uomini della matematica e delle finanze si limitano all’essenziale e all’obiettivo, mentre non vedono volentieri le descrizioni? Appunto dunque questa maniera di scrivere poco ricca di fantasia, che osserviamo nel primo Vangelo, ci fa pensare che il gabelliere Matteo ne sia l’autore. Nelle sue informazioni evangeliche, egli tralascia parecchi particolari di ornamento e di quando in quando abbrevia tanto le descrizioni che esse ci riescono oscure; frattanto però il suo Vangelo è riuscito pure efficacemente misurato, solenne e dignitoso, a tal punte che in parecchi capitoli ci richiama le immagini rigidamente ieratiche di Bisanzio o una sacra funzione liturgica con corale calmo e maestoso. Quanto alle sue cose personali, Matteo nel suo Vangelo ha voluto essere molto riservato; tuttavia, non v’è riuscito in un settore, e cioè in quello… finanziario; il gabelliere Matteo, contro sua volontà, è tradito dalla conoscenza di denari e di affari, di cui si mostra ornato l’autore del primo Vangelo; come nel Vangelo di Luca le notizie di ammalati e guarigioni, così nel Vangelo di Matteo le « notizie di denaro » ricorrono più frequenti e più circostanziate; si capisce che le istruzioni di Gesù intorno a questa materia restarono impresse in modo particolarmente profondo nella memoria del pubblicano d’un tempo. Matteo scrive di denaro e di monete in dodici passi del suo Vangelo, mentre Giovanni soltanto in due. Il pubblicano… e l’aquila! Matteo menziona « l’oro » sin dal presepio di Gesù Bambino a Betlemme; è unico fra gli Evangelisti a riferire anche la riscossione e il pagamento miracoloso dell’imposta per il Tempio da parte di Cristo e di Pietro; solo nel suo Vangelo si leggono le parabole del « tesoro, che giaceva nascosto in un campo », e del « commerciante, che cercava delle perle nobili; quand’ebbe trovata una perla preziosa, andò e vendette tutto quello che possedeva e la comperò »; nel riferirle Matteo forse ripensò alla propria vocazione al regno dei Cieli; solo lui racconta dell’immisericordioso « servo, cui il re, alla resa dei conti, condonò dieci mila talenti, il quale però all’uscita acciuffò uno dei suoi conservi, che gli doveva cento denari »; degli « operai, che il padre di famiglia prese a giornata per la sua vigna, e pattuì con loro un denaro per giornata »; dei « talenti, che il padrone affidò ai suoi servi, al primo cinque, al secondo due, al terzo uno, a ciascuno secondo la sua capacità »; « al servo pigro il padrone rispose: “Avresti dovuto investire il mio denaro presso i banchieri e io, al mio ritorno, avrei potuto ritirare il mio con l’interesse” ». Comprendiamo bene che tali discorsi del Signore dovettero avere una risonanza particolare proprio in Matteo. Anche Marco e Luca, non v’è dubbio, quando è necessario, scrivono di affari e di denari; ma un confronto con loro, anche nei brani comuni a tutti e tre i Sinottici, mostra precisamente che Matteo si esprime con maggiore esattezza, con distinzioni più accurate. Così, ad esempio, quando riferisce il discorso detto dal Signore prima della missione degli Apostoli in Palestina, non rende quell’ordine: « Non prendetevi denaro per la via » così semplicemente come Luca, ma più particolareggiato: « Non procuratevi né oro né argento né rame »; nella questione del tributo dovuto a Cesare, Cristo, secondo l’informazione di Matteo, non richiede indeterminatamente « un denaro », come leggiamo in Marco e Luca, ma: « MostrateMi la moneta del tributo ». Per lui, ch’era stato esattore, non è indifferente che si dica una moneta o l’altra o semplicemente « denaro »; nessuno degli Evangelisti è come lui specializzato, vorremmo dire pedantemente esatto nel riferire il valore monetario; il suo orecchio, abituato al tintinnio delle monete, ascolta attento anche quando parla il Signore, s’Egli dica un «talento » o un « siclo », uno « statere » oppure un « didramma », un « asse », equivalente a tre centesimi, oppure solo un « quadrante », un centesimo! Nel suo Vangelo mostra di conoscere le monete più di tutti gli altri, perché ne menziona dieci specie diverse, mentre Marco ne ricorda solo cinque e Luca sei. Il primo Vangelo dunque porta evidente l’impronta del suo autore, del pubblicano e calcolatore Matteo. Nel suo Vangelo è pure manifesta la predilezione dei Giudei per i numeri sacri 3, 7, 8, 14, che vi ricorrono con tanta frequenza facilmente discernibili. Fin dal primo capitolo, che si direbbe alquanto studiato, ci incontriamo con gli antenati di nostro Signore Gesù Cristo secondo la natura umana, ch’egli enumera in tre gruppi di quattordici generazioni; il numero 14, secondo il metodo usato dagli Ebrei per indicarlo con le lettere dell’alfabeto, dà per risultato il nome « David »: D= 4 W=6; D = 4. La storia della vita di Gesù Cristo prima della sua comparsa in pubblico si articola intorno a sette profezie, il discorso al lago consta di sette parabole, il « Padre nostro » risulta di sette petizioni. Nell’ottavo e nono capitolo riferisce i miracoli spartiti in tre gruppi di tre miracoli, inserendo fra un gruppo e l’altro due richieste di Gesù. Questi rilievi ci consentono una visione panoramica della costruzione di tutto il Vangelo: è sistemato secondo determinate proporzioni, precisamente come solevano esporre i Giudei e in generale i Semiti; inoltre l’autore ama accostare quello ch’è omogeneo, tutto quello che per sostanza e forma è affine; Matteo ordina la materia sacra seguendo, almeno nel lungo tratto intermedio, dal capitolo 4, 17 al 18, 35, uno schema piuttosto logico, a differenza di Luca, che si propone di narrare « secondo ordine ». Può essere che questa propensione a scrivere secondo uno schema e sistema, per non dire con criterio matematico, quale si manifesta nel Vangelo, sia in Matteo un’eredità della sua precedente professione di esattore; comunque, percorrendo il libro, abbiamo la percezione del suo bisogno di condurre innanzi anche il Vangelo ordinatamente, con bella disposizione, come doveva fare prima con i suoi rotoli nell’ufficio della dogana. Così nella sezione centrale dell’opera raccoglie insieme i discorsi del Signore in cinque gruppi maggiori, dei quali il più importante è il discorso sul monte; e proprio nel discorso sul monte egli congiunge, in una mirabile composizione unitaria, discorsi pronunciati dal Signore in circostanze diverse, come risulta da un confronto col vangelo di Luca; in modo analogo unisce pure i miracoli di Gesù in racconti continuati, legandoli leggermente insieme coll’indeterminato « téte = dopo questo ». Ogni lettore intelligente comprende facilmente che questo metodo d’informazione evangelica, più logico che cronologico, non compromette per nulla la verità storica dei fatti; esso invece conferisce al Vangelo di Matteo chiarezza eccellente e dignitosa compattezza. In esso si distinguono chiaramente tre parti: 1. Preparazione 1, 1-4, II: albero genealogico e storia dell’infanzia; l’opera del Battista; battesimo e tentazione di Gesù. – 2. Decisione e separazione 4, 12-18, 35: Cristo offre al popolo la salvezza messianica: inizi dell’attività in Galilea; predica sul monte; prova dei miracoli; elezione e invio degli Apostoli. Il popolo rifiuta la salute: ambasciata del Battista; lamento e minaccia di Gesù; offensiva dell’ostilità farisaica. Cristo separa i credenti dai non credenti e li raduna nella Chiesa: parabole del regno dei Cieli; decollazione di Giovanni; ritorno di Gesù ai fedeli; fondazione della Chiesa su Pietro; istruzione degli Apostoli. – 3. Fine 19, 1-28, 20: Gesù in Giudea e a Gerusalemme; domenica delle Palme; contese e parole di punizione nel Tempio; la storia della Passione; Pasqua. – Come appare da questo disegno e dalle esplicite testimonianze dei Padri della Chiesa, Matteo scrisse questo Vangelo per i « Giudei », sia per quelli, che già erano passati al Nuovo Testamento, sia anche per gli altri, che ancora persistevano nel Testamento Antico; bisogna badare a questa destinazione del libro, perché giova alla sua intelligenza, giacché esso, il primo libro della Scrittura neotestamentaria, riecheggia il Vecchio Testamento. Ci si presenta subito il primo capitolo con l’albero genealogico di Gesù Cristo; agli uomini d’oggi fa l’impressione d’essere tanto arido; eppure è il venerabile vestibolo del Nuovo Testamento, è come una commovente processione delle personalità dell’Antico che muovono verso il Cristo: « Abramo generò Isacco; Isacco generò Giacobbe; Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli… ». Matteo rimanda continuamente alle rapide luci delle predizioni profetiche, ch’erano guizzate nell’orizzonte del Vecchio Testamento; appunto esse dovevano illuminare agli occhi dei Giudei la via che mena a Cristo: « Tutto questo è avvenuto perché avesse compimento quello, che il Signore aveva detto per mezzo del Profeta… »; « allora s’adempì la parola del Profeta, che dice… ». Nel vangelo di Matteo sono state contate non meno di settanta di queste citazioni e allusioni al Vecchio Testamento, mentre in Marco se ne contano solo diciotto, in Luca diciannove, in Giovanni dodici. Lo stesso senso di riguardo verso i destinatari giudei consigliò a Matteo di stendere nel suo Vangelo i discorsi del Signore circa la sua posizione di fronte alla legge del Vecchio Testamento, che Marco e Luca invece tralasciano: « Non crediate ch’Io sia venuto a togliere la Legge e i Profeti… Avete udito che è stato detto agli antichi… Ma Io vi dico…». Seguendo i Libri Santi del popolo giudaico, Matteo nel suo Vangelo cercò di persuaderlo che Gesù era il Messia promesso dalla Legge e dai Profeti, e che la Chiesa da Lui fondata era il regno messianico ardentemente atteso. Dall’abbondante materiale evangelico egli sceglie instancabile anche quelle frasi di Gesù, che si opponevano alle aspettative messianiche errate e travisate in senso terreno e nazionalistico dei Giudei: « Beati i poveri di spirito! Beati gli afflitti! Beati i mansueti… ». « Ti glorifico, o Padre, Signore del Cielo e della terra, perché Tu hai nascosto queste cose ai sapienti e ai potenti, ma le hai rivelate ai piccoli… » « Il regno dei Cieli è simile a un grano di senapa, ch’è più piccolo di tutte le altre sementi… È simile a un tesoro, che giaceva nascosto nel campo ».. Gesù è il Messia previsto dai Profeti nonostante la sua povertà e nonostante lo scandalo della croce; forse in nessun altro Vangelo ritorna tanto spesso il chiaroscuro della sua vita e ne è così percettibile il rapido cambiamento, come nel Vangelo di Matteo: Gesù è perseguitato da Erode, ma adorato dai gentili; viene battezzato come un peccatore, ma glorificato dal Padre; è tentato dal demonio, ma servito dagli Angeli; viene crocifisso come un delinquente, ma dalla natura e dagli uomini è attestato « vero Figlio di Dio ». – Matteo deve inoltre dare una ragione del doloroso mistero, per il quale anche Paolo lotta nei capitoli 9-11 della lettera ai Romani: perché il popolo eletto, nella sua maggioranza, abbia respinto Gesù qual Messia. Matteo documenta nel corso della sua storia quello, che Paolo afferma afflitto nella citata lettera: «In ogni tempo stendo le mie mani a un popolo, ch’è caparbio e restio »; e così leggiamo nel primo Vangelo della colpevole indifferenza dei capi già dinanzi al Neonato, della loro gelosia verso il Maestro, del loro odio infernale contro il Morente, della loro ultima malizia contro il Risorto. Si deve a questo motivo se Matteo, sebbene sia l’evangelista calmo, non ha avuto riguardo di consegnare allo scritto anche quel giudizio del Signore contro i suoi nemici, che, come uno scrosciante temporale, s’abbatté « sulle cieche guide dei ciechi »: « Guai a voi, Scribi e Farisei… », e per otto volte « Guai a voi»! Sembrano un’eco terrificante delle otto beatitudini all’inizio del vangelo. Ma nemmeno il popolo è senza colpa: « Il regno di Dio sarà tolto a voi e verrà dato a un popolo, che dà i suoi frutti » (XXI, 43); e Matteo è ancora il solo a notare quell’orrido grido del popolo giudaico, che rintronò mentre il pagano Pilato si lavava le mani: « Il suo Sangue scenda su di noi e sui nostri figli », e da allora rintronò in tutti i tempi e nel nostro secolo ha avuta l’eco più spaventosa. Un Vangelo scritto per i Giudei del primo secolo potrebbe sembrare per la nostra generazione sorpassato; non è però così, anche il Vangelo di Matteo trascende i tempi, anzi esso tenne sempre il primo posto fra i Vangeli sinottici e non solo in ordine di tempo, ma anche di importanza; esso può dire la sua parola precisa anche agli uomini d’oggi per la sua pacata obiettività, a motivo della quale è stato pure detto il « Vangelo accademico ». Il valore intrinseco per la cristianità moderna, tutto proprio di questo Vangelo, sta nelle sue trattazioni sul regno messianico: di contro a un regno messianico terreno, che oggi irrompe da tutte le parti e pretende da Cristo, come il Giudaismo d’un tempo, un paradiso sulla terra, è il Vangelo di Matteo che sottolinea la spiritualità del vero regno messianico; col riferire più diffusamente degli altri Evangelisti la predicazione di Gesù intorno al suo regno, Matteo è divenuto l’evangelista anche della… Chiesa, a quel modo che Giovanni è l’evangelista particolarmente della divinità di Gesù. – E in questo suo pregio, non altrove, si nascondono i veri motivi delle obiezioni contro di esso: è « il Vangelo della Chiesa », come ebbe a dirlo con caratteristica espressione il Renan; la Chiesa fondata da Cristo in esso si manifesta più chiaramente che non negli altri; le parole: « Tu sei Pietro! Su questo Pietro — Roccia — Io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno non la supereranno. Ti darò le chiavi del regno dei Cieli » risuonano lungo tutto il Vangelo. È significativo che la leggenda dei dodici articoli del Credo ponga in bocca a Matteo quello della Chiesa: « Credo in sanctam Ecclesiam catholicam — credo nella santa Chiesa Cattolica »; il suo Vangelo è il Vangelo « cattolico », cattolico nel senso più ampio della parola, anche perché, e qui sta il suo ultimo pregio particolare per la nostra straziata età, esso annunzia a tutti i popoli, i quali si sentono « eletti », che la salute messianica è comune a tutte le razze e classi e caste, è « cattolica », appartiene a tutti, tutti abbraccia, tutti concilia, tutti unisce. Com’è profondamente simbolico il fatto, che nel Vangelo di Matteo s’incontrino fin da principio dei pagani, che genuflettono dinanzi « al neonato Re dei Giudei », e nell’ultimo capitolo Cristo ordini ai suoi Discepoli: « Andate e ammaestrate tutti i popoli » (Matt. XXVIII, 19). Matteo, il pubblicano! Matteo, l’evangelista! I due momenti sono espressi vigorosamente e magnificamente dalla sua statua al Laterano: l’Apostolo, risoluto e sprezzante, mette il suo piede sopra il sacco dei denari, che scoppia, mentre il suo occhio e il suo cuore sono per il Libro Santo, che gli sta dinanzi sulle ginocchia grande e largo: esempio e monito a tutti, perché nessuno si renda schiavo delle cose di quaggiù, perché tutti camminino al di sopra della materia e divengano degni del santo Vangelo, conformino la propria vita ad esso, che ha avuto il primo redattore in Matteo. Poiché « l’uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola, che esce dalla bocca di Dio » (Matt. IV, 4).