
ORTODOSSIA: CEDIMENTI, COMPROMESSI (1)
[in: Riv. Dioces. Genov., 1961, pp. 270-308]
II – Ortodossia
Cari confratelli, il 1 agosto 1959, indirizzandovi una nostra lettera dal titolo Ortodossia, errori, pericoli, [Lettera pastorale scritta il 7 luglio 1961; «Rivista Diocesana Genovese», 1961, pp. 270-308], vi assicuravamo che avremmo continuato l’opera di denuncia contro gli errori soprattutto sottili, in lettere successive. Siamo qui per compiere insieme una promessa ed un dovere insiti nel nostro ufficio. Noi scriviamo per la verità, ben sapendo che solo sulla verità si erige il bene e che la fede, prima condizione per salvarsi, è di natura sua legata all’ortodossia, cioè alla verità. – In questa nostra lettera vogliamo intrattenervi su taluni indirizzi intellettuali e pratici che o si avviano a violare il sacrario della ortodossia cattolica, o contengono in sé i germi dai quali nascono, prima o poi, contraddizioni o, almeno, incongruenze colla stessa ortodossia cattolica. – Non certamente voi, cari sacerdoti di questa nostra diocesi, ma altri si adonteranno per il fatto che difendiamo la ortodossia. È già accaduto e accadrà ancora. Esiste gente che ha il sottaciuto pensiero di una mutazione universale delle cose, dalla quale nulla si salverà o si potrà salvare. Per essi il problema della ortodossia è quello di «adattare» o di «interpretare», non quello di difendere inalterato il deposito lasciatoci dagli Apostoli. Pertanto si offendono di chi difende la ortodossia; ma hanno torto, perché non vedono i punti fissi di questo gran mondo in cammino ed in movimento perenne, punti fissi che testimoniano della immobilità nella realtà e verità ultima. Essi non capiscono che cosa vogliano dire e testimoniare la loro stessa nascita e morte, punti non certo soggetti a mutazione, come molti altri. Noi reagiamo e reagiremo sempre, finché Dio ci darà vita, a questa equivoca illusione, ben sapendo che solo credendo e credendo a quello che ha voluto il Signore Nostro Gesù Cristo, senza adulterazioni e senza riduzioni, noi avremo la vita eterna (cfr. Gv. XX,31). – Ora, come già abbiamo avvertito nella precedente analoga e sopra citata lettera, non si tratta tanto di combattere contro aperte e formali eresie, ma contro infiltrazioni caute e viperine, le quali contano sulla grandissima ignoranza religiosa di moltissimi laici e sulla poca scienza teologica di non pochi dello stesso clero. Una parte di libri o di periodici, i quali si prestano alla infiltrazione di mentalità errate o pericolose, è talvolta passata sotto occhi ai quali una maggiore precisione teologica avrebbe certamente dato un senso di allarme e di motivato disgusto. Sappiamo finalmente che tutto l’argomento nel quale entriamo si troverà innanzi obiezione o addirittura condanna, per l’istanza della modernità, volendosi intendere come passatismo, conservatorismo, sclerosi, etc. tutto quanto difende la Tradizione. Se qui si parla di «passato» si intende accennare a quel «passato» che sono i fatti e i detti di Gesù Cristo, alla tradizione apostolica, all’opera magisteriale e di regime svolta nei secoli dalla Chiesa. – Sarà opportuno intenderci subito sulla modernità, senza bisogno di ripetere quanto vi abbiamo scritto in una nostra lunga lettera in proposito nel 1950. La modernità sarà nella comprensione e nella adeguazione ai tempi che si vivono, ma non è affatto nel contrarre le malattie, le menomazioni e le pazzie dei tempi che si vivono. Chi le contrae non è moderno, è malato. Chi se ne difende probabilmente sarà sempre in vantaggio sui tempi. Fare sacrifici, anche a danno della verità, per adeguarsi a malattie è accettare vie false e ridicole. Non crediamo che siano ancora a punto, per tutti i paesi, le statistiche obbiettive sul pauroso aumento delle malattie nervose, delle malattie mentali, delle anormalità. Da quello che si conosce, le cose si delineano preoccupanti. Ma se ci si prova a far proseguire la curva fino al 2000 colla stessa progressione (ed è poco perché la progressione aumenta), ci si deve domandare che cosa succederà allora. E questo non è un divertimento per quanti possono sperare di esserci, mentre è una pace per quanti possono presumere di non essere più in questo mondo. Se pure non accada che Dio, prima del 2000, abbia già permesso la punizione terribile alle presunzioni del mondo e alle paure di coloro che alle presunzioni non hanno per vigliaccheria resistito a tempo. Non tiriamo dunque in campo termini equivoci. Essi, del resto, verranno ancora discussi nel corso di questa nostra non breve lettera.
La lotta alla divina tradizione
La sacra Scrittura non è il solo fonte della rivelazione divina e pertanto non è la sola fonte dalla quale possiamo e dobbiamo sapere la «Parola di Dio». Ciò significa che non tutta la parola di Dio è stata consegnata allo scritto come accade nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, nelle Lettere apostoliche, nella Apocalisse. Vi è un margine che sta certamente oltre gli scritti apostolici. Del resto la Chiesa per qualche tempo nulla ebbe di scritto ed ebbe quello che possediamo noi solamente in tempo successivo, pur non eccedendo cronologicamente la vita del più longevo tra gli apostoli. Essa visse sostanzialmente di divina tradizione, poi a poco a poco, prima che si estinguesse la favilla diretta degli Apostoli, ebbe la Scrittura neotestamentaria. La Scrittura attinse da essa, ossia da quanto era stato consegnato a viva voce da Gesù e dai suoi autorizzati interpreti. La esistenza ed il valore della divina Tradizione appartengono alla fede cattolica e rinnegare la Tradizione è andare senz’altro fuori della ortodossia. – Gli antichi Concili hanno iniziato da una professione di fede nella Tradizione; alla stessa tutti si sono richiamati. Il Concilio di Trento, pur non avendo trattato a fondo l’argomento, afferma ed insegna esplicitamente la divina tradizione nella sua IV sessione; Pio IV riprende nettamente l’affermazione nella Professio Fidei Tridentina, imposta attraverso la Bolla Jnjunctum nobis del 13 novembre 1564. Non meno chiaramente si esprime il Concilio Vaticano I nel capitolo III de Fide. Di una cosa tanto chiara si nota in molti scrittori uno strano silenzio. Dobbiamo ricordare che Lutero si è divaricato dalla Chiesa tra l’altro per aver rigettato la divina tradizione, almeno nella sostanza. Al silenzio si aggiungono alcuni dati, che vanno ponderati con cura.
Teologia, predicazione, catechesi kerigmatica.
Se ne parla molto. Premettiamo che per kerigma si intende la «predicazione o il messaggio» di Gesù Cristo. Ma di tutto questo si può parlare in due sensi, l’uno buono, lodevole, utile; l’altro non accettabile dal senso cattolico.
a) senso buono.
La teologia, predicazione, catechesi kerigmatiche sono quelle che si attengono preferibilmente, ma non esclusivamente, al «messaggio scritto» di Nostro Signore. Tanto fanno per una duplice istanza, di essenzialità e di concretezza. La bontà di questo modo di concepire la «teologia kerigmatica» è garantita dal fatto che si attiene al « messaggio » e non esclude affatto il resto; ha cioè l’intenzione di cogliere ed incidere l’immediato ed essenziale della parola di Dio, facendo reazione al troppo dilagare di pensieri di uomini. Nessuno può negare che ci sia bisogno di un onesto richiamo all’essenziale, garantito da Dio.
b) senso cattolicamente non accettabile.
La teologia, predicazione, catechesi kerigmatiche contengono una affermazione negativa (larga in modo diverso). Cioè: che non ci si fida più di quanto sta oltre il nudo messaggio scritto, o lo si ritiene mutile, o lo si giudica aggeggio umanamente superaddito, tale pertanto da doversi ignorare volutamente o da doversi espungere. Nessuno vorrà mettere in dubbio che il kerigma così inteso non è cattolicamente accettabile; perché il modo diverso (a seconda delle diverse disgiuntive elencate) partecipa della posizione o addirittura della eresia protestantica. Infatti. Che cosa ci sta oltre il nudo messaggio di Cristo contenuto nella sacra Scrittura? Ci sta: la divina tradizione, l’opera di deduzione, esplicitazione, applicazione, ulteriore intellezione della parola di Dio sia scritta che tradita. Ora: quanto alla divina tradizione, abbiamo già parlato sopra e non occorre ripetere; basti dire che espungere la divina tradizione è la stessa cosa empia che espungere la sacra Scrittura. Si tratta infatti di un fonte della rivelazione divina. Per il rimanente (deduzione, etc), quanto è direttamente garantito dal magistero della Chiesa, sia ordinario che solenne, non può venire escluso, pena il rifiutare il Magistero stesso, ciò che implica la eresia protestante. – Il dovere di accettare quanto è presentato col consenso dei padri, o dei teologi, etc. (siccome si insegna nel trattato de locis theologicis), che è criterio certo di verità, lega proprio per la connessione col magistero infallibile della Chiesa. Accanto a tutto questo c’è un opera di delucidazione, di approfondimento, di sintesi, etc. fatta dalla teologia. Tale opera, per quanto beneficia del Magistero o del «consenso» dei quali si è discorso or ora, ha la stessa garanzia. Per quanto rappresenta l’indagine personale del teologo o di alcuni teologi, vale tanto quanto gli argomenti portati, nonché la serietà ed il sensus catholicus del metodo seguito. In questo campo si trova adunque l’opinabile e il discutibile. Per questa facoltà di opinare nel margine di ricerca, teologi hanno discusso anche tutta la vita. Tuttavia sarebbe nell’errore chi disprezzasse a priori questo lavoro dei teologi o della teologia. Esso, nella peggiore delle ipotesi, ha sempre rappresentato il necessario tentativo od allenamento per aiutare gli uomini a capire meglio la rivelazione divina ed a trarne più utili e salutari frutti. Taluni punti non si sono dilucidati bene se non attraverso una ridda di ipotesi e di opinioni spesso tra loro discordanti. Restringersi oggi soltanto al kerigma significherebbe probabilmente un arresto alla utilizzazione delle infinite ricchezze contenute nella «Parola di Dio». Il mondo, probabilmente, ha ancora da vivere e da camminare ed avrà necessità di trarre al giusto momento quella ricchezza e consolazione che la infinita paternità di Dio ha predisposto per i bisogni di tutte le diverse epoche nel fugace pellegrinaggio terreno. – C’è tuttavia qualcosa di più profondo e forse di più grave in questo modo inaccettabile di concepire il kerigma e pertanto la teologia, la predicazione e le catechesi kerigmatiche da parte di taluno, si tratti di buona fede o di mala fede (non siamo in grado di giudicarne). In costoro il misconoscimento o disprezzo della teologia lascia trasparire abbastanza la sfiducia nella ragione (agnosticismo kantiano), la opinione del «vuoto» o della inconsistenza delle nostre rappresentazioni intellettuali (nominalismo), la dottrina della doppia verità e pertanto del relativismo colla presunzione di tenere la porta aperta ad ogni evoluzione ed ulteriore creazione (idealismo). Costoro risuscitano il modernismo, solennemente condannato da Pio X. Essi dimenticano che per difendere una sola verità occorre difendere tutta la verità e che la verità è la base di tutto, anche della vita e dell’atto esistenziale. Ma qui non ci è sufficiente un giudizio, e lo abbiamo dato netto, ci occorre approfondire un punto. Coloro i quali ostentano sufficienza e disprezzo per la teologia, come se fosse in buona parte un garbuglio di filosofemi di nostra invenzione, non riflettono ad un punto, che è il seguente:
La divina rivelazione ha un contenuto reale e pertanto vero.
Mettere in dubbio questo non è eresia, è apostasia, perché è rinnegare tutto. Orbene, che significa avere la Rivelazione un contenuto reale vero? Significa che essa, così come è, e cioè nella sua espressione umana, corrisponde veramente ad una realtà obbiettiva divina. Ciò significa che i suoi mezzi espressivi – termini, costruzioni, immagini, sintesi, procedimento discorsivo e raziocinativo- , pur essendo «umani» e di comune corso nel pensiero e linguaggio umano, esprimono con verità (sia pure analogica) realtà terrestri e realtà celesti. – Andiamo avanti. Quelli che ho chiamato «mezzi espressivi» della Rivelazione sono gli stessi usati per qualunque indagine, costruzione od affermazione filosofica, letteraria, scientifica. Se hanno un valore per esprimere realtà rivelate sia terrestri che divine, hanno un valore nel puro e semplice pensiero umano. Anzi, prima lo hanno in questo,poi in quello. Essi, come connotano una realtà divina mentre servono alla Rivelazione, presuppongono la capacità di connotare una realtà terrestre, obbiettiva, concreta. Ossia: i termini del linguaggio e del pensiero, assunti dalla Rivelazione, rimandano ad una obiettiva filosofia umana e stabiliscono un rapporto di valore in quella; la quale, se valore non avesse, neppure servirebbe ad esprimere con valore cose divine. In breve: la assunzione di termini espressivi da parte della Rivelazione stabilisce un rapporto con quelli, col loro valore, col pensiero umano, col valore di questo. – Se così non fosse, ossia i termini assunti dalla Rivelazione non portassero in obiettiva e vera (sia pure analogica) cognizione di cose divine, Dio avrebbe rivelato nulla, non esisterebbe la Rivelazione, la tenebrosa solitudine caratterizzerebbe l’umana esistenza. – Il giorno in cui si negasse questo rimando della Rivelazione ad una filosofia umana, comune ed intramontabile per essere percepita ed intelletta, ad essere logici, si finirebbe col negare la rivelazione divina. Il che, siccome si è detto sopra, sarebbe non solo eresia, ma apostasia. Se i termini che io leggo nella Bibbia non hanno definizione sufficientemente intelleggibile e certa, la Bibbia cessa di dirmi qualunque cosa. E a questo punto che bisogna affrontare molte questioni poste con colpevole leggerezza da uomini insipienti. Ecco chiaro il motivo per cui il solo kerigma mi dice nulla, se non suppongo che i suoi termini hanno un valore obiettivo e durevole. Ecco il motivo per il quale nessuno può disprezzare la teologia, non solo quando fa le sue conclusioni teologiche, le sue applicazioni, etc, appoggiandosi ad un consenso e in definitiva ad un magistero divinamente costruito, ma anche quando diventa speculativa ed (indagando il valore umano dei termini e concetti assunti, oggetto della filosofia) illumina a buon diritto e con giusto criterio un pensiero divino tradotto a noi con rappresentazioni intellettive, le quali sono pure umane. La teologia non può essere ridotta alla filologia. Che mi importa della Incarnazione, se io non posso dare un valore a questo termine? Vi prego di passare tutte le parole che si trovano nella Rivelazione e porvi la stessa domanda. Affermare che la teologia non ha alcun contatto colla filosofia, che non è utile alcun sussidio derivato da questa, che basta il suono delle parole, è affermare una proposizione senza senso e anche contraddittoria per la pretesa di sapere, mentre si prescinde da quel valore obiettivo in base al quale si «sanno» i termini e senza del quale si sogna e non si apprende, si creano ombre inconsistenti, si getta tutto e tutti in quella relativa evoluzione senza appoggio, che è precisamente il modernismo. – Quale filosofia? Per rispondere occorre una osservazione previa. Esiste una somma di termini, di concetti, di principi che tutti gli uomini hanno sempre avuto ed hanno tuttavia, tutti, quando non si pongono in posizione riflessa, ossia artificiosa. Da quelli derivano conclusioni maggiori, legittime e ferme. Questi li ritrovo in tutti gli atti concreti degli uomini che vi si uniformano. Anche il filosofo, che nega il principio di causalità, non mette il dito sul fuoco per non scottarsi ed in tal modo, quando non è in posizione pregiudiziale, perché malamente e artificialmente riflessa, afferma continuamente quello che in qualche cattedratico momento nega. Si disegna così una filosofia perenne, strettamente imparentata con tutti i principi scientifici, veramente passati in patrimonio incontrovertibile della scienza, la quale vi ritorna ogni giorno per non morire. – Accanto a questa filosofia perenne esistono le filosofie, ora presuntuose ora rinunciatarie; ora astratte, ora troppo concrete; ora intellettualistiche, ora emotive, ora fantastiche. Queste hanno sempre qualche grano di saggezza; ma vanno e vengono come le mode, muoiono, risorgono e muoiono ancora. Esse hanno molte ragioni per dimostrare tale loro singolare andamento. Sono di pochissimi uomini, per quanto, tradotte in letteratura e così volgarizzate, hanno influenza anche su tutti gli uomini. Ma passano. Non è affar nostro in questa lettera discorrere delle ragioni dello strano fenomeno di contraddizioni, che talvolta a qualche spirito poco informato e meno avveduto suggeriscono tentazioni sconfortate di acre scetticismo. E sufficiente quello che abbiamo detto. – Ora abbiamo innanzi i due filoni del pensare umano. L’uno resta, l’altro muta. L’uno sgorga dalla natura, dal vergine raziocinare, dalla perenne ed identica constatazione della esperienza; l’altro ha origini opposte ed effimere. Ma un pensare universale ed identico, al quale tutto ritorna, c’è! E a questo evidentemente che si rivolge la teologia quando vuol indagare, usando di un suo diritto e compiendo un suo dovere. E per questo che la teologia, lasciando ai suoi margini le lotte di ulteriori indagini e di ipotesi di lavoro, ha avuto un filone costante, pur non essendo quasi mai stata nuda enunciazione di un kerigma, che per la sua divina sostanza dovrà essere pensato nel tempo e nella eternità e per la sua semplicità chiede l’ausilio interpretativo dell’umano linguaggio intellettuale. – E la filosofia tomistica? Nessuno che senta cattolicamente può accantonare l’enciclica Æterni Patris (4 agosto 1879) di Leone XIII. Quella enciclica è intramontabile. La risposta è facile. La Chiesa ha indicato come sussidio maggiore, tra tutta la produzione filosofica, quella di S. Tomaso d’Aquino, perché, oltre al pregio di sistemazione limpida ed universale del pensiero, aveva la qualità di essere aderente alla filosofia perenne. Ed è in questa aderenza che sta la forza di S. Tomaso. Non fu l’unico; fu l’unico a raggiungere un’altezza (che solo un altro grande può contendergli), unita ad una sistemazione scolastica. Come si vede la questione del kerigma non è questione così semplice, siccome appare a taluni. Essa involve questioni di fondo, che si impongono alla prudenza ed alla umile meditazione di chi ama la verità, perché ama Dio. Il discorso continuerà a proposito di un argomento che segue.
La cultura
Siamo dinanzi ad un argomento a proposito del quale occorrono talune gravi chiarificazioni coraggiose. Infatti la «cultura», o quello che non sempre a ragione si chiama «cultura», è diventata come il bosco di Efraim, del quale dice il secondo libro di Samuele, a proposito di una celebre e disgraziata battaglia tra fratelli, che «furono un numero molto più grande quelli che di tra il popolo uccise il bosco, che non gli accoppati dalla spada in quel giorno» (2 Sam. 18, 7-8). – E infatti nel campo della cultura che, sia dal punto di vista intellettuale, sia dal punto di vista pratico, appaiono cedimenti. Rispetto a questi cedimenti noi abbiamo il dovere di mettere in guardia i nostri confratelli. Si tratta di un discorso che, per ora, cominciamo soltanto. Per essere più sistematici è opportuno distinguere la cultura in senso soggettivo dalla cultura in senso oggettivo. La cultura in senso soggettivo è una qualità acquisita nello spirito umano dallo studio od almeno dall’apprendimento della natura, del pensiero altrui, delle lettere, delle scienze, delle arti, dei fatti. Questo studio od apprendimento è solo una fase necessaria per raggiungere la qualità sopraddetta. Infatti non basta l’apprendimento, ma occorre l’assimilazione degli elementi appresi, l’esercizio circa i medesimi in modo da conquistare – per la intelligenza stessa, per la intuizione, per il gusto, il sentimento e le rispettive capacità espressive — una nuova perfezione, una maggiore ed anche superiore finezza, una più feconda forza creatrice, doti di distinto pregio, più limpida armonia, saggezza. Infatti questo è quanto pensano gli uomini, magari indistintamente, allorché chiamano «colto» un loro simile. Nella – qualità spirituale che noi chiamiamo «cultura» è evidente il connubio tra gli elementi provenienti dall’esterno e la esercitazione e maturazione interiore; non è meno evidente il rifluire di tutto all’esterno, alla vita associata, con quelle manifestazioni irradianti sull’ambiente e sulle cose, dalle quali noi misuriamo l’«uomo di cultura», nonché la esistenza di un livello civile. La cultura in senso oggettivo è formata da tutto il patrimonio di pensiero, di scienza e di arte, di mezzi espressivi, sia fissato nei documenti e monumenti di qualunque genere, sia vivente nelle istituzioni, nei costumi, negli usi, nelle risorse crescenti di impiego della natura, o nel tenore di vita e nei rapporti tra gli uomini, nonché nel livello spirituale della loro esistenza; è formata ancora dal complesso di strumenti dei quali si mantiene e si aumenta il patrimonio stesso. Questo patrimonio assimilato e vivente, questa strumentazione amplissima confluiscono a determinare un livello, per sé sempre più alto, di attività spirituale e di situazione materiale. E importante notare come nella cultura in senso tanto soggettivo che oggettivo entra la libertà umana, anche scapigliata, colle sue mutevolezze, col gioco delle sue ombre illusioni errori, col peso delle sue passioni, colla vicenda delle sue colpe. Il gioco della libertà è reciproco; va cioè dalla cultura soggettiva a quella oggettiva e viceversa. E difficile determinare in questa reciprocità il valore dei rapporti. Tanto basta per stabilire con chiarezza che la cultura non è una astrazione angelica; è solamente un campo in cui tutto può essere pulito e sozzo a seconda del comportamento degli uomini, in cui generalmente, come è proprio di ogni settore umano, bene e male facilissimamente si mescolano. – È dunque grave errore parlare della «cultura» come di una entità a sé stante, esente da colpa originale e da deformazione. E cosa grande come è grande l’uomo ed è corruttibile come è corruttibile l’uomo. Abbiamo cercato di delineare sopra un concetto chiaro e scolastico, perché è inutile istituire un discorso su un argomento del quale o non si dicono o addirittura non esistono i contorni definienti. Tuttavia le cose vanno ben altrimenti nelle accezioni e confusioni correnti. Non che si tratti di definizioni (almeno nella maggior parte dei casi). Infatti la moda aborre freneticamente dalle definizioni ed il margine di incerto, quello lasciato dal tacere delle definizioni, oltre a permettere a ciascuno di dire quanto crede senza alcun obbligo di sola verità, crea un alone assai largo di incerto, di inafferrabile e di volubile, il quale alone fa parte sostanziale della cultura oggi ufficiale. Noi sappiamo benissimo che avremo fiere condanne, non tanto per quello che diciamo, quanto per aver dovuto portare l’argomento fuori dell’incerto comodo e versatilissimo. Comunque le cose stanno così. – Quando si vogliono recensire i diversi concetti di «cultura» conviene guardare ai fatti. Sono essi che presentano l’equivalente di bene o male congegnate definizioni. Guardiamo i fatti . Si tacciano come avversari della cultura coloro che non seguono le mode correnti letterarie, artistiche e filosofiche. Le mode correnti sono fatte da un certo numero di «centri», di «salotti», di «riviste», di « premi letterari ed artistici», e soprattutto di imprese industriali editoriali. La nota più rilevata è che nella maggior parte dei casi, qual motore aggiunto o motore unico, ci si scopre l’«affare economico», le mode correnti fanno avanzare e retrocedere gli astri; talvolta incappano in figure od iniziative che hanno indiscutibile valore; molte volte i valori creano, visto che non ne trovano. Le mode, da che mondo è mondo, sono sempre state associate alla frivolezza, al fanatismo ed alle reazioni. Certo, non sempre nella stessa misura. Ad osservare questo verrebbe di affermare la seguente definizione: « la cultura è quello che nelle anime e negli ambienti depongono un certo numero di mode più o meno fra loro organizzate». Non è una definizione incoraggiante. Si tacciano come avversari cella cultura coloro che non bevono, coi più ampi segni di consenso intimo, alle sorgenti dell’idealismo, del marxismo, dello esistenzialismo, del laicismo. Non abbiamo alcuna idea di discorrere qui del merito di queste vicende intellettuali. Ci preme solo trarre da questo contegno la definizione di cultura, che è evidentemente «sentita», alimento nel subcosciente, da gravi anatematizzatori. Essa è la seguente: «la cultura è lo stato dello spirito umano e della società in cui esso vegeta, allorché l’uno e l’altra si lasciano profondamente imbibere dallo idealismo, dal marxismo, dall’esistenzialismo, etc » . Tale definizione è meno incoraggiante della precedente, perché oltre tutto, affetta da un particolarismo rispetto al tempo e alle cose, con segni di aggravata caducità. – Si tacciano come avversari della cultura coloro che non accettano il dogma della evoluzione di tutte le cose, magari colla sottaciuta idea che conta la evoluzione in se stessa e non contano le cose in evoluzione. Se da un ambiente più sostenuto si scende ad un ambiente meno sostenuto, come se da un teatro ci riducessimo al teatrino delle marionette, si trovano tacciati come avversari della cultura quelli che non credono alla fantascienza. La scienza, quando è vera, è altra cosa ed è pienamente rispettabile. E opportuno ascrivere al seguito della fantascienza tutto il pensare e scrivere, che ritiene, con lo spostamento delle cognizioni fisiche e delle applicazioni tecniche, cambiare l’uomo e i principi dai quali fu retto fin qui. Al fondo di tutto questo si compone così una definizione: «la cultura si raggiunge al momento in cui ci si abbandona ad una corrente che cammina in avanti, verso un mondo privo di qualsiasi elemento in comune con quello nel quale siamo, ahimé!, troppo presto nati». – Si tacciano di avversari della cultura coloro che si rifiutano di abolire in ogni manifestazione del pensiero e dell’arte o della attività umana il diritto supremo della legge eterna, della verità di Dio. Difatti quando si osa dire che la morale e la verità stanno prima e sopra la cultura, i suoi strumenti, i suoi ozi e i suoi trionfi, si è investiti da un urlo che parrebbe tremendo. Ecco dunque la definizione che ne deriva: «la cultura è lo stato di evoluzione intellettuale e tecnica dell’uomo che ha abolito ogni assoluto e pertanto ha abolito Iddio». Questa definizione è la più rispondente al momento attuale di confusione delle lingue. – A taluni, che si dicono cristiani e lo sono in verità assai poco, vorremmo ricordare come essi tacciano di avversari della cultura quanti respingono il razionalismo. Dovremmo dire dunque che essi definiscono la «cultura» così: «adeguazione al razionalismo» ossia a quello che può essere eresia ed apostasia? Alle cose si dà il nome che meritano. Noi potremmo continuare coi fatti e colle definizioni relative. Chiediamo ai nostri confratelli di prendere atto della confusione regnante nell’argomento. Il prendere atto della confusione e della miseria su cui essa si regge è altro punto importante per lo scopo per il quale scriviamo. Si comprende però perché mai dissennatamente si parli di abolire la cultura classica greca e latina, la maggiore che abbia avuto la vita civile; perché si sostenga di dare solo o quasi solo una cultura tecnica, la quale difficilmente diverrà cultura per la assenza dell’aspetto più umano, ma in compenso renderà gli uomini schiavi dei tiranni. Infatti i tiranni sanno come usare le tecniche, tremano davanti ad ogni espressione del pensiero, ossia della humanitas. In tutto questo le più colpite sono la intelligenza, che viene o negata o anestetizzata, e la verità di cui si tace quasi sempre. Intanto il termometro scende. Il passato non dovrebbe esistere più: tradizione, patrimonio classico, autorità, … tutto ciarpame in nome della cultura. Un’orgia dello stesso tipo fu fatta in altro tempo in nome della libertà. Era il tempo in cui fu inventata la ghigliottina e fu usata più che in ogni altro tempo la ghigliottina. Quando si parla di cultura, si osservi bene questo panorama. Noi siamo qui a difendere la cultura. Ma per farlo dobbiamo denunciare le sue contraffazioni. Infatti diviene ora valevole una conclusione generale: mentre per cultura si dovrebbe intendere una somma di elementi positivi e veri, la loro assimilazione per la maggiore resa anzitutto spirituale dell’uomo, molti e forse troppi per cultura intendono piuttosto una elezione di metodi negativi, reazionari ed anarchici. Così la cultura pare a loro l’estremo grido di una libertà contro ogni legge, fosse pure in sostanza contro Dio stesso. Il fatto così inquadrato attenta anime che si credono cattoliche. Abbiamo voluto insistere sul concetto obbiettivo, visto anche in controluce, perché la «cultura» è in se stessa una cosa seria e sommamente utile, nonché per dare il criterio di distinzione da tutte le sue forme aberranti. Riassumiamo ora come sono andati i fatti e quale è stata l’anima che li conduce, in modo da vedere l’aspetto maggiormente permanente e sempre in modi diversi risorgente nella cosiddetta «cultura», che può essere e può non essere veramente tale. – Coll’umanesimo, venuto dopo la stanchezza d’un tramonto del Medio Evo, per reazione, per acquisizione splendida di elementi antichi, per bisogno di novità malamente interpretata, per colpa di coloro che hanno avuto troppi pensieri terreni, si è formata una concezione particolare. Essa non era aliena dal riprendere, dopo mille anni, un certo tono pelagiano. Eccola. L’uomo di lettere, di studio se non sempre di scienza, di mondo, si è creduto capace di organizzare colle sue sole forze tutto il suo destino e la sua felicità terrestre. Ha talvolta continuato a credere nella Rivelazione; ma ha cominciato a credere che quella valesse per la vita eterna e non fosse più affatto necessaria a regolare o condurre le vicende terrene. Era la più o meno esplicita negazione del soprannaturale che eleva la natura, non riconoscendo che i due aspetti si componevano per dare alla vita la sua equilibrata e salutare base. La vecchia gnosi docéta non riconosceva il vero corpo umano di Cristo, perché non era capace di pensare al supremo connubio tra qualcosa di materiale o terreno e quello che, ben più alto, aveva carattere e realtà divina. Il punto che serve a qualificare tutto nella Rivelazione del divin Salvatore è la Incarnazione, il mistero della unione ipostatica, tipo di tutte le altre disposizioni della Provvidenza per il mondo redento. – Comunque l’uomo di lettere, che si riteneva capace di far tutto da sé in questo mondo, operava, quasi non rendendosene conto, una separazione tra la redenzione e la terra, tra il cristiano e l’uomo. Faceva di più: sotto la spinta protestantica, che tentò di abolire la Chiesa, continuazione storica del Cristo, indusse per quella separazione la totale indipendenza, anche la opposizione in funzione di indipendenza. E la indipendenza filtrò dovunque contro gli stessi principi e valori che in seno alla natura, ben usata, avrebbero finito col fare dar ragione a Dio. Così oggi spesso l’uomo di lettere, di scienze e di arte, o di pensiero, non solo si sente indipendente da una rivelazione, ma è diventato indipendente da una intelligenza logica, da una verità obbiettiva, da un sentimento di universale armonia, da una nobiltà morale, che pure avrebbe trovato in qualche modo, anche se non perfetto, nel campo della natura. E dice e fa quello che vuole; fa scempio di quello che crede. Come se non dovesse morire e non portasse dentro di sé la testimonianza della sua immortalità! Non si accorge di ripetere solo una storia vecchia assai e della quale con pochi rimandi abbiamo descritto le ragioni e le fasi. E per questo motivo che esiste il laicismo: la lotta contro la Chiesa è solo un aspetto della lotta di indipendenza contro il soprannaturale della Rivelazione. È storia vecchia, nella nostra epoca moderna ebbe la sua più clamorosa vicenda coll’illuminismo, in quanto l’illuminismo parve segnare vittorie. Poiché una delle pagine più grandi della lotta sotto questo profilo, per la esaltata ricchezza di sommi ingegni e per lo slancio di vivaci ardimenti, si svolse in Francia sotto Luigi XIV, è sufficiente vedere che cosa rappresentino, da una parte il Tartuffe di Molière e dall’altra le prediche di Bossuet, lo splendore di Versailles e la fondazione della trappa compiuta, in reazione, dall’ex damerino l’Abate de Rancè. Episodi forse, ma episodi rivelatori al sommo della vera vicenda della cultura e del suo intimo significato. I termini si ripropongono oggi ed è singolarissimo quanto indicativo che, allorché il gran mondo tenta entrare nella Chiesa (o si trova sui margini vicini ad essa), non riproponga la tesi di Sartre, ma riprenda in parte il linguaggio della Action Française e, più indietro, dello illuminismo. Si tratta infatti della dottrina dei due piani separati, il terrestre e il celeste: «il mondo si occupi in piena indipendenza da ogni legge e criterio soprannaturale del primo, la Chiesa si occupi del secondo; gli uomini siano solamente uomini nel mondo e si mescolino a tutte le vicende e pensieri e passioni, siano invece dei cristiani in chiesa». Per taluni cattolici la cultura è tutta qui: dire e rifriggere, magari, ed accade spesso senza alcuna venustà letteraria, questa grande cosa terribilmente vecchia e vecchia come il docetismo, come il pelagianesimo. Si tratta insomma della lotta fra Cristo e il mondo, tra Dio creatore e l’uomo che tenta l’avventura del figliol prodigo e vuole assolutamente andarsene per conto proprio, finendo col mangiare ghiande. Tutta la storia è narrata già nel Vangelo di S. Luca al cap. XV. In questa lotta, se il cattolico entra ad un certo modo, può essere non se ne accorga (e Dio conceda il beneficio della ignoranza invincibile), tuttavia accetta molte conseguenze, delle quali, ove conoscesse le premesse, avrebbe orrore. – La vera cultura continua, come continua la missione dell’uomo in questo mondo e per essere se stessa, grande e aderente alla scienza ed alle scoperte, non ha affatto bisogno di scender a mettersi in contrasto col suo Signore. Abbiamo scritto perché foste avvertiti e perché possiate avvertire altri.
Cultura e tecnica
Ecco un altro punto sul quale si possono avere dei cedimenti dannosi e, soprattutto, falsi. Esiste una presentazione, effettuata coi mezzi propri degli ambienti di «cultura» che può essere riassunta come segue. – « Si deve considerare il complesso delle nozioni scientifiche (matematiche, fisiche, naturali di qualunque piano) come le vere espressive della nostra età, come le vere efficienti per il suo domani di benessere terreno, come nettamente distinte e nettamente superiori all’altro complesso di nozioni riassunte sotto il termine « umanesimo» e che comprendono pensiero filosofico, letteratura, arte, diritto, storia, etc ». Dunque: due complessi. Valutazione di superiorità assoluta per il complesso scientifico, tecnico, rispetto al complesso umanistico. Previsione di futura larga inutilità per il complesso umanistico e sua necessaria condanna, se non a scomparire, almeno ad assolvere solo una funzione marginale; e comunque: anche nel superstite umanesimo, prevalenza assoluta del dato positivo, erudito, statistico, nonché cella critica (soprattutto bibliografica) rispetto a tutto il rimanente questo è del resto quello che si fa già in larghissima misura). Infine opportunità di abolire quanto è possibile i due fulcri culturali classici che sono la cultura greca e la cultura latina e di sostituire una istituzione sostanzialmente tecnica, pedagogicamente e didatticamente adeguata alle nuove concezioni neopositivistiche. La questione ci riguarda per molti titoli, anche di fondo. Affinché voi, cari confratelli, siate in grado di giudicare, sottoponiamo diverse considerazioni che appaiono opportune.
a) Le nozioni scientifiche (intendendo scientifico secondo la proposizione or ora fatta) si raggiungono sperimentalmente solo attraverso l’accidens quantitatis che è una fondamentale caratteristica della materia e, per noi, la porta di accesso alle altre caratteristiche della materia stessa. Questo dato sperimentale può trovare nell’intelletto sviluppi e sintesi, ma non ne abbandona mai del tutto la unilateralità nella quale sta il fondamento su cui sorge. Si tratta dunque sempre di nozioni che, per quello che riguarda l’uomo, sono «parziali».
b) Le nozioni scientifiche (sempre nel senso sopraddetto) riguardano direttamente solo la materia; indirettamente riguardano fenomeni psicologici, ma in quanto controllabili dal dato sperimentale. Si tratta dunque di nozioni, le quali per altro titolo, collegato col primo, ma da esso diverso, sono ancora «parziali».
c) La «parzialità» è ovviamente rispetto all’uomo che:
– mediante la intelligenza supera il margine, per lui non impreteribile, dell’accidens quantitatis e può adire indefiniti oggetti in tutte le direzioni;
– mediante il sentimento ha aperto un campo al tutto estraneo al limite di quantità, anche se la quantità ne può misurare talune manifestazioni;
– mediante la intuizione è in grado di superare e prevenire moltissimi procedimenti della pura esperienza scientifica (siccome è accaduto per le più grandi scoperte);
– mediante le attività religiosa, morale ed artistica raggiunge realtà e rappresentazioni, non altrimenti raggiungibili;
– mediante la «vita», il cui misterioso principio sta dentro di lui unitario e continuo, ha una sovrana indipendenza di essere dal mondo che lo circonda. Al di là del mondo rappresentato dalle nozioni scientifiche sta un mondo incredibilmente più vasto e più vario. La cosa più curiosa e più misteriosa dell’umana esperienza resta la libertà degli uomini e pertanto la storia forgiata col diretto concorso di questa stessa libertà.
d) La «parzialità», della quale abbiamo discorso, dice chiaro che il complesso di tutte le nozioni scientifiche e tecniche presenti e future non sarà mai sufficiente a costituire per l’uomo una «cultura» che lo adegui convenientemente. La parte non vale mai il tutto.
e) Che se si volesse instare ed ottenere una «valutazione» di questa «parzialità», e stabilirne il rapporto rispetto al «rimanente» (se più, se meno), basterà ricordare qualcosa di quanto già detto. Un complesso di nozioni contratto entro le possibilità offerte da un solo accidente della materia stessa non sarà mai alla pari del complesso offerto da tutti gli accidenti e dalla sostanza stessa delle cose. Questo se si sta nel piano puramente materiale. Si aggiunga il piano spirituale, immenso, divino, eterno e si avrà una idea di come si facciano piccole, anche se ben importanti, le proporzioni culturali dell’elemento in oggetto. A questo punto ci rifacciamo semplicemente a quello che già abbiamo scritto nella precedente nostra Pastorale Ortodossia, errori, pericoli, dove abbiamo analizzato, a proposito di conquiste scientifiche quello che per gli uomini è il «meno» e quello che per loro sarà eternamente il «più». – Forse taluni non si accorgono affatto che nel difendere certe applicazioni od opposizioni, in verità, accettano premesse positivistiche, materialistiche, marxiste, in contrasto insanabile colla loro fede, ma in contrasto pure col più elementare buon senso e colla poesia che ha sempre, vivaddio, alitato sul mondo ben prima ed oltre tutte le formule.
f) Precisato tutto questo riconosciamo come il complesso scientifico tecnico diventa grande strumento per la vita e per le attività degli uomini diverse da quella scientifica. Esso permette di sviluppare l’agio, la ricerca, l’esperienza, la giustizia, le risorse. Per esso è possibile redimere il mondo dalla fatica bestiale e fare una più larga e più equa distribuzione dei beni della terra. Per esso si può rendere economicamente e pertanto umanamente più indipendente il singolo uomo. Per esso si propongono indefiniti oggetti che offriranno maggiore cognizione della Provvidenza e del Creatore. Ma si tratterà sempre di una parte, non della parte maggiore o sola costitutiva della cultura.
– Stiamo dunque attenti: per il bene degli uomini i vari aspetti vanno sommati e non reciprocamente elisi. Quando il mondo fosse tutto tecnico, il pensiero raffermo, nessuno libererebbe più gli uomini dalle tirannie; anestetizzato e meschino l’uomo sarebbe prigioniero. L’accidens quantitatis è sempre una cortina; l’anima sola ha la libertà di spaziare ovunque ed a questo le serve anzitutto la humanitas. Oltre, sta la parola e la grazia di Dio. Anche queste, che sono il «più», vanno computate e non appartengono certo alle nozioni dette scientifiche. Almeno per quelli che sono e si dicono cristiani. – L’attentato, che si sta facendo oggi (anche influendo in istituzioni giuridiche), è in realtà un attentato alla umanità, senza tener conto che il latino non lo vogliono soprattutto perché è uno strumento della Chiesa, con il quale essa si collega attraverso i tempi e attraverso lo spazio, ma perché distruggendo il latino è distrutta gran parte della humanitas. – Il rapporto tra la fede cattolica e la «cultura» è basato su alcuni principi, i quali debbono essere chiari e ben compresi.
a) Lo scopo del Regno di Dio in terra, e pertanto della Chiesa, è quello di continuare la missione redentrice di Gesù Cristo e pertanto di rendere gloria a Dio portando in cielo le anime.
b) Ogni altro scopo è secondario; non solo, ma deve essere ordinato in tutto a quello, che resta supremo.
c) Il Regno di Dio usa anzitutto e soprattutto i mezzi stabiliti da Gesù Cristo, per il raggiungimento dello scopo eterno, che rimane massimo anche per gli uomini singoli od associati. Tali mezzi sono: la fede, la grazia, la legge con tutti i relativi strumenti molto ben determinati nella rivelazione divina. Gli altri mezzi e strumenti sono secondari; debbono essere assunti ed ordinati secondo la ragione di quelli che rimangono principali.
d) La fede ha per oggetto la verità che Dio ha rivelato. Tali verità affermano anzitutto che esiste una verità assoluta, la quale, essendo manifestata attraverso forme intellettuali accessibili ed usate dall’intelletto umano, irradia una luce di sicurezza e di valore sulle verità di diritto naturale. La fede impone così un primato della verità, dalla quale pertanto nessuna attività umana può prescindere.
e) La grazia ha per contrapposto il decadimento del peccato dal quale eleva e redime, nonché la debolezza propria della natura umana anche come conseguenza del peccato stesso. Ossia la grazia afferma la esistenza del peccato e della debolezza, entrambi non come oggetto di umano trastullo, ma come termini dai quali e non contro i quali si deve risorgere.
f) La legge impone doveri, che sono proporzionati al fatto della divina adozione (lo stato più alto nel quale venga a trovarsi ed a crescere l’uomo). Ad essa tutto il rimanente rimane sottoposto. La legge divina poi, qualunque essa sia, naturale o sopranaturale, vincola ogni atto umano e non lascia pertanto alcuna area neutra, nella quale non entri la ragione di moralità.
g) Con la fede (accettazione di verità superne), con la legge (ordinamento degli atti verso un fine eterno e pertanto disposizione dei medesimi secondo superiore intelligenza, superiore armonia e superiore bellezza) il Regno di Dio dà e costituisce di per se stesso una «cultura» per gli uomini, essenziale, insostituibile, superiore.
h) Considerando che il Regno di Dio in terra è tutto definito e valutato dal suo fine proprio ed eterno, si deduce che non ha come fine suo essenziale e diretto quello di promuovere «la parte umana della cultura degli uomini». – Tutto ciò significa: che il Regno di Dio potrebbe anche non occuparsene, quando ciò non fosse richiesto da altre giuste considerazioni; che in ogni modo la parte «umana» della cultura occuperebbe sempre solo un posto secondario e al tutto subordinato. Ciò per le ragioni sopra dette: prima la salvezza delle anime nella gloria di Dio, poi tutto il resto.
i) Il Regno di Dio in terra mette a nudo, sia per la forza diretta della verità e della legge che porta con sé, sia per discriminazione operata dal confronto, tutto quello che c’è o ci può essere di errore, di deformazione, di debolezza, di malo uso della libertà nella parte «umana», nella cultura degli uomini. Questa funzione illuminativa e discriminatoria ha lo stile netto, solenne e vivacissimo che ebbe Cristo stesso quando si levò contro le deformazioni di tutti i generi nel suo tempo in mezzo al suo popolo. – Dunque non è tutto buono nella «cultura» umana, e nulla può sfere accettato per il fatto solo che a titolo vero od appariscente appartiene alla «cultura». Ossia: l’essere o il parere cultura non dispensa affatto dalla grande distinzione tra il bene ed il male e non autorizza ad assumere a titolo di cultura quello che è in se stesso un male. Il primo grande rapporto tra il Regno di Dio e la cultura umana sta in questa illuminazione, discriminazione, classificazione, che rientra nella distinzione tra «Cristo» e il «mondo». Quello che è vero e onesto, seriamente scientifico, vera e pura espressione di arte, non cadrà sotto questa condanna o discriminazione.
l) La cultura propria del Regno di Dio, della quale si è parlato sopra, implica ed istilla una particolare simpatia, un profondo interesse, una amabile sollecitudine per la «parte puramente umana della cultura». Ciò purché non sia contaminazione di errore, attentato alla debolezza, provocazione al disordine ed al peccato. Vi è una singolare naturalezza, perché la Rivelazione divina, entrando negli uomini con un loro atto di fede (ossia di intelletto), volge la elezione di simpatia verso ogni uso ed elevazione della intelligenza umana e del complesso nel quale la intelligenza è signora e regina. – Ossia: premessa una ben netta e chiara distinzione e valutazione, il Regno di Dio in terra ama, non odia, favorisce, non disprezza la integrale cultura degli uomini. Anche perché alla medesima apporta il divino contributo ed il divino criterio della Parola di Dio.
m) L’opera del Regno di Dio trae certamente vantaggio dalla «cultura» umana, quando essa è onesta ed in quanto essa è onestamente assunta. Fino a questo punto non abbiamo affatto invocato la verità storica. Potevamo anche farlo. In realtà della conservazione della cultura antica e dell’avviamento di tutta la cultura moderna il mondo va debitore alla Chiesa. L o stesso ordine degli studi medi, ad onta di tutte le riforme, ricalca ancor oggi la Ratio studiorum che S. Ignazio dettò per le sue fondazioni. Ci furono contrasti, dei quali non è affare nostro discorrere qui, ma alla luce dei principi detti sopra si è in grado di capire l’intima logica di tali contrasti. Per la Chiesa il divino impegno di salvare le anime ha sempre la precedenza e, se si comprende che cosa sia il salvare l’anima, nessuno, in via di massima, le vorrà dare torto. Gli episodi singoli seguono talvolta i difetti piuttosto che le «linee» della Chiesa. Non è dunque a questi episodi che si deve soltanto guardare per esprimere un giudizio complessivo. – Noi abbiamo scritto questa parte nell’intento di servire i confratelli della nostra diocesi, perché avevamo obbiettivi ben definiti. Essi saranno chiari in queste conclusioni. E sarà anche chiaro perché l’argomento trattato sta sotto il generale titolo di Ortodossia: cedimenti, compromessi. – Nel voler portare la Chiesa verso la «cultura moderna» talvolta si cela un pericoloso equivoco. Ciò significa che si possono dire cose vere e cose false; che si possono adottare orientamenti ragionevoli e orientamenti irragionevoli. L’equivoco si evita discernendo accuratamente tra i primi e i secondi. Sta di fatto che taluni cattolici appaiono investiti di questa missione: portare la Chiesa verso la «cultura moderna». Nessuno dubita delle intenzioni. Si tratta di valutare le azioni.
a) Se nell’intendimento di portare la Chiesa verso la «cultura moderna» si celasse, come di fatto in taluni si cela, l’idea che, senza un bagno di «cultura moderna», la Chiesa non può rimanere giovane o compiere la sua missione, si sbaglia. – La Chiesa ha dal suo divin Fondatore tutti i mezzi necessari per assolvere il suo compito. Può giovarsi di tutto, senza fallo; ma altro è dire che qualcosa le giovi, altro è dire che qualcosa le è necessario od è condizione perché essa operi.
b) È fuori dubbio che per «bagno di cultura moderna» si intende da taluni una certa evoluzione, se non una completa evoluzione, una adozione anche parziale del relativismo, un modo interpretativo del dogma e della Parola di Dio che si avvicini al «libero esame», una rielaborazione della morale, tale da far accettare la zaffata immonda di molte espressioni scritte e figurate nella «cultura moderna» stessa. – Il grosso equivoco, il pericoloso cedimento sta proprio qui. Non manca chi stabilisce termini di una evoluzione, la quale va fuori della retta dottrina. Tuttavia nella maggior parte dei casi si parla in modo generico e tale che impedisce un giudizio preciso. Ma il timore lo si prova precisamente dinanzi al parlare generico di evoluzione. Infatti chi parla troppo generico o è perché non sa o è perché nasconde di peggio. Pelagio e Celestio con il loro parlare generico nella più insidiosa eresia della storia cristiana tennero a bada per qualche tempo le condanne, e a disincantare la questione dalle nebbie ci volle un sinodo palestinese. Pertanto il parlare generico di ma evoluzione o, se piace, di una cultura moderna che liberi la Chiesa e la metta sulla strada di una evoluzione generica, purtroppo, autorizza a decidere niente, autorizza a sospettare tutto. Anche il peggio., già debitamente condannato dalla Enciclica Pascendi e nel decreto Lamentabili di san Pio X . Lo stesso deve dirsi se l’avvicinamento alla cultura moderna ha per scopo di farle assorbire relativismo, idealismo, amoralismo. – Quando si accarezzano espressioni letterarie e filosofiche che o stanno su certe sponde o a certe sponde mirano, non si tenta forse di attirare i cattolici e la Chiesa stessa su un terreno che non è più di Gesù Cristo? Per «cultura moderna» si intendono anche certe sue «istanze», le quali riscuotono al momento e per motivi passeggeri un interesse di un determinato tipo. La libertà e la democrazia possono essere di tutti i tempi. Oggi costituiscono per molti un ideale, che ha sfumature interessanti. La libertà viene, in questo cono d’ombra, presentata anche come uno svincolo da ogni legge, da ogni superiorità ed autorità. E la vendetta di chi non può che essere piccolo, contro quello che ritiene sia grande. La democrazia, che è degnissima cosa, nel parlare e nel costume di taluni è una forma di sentirsi superiori ad ogni pur necessario ordine costituito, senza limiti e senza remore. – Ora, a leggere certi scritti e ad esaminare certi contegni, si deve dedurre che «condurre la Chiesa verso la cultura moderna», significhi proprio portarla verso quel concetto di libertà e democrazia. Essi sognano i tempi in cui i vescovi faranno i salariati e il Papa riprenderà a pescare con le reti di S. Pietro. Sarebbe un bel successo. – Non si creda che intendiamo scherzare. Si tratta di anarchia, di indisciplina, di incapacità ad osservare una legge, di invidia, di rancore, di spirito di rivincita. Si tratta di creare miti i quali suppliscano a quello che non c’è. A questo punto la «cultura» non c’entra più; c’entra tuttavia il suo cartellone. Perché il suo cartellone si inalbera ovunque c’è uno stampato, un convegno, un raduno, o qualche Balatrone che, suspendens omnia naso comechessia, fa un po’ di retorica. C’entra poi sempre dove ci sono fogli, concorsi e premi.
d) Nella cosiddetta cultura moderna tengono i «primi posti» la forma, l’arte intesa come forma espressiva od intuitiva, la originalità, la vampa di indipendenza, l’audacia di giudizio spregiudicato, l’avventura di negazioni, «l’angoscia del dubbio». – Forse domani alcuni di questi «primi posti» saranno qualificati fuori della «cultura» e magari nella «patologia»; ma per oggi è così. In questo caso «portare la Chiesa verso la cultura moderna» significa tentare di addormentarla perché, sotto la forma e l’arte, non si prenda più pena per la sostanza, per il fine eterno, per il peccato commesso, per lo svuotamento della intelligenza e della vita. Vale la pena di soffermarsi e riflettere. – La «forma» (sia letteraria, sia artistica) non è mai sola «forma», a meno che non ci si riduca ad una decadenza retorica, che blatera senza dire. Ogni «forma» vera, letteraria od artistica, è quello che è perché trasuda in essa una sostanza interiormente espressa e sentita. Per tale motivo la questione della «forma» nella cultura è questione grave e difficile, da trattarsi con rispetto e con misura. E può anche essere che, per influsso di alta intelligenza e alta emozione, sia notevole e di pregio persino la forma che avvolge una sostanza indegna. In questo caso la «forma» non dispensa mai dal giudizio netto e vero sulla sostanza indegna. – Dinanzi alla «forma» che avvolge ed esprime una sostanza indegna o che mette in opera un attentato alla onestà delle anime (sia letteraria, cinematografica od altro), non si può fingere di non vedere. – Si potrà far capire che, colle riserve e condanne sulla sostanza, si apprezza l’intelligenza e la sensibilità. Ma il giudizio deve essere discriminato e non sciocco. Si potrà addolcire con oneste risorse qualche giudizio «vero» e «discriminante»; in tal modo si potrà fare dell’apostolato verso i lontani. Con essi, quando non v’è l’occasione di doversi esprimere, si potrà anche tacere. Qualche volta. Ma intendere un apostolato verso letterati ed artisti come un perenne atto di «contrarre» la verità, per piacere a loro e persuaderli meglio, non è onesto. Non sunt facienda mala ut veniant bona! Del resto la nostra personale esperienza di ben trent’anni in questo campo ci avverte che i pensatori o letterati o registi, etc., poco in linea colla verità e la legge di Dio, se apprezzano la nostra amabilità sincera verso di loro, apprezzano soprattutto la nostra coerenza. Nessuno di costoro, se è intelligente davvero, stima chi nasconde qualcosa. Misura, cortesia, carità squisita, comprensione sono grandi armi per l’apostolato (soprattutto la pazienza); ma valgono poco se creano una verità effimera, diversa da quella obbiettiva, tirata per la occasione entro il letto di Procuste. Il gioco, ai veramente intelligenti, almeno, rimane sempre scoperto. Per gli altri non è onesto.
e) Nella cosiddetta «cultura moderna» hanno forza di assioma alcuni effati, i quali sono fortemente discutibili o addirittura erronei. Soprattutto hanno la durata delle cose effimere. Eccone un esempio.
-«La filosofia deve essere originale. Non si ammettono ripetizioni».
Nessuno nega che la originalità sia indice di ingegno. Ma se la originalità diviene canone supremo, esso vince sulla verità ed immette valevole quanto è originale anche se non risponde ad una verità obbiettiva. La filosofia ha del cammino da percorrere; ma nessuno può imporle di rinnegare quello che è seriamente acquisito, soprattutto se verte su principi supremi, su fondamenti universali, su problemi di fondo.
–«La problematica e la critica non hanno limiti nei loro diritti».
Ciò è falso per ragioni evidenti. Anzitutto non può essere problematico quello che è evidente o seriamente dimostrato. In secondo luogo la critica ha luogo ove resta ancora possibile un giudizio; sia perché si tratta di affermazione particolare, sia perché si tratta di aspetti diversi, sia perché pencolano dubbi seri, sia perché si sta nel campo dell’opinabile. Insomma: si giudica quando c’è da giudicare, se se ne hanno la competenza e gli strumenti adeguati. Fuori di questo limite si cade per lo meno nell’arbitrario e probabilmente nel falso e nell’ingiusto.
-«La demolizione del passato e di ogni tradizione fa parte del rinnovarsi dello spirito umano».
Non si demolisce per demolire, ma si demolisce solo quello che non ha diritto di esistere e non ha ragione per esistere. L’assioma pertanto nel suo carattere assoluto è falso, perché abbisogna di molte distinzioni e deve essere contratto a casi particolari, nonché documentati. In secondo luogo la nostra vita e i suoi strumenti, senza soluzione di continuità, appartengono al passato, il quale continua ad essere il centro sul quale ruotano i fatti e sul quale si stabiliscono via via le acquisizioni nuove. In terzo luogo gli elementi sostanziali perché l’uomo viva da uomo rimangono invariati: la famiglia, la socialità, l’amore, la morale, l’istinto, il dato biologico; il cosmo nella sua materia e nelle sue leggi, i fondamentali bisogni della luce, del buono, del bello, dell’ordine, dell’avvenire, anche oltre la morte, la quale continua ad essere signora unica di coloro che non si piegano a Dio. – Si aggiunga che la volontà della demolizione è frutto di una ira indiscriminata ed indistinta, segno a sua volta di una deformazione e di una inutile pena. Il rinnovarsi dello spirito umano, dato che le cose sono quelle che sono, avviene acquistando e componendo nuove esperienze; perdendo quello che ha incrostato ed appesantito l’anima; ritornando continuamente ad un equilibrio, senza alcun compromesso. La rinnovazione è insomma un atto positivo e non negativo. L’uomo non vive di rabbia contro se stesso, contro il cielo e contro la terra. Per molte persone la «cultura» è leggere libri che propalano simili panzane. Per altre la «cultura» è fingere di prendere sul serio, imbastendo critiche elogiative, i medesimi libri. Al qual proposito badiamo di non dimenticare che per taluni ambienti la «cultura» è data dal leggere e dissertare ogni anno su quella dozzina di libri che invadono un certo numero di salotti e li invadono perché sostenuti da una organizzata propaganda, orientata solamente sul guadagno.
–«La cultura è essenzialmente soggettiva e deve riflettere stati dello spirito umano».
La affermazione così come è detta è falsa. La ragione è che se la cultura dovesse solo rappresentare stati dello spirito umano (col che si intende sempre e positivamente escludere il raziocinio), dovrebbe mettere da parte la storia, la scienza positiva e tutti gli strumenti coi quali si aiutano gli uomini a passare dallo stato di ignoranza allo stato di cultura. Tutti gli insegnanti dovrebbero limitarsi ad aiutare i loro alunni a interpretare i propri stati d’animo. In tal caso la diversità tra il mondo della cultura ed una grigia clinica psicanalitica sarebbe ben poca. – Esagerazione questa? Solo lo sviluppo logico di una affermazione che ha un significato ben preciso. Tanto basta perché si veda che la proposizione non regge, anche se per avventura avesse in sé qualche elemento accettabile. E l’ha di fatto, perché la cultura ha molte sorgenti, alcune obbiettive ed altre soggettive. Voler negare la incidenza soggettiva nella letteratura e nell’arte sarebbe accollarsi un torto evidente. Tuttavia c’è diversità fra dato soggettivo e stato d’animo. Essi coincidono solo in parte. Il dato soggettivo abbraccia quanto è all’interno; lo stato d’animo si restringe ad un settore di emotività. Tutta l’arte è pervasa anche dal mondo soggettivo; chi potrebbe negarlo? Ma se lo stesso mondo soggettivo disdegna certe sue manifestazioni e tende solo ad esprimere l’istinto (comechessia), certamente impoverisce. Potrà continuare ad addurre qualcosa al mondo della cultura; ma resta ben lontano dal costruirlo da solo e soprattutto resta incapace di costruirlo bene. Gli antichi hanno raccontato qualche volta delle favole, anche con grande saggezza; ma le favole si raccontano ai bimbi nella fase di crescita della loro innocente fantasia. Si narrano anche ai grandi; ma non come favole, bensì in modi abbastanza decorosamente togati. La proposizione, che ha momenti di meritata prosperità, vive esclusivamente di linfa idealistica e sottrae agli uomini forse la parte migliore della loro complessiva esperienza terrestre. Essa costituisce un limite culturalmente dannoso. – L’uomo non vive un sogno che naturalmente si dissolva nel nulla. Quel sogno riassume tutta la popolazione culturalistica anticattolica moderna. Nessuno di noi può recitare il «Credo» e poi, anche solo indirettamente, barare colla parte decisamente avversa al «Credo». Per lo stesso motivo nessuno può ritenere terreno neutro quello in cui stanno, aperte o palliate, se non tutte le affermazioni, almeno tutte le premesse di una negazione totale della fede. Noi sappiamo al contrario che la vita non è un sogno, ma una realtà di prove preziosa e pericolosa. Come non si dissolve la vita nel sogno, neppure si dissolve la verità nella illusione. Verità, bene e bellezza continuano a essere le grandi linee orientative di una cultura, qualunque essa sia. – L’indirizzo culturalistico moderno mantiene ben pochi rapporti con la verità di cui non ha neppure il senso, col bene di cui ha sovente il disprezzo, col bello di cui non ha, si direbbe, neppure più la capacita, pur tradendone ad ogni passo la incommensurabile sete. Formule, che sembrano culturali, contrabbandano invece uno stato di alterazione e di malattia. Di fatto il clima di catastrofe cresce nel mondo e prima responsabile ne è la cultura. – A noi interessa gettare il grido di allarme: perché il clero e i veri cattolici si ricordino che la missione della Chiesa sta prima e sopra la cultura, perché non si apra la porta al complesso di inferiorità il quale induce a scimmiottare quanto fa il « mondo »; perché non si apra, magari umidamente, la porta a fantasie e dissolvimenti, contrabbandati quale cultura e che invece non sono altro se non corruzioni dello stesso umano valore. – Noi vogliamo la cultura, ma ci riserviamo integro il diritto di giudicare se lo sia, oppure se non sia tutt’altro. Noi non abbiamo scritto contro la vera cultura, ma solo contro le sue deformazioni, che tentano di dividere e di macerare il campo cattolico. In tali settori l’intento diabolico è riuscito e questo constatiamo con infinita amarezza. – La Chiesa, pur non essendo mandata a fare per sé una azione di umana cultura, come si è detto, ha il diritto di intervenire e prendere iniziative tanto quanto ha il diritto di attendere alla educazione e quanto ha il diritto di promuovere in ogni settore il bene delle anime, l’indirizzo cristiano della società. Quello che deve rimanere è la distinzione tra la vera cultura e le deformazioni della medesima o quelle subdole sostituzioni, le quali coincidono di fatto cogli strumenti della falsità e della colpa. Strane fissazioni, artificiose limitazioni, illusioni proiettate per lasciare in ombra realtà e responsabilità eterne, ingenui fantasmi e petulanti chimere sembrano solcare la cosiddetta cultura moderna. La anarchia dal raziocinio e dai principi di esso pare esserne gran vanto. Essa costruisce una sorta di satellite artificiale sul quale, a piacimento, nulla trattiene più la esplosione dell’istinto e della irresponsabilità. Chi vuole la cultura deve avere la saggezza di cercare al di là del satellite artificiale o, meglio, deve cercare sulla terra vergine i lineamenti coi quali l’ha fatta Iddio. E ormai chiaro: non parliamo di quello che merita e meriterà sempre il nome di cultura. Parliamo della «cosiddetta cultura», fatta non della ricerca, delle biblioteche, della saggezza di tutti i tempi, della pensata responsabile esperienza d’oggi sommata con quella di ieri, ma fatta dai salotti, dalle riviste di moda, dalle ombre peccaminose delle quinte, dai premi, soprattutto da mali istinti politici e dagli ingordi affari. – Questo richiamato e premesso, invitiamo i nostri confratelli ad osservare il rapporto che c’è tra il «mondo» e la «cosiddetta cultura». Si tratta del «mondo» del quale il Salvatore ha duramente sentenziato, ambiente di peccato, di rivolta, di negazione e di vendetta. La «cosiddetta cultura» è espressione di quel mondo. Oggi ne è lo strumento più diretto e penetrante. – Ascoltiamo ora la Parola di Dio. Scrive san Paolo nella I ai Corinti (I, 18 sgg., II, 1 sgg.): «La Parola della Croce infatti è stoltezza per coloro che se ne vanno in perdizione, ma per noi, che siamo sulla via della salvezza, è forza di Dio, poiché fu scritto: «Manderò a male la saggezza dei savi e renderò vana la intelligenza degli intelligenti». Dov’è il sapiente? Dove il letterato? Dove il filosofo di questo mondo? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti non avendo il mondo con tutta la sua sapienza conosciuto Dio nelle opere della sapienza divina, piacque a Dio salvare i credenti colla stoltezza della predicazione. Invero i Giudei domandano miracoli e i Greci ricercano la sapienza; noi invece predichiamo Cristo crocifisso, che è uno scandalo per i Giudei, una stoltezza per i gentili, ma per quelli che da Dio sono chiamati, siano essi Giudei o Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Sì, la stoltezza di Dio è più forte di tutta la potenza umana. Considerate fratelli la nostra vocazione: tra voi non ci sono né molti uomini sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma invece Dio ha scelto gli stolti agli occhi del mondo per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, e gli ignobili e spregiati dal mondo e ciò che nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa darsi vanto dinanzi a Dio. Orbene per mezzo suo voi siete con Cristo Gesù il quale per opera di Dio divenne nostra sapienza e giustizia e santificazione e redenzione […] Io pure quando venni da voi, fratelli, non venni ad annunziarvi il messaggio di Dio con sublimità di eloquio o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro in mezzo a voi che Gesù Cristo e Gesù crocifisso […] Affinché la vostra sapienza non sia basata sopra l’umana sapienza, ma sulla potenza di Dio. Parliamo, sì, noi pure di sapienza, tra i perfetti, ma non già della sapienza di questo mondo, né dei principi di questo mondo ridotti all’impotenza, ma parliamo della sapienza di Dio, avvolta in un arcano, sapienza nascosta, che Dio prima dei secoli preordinò per gloria nostra». – Quanto abbiamo scritto in questo capitolo, cari confratelli, abbiamo scritto per prepararvi a leggere questo grande brano della sacra Scrittura. In esso è chiaro che dobbiamo sacrificare tutto per salvare la verità di Dio (ove occorra); è chiaro che questa non è sostituibile da alcuna «cultura» umana; è chiaro che se la cultura si proclama indipendente da Dio «è ridotta all’impotenza».
[Continua …]
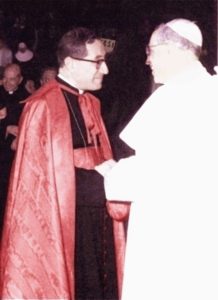



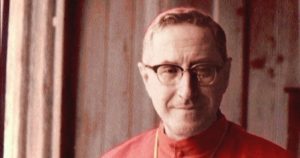

 S. S. GREGORIO XVII
S. S. GREGORIO XVII
