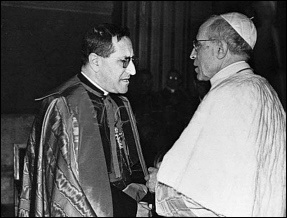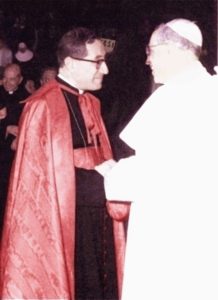
GREGORIO XVII – IL MAGISTERO IMPEDITO: IDEALI SANTI – MODE – CELESTE PRESENZA (4)
- — Ortodossia
[Lettera pastorale scritta il 23 luglio 1963; «Rivista Diocesana Genovese», 1963, pp. 192-245.].
Parte terza: Celeste presenza
Il panorama del nostro piccolo mondo viene vivificato dagli ideali: senza di essi è deserto e deserta resta la vita. Per questo si è parlato di alcuni ideali. Il panorama del mondo vario, pur sempre nuovo e ricco come lo ha creato Dio, può venir guastato da artificiali e irrazionali rughe, quali determinano gli uomini, allo stesso modo con cui artisti senza umanità guastano i paesaggi. Per questo abbiamo parlato di qualche moda. Il panorama del mondo, per chi ha fede, può completarsi con realtà superiori, per nulla chimeriche, sempre operanti. Per questo parliamo qui dei santi. – La presenza dei santi ha sempre trasformato il mondo, che pare attenda la quotidiana visita di questi suoi intercessori, per non restare troppo solo. Ne parliamo perché è utile fare in proposito alcune precisazioni e perché un certo qual processo di disumanizzazione (non si tratta di altro!) pare che qualche volta investa anche i santi. Vorremmo precisare che, per quanto non sia qui oggetto diretto della nostra attenzione, quello che si dice dei santi va detto in forma assai più alta, ampia e singolare della santissima Vergine Madre di Dio. – Se qui, a proposito dei santi, ci interessa la espressione positiva, dobbiamo pure, come è nella natura e finalità di questa nostra lettera, occuparci di fatti (chiamati sopra «disumanizzazione») che possono presentarsi brevemente così: taluni, ossequenti all’andazzo esistenzialista, tendono a ridurre la valenza dei santi, mezzo eccellente per ridurre il culto, altri si direbbe che li considerino un velo frapposto tra noi e Cristo, tali dunque da desiderarne una certa rimozione quasi fossero danno al culto dovuto a Dio; altri finalmente hanno perduto la nozione della funzione complessa dei santi nella economia della salvezza. – Scriviamo perché tali mende non abbiano presa in voi e perché voi possiate educare nella serena tradizione cristiana i vostri fedeli, senza lasciarli in balìa tanto di entusiasmi vuoti che di dimenticanze offensive e dannose.
La dottrina sui Santi
Nella sua sessione XXV, il conciliò di Trento ha dedicato un notevole testo alla dottrina cattolica circa i santi, che è riassuntivo di tutta una tradizione cattolica. Vogliate leggerne qualche brano. «Mandat sancta Synodus omnibus episcopis et cœteris docendi munus curamque sustinentibus, ut iuxta catholicæ et apostolic ecclesiæ usum a primaevis christianæ religionis temporibus receptum sanctorumque Patrum consensionem et sacrorum concilio rum decreta, imprimis de sanctorum intercessione, invocatione, reliquarum honore et legitimo imaginum usu, fideles diligenter instruant, docentes eos sanctos una cum Christo regnantes orazione suas prò hominibus Deo offerre, bonum atque utile esse suppliciter eos invocare et ob beneficia impetranda a Deo per filium ejus Jesum Christum Dominum nostrum, qui solus noster Redemptor et Salvator est, ad eorum orationem opem auxiliumque confugere, illos vero qui negant sanctos æterna felicitate in cœlo fruentes invocandos esse, aut qui asserunt, vel illos prò hominibus non orare, vel eorum, ut prò nobis etiam singulis orent, invocationem esse idolatriam, vel pugnare cum verbo Dei, adversarique honori unius mediatoris Dei et hominum Jesu Christi, vel stultum esse in cœlo regnantibus voce vel mente supplicare, impie sentire» (DS. 984). [«Il Santo Concilio impone a tutti i vescovi e a tutti coloro che hanno l’obbligo d’insegnare, secondo la consuetudine della Chiesa cattolica e apostolica, ricevuta sin dai primi tempi della religione cristiana e secondo il sentimento unanime dei santi Padri e i decreti dei santi Concili, di istruire diligentemente i loro fedeli particolarmente riguardo all’intercessione dei Santi, la preghiera che viene loro indirizzata, gli onori resi alle reliquie e il legittimo uso delle immagini. Che insegnino loro che i Santi che regnano insieme a Cristo offrono a Dio le loro preghiere per gli uomini, che è buona cosa e utile invocarli umilmente e, onde ottenere i benefici di Dio per mezzo del Figlio Suo, nostro Signore Gesù Cristo, che solo è il nostro Redentore e Salvatore, di ricorrere alle loro preghiere, al loro aiuto, alla loro assistenza. Coloro i quali negano che si debbano invocare i Santi che godono in cielo l’eterna felicità; o che affermano che questi non pregano per gli uomini, o che le domande che a loro si indirizzano di pregare per ciascuno di noi sono idolatria; o che sia cosa contraria alla parola di Dio e opposta all’onore di Gesù Cristo, unico Mediatore tra Dio e gli uomini; o che sia stoltezza supplicare vocalmente o mentalmente coloro che regnano nei cieli; tutti costoro hanno pensieri empi. ».] – Il testo che segue è un’ampia conferma, anche nei particolari, circa il culto da rendere ai santi, alle loro reliquie, alle loro immagini. La Sacra Scrittura non è affatto equivoca, né avara per quel che riguarda il culto dei santi Angeli. La prassi ecclesiastica, fin dagli inizi testimone del pensiero rivelato e delle sue applicazioni, ha reso ai Santi un culto analogo a quello che la teologia biblica indica per gli Angeli. Tra questi Santi furono annoverati gli Apostoli, molti presentati o ritenuti sia discepoli del Signore, sia collaboratori degli Apostoli, i martiri. Dopo la sufficiente pace accordata alla Chiesa si diffuse, per lo stesso titolo, il culto reso ai santi non martiri, detti pertanto semplicemente confessori, nonché alle vergini e alle sante donne. – Dal secolo quarto e cioè dal momento in cui la Chiesa poté indisturbata elevare i suoi templi si direbbe che tutto si aggrappa ai Santi, alla loro memoria; e si accentua il bisogno di far passare attraverso i Santi molto di quello che deve salire a Cristo, a Dio. La comunità dei viventi, con questi non più tra i viventi, è un fatto reale, solenne, commovente, continuo. Fu specialmente al tempo della decadenza dell’impero e in tutto il medioevo come se, incombendo una solitudine sulla lenta e talvolta oscura incubazione della nuova civiltà, apparisse imperiosa ed insostituibile la ricerca di questa superna compagnia. La quale era, ancora in qualche modo, tanto umana da attrarre e non intimorire e restava sempre talmente superna da infondere fiducia, serenità e gioia. – La prassi dei secoli cristiani, a proposito dei Santi, è una prassi di compagnia continua con la città superna. Le orme impresse dalla loro vita diventavano travature per la vita pubblica e privata ed erano travature oneste, sagge, dignitose ed utili. Ancora oggi in Liguria tutto il percorso fatto al secolo ottavo dalla salma di sant’Agostino, portata a Pavia da Liutprando, è riconoscibile dalle memorie, mai estinte, che di lui vi sono scaglionate, come analoghe memorie costellano le strade per le quali passò san Bernardo. I Santi apparvero sempre come i felici e sicuri compagni di quelli che erano ancora a meritare, a penare e a combattere nel pellegrinaggio terreno. La storia del culto dei Santi, mentre attesta un dato di tradizione divina, è la storia di una singolare e vera compagnia tra viatori e beati. Resta un fatto pertinente alla vita ed alla sostanza della Chiesa, mentre non cessa di essere un fatto dei più umani e toccanti. – Naturalmente non mancarono le ingenuità, specialmente a proposito di reliquie, che furono contese e talvolta autenticate con fretta, senza indagine sufficiente a scoprire una dubbia e forse ingannevole origine. Ma questo resta un fatto marginale che attesta quanto abbiamo sopra scritto e che non viola la serietà del culto, perché le reliquie trasmettevano l’onore sempre, e per chiara intenzione, a coloro che vivevano in cielo, senza far ristagnare nulla nei possibili errori della terra. Si trattava e si tratta, nel caso, di culto relativo. – La liturgia visse sempre anche dei Santi e non li considerò mai ingombri o veli per quello che andava a Dio, ma piuttosto fautori di una comunità vibrante e fremente di vita, nonché strumenti di un maggiore onore reso a Cristo. E strano che molti non capiscano come talvolta sia giusto onorare Iddio, più che con quello che abbiamo fatto noi, con quello che ha fatto Lui. E sua la divina parola, è sua la certezza della verità consegnata alla Tradizione, ma i Santi sono pure opera sua. – Perché dunque qualcuno deve temere di onorarli, di collocarli sulle pareti delle chiese, di narrare la loro storia, di proporre i loro esempi, di leggere e far leggere le loro vite, di rivolgersi a loro con la semplicità dei bimbi bisognosi di fratelli maggiori? Non credano siano gran gloria di Dio quei patiti, i quali sempre hanno da rinfacciargli di aver fatto cose incomplete (quei che si lamentano sempre, e trovano tutto storto; quei che rimpiangono, come i rivoltosi ebrei davanti a Mose, i cibi d’Egitto ed hanno da accusare sempre la Chiesa appartengono a questa categoria); gloria di Dio sono quaggiù, dopo i fatti divini in se stessi, i Santi. La Redenzione trionfa nei Santi. Ma vorremmo che il concetto, sul quale si ritornerà, di questi accompagnatori sereni e caldi della solitudine terrena non vi abbandonasse mai più, e per la estimazione del fatto in se stesso e per il completamento della vita della Chiesa e per il sostegno della vita interiore dei singoli, ai quali tutto può risultare vuoto se nella loro anima non si affaccia la presenza dei Santi. La ragione più grande che ci ha deciso a prendere in mano la penna e scrivere dei Santi è qui. – Noi sentiamo ogni giorno intorno a noi il peso della solitudine cupa di gente che vive nel rumore della folla ondeggiante e nella vicenda frettolosa dei fatti, ed abbiamo pietà di questa solitudine. Con Dio non si è mai soli, ma è piaciuto a Dio, nostro Signore, che noi troviamo la compagnia dei nostri fratelli, ormai certamente sicuri. – L’avvenire degli uomini non è mai chiaro, perché tutti i loro peccati corrodono tutti i sentieri della storia e inducono una dialettica intricata di cause e di effetti, di errori e di nemesi, di esplosioni e di interrompimenti. La certezza che i Santi continueranno ad accompagnare gli uomini è una delle poche garanzie dell’avvenire. – La congiunzione con Cristo Signore e Redentore sta alla base di tutto. Questa congiunzione è affermata dalla verità per cui noi formiamo con Lui un solo Regno, una sola Chiesa, un solo Corpo. – l’ordine della grazia nella sua più larga accezione e la adesione della fede sono i nessi di questa singolare unità: communio sanctorum. La congiunzione rende, quanto è possibile a creatura, partecipabile dai redenti quello che è di Cristo Verbo Figlio di Dio: la vita divina, la reazione eterna, la gloria. La vita degli uomini non può mai essere oscura, dato che si può articolare tra questi termini. – I gradi della congiunzione a Cristo sono diversi, a seconda della grazia e del merito. Un grado netto distingue quelli che sono ormai fuori delle vicissitudini del tempo e regnano in eterno da quelli che sono ancora nella prova terrena. La sublime imitazione di Gesù Cristo può raggiungere il grado di una presentabilità agli uomini per la loro edificazione, garantita dall’intervento dei segni divini: in tal caso alcuni partecipano all’onore stesso di Gesù Cristo, anche in questo mondo: sono i Santi. Insomma i Santi sono lo stato logico e più vero della famiglia di Dio, di quella famiglia nella quale la Incarnazione del Figlio e la nostra assimilazione a Lui ci ha raccolti e nella quale possiamo chiamare Dio «Padre». – Per tale motivo i Santi non sono un’appendice della verità rivelata; essi sono inseriti nella sostanza rivelata e solo così si intende tutta la loro logica. – I Santi sono la parte più autentica della famiglia di Dio, del Regno, se così si preferisce dire, le membra migliori del Corpo Mistico di Cristo. Se noi li dovessimo depennare o trascurare noi toglieremmo al Corpo Mistico di Cristo qualcosa della sua realtà. I Santi partecipano alla gloria del Redentore, tanto quanto gli sono certamente e definitivamente congiunti. I Santi sono il grande e più completo frutto della Incarnazione e della Redenzione, preceduti in questo dalla grandezza unica della Madre del Signore. Ove se ne tacesse o si facesse nella Chiesa quello che equivale a «tacere» si presenterebbero i misteri divini come se fossero sterili. Quando i Santi appaiono nella santa Messa e vi si ricordano, o per merito delle loro azioni terrene edificanti si leggono i passi scelti dalle Sacre Scritture proprio per riferimento a tali meriti, si fa soprattutto questo: accanto al sacrificio che fu ed è causa della salute, si mettono i rappresentanti dei suoi infiniti frutti. Un’ombra sul volto dei Santi getta in ombra la fecondità della Redenzione. Essi intervengono nella storia, nella vita e nella liturgia come il grande autentico e glorioso corteggio di Cristo e della Redenzione, l’esigenza dei Santi deriva dalla realtà concreta della venuta di Cristo nel mondo. La trascuratezza nel confronto dei Santi non può essere che il frutto di una concezione meschina, incompleta e probabilmente erronea di Cristo e dell’opera sua. – Gesù Cristo non ha bisogno dei Santi, ma dal momento che come causa li ha legati a sé, non è più in poter nostro separare il Salvatore da coloro che Egli ha salvato nel più glorioso dei modi. Nella liturgia il «santorale» non è affatto un intruso, da sopportarsi per timore di sconfessare una tradizione. Il «santorale» è al suo posto anche se resta vero che le proposizioni debbono far cedere il passo al «proprio del tempo». – Il modo con cui la Chiesa nello svolgimento della sacra liturgia ha abbracciato i suoi Santi, in tutti i tempi, sotto tutti i cieli, è la attestazione di quanto sopra abbiamo detto. Concludiamo: i Santi sono inseparabili dalla pienezza del mistero di Cristo in concreto, come sono inseparabili dal mistero della Chiesa, santa, anche per la loro qualità di documento e trionfo delle sue divine sorgenti. – Per sottrarci decisamente alla ventata di esistenzialismo distruttore che educa al disprezzo ed al rinnegamento di tutto anche certi sedicenti cattolici è necessario vedere con cristallina chiarezza come i Santi siano inscindibilmente inseriti, e con quale forza, nel mistero stesso di Cristo. – La canonizzazione dei santi è, tra l’altro, atto solenne col quale si propone l’esempio delle loro virtù, autenticate in tal modo per esser guida dei fedeli e per allargare l’assortimento dei mezzi e delle applicazioni atte a rendere più intensa e vigorosa la vita spirituale dei fedeli stessi. Non si può dunque negare che le canonizzazioni includano un atto di Magistero. Questo Magistero riguarda la capacità di esempio di fatti, è vero; però questi fatti appartengono al materiale documentario col quale si dipana attraverso i secoli il deposito della tradizione divina. Errerebbe chi credesse di trovare questa soltanto nei testi di autore, magari scelti con preconcetti restrittivi: la Tradizione si ha attraverso tutto quello che accade nella Chiesa ed essa si ritrova nella unità e nel consenso legittimo. Non possiamo negare, e neppure nascondere, lo stupore col quale abbiamo osservato in autori recenti la piena dimenticanza del modo con cui cammina attraverso i tempi la divina tradizione, fonte della Rivelazione divina. – E dunque necessario vedere i collegamenti tra i Santi e il Magistero o la Tradizione, per comprendere la funzione teologica che compiono i Santi e che è del massimo interesse. La funzione teologica dei Santi è duplice: essi sono in maniera diversa dei testimoni, anzi dei mirabili «portatori» della divina tradizione; essi sono un’apologia perenne, un motivo di credibilità.
La funzione teologica dei Santi
l a divina tradizione va avanti nella Chiesa. Molte verità certe non possono sostenersi perentoriamente che con documenti presi dalla Tradizione. Sarebbe violenza far dire a certi testi biblici talune verità, a meno che non sia intervenuto un consenso od un atto del magistero circa il loro valore. Questa Tradizione non è attestata, ossia non ha i suoi testimoni esclusivamente in documenti scritti e reperibili presso scrittori ecclesiastici (oltre che presso i Padri), ma in tutto quello che è nella prassi e nel fatto ecclesiastico. L’umile parroco il quale insegna il catechismo secondo il testo approvato dall’autorità competente è testimone della Tradizione non meno di un teologo, e sovente lo è assai più per la semplice ragione che utilmente e reverentemente trasmette; il teologo può sentirsi invece in dovere di introdurre qualcosa di personale, di opinabile, di dubbio, di polemico. Le consuetudini di un monastero sono testimoni della Tradizione, quando naturalmente stanno nell’intonato concerto di vita della Chiesa, allo stesso modo. Gli scalpellini che su tante pietre delle antiche cattedrali italiane, inserite qua e là tra i conci, hanno scolpito, anche rozzamente, figure sognate dalla loro pietà sono testimoni. La più umile carta d’archivio, quando è, ripetiamo, in un concerto che è universale e che continua, è testimone di Tradizione. Insomma la «vita» di ogni tempo della Chiesa, colle infinite forme per le quali si rifrange, è testimone della verità che la Chiesa custodisce attraverso i secoli. Ed è soprattutto in questi Testimoni, si direbbe di minore e minimo rilievo, che si assiste ad una funzione di equilibrio, di buon senso, di perenne scelta tra quello che, dell’ardita indagine teologica, può passare e quello che deve andare a ristagnare tra le opinioni e le liti. E in questo che spesso si rifrange cristallino, selezionatore, rassicuratore il magistero ordinario della Chiesa. E in questo complesso documentario dalle immense sorgive che si ha il legame forse più autentico tra i vari tempi nella perennità della tradizione divina. – Abbiamo poi usato le due parole «testimoni e portatori», perché i testimoni richiamano piuttosto quello che «fu» (e ciò è certamente vero), mentre i «portatori» sono coloro che di fatto trasmettono, in questo divino alone dove gli uomini vengono assunti in un fatto divino, la verità. La divina tradizione non è fatta solo con le carte, ma con tutto quello che accade nella Chiesa, che è vivente, proprio perché intimamente guidata e sorretta e difesa dallo Spirito Santo. I Santi, anche prescindendo da quello che hanno scritto (e i loro scritti hanno abitualmente pregi singolari), sono dei testimoni e portatori della divina tradizione. Essi ricevono dalla Chiesa nel periodo di loro formazione, e quante volte qui si incontrano umili genitori senza alcuna presunzione e con tanta scienza di Dio, appresa nel continuo contatto con la Chiesa, con la liturgia, con Cristo stesso, la Vergine e i Santi. Essi mantengono tutto quello che hanno ricevuto, fuori delle dispute e delle avventure di pensiero, in una luminosità di virtù, di orazione, d’amore. Essi riesprimono, con la ricchezza che la comunione con Cristo è capace di produrre, ed in infiniti modi, insegnamenti, applicazioni, risoluzioni chiarificatrici di princìpi, orientamenti spirituali fermi, sicuri, protesi ai secoli; sintesi e conseguenze di vera e altissima dottrina. Mentre fanno questo in vita spesso – non sempre – su di loro si fissa l’attenzione ammirata della stessa autorità che assiste, approva, incoraggia, giudica serenamente e pacificamente; realizzando così un consenso teologicamente valevole, o iniziando a concretare così un consenso teologicamente valevole. Per i Santi, che sono stati giuridicamente ed espressamente canonizzati, c’è una disamina intorno a loro, c’è una sanzione che aumenta assai il valore di quanto detto fin qui. Noi potremmo comporre tutta la tradizione divina affidata alla Chiesa, lasciando tutto da parte e guardando solamente ai Santi. – Che sia proprio questa la ragione per cui taluno guarda i Santi come fastidiosi? Quando si tratta di fare una teologia della orazione, santa Teresa, a parte il suo valore personale e il suo genio, con la riforma che fece, con le approvazioni implicite ed esplicite che ottenne, con quello che iniziò di duraturo nella prassi conventuale, ascetica e mistica, è certamente testimone della Tradizione assai più di molti teologi messi insieme, perché raramente le pagine di questi si sono fuse col respiro stesso della Chiesa, come invece è accaduto per santa Teresa di Gesù. – L’ufficio, anche inconscio, di testimoni e di portatori, è di tanto maggior rilievo nei Santi, in quanto essi sono tra gli uomini che più hanno allontanato le impurità e le scorie raggiungendo la vera e piena libertà dei figli di Dio attraverso il distacco del cuore da tutti i beni terreni. Poiché non avevano umani interessi, né impacci, si sono offerti alla grazia illuminante, all’azione dello Spirito Santo con una capacità potenziale maggiore di tutti gli altri: spesso coi miracoli Dio è intervenuto a porre il suggello diretto su quello che facevano od insegnavano. – Noi riteniamo di potere e dover attribuire ad una certa disattenzione verso questa loro singolarissima ed eminente funzione la minore stima e valutazione complessiva che i Santi godono presso certuni. Consideriamo pertanto del massimo interesse questa funzione teologica dei Santi. – I Santi hanno anzitutto un valore apologetico, ossia dimostrativo della verità della nostra fede e della santa Chiesa cattolica apostolica romana, perché concorrono anch’essi a realizzare in concreto la «nota» fondamentale della Chiesa, che è appunto «la santità». I Santi hanno un valore apologetico fortissimo per il carisma taumaturgico che si manifesta spesso nella loro vita e sempre – ciò consta almeno per i canonizzati nelle forme ordinarie – dopo la loro beata morte. – Non occorre noi illustriamo ai nostri confratelli, bene a giorno dell’argomento dai loro ordinari studi teologici, che quanto ricordato ha valore dimostrativo con obiettivo rigore logico. Una tale apologia, avente in sé reale capacità di generare logicamente una certezza, quando si tratta dei Santi, è del tutto popolare e cioè facile, intuitiva. Il popolo crede alla virtù vissuta nell’eroismo, crede soprattutto quando avverte il miracolo. E sa che i Santi significano «miracoli». Li conosce anzitutto come virtuosi, ma, non meno, come operatori di miracoli, od almeno come coloro che ne hanno fatti o ne possono fare. Il popolo ha una singolare facilità a credere al miracolo, tanto che bisogna stare attenti non s’inganni, vedendoli dove non sono; ma ha perfettamente ragione quando connette il fatto della santità al miracolo e quando a questo attribuisce la forza di divina inderogabile attestazione, ossia di prova. Ragiona molto semplicemente quando dice: la nostra fede è vera perché i Santi, questo, quel Santo, operano od hanno operato miracoli. – Ora riflettiamo bene. Molta gente non ha studiato nessuna apologetica e nessuno gliel’ha insegnata. Eppure ha esigenze logiche; ha in testa un rudimentale abbozzo di logica; si pone dei quesiti relativi alla fede e spesso non trova nessuno cui parlare dell’argomento per averne una soddisfacente risposta. Accade allora tante volte che sul suo orizzonte si affaccino i Santi. Meglio se ne ha sentito parlare molto, se ha sentito raccontare, se può evocare meraviglie già udite. Allora dice a se stesso: ci sono i Santi; andiamo avanti. È una logica od apologetica rudimentale; se è rudimentale nelle movenze semplificata, è tutt’altro che priva di contenuto logico. E intanto la fede è salva, senza che a salvarla sia intervenuto un inganno. – Spesso accade a noi, che abbiamo abbastanza studiato, di non porci il problema della logica dei poveri e degli ignoranti, che pure hanno, come tutti, bisogno di argomenti per conservare la saldezza della propria fede. Ma quando questo problema lo si pone, si capisce l’importanza dei Santi a sostegno della fede stessa. E vero che la ignoranza o la esiguità di esigenze logiche può dare valore dirimente in ordine alla fede, a esperienze o fatti per sé incapaci logicamente di dare una certezza circa il motivo della fede stessa. E ringraziamo Iddio, che prende da tutte le parti e convoglia al bene. Ma non si tratta di valori obiettivamente logici. Nel vecchio seminario di Genova si raccontava di un lattaio, annoso peccatore impenitente, il quale si intrufolò una volta, dopo aver lasciato i recipienti del latte al cancello, nella aula magna. Là si teneva una gran tornata accademica del Collegio teologico. Il Gran Cancelliere stava pronunciando un discorso in latino, di cui il povero lattaio non riusciva a capire assolutamente nulla: convinto da ciò di trovarsi sotto la maledizione divina per i suoi peccati, se ne spaventò, cominciò a piangere e ad accusarsi. Finì, quel momento stesso, con l’andare a confessarsi dopo quasi mezzo secolo di disprezzo della pratica religiosa. Evidentemente il buon Dio converte anche con prediche delle quali non si capisce nulla. Ma questo non accade tutti i giorni; soprattutto accade assai meno con persone dalle esigenze logiche. Claudel si convertì al canto del Magnificat a Natale in Notre Dame di Parigi. Non era un argomento logico, quello era solo la schiarita finale della grazia in un lungo processo interiore. – La questione dell’apologetica infantile, popolare, facile, adatta là ove la cultura non ha sedimento o dove ha sedimento una cultura al tutto pratica, in realtà e di fatto non può fare a meno dei Santi. Le conseguenze sono importanti e le vedremo. Ma, stando così le cose, che dire del sadismo dimostrato da taluni in nome della cultura, nell’annientare i Santi e nel cercar di dimostrare in loro dei difetti? La verità è la verità. Non parliamo di quella; parliamo del sadismo. Il godere di restituire la storia al posto della leggenda è sano e doveroso; ma il godere di abbattere e di calpestare è solamente patologia. E lo è perché, quando uno vuole annientare i miracoli, basta sia unilaterale, reticente, incompleto e ci può, apparentemente, riuscire; ma non ha affatto servito la verità. Tutti sappiamo che di miracoli ne basta uno, perché ci sia una certezza. Diminuire la fede in questo sovrano divino intervento, perché talvolta miracoli apocrifi hanno potuto entrare nella storia, non è servizio né alla verità (in ragione del latius), né all’apostolato, ossia alla salvezza delle anime. E vero che non manca chi vorrebbe abolire l’apologetica o si scandalizza, se si fa dell’apologetica od anche solo se se ne parla. Perché? Forse che non esistono persone che ne hanno bisogno? Ma ne hanno bisogno tutti! Forse perché non la chiedono? Ma questo è fuori della realtà. Forse perché è impossibile farla? Ma questo è razionalismo, se non modernismo!
La funzione educativa dei Santi
Teologicamente parlando, uno scopo della canonizzazione è la presentazione ufficiale dei Santi come esempi di vera vita cristiana. È ovvio che i santi compiono la parte educativa anzitutto con l’esempio che danno. Questo esempio mostra l’attuazione pratica dell’Evangelo; articola la norma evangelica secondo le diverse situazioni, capacità e congiunture; risolve problemi e dubbi; stimola alla perfezione; e infine, rianima contro lo sconforto. – Tuttavia la funzione educativa dei Santi si attua non solo con l’alto esempio della loro vita terrena, ma pure per il fatto che sono dei «santi» quali vengono concepiti e venerati nella tradizione cattolica. E questo un punto da non trascurare. – La funzione educativa è già apparsa là dove si è trattato dei Santi come perenne apologia e pertanto vero aiuto della fede. Se la fede è fondamento della vera educazione cristiana, noi rileviamo, anche solo in questo, una funzione educativa. Coll’aiuto della fede va in atto una presenza soprannaturale dei santi. Ne abbiamo già parlato. Questa presenza è fautrice di fiducia, coraggio e serenità. Se queste tre preziose risorse sono ideale di una educazione, bisogna concludere che per altro titolo la presenza dei Santi è educativa. – La presenza dei Santi è un richiamo continuo a cose supreme, al cielo, alla vita eterna, alla gloria data ai meriti. In tal modo, quanto più è viva, tanto più abitua ad un clima di elevatezza, adduce quella nobiltà di stile e di costume che è proprio di chi sta in compagnia di cose superiori. I Santi sono dei fratelli già arrivati alla casa del Padre, intorno a loro si costruisce l’alone della famiglia di Dio, della quale facciamo parte. In questa famiglia, ed in ragione della gloria raggiunta, i Santi sono dei fratelli maggiori, che restano a disposizione dei fratelli minori intercedendo per loro. Sono chiamati, in seno a questa soprannaturale famiglia, verso i deboli; mentre i loro meriti, senza nulla detrarre alla gloria loro dovuta, diventano ricchezza, risorsa e sussidio per la debolezza dei fratelli minori, ancora impegnati nella lotta o prova della vita. E così che i Santi fanno l’ambiente della famiglia di Dio. Al disopra dei Santi, la Vergine Madre di Dio completa con la maternità questo stupendo ambiente. – Se ne arenerà un influsso educativo permanente. Altra è la vita che scorre in una famiglia sentita, altra è la vita che si perde nella freddezza di cose materiali, quantitative, senza anima né suprema speranza. Vivere in una famiglia soprannaturale è impostare ad un livello più alto la propria esistenza. E l’influsso della presenza dei Santi. E difficile calcolare a dovere questo influsso attraverso la storia del Cristianesimo, tanto esso è grande e continuo. Il clima di famiglia, l’intercessione, l’apporto ai deboli costruiscono l’ambiente e l’esempio alla carità. – Naturalmente il realizzarsi di questa salutare azione educativa, questa suprema compagnia, è legato anche al modo con cui noi trattiamo i Santi. – Vediamo allora alcune risorse pratiche per rendere operante l’azione educativa dei Santi.
– Le loro immagini. Le sacre immagini sono il mezzo più diretto, semplice ed intuitivo per stimolare l’attenzione e dare il senso della presenza. Le chiese che si riducono ad un Crocifisso e tutt’al più ad una immagine della Vergine, rimanendo ferme a questo minimo indispensabile perché non c’è modo di fare di più, non meritano una condanna, ma lasciano un desiderio ed un bisogno insoddisfatti. Tali chiese non danno il senso della famiglia di Dio: mancano i veri fratelli maggiori, i Santi. – Oggi è difficile affrescare le chiese, per motivi più che evidenti. Ma resta vero che le storie dei Santi, anche ingenue, affrescate o riportate in bassorilievi, sono state parte notevole nella Biblia pauperum e lo stimolo ad imitazioni anche eroiche in generazioni intere. L’eliminazione non è una semplice dimenticanza, è un oscurarsi del senso di famiglia di Dio e dello stesso senso di umanità. Siamo ben lontani dal raccomandare l’intasamento delle chiese con immagini esposte al culto senza decoro di materia e di arte, senza piano architettonico, per generazione spontanea ossia per la richiesta, sovente capricciosa, di qualche devoto parrocchiano, con incoraggiamento a forme di devozione né serie, né equilibrate. Abbiamo anzi eliminato molte di tali immagini. Noi intendiamo parlare di quelle immagini la cui collocazione dipende da un criterio anzitutto educativo e poi logico, coerente con un insieme e con una tradizione, illuminato, architettonico. – Le sacre immagini dei Santi, oltre l’immagine crocifissa del Salvatore e quella della Vergine, trovano giusta ed utile collocazione anche nelle case dei fedeli. Saranno le immagini dei patroni personali, dei patroni della Chiesa, della città, i più conosciuti e venerati. Meglio le immagini dei duraturi Santi che degli effimeri «divi». Però questo ritorno delle immagini dei santi nelle case di fedeli deve attuarsi con un’adatta illuminazione catechistica, non abbandonato a una pura emotività, dalla quale la ignoranza può far arrivare anche dell’esagerazione e della superstizione. Le immagini dei Santi, anti, come, in grado minore, le immagini dei propri cari, portano calore nelle chiese e anche nei focolari domestici.
– Le sacre reliquie. Tutti sanno che sono oggetto di culto relativo e che il culto relativo può, entro certi limiti, tranquillizzare la coscienza rispetto alla incerta autenticità di reliquie sacre assai antiche che, accompagnate da notizie storiche talvolta dubbie o anche solamente dal sigillo di un’autorità competente. Ma, questo premesso, le reliquie sacre vanno rispettate. Il decoro, l’attenzione con cui vengono circondate, il culto, la stima, l’uso serio e diligente hanno parte grandissima nel rafforzare il culto dei Santi con quel desiderabile influsso formativo, di cui si è ora parlato. La sistemazione decorosa, evidenziata, rilevata delle reliquie sacre, specialmente se insigni, è per il sacerdote un impegno soprannaturale in cui egli si riconosce membro della famiglia vivente di Dio.
– La lettura della vita dei santi. Anzitutto occorre reagire al senso di disprezzo che viene facilmente diffuso per le mende in cui cadono senza dubbio scritti affrettati, troppo laudativi, retorici e persino stucchevoli. Censura per influire sugli scrittori, sì; disprezzo no. – Perché se c’è una forma, che può meritare rimproveri, resta una sostanza che domanda solo ammirazione. Purtroppo sono pochissimi oggi gli agiografi che meritano con serietà un tale nome e c’è da augurarsi che le stesse postulazioni si rivolgano, per redigere vite di servi di Dio, a persone di competenza scientifica che amino il soggetto, piuttosto che a qualche retore superficiale, facilmente reperibile sulla piazza. Ammettiamo dunque i difetti, che si biasimano, ma non dimentichiamo che una vita cristiana in cui manchi la lettura di biografie di Santi è una vita privata d’un soprannaturale fascino e d’una recondita forza. – Resta sempre vero che sono gli esempi a suscitare slanci generosi e dedizioni grandi. E poiché abbiamo menzionato la parola «esempio», vale la pena di sottolineare che la forza suggestiva sta proprio nell’episodio opportunamente inquadrato, mentre sta poco o nulla nelle considerazioni generali, anzi generiche, alle quali indulgono assai gli agiografi da strapazzo. L’episodio, su tutti, ma specialmente sui ragazzi e sui giovani, con quel suo stagliare concreto, con quella sua definizione rivelata di contorni, con quella singolarità netta anche se semplice, imbriglia attenzione e fantasia, stimola slanci del cuore, suscita energie. – È tempo che gli episodi dei Santi rientrino nella predicazione, che adesso si fa arida per il suo cerebralismo e inaccessibile perché priva di tradizione umana in fatti alla portata di tutti e capaci di portare le idee al livello delle logiche infantili. Per chi ha scarso sviluppo mentale, ogni membro del ragionamento deve essere dedotto da una rappresentazione concreta e descrittiva. Ed è tempo che non si abbia paura di raccontare miracoli veri e seriamente interpretati. Forse ha errato Gesù Cristo lasciando miracoli come segno della sua verità per tutti i tempi? (cfr. Mc. XVI,17 sgg.). Noi ci auguriamo una vera fioritura (e già qualcosa si delinea) dell’agiografia, priva dei pedaggi pagati al razionalismo ed al positivismo da coloro che hanno troppa paura della storia e, per averne troppa paura, la deformano o la snervano.
L’intercessione dei Santi
Fa parte della fede cattolica la dottrina sulla intercessione dei Santi che ha delle radici profonde e stupende: la loro partecipazione all’opera e alla gloria di Gesù Cristo; il valore imperituro dei loro meriti; la reversibilità degli stessi meriti. Non è questo il momento di spiegare a voi, bene edotti, tali solenni verità. Sia sufficiente l’averle richiamate. Sono le verità delle quali si sostanzia la fede nel Corpo Mistico di Gesù Cristo e nella sua ineffabile vita. Non dunque chimere o pie supposizioni, ma realtà. Per questa intercessione la Chiesa del cielo accompagna la Chiesa militante non solo moralmente, ma ontologicamente. Questa intercessione nei suoi effetti non è certamente da meno dell’effetto della fede propria dei pellegrini in terra, la quale può spostare le montagne. Anche per questa intercessione né la Chiesa, né i fedeli sono nella solitudine. I Santi in verità popolano la terra più dei viventi. L’intercessione dei Santi, per il modo con cui si attua e per gli effetti che opera, costituisce una delle pagine più interessanti della vita sotterranea della Chiesa. Con essa i Santi adempiono missioni postume, realizzano presenze specifiche, compiono cicli di straordinaria partecipazione alle vicende della Storia: la Chiesa con l’istituzione giuridica dei patroni asseconda questo fatto e la relativa fede. Se ne ha una varietà, una ricchezza di sfumature che solo i grandi storici cristiani e i grandi agiografi sono in grado di cogliere e di rendere. Per i Santi la primavera non cessa mai! La liturgia, la prassi, la devozione, la iconografia sono un tratteggio di questa storia. – Non si dimentichi che come la gloria segue i meriti, così la intercessione dei Santi segue anche la loro missione terrena e continua a compierla. È questa verità che richiama al culto particolare dei propri Santi. I Santi hanno dato la vita ad una terra, ad comunità, ad una missione; abbiamo il diritto di ritenere la loro intercessione fecondamente se non esclusivamente ancorata a quella terra, a quella comunità, a quella missione. Sono vicini. Non sempre indicati da una moda, hanno il diritto di essere particolarmente onorati da coloro che continuano a camminare sulla loro via. – Per questo noi intendiamo non risparmiarci per inculcare la devozione ai nostri Santi. Ne abbiamo nei nostri antecessori, ne abbiamo tra i fedeli dei due sessi, tra i religiosi. – Le loro memorie, le loro reliquie, la loro tradizione deve essere preziosa e noi dobbiamo mantenerle nel vivido calore di un affetto cosciente e profondo. La tradizione cristiana della nostra terra arriva al primo secolo: che i santi Nazario e Celso abbiano irrorato della loro predicazione la riviera ligure non è soltanto una leggenda. Noi speriamo di vedere presto restituita all’uso la cripta del Santuario di nostra Signora delle Grazie, rimontante al secolo IX, che consacra in tempo non sospetto la vivacità di questa tradizione, perché quella cripta è stata voluta prorio per ricordare i Santi Nazario e Celso, qui approdati verosimilmente dal mare. Tutte le chiese e tutti gli oratori dedicati ai martiri sull’arco ligure indicano la potenza e la vastità di una tradizione che, quanto più è potente e vasta, tanto più ha diritto di essere considerata elemento scientificamente valido per avvicinarci ad una verità storica. – Il mondo è solitario. Circondato dalle sue macchine e dai suoi ordigni esplosivi, intriso delle sue esperienze prevalentemente materiali, vede ridursi la letizia delle anime; ricco di fatti assordanti, a mala pena intende le voci che si levano irruenti dalla stessa natura. Ha bisogno di essere ripopolato spiritualmente. Per questo, nell’intendimento di tutelarne tra voi, contro pericolose deformazioni il giusto senso, abbiamo parlato di ideali santi e dei Santi stessi, dando ai due argomenti un qualche risalto per opposizione alla snervante esperienza di certe mode terrene. Voi avrete capito, cari confratelli, che abbiamo voluto invitarvi ad alzare lo sguardo verso la Terra Promessa che è e rimane l’unica prospettiva importante nella storia degli uomini, pur quando gli uomini rischiano di dimenticarsene, per propria colpa o anche solo per distrazione.
[Fine]