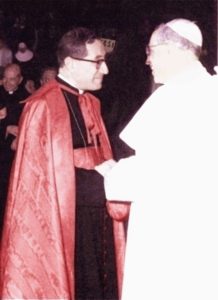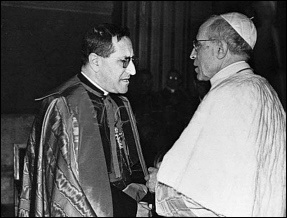
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
[Lettera pastorale scritta il 17 dicembre 1967; «Rivista Diocesana Genovese»,1968. pp. 28-63 ]
(1)
Lo scopo di questa lettera
Il sacramento della Penitenza è il primo tipico strumento per la remissione dei peccati, nonché il massimo mezzo per la profonda formazione cristiana dei fedeli, come singoli. Il nostro scopo non è quello di ripetere qui quanto può essere facilmente letto in qualunque testo approvato di Teologia morale. Per questo sarebbe sufficiente pubblicare una nota bibliografica con la raccomandazione di servirsene. – Il nostro scopo è solo quello di illustrare la proposizione espressa in apertura di questa lettera e di concorrere, per quanto ci è possibile, a crearne nei nostri Sacerdoti il convincimento serio e operante. Riteniamo che, per conseguire questo scopo, si debbano trattare diverse questioni.
Perché la Penitenza è il primo tipico strumento per la remissione dei peccati personali?
Perché, nella ipotesi esistano peccati personali, la penitenza è necessaria, ossia senza di essa in re od almeno in voto non si dà perdono dei peccati. Ciò pone, nel caso esistano peccati mortali personali, una alternativa netta ed impreteribile: o penitenza, almeno in voto, o dannazione. Gli altri mezzi per ottenere il perdono dei peccati senza la attuale amministrazione della Penitenza sono validi e raggiungono l’effetto in quanto contengono in qualche modo il «voto» e pertanto il riferimento al sacramento stesso della Penitenza. La affermazione – estremamente grave – non è una sottigliezza teologica, è un dato fondamentale ed elementare del semplice catechismo. – Per vedere chiaramente la gravità della affermazione, bisogna aver precise e stagliate due verità altrettanto elementari. Il peccato è la più vergognosa e terribile macchia che possa incogliere l’uomo, perché la legge divina – contro cui si lancia il peccato – è condizione impreteribile di salvezza eterna. Legge e peccato sono termini collegati: per dimenticare l’uno bisogna dimenticare anche l’altro. La incarnazione del Verbo ha una sua ragione fondamentale nella redenzione dal peccato; Gesù è l’Agnello che toglie i peccati dal mondo. – Il sacramento della Penitenza, collocato nella cornice di queste due verità, assume la sua grandiosità imponente. Se il nostro ministero non compie quello che occorre per togliere i peccati dal mondo, resta un ministero sostanzialmente sterile. Il sacramento della penitenza è la riduzione sacramentale della vicenda espiatrice del Verbo fatto uomo.
Perché la Penitenza è il massimo mezzo per la formazione dei fedeli come singoli?
Perché il confessore, che è nella Penitenza padre e dottore, deve compiere le funzioni di medico dell’anima ed in tale veste deve rendersi conto delle radici dei peccati, deve prescrivere rimedi congrui, deve dare consigli salutari, deve pensare ad evitare le ricadute. Tutto questo fa nel segreto del sigillo, per il quale più facilmente le anime si aprono, nella intimità discreta della cognizione, la quale dispone con singolare naturalezza il penitente alla umiltà, nella dignità di un sacramento del quale non si evita il soprannaturale prestigio. Ossia: nella Penitenza il confessore agisce in maniera diretta sulla vita interiore, vi ha una ineguagliabile capacità incisiva, si impone con giustificata autorità, quanto compie è accompagnato da una divina grazia che supera ogni altra umana efficienza. Nella Penitenza il confessore, ben conscio del suo ministero, illumina, corrobora, orienta, rassicura. Ciò dimostra la capacità educativa dello strumento sacramentale. Nessuno in questo mondo entra nell’anima altrui con la nobiltà, intimità ed efficacia, offerto dalla Penitenza. La psicanalisi entra nella situazione psicologica di fatto, che è un’altra cosa, perché l’anima di un uomo non è da confondersi con la sua fantasia, con i l suo istinto e con il suo subcosciente. Alle spalle della psicanalisi non ci sta un ordine ed una efficacia di ordine divino.
Perché preoccuparsi dello scopo specifico della Penitenza?
Perché si tratta di uno scopo essenziale della nostra Fede. Dove si arriva, infine, se non si tolgono i peccati dal mondo? Poiché nasciamo peccatori, liberi ed immaturi, abbiamo bisogno di una educazione. Poiché la nostra fisionomia interiore e la indefinita varietà degli atti personali che ci seguono portano ad una non minore varietà di situazioni personali, il più delle volte indecifrabili dall’esterno, non è affatto sufficiente ed adeguata una educazione esteriore e di massa. Occorre che il tocco educativo attinga le singole anime. Finalmente a nessuno può sfuggire che l’avvenire del popolo di Dio, formato di fedeli singoli, è intimamente legato alla esistenza di una educazione cristiana, specifica e pertinente. – Questo è necessario capire: che nessuno strumento per quanto ingegnoso, per quanto tecnicamente perfetto, ha nel sacro ministero la potenza penetrativa, la capacità forgiatrice del sacramento della Penitenza. – C’è tuttavia un motivo che dimostra la urgenza di occuparsi dell’argomento. La tecnica ministeriale, che deve pur essere considerata con fiducioso rispetto, tende per un complesso di fatti (che non possiamo esaminare qui) ad invadere e dominare il campo dell’apostolato sacerdotale. I mezzi sacramentali vengono ricercati meno, spesso troppo poco. Un certo umanesimo, di sapore del tutto pelagiano, nel campo intellettuale tende a mettere in primo piano risorse, anche oneste in sé (come la tecnica psicologica, età), ma che in molti servono a distogliere dalla stima per i superiori mezzi: origine divina, quali sono il Sacrificio e i sacramenti. Il naturalismo acquista ogni giorno espressioni scaltre, che paiono accreditarlo non meno del soprannaturale, specialmente se presentato come un ragionevole compromesso per incontrare il mondo, mentre l’incontro con il mondo deve essere fatto nell’ambito segnato dall’Evangelo applicato dai santi Apostoli. Il demonio gioca la tattica di far sostituire ai mezzi dell’Evangelo i sotterfugi di una vacua razionalità mondana. E talvolta ci riesce. Non esitiamo affatto a giudicare tutto questo preoccupante e spaventoso. Ed è per questo che questa Nostra lettera è un grido di allarme. Avevamo cominciato a stenderla or sono diciannove anni allora ci preoccupavamo di richiamare la perfetta e santa amministrazione del sacramento della Penitenza. Quella lettera non fu allora compiuta perché attendevamo l’esito di talune avventure intellettuali. Gli anni sono passati ed oggi a farci ritornare sull’argomento non è solo la preoccupazione della santa amministrazione del Sacramento, bensì il dovere di ridare al Sacramento il prestigio e la preminenza, perdute purtroppo nell’anima di taluni ministri di Dio. Il confronto tra la lettera mai pubblicata e la lettera presente è testimone che talune cose si sono volte al peggio e non al meglio. Contro questa diminuzione di un prestigio della Penitenza si levano alcuni fatti o difetti, che avremo occasione di esaminare appresso. Si leva soprattutto la fame e la sete, che del Sacramento e della direzione spirituale (così legata al Sacramento) prova un numero infinito di anime, pur senza saperlo. Non si dimentichi che il sacramento della Penitenza è la porta più ordinaria al sacramento della Eucaristia, cibo e vita delle anime, ed allora si capirà quanto sia vera la equazione: la formazione profonda dei cristiani è pari alla frequenza ed alla santità con le quali si amministra il sacramento della Penitenza! – C’è un’ultima generale ragione per preoccuparsi assai dello scopo specifico del sacramento della Penitenza. Essa è la necessità della educazione individuale delle anime. Cioè: per educazione non basta affatto quella cosiddetta comunitaria, semplicemente ecclesiale, collettiva, di massa, perché le anime si formano ad una ad una. Nessuno vuol negare che la educazione collettiva sia complementare e qualche volta suppletiva della educazione individuale; si afferma solo che generalmente non è sufficiente. – Sta il fatto che la opinione di comodo scivola verso la convinzione di occuparsi della educazione collettiva, abbandonando la educazione individuale come colpevole di opprimere la libertà della persona umana. E proprio la persona umana, che in ogni caso è ontologicamente persona e in moltissimi casi non è affatto «moralmente» persona, ad invocare l’intervento della formazione individuale. – Ora nella testa di coloro i quali credono alla educazione esclusivamente comunitaria, disprezzando la educazione individuale, entra altrettanto la convinzione che in fin dei conti la Penitenza è solo per rimettere i peccati, una sorta di lavatrice automatica. Noi dobbiamo reagire con tutta la forza contro una simile erratissima concezione che non ha nessuna verità ed un solo pregio: quello di essere molto, ma vergognosamente, comoda. Ecco le principali ragioni per le quali le anime, finché è possibile, vanno formate una per una. Si ammette che è difficile ottenere questo, ma Dio non ci imputerà ciò che diventasse praticamente impossibile, per il numero dei fedeli, per la insufficienza delle forze, per la riottosità delle stesse anime a lasciarsi guidare verso Dio. Mentre dovremo rendere conto di tutto quello che potevamo fare. Le anime sono dissimili. Riesce difficile sostenere che le anime siano o possano essere ontologicamente dissimili. Però, poiché entrano per la unione sostanziale in un composto umano che porta con sé tracce di tutte le generazioni preterite e queste tracce compone e scompone in svariatissimi modi, senza tener conto della intrusione di molti dati di fatto, le anime sono praticamente dissimili tra di loro. A noi poco importa che la ragione della dissomiglianza sia una piuttosto che l’altra; basta il fatto che la dissomiglianza c’è. – La dissomiglianza mette fuori gioco la efficacia di molti mezzi, altri riduce, altri altera. La azione educativa per questo motivo deve partire non solo da una base di principio teorico ed astratto, ma dalla conoscenza del singolo caso in concreto. Spesso accade che lo stesso metodo rende un educando amico ed un altro educando nemico e tanto basta a far capire che i metodi educativi non si possono applicare sempre e dovunque indiscriminatamente. – Le esperienze interiori – oltre che esteriori – delle anime sono dissimili. Queste esperienze infatti dipendono da ambienti, da contatti, da persone, dal grado di doti di relazione, dalle reazioni esterne e finalmente dalla stessa recettività o reattività del singolo. Anime simili possono avere esperienze non solo dissimili, mai addirittura opposte. Tutto ciò porta l’impegno educativo sempre alla considerazione e all’impegno individuale. Affinità ed analogie non mancano, si danno accostamenti che possono permettere anche qualche classificazione, ma con tutto questo non si arriva a poter abitualmente provvedere alla educazione spirituale in una formai semplicemente collettiva. Tanto quanto questa verità entrerà nella convinzione dei nostri confratelli, altrettanto aumenterà la giusta stima del sacramento della Penitenza. – Si potrebbe aggiungere che infinite compressioni di anime trovano uno sfogo giusto solo nell’ombra discreta del sacramento della Penitenza. Pensiamo che i dolori e le solitudini angustiose degli altri debbano avere il loro peso nel farci giudicare con saggezza in merito alla presente questione. Il fatto che lentamente si stia facendo una diversione falsa e dalle incalcolabili conseguenze, – dalla educazione anzitutto individuale alla educazione anzitutto od esclusivamente collettiva, dalla educazione che si adatta alla indefinita ricchezza e varietà delle anime a quella ispirata semplicemente al tipo standard, moda, folla… – deve attirare la nostra attenzione. Esso, soprattutto se entra inavvertitamente (come accade nella maggior parte dei fenomeni), ci fa mettere da parte il sacramento della Penitenza quale lo ha concepito e configurato Gesù Cristo. Infatti da qualche parte – non qui – qualcuno si è provato a dispensare dalla accusa individuale, dando larghe e gratuite assoluzioni generali alla massa. Forse qualcuno ha fatto a meno persino di quella.
La regola morale ed oggettiva divina non cambia
Il sacramento della Penitenza viene amministrato in forma di giudizio, per il fatto che si opera una scelta tra due estremi e questa scelta non è arbitraria, ma guidata dal merito delle cose tra cui si sceglie. I due estremi tra cui si sceglie sono: rimettere o ritenere il peccato. Quale il criterio per scegliere? Gli atti e le disposizioni del penitente. Le disposizioni del penitente in che consistono? Nel pieno rinnegamento del peccato. Allora, presuppongo che qualcosa sia peccato, qualcosa no. Che cosa decide tra i due casi? La Legge, ossia la regola morale obiettiva congiuntamente con la situazione soggettiva. – Comunque tutto comincia a dipendere dal fatto che vi è una regola o legge morale oggettiva, e cioè indipendente da noi, superiore a noi, anche ammettendo la esistenza di leggi positive variabili. Ecco perché in tema di confessione sarebbe inutile continuare ogni discorso ed ogni uso se non esistesse una regola morale oggettiva, capace di discriminare tra il bene ed il male. Ecco perché è importante rispondere alla laconica domanda: cambia la morale? La regola morale oggettiva e divina non cambia. Ed ecco il perché. Il piano di Redenzione delineato nella rivelazione divina ha fissato un tipo dell’uomo con una legge precisa e degli scopi ben definiti. Questo piano non cambia. Per cambiare dovrebbe cadere – contro tutte le affermazioni di Cristo e degli Apostoli – il piano divino. La natura umana non cambia. La sua costituzione, la essenzialità sei suoi rapporti sono immutabili. L’ambiente presenta infinite inazioni accidentali, che non toccano mai l’essenza dell’uomo. La Legge è stata data come definitiva ed eterna. Le norme morali date da Cristo hanno valore fino a che Egli non «verrà di nuovo», e cioè per tutti i tempi fino al momento escatologico. La fissità della norma fino all’ultimo giudizio è una delle cose che risaltano nella predicazione evangelica. – La Chiesa ha in tempo recente chiaramente disapprovato la cosiddetta «morale della situazione» ed il Vaticano II ha richiamato – fatto di morale, sia pure interpretandola secondo lo sviluppo dei tempi [chiaramente questo è criticare il conciliabolo senza che i suoi insipienti “censori” se ne rendessero conto, viste poi le successive affermazioni in evidentissimo contrasto -ndr.-], le norme sempre affermate dal magistero ecclesiastico. Contro questa fissità della regola morale si levano talvolta voci discordi, o – piuttosto – si insinuano «modi» di considerare le cose, i quali dovrebbero a poco a poco arrivare a dissolvere la norma stessa. La confusione in materia, la incompetenza teologica e la presunzione di facili scrittori possono creare il miraggio di una fata morgana possono sedurre anche dei confessori. Noi li mettiamo severamente in guardia. – A tale fine osserviamo più da vicino taluni punti sui quali è facile creare il rovesciamento della norma divina.
1. – Qualcuno ha creduto che nel Concilio venisse indotto qualcosa di nuovo a proposito del matrimonio con tutte le sue conseguenze. Vediamo anzitutto il «creduto nuovo». Si tratta dell’amore coniugale. In effetti a questo amore si dà una attenzione non consueta ai Documenti antecedenti del Magistero. Non è mancato durante la elaborazione conciliare qualcuno che avrebbe voluto si asserisse l’amore essere fine essenziale del matrimonio [tesi eretica -ndr.-]. La verità è che questa asserzione non venne e che quanto detto sull’amore coniugale era già ben noto ed è tutto uno sviluppo di quanto san Paolo afferma al capo 5 della lettera agli Efesini. Vediamo le conseguenze. Essa – la novità – sarebbe stata, nei desideri di qualcuno, una tale precedenza dell’amore sulla fecondità da consentire al primo almeno qualche sbizzarrimento ai danni della seconda. Ma questo non accadde. Si dice invece (1. c. 50) espressamente: «Il matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole. I figli infatti sono il preziosissimo dono del matrimonio». Si è fatto un gran parlare di qualche rimedio costrittore e riduttore della fecondità coniugale. I principi della morale non hanno mai ammesso mutilazioni né anatomiche, né fisiologiche, né biologiche. Restava a vedere se il conclamato rimedio fosse nulla di tutto questo, ma solo un vero ed onesto regolatore nell’ambito della natura. Dire se lo fosse e lo fosse nel senso voluto dalla morale accettata non appartiene ai teologi, ma agli scienziati. Per studiare la cosa il Sommo Pontefice [quello falso del falso concilio -ndr.] ha costituito una numerosa commissione, la quale ha già presentato il frutto dei propri studi. Ma la Santa Sede non si è ancora pronunciata in alcun modo. Pertanto le regole morali restano quelle di prima. [e tali resteranno sempre! – ndr. – ]
2. – Si è notata una certa tendenza qua e là a dare più importanza alla persona umana che alla legge divina. Il che è inammissibile, perché non esiste nella persona umana alcun diritto di legittima emancipazione dalla legge. E non che tutto questo lo si dica chiaro, ma si inducono tali accentuazioni, tali toni e tali sfumature, dalle quali è facile dedurre un qualche lenimento della legge a favore della emancipazione umana. Questi toni sdrucciolevoli si trovano generalmente negli scritti superficiali, dall’andamento più giornalistico che ragionato, tuttavia creano delle perplessità nelle anime. Noi mettiamo severamente in guardia tutti i sacerdoti contro quello che si accenna, nei facili scritti, verso una maggiore emancipazione del volere umano e li esortiamo a stare accuratamente agli insegnamenti dei testi di Teologia morale che la scuola ha messo loro in mano [cioè quelli antecedenti al conciliabolo! -ndr.-]. Facciamo qualche esempio per spiegarci meglio. Quando si mette troppo l’accento sulla incomprensione che taluni giovani constatano da parte dei rispettivi genitori ed educatori, si tace troppo e volentieri che, ad onta di qualsivoglia incomprensione, intatta – e per diritto divino — la patria potestà con le sue emanazioni. Così, per compiangere i giovani, si giunge praticamente ad asserire la loro emancipazione dalla virtù della obbedienza, dal dovere della disciplina, sostituendo un certo colloquio, che sarà sempre utile, ma non è un equivalente della obbligazione voluta da Dio. Per lo stesso motivo si finisce con l’addurre le generazioni giovanili a disprezzare l’apporto insostituibile della esperienza e ciò con danno enorme dei giovani stessi, spinti in tal modo a ricredersi per la via dell’esperimentato e generalmente tardivo dolore inutile. – Pare che molti lentamente stiano arrivando ad ammettere che tutto diventa morale quando è afferente alla libertà ed alla personaumana. Ciò in contrasto con il dato fondamentale della vita che è una prova di come ci si sa diportare di fronte ad una Legge, non deterministica, ma obbligante in linea morale.
3 — E cambiato qualcosa in materia di castità, di purezza, di modestia? (Modernamente si direbbe: «in materia sessuale», ma preferiamo mantenere la vecchia e più cauta terminologia). È certamente cambiato in molti il modo di considerare il sesto comandamento, ma non è cambiata la Legge. Vediamo dunque come è cambiato questo «modo». – Anzitutto si parla della materia come se il parlarne non implicasse più ragioni di educazione, di pudore, di cautela, di difesa dal fomite della concupiscenza. Di conseguenza se ne parla troppo. Ciò è connaturato al diffondersi della teoria freudiana. Ma, riteniamo, è dovuto molto più all’esagerato senso della personalità umana, per cui si cerca di eliminare tutto quanto alla stessa è limite, contenimento, sacrificio. Questo, dopo aver dimenticato che la persona umana è soggetta alla Legge e non è arbitra della Legge. Finalmente se ne parla troppo per non esser da meno della grande stampa, la quale ostenta abitualmente in materia la più grande procacità o la più voluta indifferenza, salvo ad abbandonarla contradditoriamente quando una regola morale le viene bene per creare lo scandalo e l’utile dello scandalo. Guardandosi intorno si può avere anche la impressione che si debba considerare morto il senso del pudore. Ma, stiano attenti i sacerdoti: non esiste un consenso nel male, ossia, il largo consenso nel male non modifica in nulla la legge del bene. Si dovrebbe osservare la Legge di Dio, anche se si restasse soli! Una ben intesa psicologia ed una retta pedagogia, considerando l’insieme del quadro in cui oggi avviene lo sviluppo e la educazione, potranno variare certe impostazioni affatto secondarie e probabilmente nocive nella situazione moderna; ma non toccano né la debolezza, né il fomite, né il rapporto di attrattiva, né la sostanza del peccato e della virtù. Siamo d’accordo nel dire che la sola modestia degli occhi oggi non basta più, data la esibizione del contegno e di tutte le comunicazioni sociali. Ma ciò significa che si deve tutelare la virtù piuttosto con il metodo attivo, positivo e combattivo, e che occorrono maggiori riserve interiori; non significa affatto che la modestia degli occhi oggi non sia più necessaria. Il pericolo di peccato è aumentato, non diminuito. Il rapporto tra l’anima ed il corpo rimane lo stesso; le conseguenze del peccato originale non si sono affatto affievolite; il rumore, la fretta e la incessante varietà delle sensazioni non dispensano dai problemi, ma ne creano uno nuovo togliendo concentrazione e indipendenza all’azione dello spirito. Il mistero del quanto il materiale attinga lo spirito e del quanto lo spirito incida sul materiale è ben grande; rimane non meno il dovere obiettivo di difendere lo spirito, di prendere tutte le necessarie cautele contro le debolezze proprie del composto umano. – Dovremo appresso ritornare sull’argomento.
4. – Non è mutata la fisionomia teologica del sacramento della Penitenza. E dottrina cattolica che esso è intrinsecamente, oltre che un sacramento, un giudizio. La interpretazione che la Tradizione ha sempre dato di tutte le parole evangeliche riferentisi alla istituzione del sacramento ed al conferimento del perdono non lascia dubbi al riguardo. Il consenso di tutta la Chiesa, durato tanti secoli, chiama in causa la sua infallibilità e pertanto la divina garanzia. Chi volesse toccare il carattere giudiziario del sacramento della Penitenza sarebbe obbligato a distruggere la Tradizione ed il magistero ecclesiastico. Per questo motivo la fisionomia teologica e giuridica del sacramento non viene né può venire in discussione, come non possono discutersi tutte le conseguenze della essenza; anche giuridica. È per questo motivo che, salvo il caso di necessità urgente o di impossibilità, nessuno può arbitrarsi di manomettere in qualsivoglia modo la integrità formale della accusa dei peccati, sostituirla con accuse generiche e collettive o trovate simili.
5. – Fino a questo momento non è cambiato neppure il rituale del Sacramento. Il rituale costituisce una Legge, che vincola in coscienza. Pur sapendo che anche il rituale dei sacramenti andrà soggetto ad una riforma, bisogna attendere che venga e nessuno è autorizzato a sostituirsi nelle innovazioni ad una Autorità, quale risiede solo nella Chiesa. In conclusione: solo la Legge può addurre mutazioni; prima della legge, quando non si voglia garantire la perfetta osservanza, non resta altro che la indisciplina e la anarchia. Il diritto liturgico è stato legittimamente per molti secoli riservato al potere supremo della Chiesa; attualmente il Concilio Vaticano II ha riconosciuto alcuni poteri ad organi inferiori [altra chiara stoccata alle mutazioni del falso concilio – ndr.-]. Nella materia di loro competenza bisogna attendere che questi decidano. L’ondata pseudoculturale di estrazione hegheliana che ha investito tutte le manifestazioni intellettuali, impoverendole, ha investito anche talune scuole e persone ecclesiastiche. Si tratta di ignoranza di quella estrazione (come abbiamo già molte volte ammonito), si tratta di complessi di inferiorità rispetto ai grandi colori della messinscena pubblicitaria, si tratta in ultima analisi di uno svanire nella distinzione del bene dal male, della verità dall’errore, di una pretesa creativa dell’essere nel vero e nel buono: gli ecclesiastici se ne guardino specialmente a proposito di un sacramento fondamentale per la salvezza dell’uomo peccatore. L’idea della indifferenza tra bene e male è praticamente presentata in concreto dalla grandissima maggioranza degli attuali mezzi di comunicazione, in termini espliciti da imprese editoriali, che non si occupano né del bene né del male, ma solo del danaro. Essa, immessa dalla lettura quotidiana, a poco a poco, si può insinuare e di fatto in qualche modo si insinua anche nel clero. Questo denunciamo altamente e contro questo pericolo mettiamo tutti in guardia. – Il sacramento della Penitenza è legato con situazioni che non muteranno mai; neppur esso cambierà, quanto alla sua sostanza ed alla base morale che sempre suppone il giudizio morale.
[Continua… ]