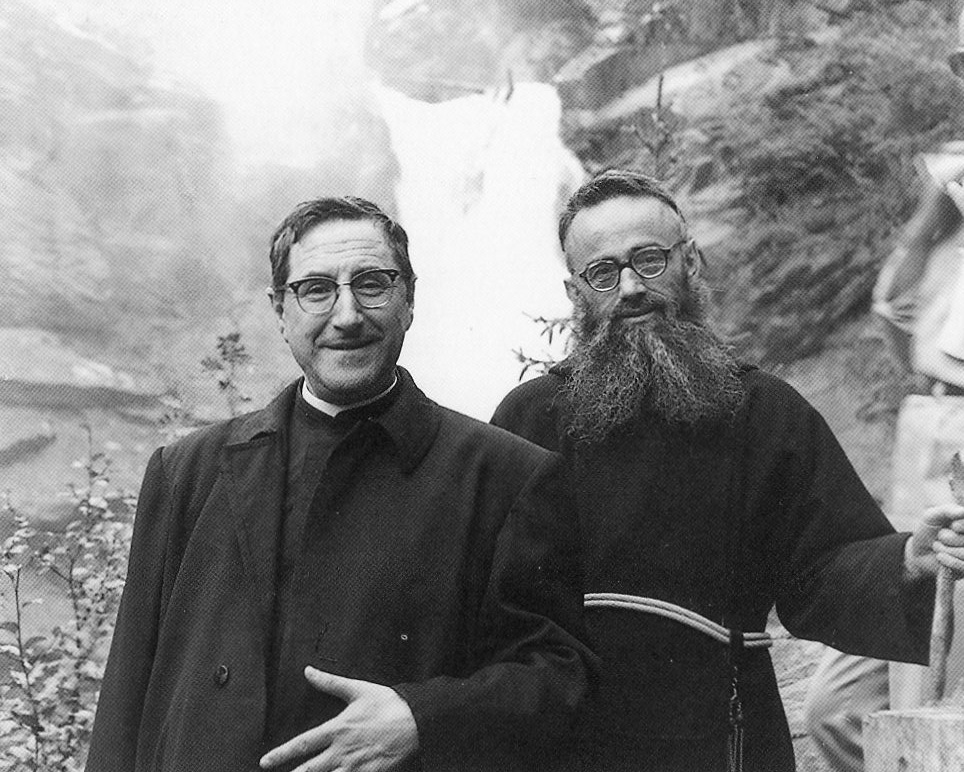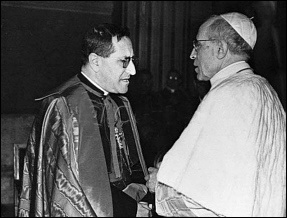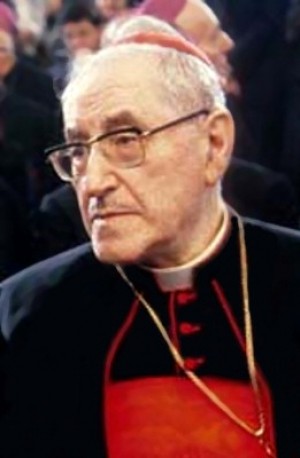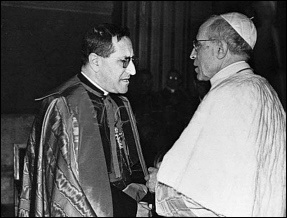
S. S. GREGORIO XVII: IL MAGISTERO IMPEDITO.
III CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI (2)
[G. Siri: Esercizi Spirituali; Ed. Pro Civitate Christiana – Assisi, 1962]
IL NOSTRO ITINERARIO CON GESÙ’ CRISTO
2. Il peccato
Facciamo la meditazione sul peccato. Del peccato bisogna che consideriamo un aspetto particolare. Nella nostra condizione, se pecchiamo, noi pecchiamo mentre camminiamo con Cristo. Ecco tutto. Pertanto io non mi fermerò a insistere sulla nozione ben nota del peccato, che è la rottura volontaria, consapevole della legge di Dio. Non credo che voi abbiate bisogno di queste nozioni e di sapere le condizioni per commettere un peccato, almeno il peccato grave: la gravità della materia, la cognizione, la volontà. Queste sono nozioni scontate. È necessario che l’anima nostra venga invece a riflettere su questa circostanza: il Cristiano, quando pecca, pecca mentre cammina con Gesù Cristo. Sì, la cosa può avere diversità notevole; il Cristiano che non entra mai in chiesa, se pecca, ben poche volte s’incontrerà con Gesù Cristo; ma se là dove colui che pecca c’è una chiesa, c’è il tabernacolo, c’è Gesù Cristo presente, il rapporto tra lui e Gesù Cristo è molto più vivo, anche se lui non lo riconosce, anche se lui non ci pensa, non ne fa oggetto di meditazione e di richiamo e di pungolo di coscienza. Non importa, c’è. Questo Cristiano, se pecca, pecca mentre cammina con Gesù Cristo. Perché l’aria è impregnata di Gesù Cristo, anche dove non lo si vuole, anche dove non lo si ama, dove lo si bestemmia, dove non lo si cerca o lo si rinnega. Il peccato degli uomini ha questa caratteristica, che il peccato essi lo fanno camminando con Gesù Cristo. – Guardate che qui si tratta di noi, perché noi lo incontriamo tutti i giorni, molte volte al giorno; noi lo abbracciamo ogni giorno, perché ogni giorno riceviamo il Corpo del Signore, noi parliamo ogni giorno con Lui. Pertanto il fatto dell’iter non è soltanto un fatto obiettivo legato a cose imprescindibili, al carattere battesimale, al carattere della S. Cresima, elementi che, volere o non volere, ci legheranno per sempre con Gesù Cristo, per cui la vita dovrà essere tutta con Gesù Cristo. E questo accadrebbe per noi che camminiamo con Lui, sicché Egli può rivolgere a noi il suo sguardo e dire: « Et tu, notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos, notus meus et contubernalis meus », « tu, mio familiare, che dividi la tua vita con me, che prendi insieme a me il tuo dolce cibo », anche tu! Questa è la grave circostanza sulla quale io voglio attirare la vostra attenzione perché sia limpida. Noi dobbiamo arrivare ad avere una vita cristiana guidata da una coscienza che sia netta, e lo scopo degli Esercizi è di fare chiaro negli angoli, quegli angoli che la consuetudine tende a rendere sempre più ampi, sempre più comodi e sempre più scuri, dove si nasconde tutto quello che si vuole, dove si può lasciare tutto in disordine, e che talvolta diventano così grandi che quasi non c’è più posto nella casa. Gli angoli. Gli Esercizi Spirituali sono fatti per folgorare questi angoli, angoli di dimenticanza, angoli di abitudine, angoli di incoscienza, dove noi lasciamo avvenire cose che possono anche avvicinarsi alla terribilità o dove confiniamo a marcire cose che possono rappresentare la salvezza. Cominciamo a riflettere dal punto di vista obiettivo: noi il peccato lo commettiamo mentre camminiamo con Gesù. Non so se voi per caso vi siate mai trovati da qualche antiquario dove talvolta è dato vedere lampade d’argento che hanno bruciato l’olio davanti al SS. Sacramento. Fan pena. Sono finite qui. Ma chi è stato quell’incosciente che ha permesso, o per essersi dimenticato o per aver venduto o per aver lasciato a parenti incoscienti, che sian finite qui? Talvolta si vedono pezzi di sacri parati, pianete che hanno servito per celebrare la S. Messa, piviali ricamati o di broccato che poi vanno a finire come dei postergali in qualche salotto; peggio, perfino dei calici, che furono e permangono consacrati, perché non è accaduto ancora qualcuno di quei fatti che tolgono ai calici la consacrazione. Che pena fanno! Ma dappertutto c’è la traccia di Gesù Cristo. Si fanno le processioni del Corpus Domini e Gesù Cristo passa per queste strade, passa accanto a quelle siepi, la processione costeggia case, boschi, giardini. C’è passato lui. Dove passa Dio, passa l’eternità, passano le cose infinite. Non è come il profumo di un fiore arrivato per un colpo di vento da un giardino, che passa per un momento e presto svanisce nell’aria. No. È Dio, e dovunque passa, passano cose eterne, passano cose infinite. In quasi tutte le case, credo, almeno nei paesi cristiani, è entrato Gesù Cristo, perché è andato a trovare qualche ammalato, è diventato il Viatico ultimo, il supremo sostegno al passo estremo. E qualche cosa di grande e di divino è passato ed è rimasto. Guardate se non è vero che la nostra vita, vogliamo o non vogliamo, cammina con Gesù Cristo. Lo trova dappertutto. Un sacerdote porta con sé Gesù Cristo, perché ogni mattina ha detto la S. Messa, lo ha toccato, lo ha dato. Esiste ancora nei fedeli, anche in quelli più slavati, a un certo momento il senso di rispetto per il sacerdote perché tocca le cose sacre. È inutile, dappertutto c’è la traccia del passaggio di Gesù Cristo. Ricordo un racconto inteso dai vecchi del paese di mio padre sulle montagne di Liguria. E ricordo ancora la piccola croce che ho ritrovato da bambino là dove si raccontava il fatto. Un secolo prima un sacerdote che d’inverno andava attraverso la neve per dire la Messa a quella povera gente, fu assalito dai lupi che lo hanno divorato, ma hanno lasciato intatte le quattro dita, quelle non le hanno toccate, le quattro dita che vengono consacrate dal Vescovo. È un fatto che ho sentito raccontare quando avevo tre anni e da allora mi ha accompagnato. Le quattro dita. E mi dicevano i vecchi: « Sai, non le hanno potute mangiare, quelle, perché sono le dita con le quali celebrava la Messa ». – C’è questa obiettiva presenza, dappertutto. Il peccato degli uomini ha per scenario ciò che, tutto, è stato dipinto per Gesù Cristo. Nella nostra vita noi parliamo talvolta male, potremmo averlo fatto se anche ora non lo facciamo più, ma la nostra lingua ha toccato Gesù Cristo. Questa nostra carne ha toccato Gesù Cristo. Sarebbe così logico che, avendo toccato Gesù Cristo, fosse trasumanata e che noi la considerassimo come trasumanata. Forse non l’abbiamo mai considerata così; ma ha toccato Gesù Cristo! E le mani sacerdotali toccano Gesù Cristo. Egli è dappertutto. E la vita, si voglia o non si voglia, cammina con Lui. Notate bene, con Lui non solo perché c’è la presenza di un pensiero cristiano, di un richiamo morale cristiano, di un pungolo di coscienza cristiana, non solo perché dovunque c’è la presenza dovuta alla divina ubiquità, ma perché positivamente, qualitativamente, in modo caratterizzato c’è dovunque la presenza della Eucaristia, ossia di Gesù Cristo. È questo il punto. Logicamente parlando — si dovrebbe dire così ma la logica non è il forte della morale degli uomini —, è possibile che il peccato possa entrare dove è entrato Gesù Cristo, dove questa divina presenza è scesa, dove questa divina munificenza si è attuata, dove c’è stato il tocco di questa divina carezza? Però il fatto è che quando si pecca, si pecca in questa situazione, ed è un fatto dal quale noi non possiamo assolutamente prescindere. Certamente occorre la conoscenza, perché ci sia il peccato mortale, e la pienezza del consenso; ma una conoscenza riesce a essere perfettamente sufficiente alla colpa anche dimenticando tutte queste cose, dimenticando l’elemento circostanziale che aggrava il giudizio del peccato nel mondo. Ah, se la conoscenza necessaria alla colpa, grave almeno, avesse bisogno di arrivare fino a questo punto! Ma allora forse non ce ne sarebbero più di peccati nel mondo. Eppure la stortura c’è: l’apprendimento che si viola la legge di Dio è sufficiente. Noi dobbiamo gettare la luce in quest’angolo affinché questo aspetto circostanziale del peccato, per noi che abbiamo scelto di vivere più vicini a Gesù Cristo, illumini e mostri che cosa in esso abbiamo confinato o che cosa contro di noi, in esso, sta in agguato. – Passiamo ora al secondo punto della meditazione. Il secondo punto vuole specificare questo: appunto perché quando abbiamo dei difetti, se non proprio dei peccati gravi, li abbiamo camminando con Gesù Cristo, allora non si tratta soltanto di considerare i peccati isolati, qualificati, caratterizzati, ma si tratta di qualificare degli stati d’animo che sono dovuti a una carenza, a un difetto. – Il discorso del peccato mortale a molte anime, forse a tutte le anime che mi stanno ad ascoltare, può sembrare un discorso lontano, distante, che può riguardare tutti gli altri che sono fuori di qui, ma che qui se ne parla per quella correttezza burocratica per cui negli Esercizi Spirituali si parla anche del peccato. Accostiamoci allora a quello che può essere invece di più il pane nostro quotidiano, ai nostri peccati più tipici; così almeno veniamo via dall’astratto e vediamo quello a cui noi dobbiamo applicare la presente meditazione, e cioè che il peccato nostro è fatto mentre camminiamo con Gesù Cristo. Per esempio il peccato dell’immobilismo. È un peccato che non si trova elencato nei libri di morale; sì e no lo si trova elencato nei libri di ascetica. Che cos’è il peccato dell’immobilismo? È questo: noi facciamo il cammino con Gesù Cristo; Lui va avanti e noi rimaniamo perennemente indietro. Cammina, si volge a guardarci quasi a dire « Vieni », e noi ci si siede, ci si addormenta, si dorme per dieci anni, vent’anni, trent’anni. Bel modo di camminare con Gesù Cristo! Ecco l’aspetto del peccato che diventa reale per noi. Quell’altro potrebbe anche essere meno reale per noi, per grazia di Dio, anzi io desidero e credo che sia affatto irreale. Questo no, questo potrebbe essere perfettamente reale. L’iter con Gesù Cristo a questo modo. Immaginatevelo: la fantasia qui ci aiuta stupendamente. Sedersi e dormire per vent’anni, trent’anni, e Lui che va e si gira continuamente indietro. « Ma vieni, ti muovi? ». Il peccato dell’immobilismo, che consiste nel fatto — scendiamo dalla metafora alla realtà — di non portare innanzi l’opera della purificazione propria e di non portare innanzi l’opera della propria perfezione. Ah, se voi mi dite: quanto all’altro peccato, non abbiamo niente da dire, potrebbe essere che su questo abbiate qualche cosa da segnare sul libro della vostra coscienza. Può essere che tutti noi, tutti, nessuno escluso, abbia qualche cosa da segnare e ne debba piangere. Se noi oggi ci troviamo ad avere lo stesso grado di orazione che avevamo l’anno scorso quando facevamo gli altri Esercizi… a questo proposito, che cosa abbiamo fatto in questo anno, per che cosa sono passati 365 giorni? Fanno tanto presto a passare, uno dopo l’altro, i giorni, e bisogna far presto, bisogna arrivare, non abbiamo tempo da perdere! Gli anni volano. Se noi abbiamo oggi delle reazioni di orgoglio, le stesse reazioni che potevamo avere l’anno scorso, miei cari amici, voi capite che è il caso che noi abbiamo a domandarci : « Ma allora quest’anno che cosa siamo stati a fare? ». Allora vuol dire che si è vegetato, non vissuto. Questi sono i peccati reali, che talvolta scandiscono in periodi lunghissimi e gravi e grevi la vita delle anime che pure fanno professione di religione e professione di apostolato. Il peccato dell’immobilismo. Notate bene che se noi quest’anno constatiamo di avere nei nostri rapporti con gli altri — i rapporti sono i giudizi che diamo, i giudizi che, se non diamo, sentiamo in fondo all’anima, gli atteggiamenti che emergono da questi giudizi, atteggiamenti che possono essere fatti in parte di simpatia e in parte di antipatia —; se noi in questi rapporti fatti di miserie come di piccole reazioni, del modo particolare di giudicare le azioni di questa determinata persona, di quell’altra, a seconda che è vibrata la corda della simpatia o la corda dell’antipatia, e gli atteggiamenti nostri che sono stati colorati da determinati punti del nostro temperamento, da nostri stati d’animo; se in questi rapporti siamo oggi allo stesso punto in cui eravamo l’anno scorso, allora è il caso di domandarci: Ma noi, che cosa abbiamo fatto? Per che cosa abbiamo vissuto un anno? La via della purificazione deve andare innanzi, portar via le scorie, le macchie, le deformità, le carenze, le anemie. So bene che la via della santità è una via lunga e non è una via facile, ma quello che importa è che non si rimanga fermi. Accompagnarsi con Gesù tutto il giorno, tutti i giorni, e lasciarlo camminare idealmente sotto il peso della croce che porta, che ha portato, atto divino ed eterno, per cui « sempiternum habet sacerdotium », e noi seduti lì, ai margini della strada a contemplare uno spettacolo o un panorama che soltanto la nostra fantasia compone e che il nostro sentimento aduggia! Ecco il peccato dell’immobilismo. – Faccio la conclusione. Voi vedete come, in tema di peccato, noi che facciamo una vita spirituale, che veniamo tutti i giorni in chiesa, che pretendiamo di parlare col Signore tutti i giorni, dobbiamo trasportare la nostra considerazione dagli atti alle abitudini, dagli atti positivi agli atti negativi che sono le carenze, dalla sostanza alle sfumature. E la conclusione è che gli esami di coscienza delle anime che vogliono veramente camminare con Gesù Cristo, perché sono sulla strada con Lui, non possono starsene soltanto su uno schema d’esame di coscienza degli atti qualificati. Ho ammazzato? No. Ho bestemmiato? No. Ho fornicato? No. Ho lasciato la Messa? No. Ho detto delle gravi bugie? No. Ho desiderato la roba, la donna d’altri? No. L’esame di coscienza deve portarsi alle sfumature, agli stati d’animo, alle abitudini contratte e perché contratte diventate incoscienti. È tutta una trasposizione che bisogna fare. Naturalmente non si debbono perdere di vista i peccati come atto, anche perché i peccati come atto sono oggetto del Sacramento della penitenza. Non sarebbe una confessione abbastanza specificata, e pertanto utile, se vado a confessarmi e dico: Sono stato un immobile. Voi mi avete inteso, vero? L’aver considerato che il peccato, qualunque peccato, noi lo facciamo mentre camminiamo con Gesù Cristo ha illuminato lati profondi, circostanziati del peccato e ha fatto capire che gli esami di coscienza nostri si debbono distaccare dagli atti; debbono contenerli, mantenerli gli schemi degli atti; ma se li vogliamo veramente proficui al profitto spirituale e alla maggiore dignità di questo nostro cammino con Gesù Cristo, debbono arrivare a quello che non è atto ma è abitudine comunque considerata: carenza, stato d’animo, stato negativo, tiepidezza.