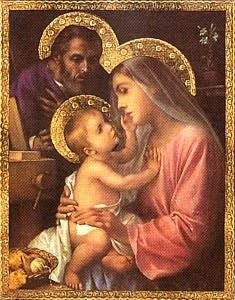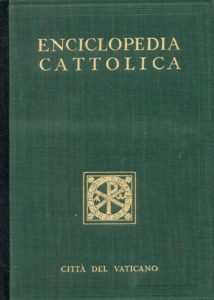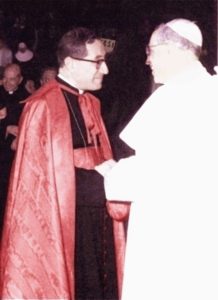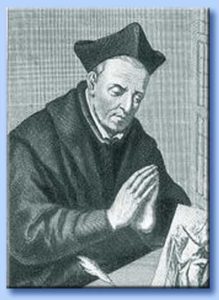
INFERNO [2]
[E. Barbier: I tesori di Cornelio Alapide, S.E.I. Ed. Torino – vol. II, 1930]
3. Il reprobo è maledetto da Dio, dal demonio, e dagli altri reprobi. — 4. Morte nell’inferno.— 5. Come i demoni trattano i reprobi. — 6. Disperazione nell’inferno. — 7. Gradazioni di supplizi. — 8. Eternità delle pene infernali. — 9. L’inferno è conforme alla giustizia di Dio. — 10. Mezzi per schivare l’inferno.
3. – IL REPROBO È MALEDETTO DA DIO, DAL DEMONIO E DAGLI ALTRI REPROBI. — Dall’istante in cui il Giudice supremo avrà pronunziato contro i peccatori che entrano nell’eternità macchiati anche di un solo peccato mortale la terribile, irrevocabile sentenza: Partitevi da me, o maledetti, e andate al fuoco eterno: — Discedite a me, maledicti, in ignem æternum (MATTH. XXV, 41), la maledizione di Dio non si allontanerà mai più da loro, ma li pigerà e li travolgerà per tutti i secoli. Della maledizione di Dio leggiamo nella Scrittura: « Amò la maledizione e gli pioverà sul capo; non volle la benedizione e si scosterà da lui. La maledizione lo coprirà come vestimento, entrerà come acqua nelle sue interiora, penetrerà come olio nelle sue midolla. Diventerà per lui come abito che mai non si depone, come fascia che gli cinge le reni » — Dilexit maledictionem et veniet ei; noluit benedictionem et elongabitur ab eo. Et induit maledictionem sicut vestimentum, et intravit sicut aqua in interiora eius. Fiat ei sicut vestimentum quo operitur; et sicut zona qua semper præcingitur (Psalm. CVIII, 16-18). Ecco dunque designati quattro terribili effetti della maledizione di Dio: 1° essa circonda all’esterno il reprobo…; 2 ° entra nell’interno e si appiglia alle potenze dell’anima …; 3 ° si spinge ancora più innanzi e la ferisce fin dentro la sua sostanza, come olio che penetra fino alle midolla…; 4° questa maledizione non l’abbandonerà mai un momento … Tale è l’infelice condizione del dannato sotto l’incubo della maledizione divina! . . . Un’anima creata a immagine di Dio, redenta col sangue di un Dio, essere maledetta dal suo Dio, dal suo Creatore, dal suo Redentore, dal suo solo ed unico bene! Chi può comprendere, chi può spiegare questo sommo, indefinibile male?… Mentre i peccatori sono in questo mondo, i demoni non cessano di adularli, per sedurli e precipitarli nell’inferno. Come già ai nostri progenitori, essi offrono loro ad ogni ora dei frutti vietati, dicendo: « Non morrete, ma diventerete come altrettanti dèi » — Nequaquam moriemini; eritis sicut dii (Gen. III, 4-5). Ma nell’inferno invece di adularli, malediranno senza fine quei ciechi che trangugiarono il veleno della seduzione… Nell’orribile prigione dove si scontano fra supplizi atroci le colpe della vita, si troveranno radunati insieme i compagni di dissolutezza che gareggiavano a chi più facesse onta al pudore. Là gli amici diventeranno carnefici degli amici; si svillaneggeranno a vicenda, si oltraggeranno, si caricheranno di amari rimproveri, si scaglieranno sanguinose ingiurie e orrende maledizioni. Là il padre negligente e scandaloso si troverà col figlio scapestrato che griderà furioso: Padre maledetto, sei tu che mi mettesti nella via del delitto; tu mi hai insegnato ad ingannare il semplice e l’incauto, a frodare l’artigiano; tu mi hai seminato in cuore i funesti germi dell’ambizione, tu mi hai insegnato a profanare la domenica, a bestemmiare, ad ubbriacarmi, a disprezzare i precetti della Chiesa. Tu sei l’autore della mia disgrazia; io ti maledico e ti maledirò in eterno! La figlia si avventerà quale furia contro sua madre, urlando: Madre disgraziata, perché darmi alla luce, se volevi prepararmi un’eternità di supplizi? Il tuo esempio mi fu continua scuola d’immodestia, di civetteria, di libertinaggio; la tua colpevole e frivola noncuranza, la tua rilassatezza mi ha perduta! Perché non mi hai strozzata di tua mano, in culla? Sii maledetta per sempre! E tutti gli echi dell’inferno ripeteranno: Sii maledetta per sempre! Là, o libertini scandalosi, vi troverete con le vittime delle vostre seduzioni; esse vi staranno sempre ai fianchi per pungervi e dilaniarvi e ciascuno dei loro rimproveri sarà acuta e ardente saetta che vi trafiggerà il cuore. – Corruttore abbominevole, assassino crudele, seduttore ipocrita, tu mi hai tolto la mia innocenza, rapito la mia verginità, rubato l’onore, involato la corona; mi hai ucciso l’anima e fatto perdere il mio Dio! Va, diavolo incarnato! in che ti aveva offeso l’anima mia immortale, destinata alla vita della eterna gloria, da meritare che tu le vibrassi il colpo di eterna morte? Soffri e disperati, o crudele, soffri per sempre! Nell’implacabile odio mio, ti maledico in eterno!
4. – MORTE NELL’INFERNO. — Dice il profeta che i reprobi saranno stipati come pecore nell’inferno e la morte ne farà suo pasto: — Sicut oves in inferno positi sunt; mors depascet (Psalm. XLVIII, 14). « Ottimo paragone è questo, scrive S. Bernardo: perduto il vello delle ricchezze, i reprobi duramente e interamente spogliati, sono gettati ad ardere nudi tra le fiamme eterne. La morte ne farà suo alimento, perché moriranno sempre alla vita e vivranno sempre per la morte; il loro corpo è abbandonato ai vermi, l’anima al fuoco fino al giorno in cui nuovamente congiunti in un’infelice unione, patiranno insieme i supplizi, essi che furono compagni nei vizi ». – « La morte, soggiunge S. Gerolamo, commentando le citate parole del Salmista, la morte sarà il mandriano dei dannati; è giusto che siano guardati e pasciuti dalla morte coloro che non vollero avere per buon pastore il Cristo ». « Il peccato consumato genera la morte » — Peccatum cum consummat um fuerit generat mortem ( IACOB. I, 15). « E non vi è morte, dice S. Agostino, tanto terribile e disgraziata, quanto la morte che non muore mai (Lib. VI, De Civ. cap. ultimo) ». – Quaggiù in terra, osserva anche S. Gregorio, il peccatore muore alla vita, nell’inferno vivrà della morte. La morte vive per voi, o reprobi sventurati, e la vostra fine è sempre sul cominciare. Il dannato sconterà tutti i suoi delitti, ma non sarà distrutto. La morte non lo annichila, perché se la vita di questa morte fosse distrutta, egli cesserebbe di esistere; ma affinché sia tormentato senza fine, è costretto a vivere nei supplizi; è giusto che quegli la cui vita su la terra fu una morte nel peccato, soffra nell’inferno una morte che sia una vita nei castighi (Mor. 1, XV, c. XII). «Nell’inferno, ripete altrove il medesimo santo, l’anima perde la vita della felicità, ma non il suo essere; di qui la dura necessità per lei, di soffrire la morte senza morire, di perire senza perire, di finire sempre senza finire mai; perché per essa la morte è immortale; è una consunzione senza consumazione, un fine senza termine. La morte è dunque per i dannati una morte immortale, un fine infinito, una distruzione indistruttibile (Dialog. 1. IV, 45) ». Come triste e terribile è la sorte dei reprobi! Poiché, come i cadaveri servono di pastura ai vermi, così le anime riprovate servono di alimento alla morte per tutta l’eternità e la loro vita sarà un nutrirsi della morte!… Nell’inferno la morte è sempre vivente; là è il suo regno, il suo trono; là trova una fecondità immancabile. Se dunque volete sapere che cosa sia l’inferno, udite: l’inferno è la dimora, il regno della morte; perché la morte eterna vi domina assoluta, regna su tutti i dannati, uomini e demoni e il suo impero non vedrà mai fine. Sulla terra, i peccatori stanno nel vestibolo dell’abitazione della morte, ma nell’inferno stanno nei più segreti appartamenti, nelle stanze più interne del suo palazzo. Il cielo è il regno della vita, perché ne è il re Iddio; l’inferno è il regno della morte, perché essa vi comanda e signoreggia sola padrona. « Mi fa spavento, esclama inorridito S. Bernardo, la morte sempre vivente; rabbrividisco al pensiero di cadere preda di quella morte che sempre vive, di quella vita che sempre muore; è questa la seconda morte che mai non toglie i sentimenti, eppure sempre uccide. O Dio! chi darà tal grazia ai peccatori, che muoiano una volta, perché non muoiano in eterno! (De consid. I, V. c. XII) ». – E poi a proposito di quelle parole d’Osea: « Diranno ai monti, rovesciatevi addosso a noi ed alle colline, seppelliteci » (OSE. X, 8), così continua: « Che vogliono i dannati se non la morte della morte, perché possano finalmente morire, o fuggire la morte”? Ma per quanto essi invochino la morte, la morte non verrà mai a liberarli ». (De Consid. I. V) – « Poiché nell’inferno, dice S. Gregorio, l’anima è immortalmente mortale, e mortalmente immortale. E immortale in modo però che può morire, ed è mortale in modo che non può morire: il vizio ed il tormento le tolgono bensì la vita beata, ma le lasciano la vita che dipende dalla sua essenza ( Moral. Lib. IV, c. VII ) ».
5. – COME I DEMONI TRATTANO I REPROBI. – — Udite come Isaia descrive l’accoglienza che si fa al reprobo nell’inferno: « Al suo primo comparire su la soglia dell’inferno, la casa della morte ne va sossopra; i demoni che v’imperano, gli si slanciano incontro a dargli il benvenuto e tutta la turba dei dannati, battendo a palma e levando orrende, altissime strida, gli dice: Anche tu sei stato ferito come noi! Anche tu sei divenuto simile a noi! La tua alterigia è caduta in fondo all’abisso, il tuo corpo giace in terra e i vermi saranno il tuo vestimento » — Infernus subter conturbatus est i n occursum adventus tui. Omnes principes surrexerunt de soliis suis, universi dicent tibi: Et tu vulneratus es sicut et nos, nostri similis effectus es. Detracta est ad inferos superbia tua, concidit cadaver tuum; subter te sternetur tinea, et operimentum tuum erunt vermes ( ISAI. XIV, 9-11). Tutti i demoni si attruppano alla porta dell’abisso e al presentarsi di un dannato, gridano con gioia infernale: Vieni, o reprobo, a dimorare con noi, in mezzo al fuoco, tra fiamme eterne; vieni a bearti del fumo dei tormenti, che ascende nei secoli. Vieni, che nulla tanto ci preme quanto premiarti dell’obbedienza con cui accogliesti le nostre sollecitazioni. Tu ci hai ascoltati e seguiti allorché ti andavamo susurrando: Bevi di questo liquore della voluttà, inebriati di collera, di bestemmia, ecc. … Tu ci porgevi orecchio su la terra, ascoltaci anche adesso che ti diciamo: Bevi il calice del fuoco misto a zolfo; tracanna la coppa della collera del Dio vivente; tuffa le labbra nel vaso del nostro furore… Tutti i demoni sono accaniti nel perseguitare e malmenare e straziare il reprobo. Vittima sulla terra delle loro suggestioni, diventa nell’inferno vittima del loro incessante furore… Meditate, o peccatori, queste terribili, ma salutari verità.
6. – DISPERAZIONE NELL’INFERNO. — I reprobi sono scomunicati e separati per sempre da Dio, dagli Angeli, dalla Chiesa. Essi né ricevono né possono ricevere aiuto né da Dio, né dagli Angeli, né dagli uomini, né da altra creatura di sorta. Dimenticati e abbandonati da Dio, dal cielo e dalla terra, ormai non hanno più modo di fare penitenza; le loro preghiere non hanno più valore, la redenzione non può più essere loro applicata; esclusi per sempre dalla misericordia sono condannati, per irrevocabile giudizio, a non vedere mai più Iddio, a dimorare eternamente con i demoni, in un fuoco che non sarà mai spento; tutte le creature visibili ed invisibili, corporali e spirituali sono loro nemiche; si odiano e si maltrattano a vicenda; sono privi di ogni carità e di riconciliazione; chiarissimamente comprendono e vivissimamente sentono quello che hanno perduto per sempre e quello che si guadagnarono col peccato; si vedono stremati di ogni mezzo, chiusa ogni via di giungere ad amare Dio … – In quest’orrendo stato, il reprobo digrigna i denti e si abbandona alla più desolante e crudele disperazione. Nella rabbia della sua irrimediabile disgrazia, va ripetendo: Il mio fine è perduto, non vi è più per me filo di speranza: — Periit finis meus, et spes mea a Domino (Lament. III, 18). Il mio smarrimento è senza uscita, non più scampo, non più vita; vana, impossibile è ogni speranza di vedere la fine delle mie disgrazie; esse non avranno più termine; non ne sarò mai più liberato; non avrò mai più minuto di riposo, di libertà, di gioia, di consolazione! L’orribile carcere donde non uscirò mai più, non ha porta! — Periit finis meus, et spes mea. — E non è questo, un argomento da invelenire la loro rabbia, da costringerli a digrignare i denti! – « In braccio all’orribile disperazione, essi fanno udire, dice S. Efrem, questo doloroso addio: Addio, apostoli, profeti, martiri, giusti tutti quanti! addio, senato dei patriarchi! addio, esercito degli anacoreti! addio, croce preziosa e vivificante! addio, eterno regno dei cieli, bella Gerusalemme, madre degli eletti, paradiso di delizie! addio anche a voi, Signora nostra, madre di Dio, genitrice di Colui che ha tanto amato gli uomini! Addio, padri e madri, figli e figlie, sposi e spose; addio, noi non ci rivedremo mai più! •> (Tract., de Abrenunt. et variis inferni poenis).
7. – GRADAZIONI DI SUPPLIZI. — « Giudizio severissimo aspetta quelli che sovrastano », dico la Sapienza, e quindi un castigo più rigoroso sta preparaper costoro nell’inferno: — Iudicium durissimum his qui præsunt fiet (VI, 6). I più famosi nei delitti, i più astuti nelle seduzioni, i più scandalosi nei costumi, i più furfanti negli impieghi, saranno condannati a più duri tormenti, sottoposti a più atroci supplizi, un fuoco più ardente, una notte più buia, un freddo più intenso, strazi più orrendi, angosce più cocenti, insomma un inferno più spaventoso dovranno provare quelli che nel mondo ebbero più facoltà di fare il male: — Potentes potenter tormenta patientur… Fortioribus fortior instat cruciatio (Ib. 7-9). « Molti appartamenti vi sono nella casa del padre mio », disse Gesù Cristo: In domo Patris mei multæ mansiones sunt (IOANN. XIV, 2); poiché i giusti hanno una gloria adeguata ai loro meriti, essendo da Dio premiati ciascuno secondo le sue opere. Or bene, il medesimo avviene nell’inferro: vi sono colà molti e diversi stalli; quanto più ree sono le anime che vi cadono, tanto più in basso e vicina ai demoni è la loro dimora, tanto più gravi sono i loro supplizi. La giustizia di Dio regna nell’inferno come nel cielo. Gli Apostoli tengono lassù u n luogo distinto dagli altri eletti, il loro seggio è vicino al trono dell’Agnello; Giuda, l’apostolo traditore, occupa nell’inferno uno stallo ben diverso da quelli della folla dei reprobi. Ogni peccato mortale merita l’inferno; perciò chi vi precipita carico di cento, di mille colpe gravi, deve incontrare tormenti cento, mille volte più gravi di quelli che soffre il reprobo il quale fu condannato per un solo peccato mortale; supposto che un peccato di quel primo reprobo sia in gravità affatto uguale a quello di questo secondo; perché vi sono peccati molto più gravi gli uni degli altri, ed i più gravi vanno soggetti a pena più grave… – Dio infinitamente saggio e giusto pesa tutto scrupolosamente e dà a ciascuno quello che gli tocca, sia premio o sia castigo… Come cieco ed infelice si mostra l’uomo che non cerca di accrescere ogni istante il tesoro dei meriti, lo splendore della sua corona; aumenta invece ogni momento i suoi peccati e l’acerbità dei suoi supplizi! …
8. – ETERNITÀ DELLE PENE INFERNALI. — Per quanto gravi, orribili, insopportabili siano i tormenti infernali, essi sarebbero ancora poca cosa se dovessero finire, ma l’eternità loro è il peggiore dei supplizi. Quel fine che sempre comincia, secondo l’espressione di S. Agostino: — Finis semper incipiet, — è ciò che propriamente forma l’inferno e dà alle pene che là si soffrono, l’ineffabile, indefinibile qualità che le distingue da tutte le altre pene, ancorché atrocissime. Tutti i reprobi soffriranno tra l’orrore e l’affanno, sempre vivranno della morte, sempre disperati di misericordia e di perdono. Eccola disgrazia delle disgrazie, l’inferno dell’inferno. Tormenti eterni! … Non vedere mai più Iddio, né la Santa Vergine, né i santi, né gli amici, né i fortunati parenti, né il cielo; e quel che è più, non poter nemmeno figurarsi una lontana ombra di speranza di vederli: ecco il sommo dei supplizi, ecco la più atroce delle torture! « Partitevi da me, o maledetti, e andate al fuoco eterno, sentenzierà il Giudice supremo, e a quell’intimazione, andranno i reprobi nel supplizio eterno e gli eletti nella vita eterna » — Discedite a me, maledicti, in ignem æternum. Et ibunt hi in supplicium æternum, iusti autem in vitam æternam (MATTH. XXV, 41, 46). Già vediamo accennata questa sentenza in quelle parole di Daniele: « Quelli che dormono nella polvere della terra si sveglieranno; gli uni per la vita eterna, gli altri per l’ignominia la quale si vedranno sempre dinanzi » — Qui dormiunt in terræ pulvere evigilabunt; alii in vitam aeternam, et alii in opprobrium ut videant semper (DAN. XII, 2). – Oh! se almeno a tutti i mali dell’inferno vi fosse un termine! Ma no; non vi sarà mai né termine, né fine, né sospensione, né diminuzione di pena; o Dio! che disgrazia, che infelicità è mai quella!… No, non vi è redenzione per il reprobo: « Il sangue che Gesù Cristo ha sparso sulla terra non penetra nell’inferno, dice S. Cipriano, perché tutto lo bevvero i peccatori (Serm.) » i quali pertanto, dice l’Apostolo, sconteranno la pena di un’eterna dannazione: — Pœnas dabunt in interitu æternas (Thess. II, I, 9). – «La miseria della pena, scrive Ugo da S. Vittore, cadrà sulla miseria della colpa, affinché restino insieme congiunte e fino a tanto che rimarrà la colpa, durerà la pena; ora siccome nell’inferno la colpa resta in eterno, così in eterno ancora restano la pena e il castigo » (Lib. de Anima). « E non è forse giusto, dice S. Gregorio, che coloro i quali avrebbero voluto sempre vivere per peccare sempre e dimostrarono questo loro desiderio col peccare sempre, finché vissero e non vollero mai separarsi dal peccato durante la vita, non siano mai dopo morte separati dal supplizio? (De pœnitentia, can. LX) ». «Bene sta, ripiglia S. Agostino, che la volontà la quale volle l’eterno godimento del peccato, sia punita con un’eterna severità di vendetta (In Spec. peccat.)», – Ogni peccato mortale importa di sua natura una punizione eterna. L’uomo, cadendo in colpa grave, si uccide per l’eternità e non può più risuscitare senza l’onnipotenza di Dio. Ora questo miracolo di risurrezione, a cui Dio punto non è tenuto, quando avviene, non avviene che nel tempo: ma giunto che sia l’uomo nell’inferno, il miracolo non ha più luogo: chi passa all’eternità macchiato di peccato mortale, vede la sua colpa e la pena di questa colpa diventare eterne… Dio è buono; ma appunto perché infinitamente buono deve odiare il peccato finché ne rimane traccia; ma non essendo mai distrutto il peccato nell’eternità, ne segue che sarà eternamente punito in forza dell’odio eterno che gli porta Iddio… La Scrittura ci dice che Dio ha viscere di misericordia per gli uomini, ma si dichiara ancora nel medesimo tempo che vi è un fuoco eterno, che Dio ha decretato eterne pene al peccato non cancellato dalla penitenza. Oseremo dire che Dio non è giusto! È vero che l’azione colpevole dura poco; ma il male più che nell’azione, sta nella malizia, nella disobbedienza, nella volontà. Accuserete voi d’ingiusta la legge umana, che punisce nel malfattore il delitto di un momento con lunghi anni di pena infamante?… « L’uomo peccatore, dice S. Gerolamo, deve soddisfare eternamente a Dio, perché era sua volontà di resistere eternamente a Dio» (In Psalm. XVIII). «In una volontà perversa non si deve tanto guardare all’effetto, dice S. Agostino, ma all’affetto del cuore; quantunque l’effetto fallisca, perché non dipende dall’uomo, è giusto che la volontà sia punita con pena proporzionata alla sua malvagia disposizione (De Civ. Dei)». Ora che altro vorrebbe il peccatore ostinato, se non che sempre vivere per burlarsi sempre di Dio e della sua coscienza? L’atto del peccato non dura, ma l’affetto al peccato dura sempre in fondo al cuore… Inoltre nell’inferno il peccatore è privo della grazia e senza di questa è impossibile ottenere il perdono dei peccati… Il peccato è un allontanamento volontario da Dio, è un disprezzo formale della Maestà divina, è l’amore della creatura preferita al Creatore, ossia un adulterio spirituale, è quindi la più enorme ingiuria che si possa fare a Dio. Misurate la gravità di una tale ingiuria con la grandezza del Dio ch’essa oltraggia e vedrete che è infinita nel suo oggetto perché intacca una grandezza infinita. Ma un essere finito nella sua essenza, non può sopportare una pena infinita in intensità; ne segue dunque la necessità di una pena infinita in durata. Le parole di Geremia: « Il peccato (dei reprobi) sta scritto con penna di ferro a punta di diamante e scolpito su tutta l’ampiezza dei loro cuori » — Peccatum scriptum est stylo ferreo, ungue adamantino, exaratum super latitudinem cordis eorum (XVII, 1), mentre denotano l’ostinata volontà dei peccatori nel mal fare, significano ancora che le loro colpe stanno scritte nel libro della morte a lettere di fuoco e che né acqua, né lagrima basteranno per tutta l’eternità a raderle o cancellarle. Sono scolpite nella memoria e nella coscienza dei reprobi e come verme roditore non cesseranno mai dal morderlo e divorarlo. Che disgrazia è mai questa eternità dei tormenti! Che sventura, essere condannato a vivere sepolto nelle fiamme eterne! O insensatezza degli uomini che per un vile piacere di un istante si precipitano in torture senza fine! O eternità di fuoco, di disperazione! O eternità, tormento incomparabile! O morte che non si trova mai compita! O vita che è un’eterna morte!… Si beve, si giuoca, sì scherza un momento; questo passa veloce ed ecco succedergli immantinente una calamità eterna! Così si va ridendo all’inferno, all’eterna infelicità! Vi si va, ma più non se ne torna; perché la fine della vita presente è il principio dell’eternità e questo principio è la fine delle cose di quaggiù. O fine che non termini! o morte che non sei la morte, mentre chiudi il tempo, apri l’eternità che non ha mai più fine!… Viviamo dunque in questo mondo così, che meritiamo di vivere eternamente…
9. – L’INFERNO È CONFORME ALLA GIUSTIZIA DI DIO. — Iddio non è autore del peccato, ma giusto estimatore e conservatore dell’ordine; punisce il disonore della colpa coll’onore della giustizia. « Tutte le cose fatte da Dio sono ottime», dice la Sacra Scrittura. (Gen. I , 31), egli non h a dunque fatto quello che si trova di malvagio nell’uomo. Quello che vi è di cattivo nell’uomo, è un disordine; ora ogni disordine merita castigo; ma chi si deve punire, domanda S. Agostino, se non l’autore? e chi è l’autore del peccato nell’uomo, se non lo stesso uomo ribelle a Dio? Questa punizione dell’uomo ribelle a Dio non è un disordine, anzi è l’ordine: la pena è l’ordine del misfatto. Quando io dico peccato, dico disordine, perché esprimo la ribellione; quando poi dico punito, dico cosa ordinatissima, perché è retto ordine che l’iniquità abbia castigo. Il peccatore, come un pazzo, si uccide per l’eternità; ammonito fa il sordo; vuole giustizia che sia punito… Qui viene a proposito l’avviso di San Paolo ai Galati: «Non illudetevi, con Dio non sì scherza. L’uomo raccoglierà di quello che h a seminato: se carne, mieterà dalla carne corruzione; se spirito, mieterà dallo spirito vita eterna » — Nolite errare, Deus non irridetur. Quæ enim seminaverit homo, hæc et metet. Quoniam qui seminat in carne sua, de carne et metet corruptionem; qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam æternam (Gal. VI, 7-8). – La vera, la propria causa dell’inferno è il peccato: — Persecutionem passi ab ipsis factis suis (Sap. XI, 21). Quello che forma l’inferno, non è la pena, ma il peccato. Infatti, in che cosa consiste essenzialmente l’inferno? Nella privazione della vista e del godimento di Dio, ossia nell’essere separati da Dio, che è la felicità suprema; ora solo il peccato è la causa della separazione dell’uomo da Dio. Voi dunque, o peccatori ostinati, voi vi portate l’inferno nelle viscere, perché portate dentro di voi il peccato che vi fa di scendere vivi nell’inferno. Dio non sarebbe Dio se non fosse giusto; egli deve pagare ciascuno secondo i fatti propri… A chi dunque oppone: perché un inferno, sotto un Dio buono? la risposta viene chiara e facile: Appunto perché Dio è buono, è necessario l’inferno, come perché è infinitamente buono, vi dev’essere un inferno eterno; infatti dove sarebbe la bontà, l’equità, la rettitudine sua, se il disordine morale andasse impunito? Se i tribunali non punissero, non ostante la evidenza delle prove, il parricidio, l’omicidio, il furto, l’incendio, che ne sarebbe della giustizia e della società? Se piace un paradiso per ricompensare i buoni che patirono negli stenti e nelle avversità, perché non ammettere un inferno dove siano puniti i malvagi che vissero nell’empietà e nei delitti? Dio è buono e giusto; ma ognun vede che molte virtù anche eroiche, come il martirio, non hanno in questo mondo, o nessuna o certo una inadeguata ricompensa; vi sono non pochi delitti che su questa terra sfuggono ad ogni castigo; vuole dunque giustizia che vi sia e un paradiso e un inferno.
10. – MEZZI PER SCHIVARE L’INFERNO. — I mezzi che abbiamo per evitare l’inferno sono:
1° La preghiera. Volgiamoci a Dio gridando col profeta: « Deh! o Signore, non mi sommerga la tempesta delle onde, non m’inghiottisca l’abisso, non si chiuda sopra di me la bocca della voragine » — Non me demergat tempestas aquae neque absorbeat me profundum, neque urgeat super me puteus os suum (Psalm. LXVIII, 16).
2° Il pensiero ed il timore dell’inferno. « Discendiamo nell’inferno mentre siamo vivi, dice un santo padre, se non vogliamo andarvi dopo morte ». – « Quanto si mostra sensato ed è felice, esclama S. Agostino, colui che in vita si dà tanto pensiero del supplizio, da scampare a pericolo di subirlo, dopo morte. Volesse Iddio che intendeste e comprendeste quello che è il mondo e quello che è l’inferno! Certamente voi allora temereste Iddio, desiderereste le cose celesti, disprezzereste il mondo e avreste orrore dell’inferno (In Spec. peccat.) » . – Infatti chi di voi può dimorare in mezzo a un fuoco divoratore, tra vampe ardenti e sempiterne? — Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante? quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis? — domanda Isaia (XXXIII, 14).
3 ° Il pentimento delle colpe, la detestazione e confessione dei peccati, la conversione della vita. « Chi darà al mio capo, gemeva S. Bernardo, un torrente di pioggia; ai miei occhi una fonte di lagrime; affinché prevenga col mio pianto e con i miei gemiti, il pianto unito allo stridore dei denti? (Serm. in XVI Cantic.) » .