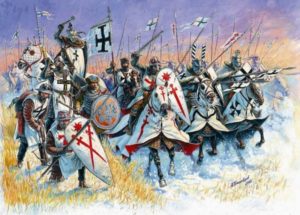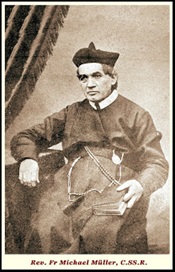GREGORIO XVII
IL MAGISTERO IMPEDITO
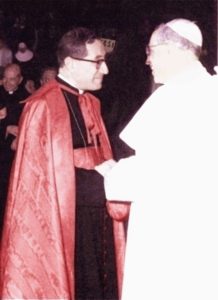
I CONTENUTI (3)
VIII. – Ortodossia
[lettera pastorale del luglio 1971; «Rivista Diocesana Genovese», 1971]
VI
I «contenuti» per il popolo di Dio
1. Noi abbiamo posto il problema dei «contenuti» al livello delle persone che leggono libri, che pongono e capiscono problemi di pensiero e che facilmente vogliono vedere il fondo degli argomenti. Ma c’è il popolo. Sono i più. La questione dei «contenuti» per il popolo, per i più, assume una particolare complessità, che Noi non possiamo assolutamente evadere. Il «contenuto» della Fede, e di quanto è a qualunque titolo connesso con la Fede, il popolo lo lega a cose concrete, semplici, tradizionali. Esaminiamo questa posizione del problema, che è di somma importanza. Queste cose concrete sono: la Chiesa, i libri di devozione, le sacre immagini, tutti i segni religiosi dei quali nel corso dei secoli sono stati abbondantemente fregiati portici, porte, muri, complessi di arredamento, canti, musica, cerimonie sacre, sacri paludamenti. Sarebbe un errore sottovalutare questo, quasi la Fede del «popolo» sia materiale e talvolta superstiziosa, anche perché ogni regione ha la sua propria emotività, che gli altri o non intendono o intendono male. La verità è che «niente è nell’intelletto se prima non è sta nell’immagine sensitiva» e tale regola può subire una applicazione più «caricata» in molti fedeli. Tutte le cose concrete enumerate, ed altre ancora, mantengono in qualche modo (magari riassuntivo, poco definito, frammentario, ma forte) il senso della Fede. E ringraziamone Dio, se ha permesso che le cose materiali e concrete concorressero tanto a mantenere la Fede del suo popolo. Spesso le nostre linfatiche prediche ed il nostro frettoloso catechismo, talvolta il nostro parlare da iniziati (teologia del linguaggio) non fanno altrettanto. Ed è per questo che la sottovalutazione delle cose concrete quando si tratta della Fede del popolo è per lo meno incapacità di comprendere, spesso insipienza completa, talvolta pazzia! È per questo che il disprezzare o distruggere queste cose concrete, le loro giuste manifestazioni esterne, le loro dignitose coreografie o cambiarle a piacimento, senza riguardo, oltre che iconoclastia è distruzione della Fede. La tradizione per il popolo ha importanza, che non potrà mai essere valutata appieno e coi suoi elementi bisogna fare i conti con pazienza e lungimiranza. – Cari confratelli, vi abbiamo spinto a togliere tutte le immagini sacre che non sono dignitose e che non hanno una giusta e possibilmente architettonica collocazione; ma vi abbiamo esortato sempre a credere nella efficacia delle Immagini sacre. – Le cose più concrete sono: il Tabernacolo, il Crocifisso, la Madonna, gli Angeli, i Santi. Prima di essere cose concrete per l’apprendimento degli uomini sono cose reali, vere! Per carità, non toccatele, non umiliatele, non affrettatene l’oblio, non diminuitene il rispetto e la presenza. Sarebbe un distruggere la Fede. A poco a poco. Cose semplici. – Sono le formulazioni riassuntive, ridotte al midollo, forse anche scarnite ed anche queste frammentarie, resti sufficienti di una impalcatura impostata dal primo catechismo della infanzia, di una saltuaria predicazione, di molti casuali incontri riesumatori e vivificatori. Ma tutto questo nella mente dei fedeli è vero «contenuto» della Rivelazione e lo sarà fintanto che si useranno catechismi chiari, semplici, dai termini assolutamente comuni e quindi accessibili, dalle definizioni precise. Le formulazioni generiche, le allusioni di scorcio, i discorsi in «ottica» e con chissà quale «prospettiva», le innovazioni maniache delle mode, le esposizioni tratte da modelli umani (troppo umani e poco ortodossi), non possono dare il solido fondamento dell’umile vero catechismo. Cose semplici sono per il popolo i racconti della storia sacra, della vita dei Santi; tali veridici strumenti nella loro ricostruzione apparentemente quasi visiva di fatti tangibili custodiscono il segreto di cose profonde, di intuizioni, di godimenti spirituali. E non c’è da aspettarsi che queste cose semplici vengano sempre a fior di labbra con parole proprie e definizioni perfette. Per fortuna l’uomo afferra molto più ed approfondisce molto più di quanto sa rendere letterariamente nella comunicazione con gli altri. L’uso degli «astratti», dei termini accarezzati, perché impegnano nessuno e niente. Non serve a mantenere la Fede del popolo. – Cose semplici sono tutte le sane, ortodosse e magari ingenue e candide devozioni, le pratiche di pietà che esse ispirano. Custodiscono e traducono a modo loro, ma generalmente efficace, quello che neppure grandi teologi saprebbero inoculare con erudite spiegazioni nell’animo dei bimbi e dei semplici, degli ignoranti in materia religiosa (che è peggiore delle incapacità infantili!). Non distruggete, per carità, Rosari, Via Crucis, piccole immagini, giaculatorie, novene, tridui, quarantore, pratiche eucaristiche,… Naturalmente tenetele nel giusto binario. Ma se vi trovaste a sottovalutare o addirittura a disprezzare e ridicolizzare tutto questo santo armamentario degli indotti ed anche dei dotti, dovremo avvertirvi che siete certamente fuori strada. Avreste perduto la nozione del modo graduale, dei diversi successivi livelli, della progressione ineffabile e mai riducibile in formule, col quale si costruiscono negli uomini e si consolidano i fatti spirituali, gli orientamenti costruttivi, tra i quali sta in primo piano la Fede. I «contenuti veri della stessa Fede» li custodirete quanto più voi farete parlare nel Tempio le «cose». – «I contenuti» (parliamo sempre del «popolo») sono profondi: Dio, Padre Figlio e Spirito Santo, Gesù Dio Crocifisso e risorto, la Madre di Dio, la Vita eterna, il peccato, la Santa Messa, la Sacra Comunione, la Confessione, la preghiera, l’Inferno, i morti nel purgatorio… il Rosario, le Litanie, la Via Crucis, le orazioni – quelle del catechismo e imparate da bimbi – , il «Dio sia benedetto » … sono al disotto della Divina Liturgia, ma spesso prima di essa e in sostituzione di essa, valevoli ad imprimere nel popolo i «contenuti» della salvezza. Non disprezzate mai, per carità, i mezzi umili e semplici. Spiegateli, teneteli nella giusta e cristiana interpretazione ma non lasciateli cadere. – Le cose semplici noi le afferriamo se guardiamo al modo umile col quale tra gli uomini avvengono i fatti più necessari, si hanno le risorse più modeste eppure più indispensabili alla vita. In fin dei conti anche gli uomini più grandi, forse più superbi, magari più tiranni e dominatori, debbono scendere a un certo punto tra le cose comuni e naturali, tra i sentimenti più domestici e spontanei, non scoppiare della loro miserabile inflazione!
Le cose tradizionali. – Non parliamo qui della tradizione divina, che nessuno può toccare. Parliamo di quello che fu e resta, che ha fatto parte giusta e non ignobile della nostra vita, che fu soddisfazione e costume di quanti sono vissuti prima di noi ed hanno costruito il clima e il contesto nel quale siamo cresciuti. Parliamo di noi gente, che ha avuto un passato, ed un passato trasmesso attraverso legami sacri di amicizia e di beneficenza, di arte e di intelligenza, soprattutto di sangue! Questa tradizione certamente non può considerarsi vetrificata, mummificata e deve costantemente accogliere apporti e variazioni, non violenze e irruzioni pazzesche. Essa deve lasciare al rotare dei fatti e della Storia, in modo amabile, senza vittime, di procedere innanzi, di percorrere il suo cammino. Non può considerarsi statica; ma i suoi adattamenti debbono avvenire in modo utile, schietto ed umano. Tutto questo va tenuto in conto quando si tratta dell’ambiente popolare più facile alla emotività che al secco ragionamento. – Il succo del discorso è questo: non distruggiamo per il popolo gli umili strumenti, che salvano ad esso il contenuto della Fede!
2. Quando si parla di «contenuti» per il popolo cristiano in genere dobbiamo soffermarci su un altro grave e impegnativo aspetto del problema. Ecco di che si tratta. – I -contenuti» della Fede intanto sono tali in quanto vengono in qualche modo «appresi». Dove non c’è l’apprendimento il «contenuto» non entra. L’apprendimento è legato alla «intelligenza» della cosa presentata. L’intelligenza penetra nella realtà, anche invisibile e non semplicemente fenomenica: è la sua caratteristica. – Ora le verità della Fede non sono rebus da imparare semplicemente a memoria. E verissimo che i misteri non possono comprendersi, non possono cioè essere esauriti dalla nostra intelligenza. Essa non ne può toccare il fondo. Però, anche quello che non si può comprendere, si può in qualche grado intendere. Si tratterà di intendimento certamente parziale ed anche estremamente umile, ma si tratta di vero intendimento. Lo si chiama analogico, perché in parte coincide con la cosa che intende, in parte (ed è infinitamente maggiore) non la raggiunge. Resta ad un modesto inizio della lunga via: è qualcosa, per noi molto. – Bisogna affermare con tutta la forza che, se non ci fosse alcun intendimento delle verità rivelate, la Rivelazione rimarrebbe incomprensibile e sarebbe inutile. – Resta dunque vero che qualcosa, anche nel catechismo dei bimbi, qualcosa deve essere capito, poco o tanto. Ecco ora la conseguente grave affermazione: per capire bisogna spiegare. Chi, come, con che mezzo? Ma si può dire anche una sola parola della Sacra Scrittura. Perché essa non sia scritta invano (il che è impossibile nella divina saggezza), deve qualche poco essere capita. La spiegazione non può partire che da una certa interpretazione della parola stessa e, se non in tutta la Scrittura, in molte parti di essa è pur necessario capire con certezza qualcosa. Ora questo è possibile applicando le regole della ermeneutica cattolica guidata dalla divina tradizione e dal Magistero della Chiesa. – Ma non ci sono solamente i concetti, le parole, ci sono le proposizioni intere che costituiscono, ad esempio, i Dogmi. Per queste «proposizioni» non è affatto sufficiente capire le singole parole staccate della proposizione stessa. Non sempre l’ermeneutica, che può spesso tenere la chiave del significato delle parole e dei modi di dire, è in grado di farci penetrare tutta la sostanza della verità. A questo punto appare evidente la assoluta necessità della teologia speculativa. Essa sola ci permette quella intelligenza delle proposizioni dottrinali tale da spiegare e rendere più intelligibile ai piccoli, al popolo, agli ignoranti, le medesime verità. Abbiamo inteso dire da maestri saggi e venerati che per spiegare dieci, bisogna almeno avere imparato e capito cento. L’aspetto pastorale della catechesi non può essere raggiunto se non c’è una teologia speculativa che ne doni lo strumento. – Errano pertanto coloro che tacciono o addirittura vorrebbero distrutta la teologia speculativa. Senza di essa e supponendo la giusta ermeneutica della Bibbia, l’insegnamento del Vangelo si ridurrebbe ad una recitazione continua, forse ad un balbettio, degno delle scuole cinesi dei tempi andati. – Anche perché il popolo vuol capire qualcosa. Ha generalmente senso dei propri limiti, ma qualcosa vuole capire: ce lo chiede. Senza teologia speculativa che possiamo dire a chi ci propone questioni, dubbi, a chi ci chiede approfondimenti, ci domanda di aprire vie che possono anche mirare alle altezze della intelligenza mistica? Noi teniamo nel debito conto tutti gli strumenti culturali ed afferenti a tale scopo, ma ricordiamo che non si spiega nulla senza teologia speculativa. – La teologia speculativa ha un valore reale. Ha certamente il valore della sua chiarezza, logica, capacità esplicativa. Ha il peso di una tradizione scolastica che non può essere sottovalutata. Ha il pregio di portare ai confini della conoscenza nella Parola di Dio. Ha la forza di sciogliere le apparenti contraddizioni che talvolta affiorano nel mistero, donando una quiete reale all’intelletto. Ma c’è altro. – In molti punti essa sostanzialmente raccoglie il consenso dei dottori e il consenso almeno tacito della Chiesa Maestra. Nessuno ad esempio può dubitare che taluni punti esplicativi del Dogma Trinitario e del Dogma Cristologico, nel secolo quarto e quinto, non sono semplici tentativi di scuola. Essa, se stiamo in un certo alveo, ha avuto il benevolo incoraggiamento e la approvazione della Chiesa Docente. Per tali motivi la teologia speculativa non è oggetto di demitizzare, ma soltanto da approfondire ed arricchire nel solco della Tradizione della Chiesa. Non dimentichiamo mai che generalmente è per la teologia speculativa che si arriva a vedere sistematicamente la coordinazione e la sintesi: punti di vista panoramici per godere nel suo insieme la Divina Rivelazione. Del resto Dio ha consegnato alla nostra intelligenza la Sua Rivelazione salvifica; dobbiamo mantenere il contenuto nella luce della intelligenza e non possiamo rassegnarci a vederla consegnata puramente all’udito toccato solo da onde sonore. – Possiamo concludere che i «contenuti» possono restare incompresi e sminuiti della loro mirabile efficacia per difetto di metodo e cioè per rinuncia all’uso impegnato della intelligenza e di tutti i suoi strumenti offerti dalla esperienza scolastica e dalla storia sotto lo sguardo del Magistero. – In argomento non possiamo tacere che sono stati tentati dei succedanei della Teologia speculativa, né conformi al senso della ispirazione, né esatti, né concludenti. – La speculativa parte dal principio che Dio ha assunto nel rivelare parole e pensiero umano, nonché dal principio che la verità rivelata rappresenta realtà superiori alla comprensione umana, sicché è possibile solo un tentativo della parziale, coscienziosa, metodica penetrazione. I «succedanei», anche se non lo dicono, hanno semplicemente saltato l’ostacolo attenuando il soprannaturale, spaziando nel campo naturalistico, che non spiega, ma elimina la Rivelazione. È il caso di qualche celeberrima pubblicazione, sulla quale mettiamo in guardia. Talvolta l’ostacolo si salta negando esplicitamente la autenticità del testo biblico o rifiutando o ignorando la sola legittima interpretazione di esso, quale è data dalla Tradizione della Chiesa. – I «contenuti» possono essere violentati da queste forme erronee di interpretazione e ne possono uscire completamente svuotati. – Non è questo che il popolo cristiano attende.
3. I «contenuti» nel popolo di Dio possono più o meno lentamente svanire, sotto diverse pressioni. Non c’è dubbio che la Fede del popolo resiste più di quella di taluni ceti. Tuttavia anch’essa va soggetta ad usura. I giovani, quelli che ora si stanno facendo le ossa in tutti i sensi, sono i più esposti a tale usura, pur dimostrando ma sete di nutrimento spirituale che meraviglia quando si avvicinano senza paura e senza complessi.
Ecco i due più gravi pericoli:
a. I «contenuti» sentono la sferza della «moda». La moda ha tanto maggiore presa quanto più uno ha bisogno della presenza, degli occhi, del consenso degli altri (si tratti di salotto, di bar, di club, di branco occasionale, di amicizie a denominatore comune). La «moda» è effimera e per questo ha un contenuto – se si tratta di mode intellettuali – che in parte almeno non è veritiero. Ora esistono mode di affermazioni sconcertanti e sconvolgenti su tutto, non fosse altro che per gustare l’effetto del disagio su chi ascolta. Non facciamo un elenco delle diverse mode, perché non abbiamo mai voluto metterci in polemica diretta. Facciamo il nostro dovere, ma non amiamo le liti tra fratelli!
b. I «contenuti» per il popolo sono insidiati dal «dileggio», oggetto del dileggio è quanto esisteva alcuni anni addietro. Per secoli si dovrebbe credere che non ne hanno indovinata una. Questo modo di comportarsi dimentica che le cose mutano e possono essere valide per una epoca e non valide per un’epoca susseguente. Proviamo a paragonare i vestiti dell’epoca vittoriana coi nostri. Eppure allora ne andavano pazzi, come i contemporanei vanno ugualmente pazzi per i loro vestiti. Il dileggio generalmente colpisce addobbi, vestiti, espressioni d’arte, modi di comportarsi etc. Si tratta di cose esterne, ma proteggono verità e sostanze non sempre tali da esporsi al dileggio. – Stanno ad esempio perdendosi buone costumanze liturgiche, né proibite, né diffidate dalla recente legislazione e che avevano una immediata influenza indicativa e stimolante. Conopei e pallii vanno scomparendo, togliendo quella immediata presenza che rendeva anche gli indotti più consci e più vicini al culto del Signore. Si gareggia in spogliazioni e ci domandiamo a quali spogliazioni delle anime e della Fede esse possano condurre.
4. Il deperimento del canto e della musica è impressionante. L’uno e l’altra hanno una efficacia insostituibile nel tenere il popolo avvinto alla sua Chiesa. La diminuzione dei fedeli che partecipano alla Messa festiva la si può già benissimo registrare e non è il caso di dare tutta la colpa al turismo domenicale. La Fede deve pure essere sostenuta con quegli onesti mezzi che la millenaria tradizione ha esperimento ed indicato, anche se non sono mancate le esagerazioni e le deformazioni. La psicologia e la emotività dei fedeli non possono essere trascurate. Sì, si tratta di cose esterne, ma i grandi «contenuti» hanno bisogno, per secondare la natura dell’uomo, anche di sostegni ed incitamenti esterni.
Conclusione
Insomma alle parole vuote, ai termini evanescenti, di cui si compiacciono letteratura e moda, vanno opposti dei «contenuti». La Fede ha un «contenuto» essenziale, preciso, intoccabile: senza questo «contenuto» non resiste. – Bisogna che saggistica, letteratura, ricerca, stampa quotidiana e periodica — cattolici beninteso – ritornino ad avere l’impegno dei «contenuti» immutabili, sacri. – Bisogna che la predicazione ritorni «decisamente» ai «contenuti». Tutti parlano di giovani. Ebbene è ora di accorgersi che questi hanno fame e sete di verità, di sostanza, di speranza, anche se per ottenerli occorre la durezza e la austerità. Col diluire, coll’accomodare si ottiene in essi la precisa sensazione che vengono ingannati e fuggono. – Capiscono che il Cristianesimo non si ha senza Croce e, per quanto possa sembrare duro, essi lo vogliono come è. Non vogliono un Cristianesimo addomesticato ed imbastardito. La ragione principale per la quale la massa giovanile manifesta segni di antipatia religiosa, sta nel fatto che da un certo numero di anni, troppi untorelli hanno predicato un Cristianesimo, che tutti capiscono non essere né vero, né serio. – E ora di finirla. Che esisteva lo scandalo della Croce, lo abbiamo sempre saputo e ce lo aveva detto Dio; abbiamo voluto edulcorare lo scandalo e la gente non ci crede più. Ha proprio tutti i torti? Bisogna che i catechismi, di prossima redazione, obbediscano a questa suprema esigenza di completezza, di chiarezza, magari di durezza. Che non si facciano prendere la mano da pubblicazioni responsabili di avere sconvolto la autentica Fede. Non si segue il mondo; anche qui: si segue Gesù Cristo!
[Fine]