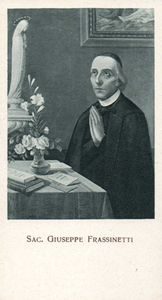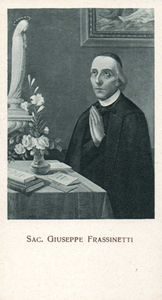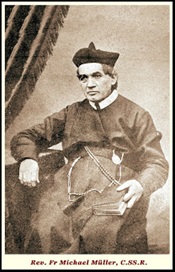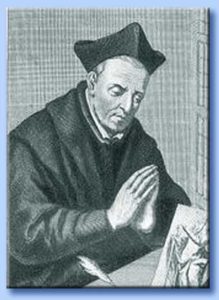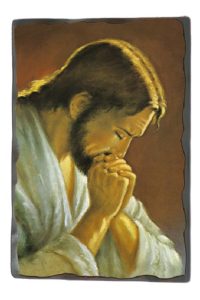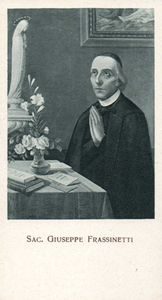
[Giuseppe Frassinetti, priore di S. Sabina di Genova:
Catechismo dogmatico
[Ed. Quinta, P. Piccadori, Parma, 1860]
CAP. VI
DELLE VIRTÙ’ TEOLOGALI.
§ I.
Nozione di queste Virtù in genere.
— Quante sono le Virtù Teologali?
⁕ Sono tre: Fede, Speranza e Carità.
— Perché si chiamano Teologali?
⁕ Perché Dio è l’oggetto di queste virtù. Con la Fede si crede Dio, e si crede a Dio. Con la Speranza, si spera Dio, cioè il suo possedimento in Paradiso, e si spera in Dio cioè nel suo aiuto. Con la Carità si ama Dio, e si ama anche il prossimo per Iddio, cioè per amor suo.
— Queste Virtù sono soprannaturali?
⁕ Sono soprannaturali, e vuol dire che, con lo nostre forze naturali, non le possiamo acquisire, ma Dio ce le infonde ricevendo noi l’acqua del Santo Battesimo.
— Vuol dire adunque che i fanciulli appena battezzati hanno queste Virtù? E dovremo anche asserire che tali fanciulli prima dell’uso della ragione credano, sperino ed amino?
⁕ È certo che i fanciulli appena battezzati hanno queste Virtù; però ne hanno gli abiti, e non le esercitano attualmente credendo, sperando, amando, perché ne sono impediti per mancanza dell’uso della ragione. Si dice che ne hanno gli abiti, i quali importano la pronta disposizione a credere, a sperare, ad amare attualmente per quel tempo in cui arriva il fanciullo all’uso della ragione. Vi delucido la cosa con un paragone. Un fanciullo cui sia morto il padre ricchissimo, mentre è sotto tutore, è ricchissimo veramente, per altro non può spendere, non può disporre delle proprie ricchezze fino al tempo opportuno. Similmente i fanciulli prima dell’uso della ragione hanno gli abiti delle Virtù Teologali, ma non possono per allora esercitarle.
— Con fare degli Atti di Fede, Speranza e Carità, queste Virtù crescono in noi?
⁕ Esercitando gli atti di qualunque virtù, crescono le virtù in noi e sempre maggiormente si perfezionano; perciò quanto più spesso faremo Atti di Fede, la nostra Fede diverrà sempre più viva; quanto più frequentemente ne faremo di Speranza, la nostra speranza si farà sempre più ferma, e quanto più moltiplicheremo Atti di Carità, ella si farà in noi sempre più ardente.
— Queste Virtù si possono perdere?
⁕ La Fede si perde col peccato dell’infedeltà, il quale si commette quando non si vuole credere, o avvertitamente si dubita di qualche verità che insegna la S. Chiesa; per esempio la perderebbe chi non volesse credere o volesse dubitare, che i Sacramenti siano sette. La Speranza si perde quando si dispera della divina Misericordia, come se alcuno credesse che Dio non gli voglia più perdonare i propri peccati. La Carità poi si perde per qualunque peccato mortale, e perciò perdendo la Fede o la Speranza, si perde sempre anche la Carità.
— Si possono riacquistare se perdute?
⁕ Si possono riacquistare pentendosi a dovere del peccato che le fece perdere.
— I Santi in Cielo hanno le Virtù Teologali?
⁕ Non resta ai Santi che la sola Carità; perché, come è cosa chiara, tutto ciò che credevano lo vedono in Dio; e le cose che sono oggetto di vista, non sono più oggetto di Fede. Ciò che speravano già possiedono, godendo Dio, e le cose già ottenute non sono più oggetto di speranza. La Fede adunque e la Speranza devono accompagnarci fino al Paradiso; ma non entrarvi con noi.
— Vi è obbligo di fare Atti di Fede, dì Speranza e di Carità?
⁕ Vi è obbligo espresso, e sì potrebbe provare con moltissimi argomenti delle divine Scritture e dei Santi Padri. L’errore contrario fu condannato da S. S. Alessandro VII: perciò questi Atti si facciano frequentemente e con distinta frequenza l’Atto di Carità.
§ II.
Della Virtù della Fede.
— Che cosa è la Virtù della Fede?
⁕ È una Virtù Teologale infusa da Dio nell’anima nostra con la quale crediamo fermamente, a motivo della Divina veracità, tutte le cose che Dio ha rivelato e, come tali, ce le propone la Chiesa da credere, (Habert de Fide).
— Perché si dice a motivo della Divina veracità?
⁕ Perché noi crediamo fermamente tutte le cose che ci sono proposte a credere dalla Santa Chiesa, per il motivo che Dio è infallibile verità e non può né ingannarsi, né ingannare; la certezza adunque della nostra Fede, si appoggia alla Divina Veracità.
— Perché si dice: tutte le cose che Dio ha rivelate?
⁕ Perché chi lasciasse di crederne una sola, sarebbe un infedele, e si fa uguale torto ad una infinita Verità dubitando della sua Veracità tanto in un punto, come in molti.
— Perchè si dice che: la Chiesa ce le propone da credere?
⁕ Perché Dio rivelò le verità immediatamente agli Scrittori inspirati come a Mosè, a Davide ecc. Similmente furono rivelate da Cristo agli Apostoli; ma ora non si devono pretendere rivelazioni particolari come le pretendono i Protestanti, volendo che lo Spirito Santo manifesti immediatamente al loro spirito privato, le verità che hanno da credere. Invece vi è la Chiesa Cattolica, la quale è la suprema maestra della verità e insegna infallibilmente ai suoi figli, tutte le verità che devono credere. Ella poi parla per mezzo dei Concili Universali e per mezzo delle definizioni dei Sommi Pontefici. A cagione di esempio insegnò per mezzo del Sacro Concìlio di Trento, che i Sacramenti sono sette, contro gli errori dei Protestanti. Insegnò che Cristo non è morto per i soli Eletti, per mezzo .delle definizioni dei Sommi Pontefici contro gli errori dei Giansenisti; e sarebbe ugualmente eretico chi dicesse i Sacramenti non essere sette; come chi dicesse che Gesù Cristo è morto in Croce per i soli predestinati (Vedi il Capit. dei Luoghi Teologici § 3).
— Quando è che ad alcuno si può dare il nome di eretico?
⁕ Quando pertinacemente asserisce qualche errore contrario a qualcuna verità della Fede. Si dice pertinacemente, perché quando alcuno asserisce un errore per ignoranza, anche colpevole, non si potrebbe chiamare eretico: p. es., trascurando alcuno d’istruirsi non sa che la Chiesa ha definito essere sette i Sacramenti; se dice che sono soltanto tre dice un’eresia; ma egli non è eretico, perché proferisce quell’eresia per ignoranza (Vedi Hubert ubi sup.).
— In che cosa differisce l’eresia dalla infedeltà?
⁕ L’infedeltà è la privazione, ossia mancanza della Fede, in chi non l’aveva ancora abbracciata; in tal modo gli idolatri, i Turchi, gli Ebrei sono infedeli; l’eresia, invece, è una mancanza dì Fede in chi l’aveva già abbracciata e fu battezzato, o almeno Catecumeno; inoltre è una mancanza di Fede parziale, cioè quando si lascia di credere uno o più dogmi, non tutti; perché se alcuno negasse tutti i dogmi della Fede, e rinunziasse perciò assolutamente alla Religione Cristiana, sarebbe il suo, peccato di apostasia; perciò un Cristiano che, lasciando di credere a Cristo e alla sua Chiesa, si fa Turco, non si dice eretico ma apostata. Questo s’intenda detto parlando con tutta la precisione delle Scuole; perché il nome d’infedeli si può dare anche agli eretici, in quanto che peccando contro la Fede, perdono questa virtù; e perciò il peccato di non credere o dubitare di qualche articolo di Fede, si chiama peccato d’infedeltà.
— Quante sorta si danno d’infedeltà propriamente presa?
⁕ Due sorte: negativa, e positiva. La negativa si trova in quelli i quali non credono, perché non hanno mai sentito e non poterono mai sentirsi annunziare le verità della Fede: e questa non è peccato. La positiva si trova in quelli che hanno sentito predicarsi le verità della Fede e non vogliono credere, o pure potevano sentirsele annunziare e hanno ricusato di darvi orecchio, e questo è peccato (Habert ut sup.).
— Gl’infedeli che non hanno mai sentito annunziarsi le verità della Fede e nemmeno si trovarono mai in opportunità di poterle ascoltare, si salveranno?
⁕ Senza Fede è impossibile che alcuno si salvi, dicendo S. Paolo che senza Fede è impossibile piacere a Dio (Hebr. XI). Per altro se questi infedeli osservassero la legge naturale, il Signore o per mezzi ordinari o straordinari, provvederebbe alla loro necessità facendoli anche istruire da un Angelo, quando altri non vi fosse, come dice San Tommaso, e abbiamo già notato. Peccando, questi infedeli, contro la legge naturale, si dannano per tali peccati, e non per il peccato d’infedeltà che in essi non è volontaria.
— Quante sorte si danno di Atti di Fede?
⁕ Due sorta: Interno ed Esterno.
— Come si definisce l’Atto di Fede interno?
⁕ Un fermo consenso che presta la nostra mente a credere le verità rivelate.
— Come si suddivide l’Atto interno di Fede?
⁕ In: implicito, ed esplicito. L’implicito si ha quando confusamente senza riguardare più a un dogma che a un altro, si crede tutto ciò che insegna la Santa Chiesa Cattolica: l’esplicito si ha quando espressamente si crede uno, o più determinati articoli di Fede. Se per esempio io dico: credo fermamente tutte le verità che insegna la Chiesa; oppure, non sapendo io ciò che il Sacrosanto Concilio di Trento ha definito circa la dottrina della giustificazione, io dico: In materia di giustificazione credo ciò che insegna la Chiesa, questi sono Atti di Fede impliciti. Se invece dico: credo che i Sacramenti sono sette; credo che senza la grazia di Dio, non si possano fare opere utili per la Vita Eterna, questi sono Atti di Fede espliciti.
— Basta per salvarsi la Fede implicita, il credere cioè tutto quello che insegna la Chiesa, senza sapere che cosa insegni?
⁕ Questa Fede non basterebbe; perché le principali verità della nostra Santa Religione bisogna crederle esplicitamente; cioè sapendole. Queste principali verità sono: che Dio è giusto, e perciò premia i buoni e castiga i cattivi; che Dio è uno e Trino, bisogna cioè sapere il mistero della Ss. Trinità: che la seconda Persona della Ss. Trinità, cioè il Figliuolo, si è fatta Uomo, ha patito ed è morta come Uomo per la nostra salute. Chi non crede espressamente queste verità non è capace di ricevere i Ss. Sacramenti, e non si può salvare. Bisogna pure credere espressamente tutte le altre verità che sono nel Simbolo Apostolico; per altro chi non le sapesse senza avervi colpa, cioè non avendole potute imparare, potrebbe salvarsi. Le prime dunque bisogna saperle di necessità di mezzo, le seconde di necessità di precetto. Tante altre verità definite dalla Santa Chiesa non è necessario che le sappiano tutti i Cristiani: ciascuno è obbligato ad istruirsi secondo il proprio stato e la propria capacità: pertanto essi frequentino le istruzioni; quindi sebbene non giungessero a sapere alcuni articoli di Fede distintamente, basterà che li credano implicitamente intendendo di credere tutto ciò che la S. Chiesa insegna. Si noti qui per incidenza, che oltre il Simbolo bisogna sapere il Pater noster, l’Ave Maria, i Comandamenti della Legge di Dio e della Chiesa, le cose necessarie per ricevere degnamente i Sacramenti, ai quali ci dobbiamo accostare, e i doveri del proprio stato particolare.
— Nel tempo della legge di natura; cioè, prima che Dio desse la legge scritta a Mosè e nel tempo di questa legge scritta fino alla venuta del Salvatore, quale Fede era necessaria agli uomini affinché potessero ottenere la vita eterna?
⁕ Oltre il credere che Dio castiga i cattivi e premia i buoni, era necessario che avessero una Fede implicita nel Salvatore del Mondo; che avessero cioè una qualche cognizione del Salvatore promesso (S. Tom. 2,2, q. 2 e 1, 2, q. 106). Perciò tutti i giusti dell’antico Testamento non solo si salvarono per i meriti di Gesù Cristo; ma si salvarono anche mediante la Fede in Cristo.
— Quando siamo obbligati a fare Atti di Fede interni?
⁕ Abbiamo già notato che li dobbiamo fare frequentemente e in modo particolare al principio dell’uso di ragione e nell’ora della morte. Vi fu chi disse che bastava fare un Atto di Fede solo in tutta la vita; ma questo sproposito fu condannato dal S. Pont. Innocenzo XI.
— Vorrei sapere se l’atto interno di Fede può stare col dubbio della verità delle cose credute?
⁕ Abbiamo detto nella definizione che la fede è una virtù con la quale crediamo fermamente; perciò essa non può stare col dubbio della verità delle cose credute. La fede esclude ogni dubbio, e inchiude la certezza che la cosa non possa essere diversamente (Bouvier de Fide, eap. 5, art. 2).
— Che cosa dunque si dovrà dire di quei Cattolici i quali ascoltando degli errori contro la fede, per. es., contro l’eternità delle pene dell’Inferno, contro il Purgatorio, contro la verginità di Maria Ss., contro il primato del Papa ecc.: essi non lasciano di protestarsi cattolici, ma frattanto pensano che i protestanti, i quali insegnano cotali errori probabilmente, o almeno possibilmente possano aver ragione?
⁕ Essi ammettendo questo dubbio, cioè la probabilità o anche la possibilità che la Chiesa erri insegnando le verità contrarie, perdono la fede, e protestandosi ancora di essere Cattolici si protestano di essere ciò che più non sono. Chi non crede fermamente, assolutamente, non crede con quella fede divina che è necessaria a salvarsi.
— Tuttavia il Cristiano Cattolico, potrà esaminare se sono realmente vere le cose che a lui insegna la Chiesa?
⁕ Se il Cristiano Cattolico esamina le verità insegnate dalla Chiesa per conoscere se sono realmente vere, e perciò dubitando che possano essere false, per ciò stesso dimostra che ha già perduto la fede; la quale in qualunque caso, da qualunque dubbio (avvertito e acconsentito) resta distrutta (Perrone de loc. theol. parte 3, sect. 1, cap. 3, prop. 1).
— Ma dunque si dovrà credere senza ragione e anche contro ragione, qualora si abbiano argomenti insolubili contro le cose che insegna la Chiesa?
⁕ Non v’ha dubbio che bisogna credere ad ogni modo; perché la fede divina, se cessa per qualunque motivo di essere ferma e inconcussa, resta distrutta. Per altro la fede divina non può mai essere né senza, né contro ragione; mentre che si appoggia all’autorità infallibile di Dio rivelante; e quando pare a noi che le cose insegnate dalla Santa Chiesa siano senza o contro ragione, ciò addiviene dalla nostra ignoranza e corto intendimento che non arriva a comprendere la verità del misteri divini: cosi all’uomo idiota appariscono senza e contro ragione molte verità fisiche e matematiche che sono evidenti al filosofo. Dobbiamo persuaderci che qualsivoglia argomento che noi troviamo contro le verità rivelate da Dio, per quanto ci sembri forte ed insolubile, non può essere che una falsa ragione ed un sofisma.
— E pure si esortano i protestanti e gli altri infedeli ad esaminare le verità che insegna la fede, perché si convincano delle medesime; se essi le possono esaminare, perché non le potremo esaminare anche noi?
⁕ Notate la diversità che passa tra costoro e noi Cattolici: essi non hanno ancora la fede divina, perciò col dubbio non la possono perdere: è necessario che studiando si convincano della verità, e si dispongano ad ottenere questo dono da Dio; noi per lo contrario l’abbiamo già; quindi mentre non la possiamo più acquistare, la perderemmo ammettendo il dubbio. Possiamo tuttavia esaminare la verità della fede per conoscere sempre meglio la loro ragionevolezza, e metterci al caso di persuaderne anche gli altri: questo esame però si deve fare credendo sempre fermamente senza ammettere mai ombra di dubbio (Perrone ubi supra).
— Perché dite che i protestanti non hanno fede divina? molte verità rivelate le credono quanto noi; perciò a riguardo di queste non hanno la fede che abbiamo noi?
⁕ La fede divina è un dono soprannaturale che non si può avere se non da quelli che sono membri della S. Chiesa; perciò i protestanti, che ne sono fuori sono privi di questo dono, e se credono alcune verità della fede, le credono con fede umana, cioè con quella convinzione che producono nel loro spirito le ragioni che militano in favore di quelle verità: noi per es. crediamo che Cristo sia il Salvatore, e che Platone fosse un filosofo: crediamo la prima di queste verità per una virtù, ossia forza soprannaturale che opera sul nostro spirito e c’inclina a crederla; crediamo la seconda per la forza degli argomenti che ci presenta la storia; quella perciò crediamo con fede divina, e questa crediamo con fede umana. I protestanti, che credono con noi ambedue queste verità, le credono ambedue per la forza che esercitano sul loro spirito le ragioni che militano per l’una e per l’altra, senza avere quell’aiuto soprannaturale che inclina noi Cattolici a credere la prima; perciò quando credono che Cristo è il Salvatore non lo credono con fede divina; ma con semplice fede umana.
— Quando si fa l’Atto di fede esterno?
⁕ Quando visibilmente, ossia sensibilmente, si manifesta la Fede interna. Se io dico che sono Cristiano, se mi prostro innanzi al Ss. Sacramento etc. , questi sono Atti di Fede esterni.
— È necessario fare Atti di Fede esterni?
⁕ Necessarissimo, e lo dice espressamente S. Paolo (ad Rom. X); perciò non basta aver la Fede nel cuore, ma bisogna manifestarla con le parole e con le opere.
— Ma qualora manifestando la nostra Fede, fossimo minacciati di qualche grave danno, non si potrebbe fingere di non essere Cristiani, oppure di rinunziare alla Fede ritenendola però nel cuore?
⁕ Questo sarebbe un gravissimo peccato e, piuttosto che fingere di non essere Cristiani o di rinunziare alla S. Fede, bisognerebbe soffrire qualunque morte come hanno fatto i Santi Martiri.
— Ma Dio, che vede il cuore, non si contenterà dell’ossequio del cuore, particolarmente quando non potessimo esternare la Fede senza gravissimo danno?
⁕ Dio padrone di tutto l’uomo, il quale consta di anima e di corpo, vuole a tutta ragione l’ossequio di tutto l’uomo, cioè interno e spirituale, od esterno e materiale. Il paliare poi e nascondere la nostra Fede per fare credere di esserne privi, o fingere di rinunziarvi è una somma viltà ed ingratitudine contro Dio che ci ha fatto questo dono. Egli fattosi Uomo sacrificò per noi la sua vita infinitamente preziosa, non sarà dovere che noi ci mostriamo pronti a sacrificar per l’onore suo anche la nostra vita che val sì poco? D’altronde se Egli permette che sia tentata la nostra fede, ci dà vigorosi aiuti affinché possiamo resistere ad ogni prova. Perciò con qualunque nostro più grave danno dovremmo, come fecero i ss. Martiri, esternare all’uopo la nostra fede.
— In teologia sono certe soltanto quelle cose che la Chiesa ha già definito e dichiarato di fede?
⁕ Il dire che siano soltanto certe quelle cose che la Chiesa ha già definito e dichiarato di fede sarebbe un gravissimo errore: il che facilmente si prova solo che si attenda alla definizione del dogma dell’Immacolata Concezione di Maria Ss. Infatti prima dell’8 Dicembre dell’anno 1854 questa verità non era un dogma definito e dichiarato di fede; tuttavia era una verità certissima, e tale che la Chiesa aveva fulminato la scomunica contro chiunque avesse ardito, non solo di negarla espressamente, ma anche contro chiunque avesse ardito addurre qualche obbiezione contraria a tale verità, senza confutarla con le opportune ragioni. – Dal non essere definita e dichiarata di fede una verità, non segue che essa si possa impunemente negare, o che almeno si debba riguardare come dubbia; ne segue soltanto, che chi non la crede o ne dubita, non è reo del peccato di eresia; per altro può essere reo di gravissima temerità: ciò poi avviene tutte le volte che la verità non ancora definita di fede, è creduta comunemente, e riconosciuta come certa dalla S. Chiesa. – Prima del Concilio di Trento non erano definite e dichiarate di fede certe verità che esso ha definito e dichiarato contro la novità dei protestanti; e pure quelle verità erano comunemente credute e riconosciute come certe dalla S. Chiesa; e sarebbe stata gravissima temerità il negarle o metterle in dubbio come fecero Lutero, Calvino ecc. Se per essere certa, una verità dovesse essere definita e dichiarata di fede, non sarebbe nemmeno certo che Cristo in terra camminasse coi piedi, non essendo mai stata questa cosa definita e dichiarata di fede. – Laonde chiaro apparisce quanto per un teologo sarebbe storto ed indegno modo di ragionare se argomentasse così: non è definito e dichiarato di fede che nell’inferno vi sia fuoco materiale, che il Diaconato sia Sacramento, che i contraenti siano ministri del matrimonio, che il Papa sia infallibile quando parla ex cathedra, e superiore al Concilio Generale; dunque tutte queste cose si possono negare, o sono dubbie: un teologo che ragionasse di questo modo, si farebbe troppo torto: mentre che, sebbene queste verità non siano dichiarate e definite di fede, sono comunemente credute e riconosciute come certe dalla S. Chiesa (Vedi i teologi, dove parlano di queste verità e dimostrano che sono proxime fidei).
§ III.
Della Virtù della Speranza.
— Che cosa è la Virtù della Speranza.
⁕ « È una Virtù Teologale per la quale con certa fiducia aspettiamo l’Eterna Beatitudine e i mezzi per conseguirla mediante il Divino aiuto, e dietro la promessa che Dio ce ne ha fatto a riguardo dei meriti di Gesù Cristo. »
— Perché si dice: con certa fiducia?
⁕ Perché la nostra speranza, essendo appoggiata agli infiniti meriti di Gesù Cristo e alla promessa che Egli ha fatto di darci il Paradiso in premio delle buone opere, e di darci gli aiuti opportuni per conseguirlo, é certa e sicura: quindi S. Paolo (Ad Hebr. VI) la appella un’àncora sicura e ferma.
— Vuol dire dunque che non possiamo temere di perderci?
⁕ Notate che si dice: certa fiducia e non sicura certezza: la fiducia di conseguire un bene suppone sempre il pericolo di perderlo; dalla parte di Dio la nostra speranza è certissima, perché da parte sua nulla ci può mancare di necessario alla salute, ma da parte nostra può mancare la necessaria corrispondenza alle sue grazie, e perciò non possiamo dire di essere certi che ci salveremo infallibilmente. Riguardando dunque la certezza della divina promessa da una parte, e la debolezza nostra dall’altra, la nostra speranza non può essere una certezza assoluta, ma solo una certa fiducia.
— In complesso ci dovremo più assicurare sulla certezza che vi ha dalla parte di Dio, o più temere del pericolo che porta la debolezza nostra?
⁕ Ci dobbiamo più assicurare sulla certezza che vi ha dalla parte di Dio, essendo che Dio è più buono di quello che noi possiamo essere cattivi; perciò dobbiamo più assicurarsi in Dio di quel che dobbiamo temere di noi.
— Può dunque stare insieme alla speranza del Paradiso il timore dell’Inferno? Bisogna distinguere varie specie di timore.
⁕ Altro è il timore detto figliale, col quale si teme l’inferno in quanto che si teme l’offesa di Dio, che sola può confinare le anime all’inferno, e si teme come cosa ingiuriosa ad una infinita Bontà; allora il timore non è il timore del proprio male in quanto è male proprio, ma è il timore dell’ingiuria dell’oggetto amato, cioè di Dio. Altro è il timore detto servile, col quale si teme l’inferno come male proprio, ma però senza avere affezione al peccato che fa meritare l’inferno. Altro è il timore detto servilmente servile col quale si teme l’inferno come male proprio avendo affezione al peccato, sicché non dispiace il peccato, ma dispiace l’inferno, e in certo modo si vorrebbe che non vi fosse inferno per poter peccare senza timore. Il primo timore è santissimo come chiaramente si vede; il secondo anche è buono, come definì il Sacrosanto Concilio di Trento contro gli eretici (sess. VI, c. 8). Perciò tanto il primo quanto il secondo sta benissimo con la speranza Cristiana: il terzo poi è il timore degli empi, indegnissimo del Cristiano.
— Il servire a Dio con la speranza del premio non è un servizio interessato e difettoso?
⁕ Così la pensarono alcuni falsi mistici moderni, gli errori dei quali furono condannati dai Sommi Pontefici. Lo Spirito Santo, nelle Divine Scritture, vuole che speriamo il Paradiso: e questa speranza animava i più grandi Santi a far gran cose per Iddio; e perciò quando serviamo il Signore, sperando che ricompenserà il nostro servizio col premio eterno, non commettiamo già alcun difetto, ma esercitiamo la necessarissima virtù della Speranza. Si noti che il Concilio di Trento scomunicò chi dicesse, peccare i giusti quando fanno opere buone per guadagnare l’eterna mercede (Sess. VI, c. 31).
— Dunque si potrà dire che pecchino i peccatori quando fanno opere buone per guadagnarsi questa mercede?
⁕ Se i peccatori facessero opere buone per guadagnarsi il Paradiso, avendo intenzione di non convertirsi a Dio, peccherebbero certamente; perché non volendo lasciare il peccato, è pessima presunzione fare conto di salvarsi; ma se i peccatori fanno opere buone per ottenere misericordia da Dio, riconciliarsi con Lui e quindi salvarsi, operano santamente: anzi è questo che Dio loro comanda e che essi devono fare.
— Il Paradiso lo dobbiamo sperare soltanto come nostro bene?
⁕ Tutto il nostro bene lo dobbiamo riferire a Dio, e perciò la nostra beatitudine in Paradiso la dobbiamo sperare e procurare, perché ridondi all’eterna gloria di Dio. In una parola dobbiamo cercare di farci Santi perché Dio sia glorificato dalla nostra santità. Ciò si ricava dal sacrosanto Concilio di Trento (Sess. VI, cap. III).
— Disse poco avanti che la nostra speranza è appoggiata agl’infiniti meriti di Gesù Cristo, come s’intende tal cosa?
⁕ Gesù Cristo è il nostro Salvatore, Egli ha offerto per noi i meriti infiniti della sua Incarnazione, Passione e Morte, e pel valore di tali meriti siamo stati resi capaci di meritarci il Paradiso.
— Aggiunse che si appoggia alla promessa che ha fatto Dio di dare il Paradiso per premio alle nostre buone opere: come s’intende?
⁕ Abbiamo veduto nel § 3 del Cap. 5 che noi non potremmo meritare il Paradiso senza di questa promessa; per ciò a lei ogni nostra speranza si appoggia: questa divina promessa è il motivo per cui speriamo il Paradiso.
— Esercitandoci in Atti di Speranza, dovremo avere intenzione di fare buone opere?
⁕ Senza questa intenzione, la nostra speranza si cambierebbe in presunzione; perché al merito delle buone opere è promesso il Paradiso, e solo possiamo sperare con fondamento di salvarci, avendo intenzione di far quel bene che si richiede per ottenere l’eterna salute.
§ IV.
Della Virtù della Carità.
— Che cosa è la Virtù della Carità?
⁕ « È una Virtù Teologale infusa da Dio nell’anima nostra, con la quale amiamo Dio sopra tutte le cose, perché è un bene infinito, e amiamo il prossimo per amore di Dio ».
— Come s’intende: che lo amiamo perchè è un bene Infinito?
⁕ Dio si deve amare per la sua infinita Bontà. Ciascuna cosa si ama in ragione della bontà che contiene, perciò si ama perché è buona, e tanto più si ama quanto è più buona. Similmente amiamo Dio perché è buono, e lo amiamo sopra tutte le cose, perché non vi è bontà alcuna da potersi paragonare con la sua.
— In quanti modi si può amare Iddio sopra tutte le cose?
⁕ In due modi, appreziativamente e intensamente. Dio si ama sopra tutte le cose appreziativamente quando la volontà è così stretta a Dio, che è pronta a soffrire qualunque cosa, piuttosto che offenderlo con qualche peccato mortale; si ama intensamente sopra tutte le cose quando alla fermezza e attaccamento della volontà, si unisce un vivo trasporto e un ardentissimo affetto, sicché nessuna cosa fa tale impressione ai sentimenti del nostro cuore quanto il piacere o il dispiacere di Dio.
— In quali di questi due modi siamo obbligati ad amar Dio?
⁕ Nel primo modo, cioè appreziativamento; e chi fosse privo di questo amore non si potrebbe salvare.
— Questo amore appreziativo ci obbliga solo ad astenerci dal peccato mortale?
⁕ L’amore appreziativo ci obbliga a preferire Dio e il suo gusto ad ogni cosa, e perciò ad astenerci anche dal peccato veniale; per altro, giacché il peccato veniale non estingue in noi la carità, qualora l’amore appreziativo non arrivasse a farci evitare il peccato veniale, basterebbe perché fossimo salvi.
— Per qual motivo non siamo obbligati ad amare Iddio intensamente sopra tutte le cose?
⁕ Perché questo amore intenso non è in nostro potere, esso è un dono straordinario di Dio, prezioso e desiderabile sommamente. Le anime più pure, ordinariamente parlando, lo possiedono anche in questa vita; però nemmeno esse hanno la pienezza dell’intensità dell’amore Divino, essendo questa pienezza, riserbata ai Santi in Cielo.
— Come può essere che un’anima preferisca Dio e il suo gusto ad ogni cosa, e frattanto qualche altra cosa faccia maggiore impressione nei sentimenti del suo cuore?
⁕ L’atto di dare la preferenza ad una cosa sopra tutte le altre è un atto della volontà la quale è libera, il sentire più l’impressione di una cosa che di un’altra appartiene alla sensibilità la quale in noi non è libera, ma necessaria: posso a cagione di esempio determinarmi a preferire il cibo amaro al dolce, ma non posso impedire di sentir l’amarezza mangiandolo. Proviene da questa sensibilità che le madri anche pie sentono un’allegrezza più viva nel vedere ristabiliti in salute i propri figli dopo una pericolosa malattia, che dal vederli pentiti di qualche loro peccato, e pure la loro volontà preferisce di vederli infermi piuttosto che peccatori.
— Quando si preferisce Dio ad ogni cosa perché è un bene infinito, e si vorrebbe perdere qualunque cosa piuttosto che offenderlo gravemente, si ha allora il perfetto amore di Dio?
⁕ É certo che allora si possiede il perfetto amore di Dio, perfetto nella sua natura, il quale però si potrebbe sempre più perfezionare, come chiaramente si vede, in chi fosse pronto a perdere qualunque cosa, piuttosto che offenderlo anche con un peccato veniale.
— L’amore, ossia la Carità perfetta, può stare in un’anima insieme col peccato mortale?
⁕ Baio insegnava che la carità perfetta poteva trovarsi insieme in un’anima col peccato mortale: ma la Chiesa condannò tale dottrina; perciò è certissimo che non si può trovare in alcun’anima il perfetto amor di Dio insieme col peccato mortale, come non si può trovar in una stanza la luce, con le tenebre (Propos. di Baio 32 e 70).
— Ma dandosi il caso che una persona rea di qualche peccato mortale facesse un atto di perfetto amor di Dio, non si avvererebbe il caso di trovare in un’anima il peccato mortale, e il perfetto amor di Dio?
⁕ Non si avvererebbe giammai; perché quell’atto dì perfetto amor di Dio, scaccerebbe subito il peccato mortale, come portata la fiaccola in una camera oscura ne scaccia subito le tenebre.
— Ma per levare il peccato dall’anima, non si richiede la Confessione Sacramentale?
⁕ Si richiede la Confessione Sacramentale, o in effetto o in proponimento. Si richiede in effetto quando vi è la sola attrizione, e in tal caso, per scacciare il peccato mortale dall’anima, bisogna che il Cristiano si confessi, e prenda la Sacramentale Assoluzione. Quando poi vi è la carità perfetta basta il proponimento di confessarsi a tempo debito. Chi ha la Carità, ossia il perfetto amor di Dio, ha pure implicitamente la contrizione, cioè il dolore di avere offeso Dio, essendo impossibile che alcuno ami Iddio sopra ogni cosa e non abborrisca sopra ogni cosa il peccato: ha insieme l’intenzione di confessarsi a tempo debito; perché è parimente cosa impossibile che alcuno ami Iddio sopra ogni cosa, e non abbia intenzione di ubbidire ai suoi comandi; perciò se un peccatore fa un atto di perfetto amor di Dio, resta subito giustificato. È per altro obbligato a confessare i peccati mortali a tempo debito; cioè quando dovrà adempire al precetto della Confessione, oppure quando si confesserà anche fuori del tempo del precetto, come chiaramente s’intende.
— Non si potrebbe dire che il perfetto amore di Dio giustifichi l’anima soltanto nel caso di necessità, come sarebbe in punto di morte, quando non si potesse avere Confessore?
⁕ Chi dicesse questo, verrebbe a dire che molte volte potrebbe stare insieme la carità perfetta col peccato mortale, e asserirebbe precisamente la condannata proposizione di Baio (La proposizione condannata in Bajo [70] è la seguente: L’uomo che si trova a vivere in peccato mortale o in un reato degno di eterna dannazione, può avere la vera carità; ed anche la carità perfetta può sussistere con il reato di eterna dannazione – Bolla: “Ex omnibus affliclionibus”, S. Pio V, 1568). Se la Carità è perfetta, quando cioè si ama Dio sopra ogni cosa perché è un bene infinito, toglie tosto dall’anima il peccato mortale.
— Chi fosse restato giustificato da qualche atto di perfetto amor di Dio, e perciò avesse allora intenzione di confessarsi a tempo debito, se poi mutasse intenzione e risolvesse di non confessarsi più; i peccati mortali cancellati dall’atto di amor di Dio ritornerebbero a macchiare l’anima sua?
⁕ Ella è verità certissima, che i peccati una volta cancellati non possono più ritornare a macchiare l’anima: se ne possono commettere degli altri simili, ma quelli non tornano più. Prendete questa parità: vi cade il fazzoletto nel fango, ed eccolo macchiato e lordo, voi lo diguazzate in un torrente, e l’acqua porta via quelle macchie e lordura; quelle macchie, quella lordura è dissipata, va giù col torrente, è impossibile che torni a macchiare il fazzoletto; lo potrete macchiar di nuovo lasciandolo cadere di nuovo nel fango. Notate però che con quella cattiva intenzione di non confessarsi più, commetterebbe un nuovo peccato mortale, e perderebbe subito l’amor di Dio, e la sua grazia.
— Se il perfetto amor di Dio ha tanta efficacia di rimettere l’anima in istato di grazia anche fuori del caso di necessità, chi è in peccato mortale non dovrà prendersi gran premura di confessare presto il peccato; ma basterà che faccia qualche atto di amor di Dio, e di contrizione.
⁕ Guardatevi dal tirare una simile conseguenza ché essa è falsissima. Non tutti quelli che fanno atti di amor di Dio e di contrizione, li fanno con quella perfezione che si richiede, affinché tolgano il peccato dall’anima; perciò molti potrebbero credere di restare giustificati e frattanto resterebbero in peccato mortale; inoltre, ancorché l’atto di amor di Dio e di contrizione fosse perfetto, questo non conferirebbe la grazia Sacramentale, la quale si dà solo nel Sacramento della Penitenza quando si prende l’assoluzione dei peccati; e quindi l’anima resterebbe priva del grande aiuto di questa grazia, di cui si parlerà nel cap. 7, § 1, D. 15. Perciò chi è caduto in peccato mortale, faccia subito degli atti di contrizione, giacché facendone uno perfettamente si rimette subito in grazia di Dio; ma poi senza aspettare l’obbligo dell’annua Confessione, e nemmeno il suo comodo, quanto più presto può, vada a confessarsi per provvedere nel miglior modo all’anima sua in cosa di tanta importanza. Questa dottrina dell’efficacia e valore della contrizione si deve insegnare perché è la dottrina della Chiesa, e perché ciascuno deve conoscere il valore della virtù della Carità e dei suoi atti; ma da questa dottrina nessuno deve prendere motivo di differire la Confessione dopo commesso il peccato mortale. Per gran contrizione che senta nel suo cuore il peccatore, subito che può, anche con suo incomodo, non differisca un momento di confessarsi.
— Come si deve amare il prossimo?
⁕ Si deve amare come noi stessi ci amiamo, e per amore di Dio; in tal modo l’amore del prossimo si rifonde nell’amore di Dio, in quanto che il prossimo si ama a riguardo di Dio, e per l’amore che si porta a Dio.
— Chi ama il suo prossimo perché o di buona indole, perché è dotto, ricco, suo benefattore, suo amico, suo parente, lo ama con amore di carità?
⁕ Chi lo ama solo per questi titoli e ragioni, lo ama con un amore naturale, il quale si trova anche negl’infedeli, e perciò non lo ama con amore soprannaturale come è l’amore di carità; bisogna adunque a tutti questi motivi aggiungere il motivo dell’amore di Dio, e perché Iddio lo vuole.
— Tutti assolutamente dobbiamo amare i nostri prossimi, e senza distinzione?
⁕ Tutti assolutamente dobbiamo amare i nostri prossimi, amici o nemici, buoni o cattivi, fedeli o infedeli; però vi deve essere distinzione nel nostro amore, dovendosi preferire gli amici, i parenti, i benefattori, i fedeli ecc., a quelli che non sono tali: cosicché p. es., se si dovessero vestire due poveri, uno parente e l’altro no, e vi fosse una veste sola, si dovrebbe dare al parente.
— Non basta per amare il prossimo, fargli del bene senza amarlo frattanto di cuore?
⁕ Non basta, e il Papa Innocenzo XI proibì due proposizioni le quali dicevano che non siamo tenuti ad amare il prossimo con atto interno e formale, e che possiamo soddisfare al precetto con soli atti esterni. Perciò è necessario amare il prossimo con affetto di cuore, e quindi fargli ciò che ragionevolmente vorremmo per noi, e non fargli ciò che ragionevolmente non vorremmo per noi.
— Siamo obbligati a fare Atti di Carità come di Fede, e di Speranza?
⁕Vi siamo obbligati, e concordano i Teologi che vi siamo obbligati anche con maggiore frequenza.
— Il precetto della Carità ci obbliga a riferire alla gloria, al servizio di Dio tutte lo nostre azioni?
⁕ Certamente ci obbliga a riferire alla gloria di Dio, al suo servizio tutte le nostre azioni anche indifferenti, come sarebbe il mangiare, il dormire, opportuni passatempi e ricreazioni ecc.
— Sarà dunque necessario in ogni azione che si fa il dire espressamente, intendo farla per la gloria di Dio?
⁕ Questo poi no: basta il rinnovare di tempo in tempo questa intenzione di fare tutte le nostre azioni a gloria di Dio.