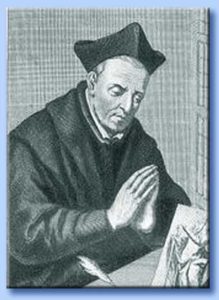PREGHIERE ED INDULGENZE APOCRIFE
I nemici della Chiesa di Cristo, di Dio e di tutti gli uomini, hanno da sempre tentato con tutti i mezzi di nuocere alla Sposa di Cristo ed ai suoi fedeli, cercando di corromperne l’anima e condurla là … ove è pianto e stridor di denti. Una delle armi più insidiose ed occulte, è quella di usare false preghiere ed indulgenze apocrife ed indurre i Cristiani alla superstizione, al sacrilegio, al peccato contro la fede, la carità, ed ovviamente alla presunzione di salvarsi senza meriti [peccato contro lo Spirito Santo!]. La Chiesa Cattolica ovviamente ha cercato di allertare i fedeli già in varie occasioni, nel passato. Qui di seguito, a mo’ di esempio, riportiamo alcuni decreti contenuti in Atti Apostolici, ove vengono condannate come apocrife una serie di preghiere anche abbastanza note e “praticate”. Ne diamo qualche esempio:
In Acta Sanctæ Sedis n. 31 (1898-1899) a pagina 127 leggiamo:
DECRETUM URBIS ET ORBIS, quo revocantur indulgentiæ omnes mille vel plurium millium annorum. [decreto che revoca le indulgenze di mille e più anni]
“Quum huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositae ex ipsa sui institutione munus demandatum sit vigilandi, ne in christiano populo falsae et apocryphæ, veliam revocatae a RR. PP. Indulgentiæ temere evulgentur, pluries ab ea quæsitum est, num Indulgentiæ mille sive etiam plurium millium annorum, quae in nonnullis Summariis et etiam in Pontificiis Constitutionibus leguntur, sint retinendæ uti veræ, an potius inter apocryphas amandandæ, ea potissimum de causa quod immoderatæ viderentur. Porro quum hæc S. C. generatim animadverterit prædictarum Indulgentiarum concessionem, ut plurimum, nulli aut suppositivo niti fundamento, prætereaque perpenderit id quod Sacrosancta Tridentina Synodus Sess. 25, cap. XXI Decret, de Indulg. docuit, in concedendis nimirum Indulgentiis moderationem esse adhibendam, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur; opportunum esse censuit, sicut alias peragere consuevit, ut Indulgentiae omnes, quæ mille vel plurium millium annorum numerum attingunt, prætermisso an veris sint accensendæ vel apocryphis, revocarentur et abrogarentur: id enim postulare videbantur et mutata temporum adiuncta, et modo vigens in Ecclesia disciplina. Emi itaque Patres huic S. Congregationi praepositi, in generalibus Comitiis ad Vaticanum habitis die 5 Maii 1898, omnibus mature perpensis, unanimi suffragio rescripserunt: Indulgentias omnes mille vel plurium millium annorum omnino esse revocandas si SS.mo placuerit. [Sono assolutamente da revocare le indulgenze di mille o più anni].
Facta autem de his omnibus relatione SS.mo D.no Nostro Leoni Papæ XIII in Audientia habita die 26 Maii 1898 ab infrascripto Card. Præfecto, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum sententiam ratam habuit et confirmavit, mandavitque per generale Decretum declarari omnes Indulgentias mille vel plurium millium annorum, quae hucusque concessae dicuntur aut sunt, revocatas esse, et uti revocatas ab omnibus habendas.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
L’anno successivo segue questo decreto:
In Acta Sanctae Sedis n. 31 (1898-1899) a pagina 727, si legge in questo Decreto:
A questa Sacra Congregazione, preposta alle Sacre Indulgenze e alle reliquie, sono pervenuti dei fogli che riportano preghiere con annesse indulgenze alle medesime attribuite, e sulla cui autenticità sono portati gravi dubbi. Pertanto questa Sacra Congregazione, affinché i fedeli non vengano tratti in errore, specialmente in questi tempi in cui tutti i nemici della Chiesa cercano ogni pretesto per irridere il tesoro inestimabile delle Indulgenze, che piamente, santamente, e incorrottamente si amministra, come da suo dovere ha avocato a se l’esame di questi fogli, e verificare e dichiarare qualora si trovi in essi promulgazione di indulgenze false, apocrife, e del tutto confuse, la diffusione di questi fogli sia del tutto proibita e le asserite indulgenze dichiarate apocrife e false. – Per qual motivo gli Em.mi Padri, riuniti in Vaticano il 5 maggio 1898 in Congregazione Generale, dopo matura riflessione, con unanime votazione hanno sottoscritto: i predetti fogli presentati a questa Sacra Congregazione sono da vietare e, come detto, le annesse indulgenze essere dichiarate apocrife e false.
Fatta di questo relazione presso il S. Padre Leone XIII nell’udienza del 26 maggio 1898, dal sottoscritto Cardinale Prefetto, sua Santità ha approvato e confermato e dato il mandato di preparare un decreto generale, nel quale venga stabilito che il contenuto dei fogli annessi, o che si trovi espresso in edizioni diverse sia proscritto e che le indulgenze riportate in essi siano condannate come false e apocrife. Seguono i “foglietti” con le preghiere ed indulgenze apocrife riportare:
Foliolum I
– Litanie della Beata Vergine Addolorata
composte dal Sommo Ponteficp Pio VII il quale accordò indulgenza plenaria nei venerdì dell’ anno a chi contrito le reciterà col Credo, colla Salve Regina e con tre Ave al Cuore addolorato di Maria SS.ma.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.
Pater de Coelis Deus, miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, … ora pro nobis,
Sancta Dei Genitrix, …
Sancta Virgo Virginum, …
Mater crucifixa,
Mater dolorosa,
Mater lacrymosa,
Mater afflicta,
Mater derelicta,
Mater desolata,
Mater filio orbata,
Mater gladio trans verberata,
Mater aerumnis confecta,
Mater angustiis repleta,
Mater cruci corde affixa,
Mater mœstissima,
Fons lacrymarum,
Cumulus passionum,
Speculum patientiæ,
Rupes constantiæ,
Anchora confidentiae, ora pro nobis.
Refugium derelictorum, ora …
Clypeus oppressorum, ora …
Debellatrix incredulorum, ora …
Solatium miserorum, ora …
Medicina languentium, ora …
Fortitudo debilium, ora …
Portus naufragantium, ora …
Sedatio procellarum, ora …
Recursus moerentium, ora …
Terror insidiantium, ora …
Thesaurus fidelium, ora …
Oculus Prophetarum, ora …
Baculus Apostolorum, ora …
Corona Martyrum, ora …
Lumen Confessorum, ora …
Margarita Virginum, ora …
Consolatio Viduarum, ora …
Laetitia Sanctorum omnium, ora …
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Respice super nos, libera nos, salva nos ab omnibus angustiis in virtute Iesu Christi. Amen.
Scribe, Domina, vulnera tua in corde meo, ut in eis legam dolorem et amorem: dolorem ad sustinendum pro Te omnem dolorem; amorem ad contemnendum pro Te omnem amorem. Laus Deo ac Deiparæ.
Ora pro nobis Virgo dolorosissima!
R). Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
Interveniat pro nobis, quæsumus, Domine Iesu Christe, nunc et in hora mortis nostrae apud tuam clementiam Beata Virgo Maria Mater tua, cuius sacratissimam animam in hora tuae passionis, doloris gladius pertransivit. Per te, Iesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.
– Salutazione a Maria SS. Addolorata
Dai Sommi Pontefici arricchita dell’ indulgenza plenaria lucrabile in ogni venerdì dell’anno da quei fedeli che confessati e comunicati la reciteranno divotamente.
Ave Maria doloribus plena, Crucifixus tecum, lacrimabilis tu in mulieribus et lacrimabilis fructus ventris tui Iesus. — Sancta Maria, mater Crucifixi lacrimas impertire nobis crucifixoribus Filii tui, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Con approvazione ecclesiastica.
Torino, 1865 — Tip. dell’Oratorio di S. Francesco di Sales.
Foliolum II
La “Corona di Spine”
LA CORONA DI SPINE.
La corona di spine spiega la vita, passione e morte di N. S. Gesù Cristo, cioè dalla sua nascita fino alla morte.
1. Ogni grano di questa corona ha la somiglianza di una testa di bestia, e rappresenta come Gesù nacque tra il bue e l’asinello.
2. Questa corona somiglia alla corona di spine con cui fu incoronato Gesù Cristo.
3. Coloro che avranno questa corona in casa sopra un Crocifisso od un quadro e reciteranno per 33 giorni cinque Pater, Ave e Gloria all’incarnazione, passione e morte di N. S. Gesù Cristo, verrà deliberata un’anima dalle pene del purgatorio della propria famiglia e questa prega per il divoto che recita questa orazione.
Queste corone sono spedite e benedette dai PP. Crociferi del Belgio e autorizzati dal S. P. Leone XIII.
Chi reciterà divotamente questa orazione acquisterà 500 giorni d’Indulgenza oltre aver liberato un’ anima dal purgatorio.
Roma — Tipografia Pontificia, 1894.
Foliolum III
L’Orazione alla Piaga della Spalla
RIVELAZIONE
Fatta a S. Bernardo Abbate di Chiaravalle dell’incognita e dolorosa piaga della spalla di Nostro Signore Gesù Cristo da lui sofferta nel portar la pesante Croce.
Domandando una volta S. Bernardo a Nostro Signore nell’orazione, qual sia stata la sua maggior doglia occulta, sentita nel corso della sua Santissima Passione, rispose il Signore: Io ebbi una piaga sulla spalla profonda tre dita, fattami nel portare la Croce; questa mi è stata di maggior pena e dolore di tutte le altre, quale dagli uomini è poco considerata perchè è incognita. Ma tu abbila in venerazione, e sappi che qualunque grazia mi chiederai in virtù di detta Piaga mi onoreranno, gli perdonerò i loro peccati quotidiani, de’ mortali non mi ricorderò più e conseguiranno la vita eterna, cioè la mia grazia e misericordia.
Eugenio III ad istanza di S. Bernardo ha concesso, a chiunque dirà tre Pater noster, e tre Ave Maria, in onore della suddetta Piaga come è stato a S. Bernardo rivelato, tre mila anni d’Indulgenza.
ORAZIONE DA DIRSI ALLA PIAGA DELLA SPALLA DI NOSTRO SIGNORE.
Dilettissimo Signore Gesù Cristo, mansuetissimo Agnello di Dio, io povero peccatore, adoro e venero la Santissima vostra Piaga che riceveste sulla spalla nel portare la pesante Croce al Calvario, nella quale restarono scoperte tre Sagratissime Ossa, tollerando in essa un immenso dolore ; Vi supplico pertanto per virtù e meriti di detta Piaga ad aver di me misericordia col perdonarmi tutti i miei peccati sì mortali che veniali, e ad assistermi nell’ora della mia morte, e di condurmi nel vostro Regno beato. Amen.
Sia sempre benedetto, e ringraziato Gesù Cristo che col suo preziosissimo Sangue ci ha salvato.
Oremus.
Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Leonem quem pastorem Ecclesiae tuae præesse voluisti, propitius respice: da ei quæsumus, verbo et exemplo, quibus præest proficere: ut ad vitam una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Dominum.
Sono pregati di un’Ave Maria per chi dispensa gratis il presente foglio.
Roma — Tipografia della Pace di F. Cuggiani.
(Vide Decr. Auth. n. 18).
Foliolum IV
La Corona “dei Meriti e della Passione di N.S. Gesù Cristo” (Spagnolo)
Imprenta de la Viuda é Hijo de Muñoz Plaza de la Merced.
CORONA DE LOS MERECIMIENTOS DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESU CRISTO.
(con licencia)
Ciudad-Real—1868
Imprenta de la Viuda é Hijo de Muñoz Plaza de la Merced.
CORONA DE LOS MERECIMIENTOS DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESU CRISTO.
Memoria de los merecimientos de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo concedida por Nuestro SSmo Padre Pio V al Duque de Herencia y á su hijo el Principe de Sirena, el cual, yendo á visitar á nuestra Señora de Loreto, fué á besar los pies á su Santidad, y le dijo que le pidiese lo que quisiera, y el dicho Principe le suplicó que para salud de las almas concediese algunas indulgencias, para lo cual mandó su Santidad viniesen todos los Cardenales al Consistorio y Congregación y que rogasen á nuestro Señor fuese servido illuminar su intendimiento y les inspirase las gracias que su Santidad iba á conceder al Principe para que fuere en provecho de las almas: y estando todos juntos dijeron que concediese un Paternoster y diez Ave Marias que se llamará corona de los merecimientos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y que tuviese las gracias é indulgencias siguientes.
1a. Concede su Santidad à las personas que tubieren esta corona y la rezaren con devoción, rogando á Dios que conceda estas gracias, indulgencia plenaria y remisión de sus pecados.
2a. Todas las personas que rezaren la corona con contrición de sus culpas y pecados ganan indulgencias plenaria y remission de sus pecados culpa y pena, aunque la recen mil veces al dia.
3a. Que á totas las personas y en todas las veces que tuviesen la Corona en la manos diciendo : Dios y Señor mio Jesucristo, por los merecimientos de vuestra pasión santísima tened piedad y misericordia de mi : le serán perdonados sus pecados.
4a. Que todas las veces, que rezaren por modo de sufragio por las ánimas del Purgatorio, se sacan tantas almas como veces les rezaren y también indulgencia plenaria.
5a. Concede su Santidad á las personas que oyeren misa y rezaren dicha corona por cada vez cuatro mil años de perdón.
6a. También las veces que la rezaren por el Pontífice que las concedió, le serán perdonados sus pecados.
7a. Que el que tuviere esta corona en sus manos en el articulo de la muerte vaya absuelto de culpa y pena como el dia que fué bautizado.
8a . Concede su Santidad al dicho principe que pueda dar la corona á veinte personas : las veinte cada una á siete y cada una de estas siete á otras siete y así de mano en mano para que se comunique á todos los fieles.
9a. Que si perdiese la dicha corona, puede elegirse otra en su lugar que tenga las mismas gracias é indulgencias y esto sea una vez tan sola.
10a. Que para ganar estas indulgencias y gracias han de tener la bula de la Santa Cruzada y un tratado de estas indulgencias.
11a . Asi mismo, su Santidad de su propria voluntad y en presencia de sus hermanos los Cardenales dio la Corona al Duque diciéndole: La daréis á los que os la pidan y unos á otros poseídos del amor de Dios delante de un Crucifijo é incados de rodillas.
12a. El orden que se ha da tener para dar dicha corona ha ser, el que la pida esté incado de rodillas, como se dijo en el articulo anterior, y ha de decir : u Hermano, yo os ruego por amor de Dios que me deis la corona de los merecimientos de nuestro Señor Jesucristo, para que yo gane las gracias á indulgencias que su Santidad me concede por ella „. El que la dá poniéndola en las manos dirá : “Hermano yo os la entrego en memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo con la gracias á mi concedidas: la podréis dar á siete personas y encargo la deis de limosna en reverencia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y rogueis por las almas del Purgatorio Amen „.
Foliolum V
Le parole dette da Maria SS. Addolorata, quando ricevette il Corpo esamine nelle braccia (oggi conosciuta come “Sentimenti di Maria SS. Addolorata …”)
O fonte inesausto di verità come ti sei disseccato! O saggio Dottor degli uomini, come te ne stai taciturno! O splendore di eterna luce, come mai la tua bella faccia è divenuta deforme! O altissima divinità come ti fai vedere a me in tanta povertà! O amor del cuore, quanto grande è la tua bontà! O delizia eterna del mio cuore quanto eccessivi e molteplici sono stati i tuoi dolori! Signor mio Gesù Cristo che hai comune col Padre, e collo Spirito Santo, una sola e medesima natura, abbi pietà di ogni creatura e principalmente delle anime Sante del Purgatorio. Così sia. Cinque Credi, una Salve Regina, un Pater Ave e Gloria, secondo l’Intenzione del Sommo Pontefice ed un Requiem.
Questa divozione, che si trovò in una Cappella di Polonia sopra una tabella, è stata approvata da Innocenzo XI, il quale concesse la liberazione di 15 anime dal Purgatorio, ogni volta che si reciterà. Lo stesso fu confermato da Clemente III.
La stessa liberazione di 15 anime del Purgatorio, ogni volta che si reciterà questa orazione, fu confermata da Benedetto XIV con Indulgenza Plenaria. La stessa concessione fu confermata da Pio IX con l’aggiunta di Cento altri giorni d’indulgenza.
S’implori una prece per chi dispensa l’orazione.
Montefortino 1893 — Tip. Marinozzi.
Foliolum VI
Gesù di Nazaret Re dei Giudei (Francese)
JÉSUS DE NAZARETH, ROI DES JUIFS, RÉDEMPTEUR
SOUFFRANT, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
Extrait de la vie du bienheureux frère Innocent à Clusa frère Minime Recollet, singulier en vertus et en miracles, décédé à Rome le 15 décembre 1631.
Dans sa vie (premièrement imprimé en italien) dédiée an pape Innocent XI, trouvons-nous cette histoire singulière: Le saint homme parlant un jour avec certain prince et quelques théologiens, disait qu’à notre Sauveur Jésus Christ, allant au mont Calvaire chargé de sa Croix, étaient sortis de l’épine du dos trois Os ou Côtes qui avaient percé les articulations de sa chair. Le prince ainsi que tous les autres ne voulaient y ajouter foi, parce que, d’après eux, ni l’Ecriture sainte ni aucune Révélation n’en faisaient mention, et que cette opinion n’était pas admise par notre Mère la Sainte Eglise; mais frère Innocent leur observait : que le pape Eugène III, d’après les instances de saint Bernard avait accordé cent mille ans d’indulgences à tous ceux qui en l’honneur et commemoration de ces trois Os ou Côtes réciteraient trois fois le Pater et Ave Maria. Nonobstant cela aucun ne voulut y croire. Mais voyez quelle chose extraordinaire en est suivie: le saint homme, en leur présence élevant son coeur à Dieu, est devenu en extase, et dans le peu de temps, qu’il y restait, un papier sur lequel était écrit et très bien détaillé toute l’histoire des trois Os, comme le frère l’avait racontée, et l’indulgence du pape Eugène III accordée à cet égard, lui a été mise miraculeusement dans la main ; et ce qui est le plus frappant, est que cet écrit était soussigné par la main propre de Clement VII, pour lors pontife régnant à Rome.
Le frère Innocent revenant de son extase, remit au prince et aux théologiens l’écrit miraculeux : mais ceux-ci troublés et interdits, ne savaient s’ils voulaient croire ce qu’il venaient de voir devant leurs propres yeux, ne sachant comment ce papier pouvait être parvenu au saint homme, ainsi signé de la main du Saint Père.
Il leur semblait qu’il ne fallait rien de plus pour ajouter foi aux grands mérites du serviteur de Dieu, par qui le Seigneur voulut faire renaître la dévotion aux trois Os, qui avait restée si longtemps en oubli dans le coeur des fidèles.
Cette histoire miraculeuse, très propre pour exciter les catholiques à la compassion et à l’amour réciproque en considération de la douloureuse passion du Fils de Dieu, ainsi que pour mériter en si peu de temps autant d’indulgences, a été imprimée d’après le désir de personnes pieuses. Plut à Dieu que chacun voulut méditer non seulement sur la pesanteur de la croix, mais beaucoup plus sur l’énormité des péchés du monde, lesquels le Père céleste a voulu faire expier par son Fils unique, notre caution, ce pourquoi les épaules innocentes et toute puissantes et ses saintes Côtes et Os ont été si péniblement démembrés.
Ex Fremac. Ord. F. M. R.
Imprimi poterit F. BONAVENT. VAN Den Dycke,
Minister provinciæ.
Imprimi poterit. Actum Antuerp. 22 Nov. 1714.
L. De CARVAIAL L. C.
Nous trouvons dans des anciens ouvrages romains, que le pape Georges III, a accordé d’après les instances de la Reine d’Angleterre, et à tous ceux qui réciteront la prière suivante après V élévation du Corps de Notre Seigneur pendant la Messe, devant le très saint Sacrement de l’Autel, ou bien devant un Crucifix, autant d’années d’indulgence que notre Seigneur Jésus Christ avait de plaies à son corps, qui étaient au nombre de 5676: ainsi trouvons-nous dans les Révélations.
PRIÈRE.
O très aimable Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, je vous prie par l’ardent amour avec lequel vous avez aimé le genre humain, quand, ô Roi céleste vous étiez pendant à la croix avec un visage divin triste, des sensés inquiets, un coeur percé, d’un côté ouvert, des reints tremblants, d’un corps disloqué, des plaies sanglantes avec des flux et reflux, des veines forcées, d’une bouche criante, d’une voix enrouée, d’un visage pâle, une couleur mourante, des yeux pleurants, un ardent amour, un gosier soupirant, une soif ardent, un goût amer de fiel et de vinaigre, avec la tête penchée, couronnée d’épines, rencontrant la mort lors de la separation de son âme divine avec son très saint corps, avec l’origine de la fontaine vivant d’amour. Par le même amour, je vous prie, ô très doux et très aimable Seigneur Jésus Christ, par lequel votre aimable coeur fut pressé et entrecoupé, que vous voudriez vous réconcilier sur le grand nombre de mes péchés, et accorder ainsi qu’à ceux pour lesquels je suis obligé de prier, ,une fin bienheureuse et une résurrection glorieuse, par votre miséricorde infinie qui vivez et régnez avec le Père et le saint Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
O êtres aimables ! soyez assidus et pensez à votre âme altérée, et nourrissez-la des mérites des très saintes Indulgences, pour obtenir par le très saint Sang de notre Sauveur Jésus Christ la remission de vos péchés et ensuite l’éternité bienheureuse. Excitez-vous donc pour l’amour des grandes souffrances de Jésus, à la récitation de cette prière divine et de trois Pater et Ave Maria, et priant ici sur la terre dans l’esprit et la personne de Jésus Christ, à savoir dans l’esprit de pénitence et de repentir, pour satisfaire ainsi conjointement avec lui pour vos péchés à la justice de sa Majesté blessée. PENSEZ-Y DONC BIEN.
Avec crainte et espoir travaillez à votre salut, dit saint Paul, Phil. 2. e. Laissons-nous faire le bien, dit-il, quand nous en avons le temps. Gai. 6. c. dit l’Eccl. 7. c. Celui qui craint le Seigneur n’omet rien ; à savoir de faire le bien là où il peut. Pour cette raison Jésus Christ, la vérité éternelle, nous exhorte. Luc. 9. Paites commerce jusqu’à ce que je viens savoir en bonnes oeuvres. Matth. 6. Amassez-vous des trésors pour le Ciel. Et après avoir fait assiduité dites avec Luc, c. 10, nous sommes des serviteurs inutiles, sur quoi S. Bernard dans le Psal. Qui habitas sermo 4, en nous menaçant dit: malheur à nous, si nous n’avons fait ce que nous devions faire. Jésus soyez loué! et prions-le mutuellement jour et nuit sans discontinuer comme dit S. Paul: car à toutes heures nous sommes à la porte de l’éternité, où nous suivra et le bien et le mal que nous aurons commis et cela pour l’éternité. Mâchez bien la nourriture Cela empêche la pourriture. Que le Saint Esprit soulage et remplisse les âmes des fidèles. Ainsi soit-il.
Bruxelles. Typ. J. Crols-Pirmez, rue de Flandre 106.
(Vide Decr. Auth. n. 18).
Foliolum VII
1 Orazione al Salvatore del mondo
ORAZIONE AL SALVATORE DEL MONDO.
Signor mio Gesù Cristo Padre dolcissimo per amor di quel gaudio, che ebbe la vostra diletta Madre quando le appariste in quella sacratissima notte di Pasqua, e per quel gaudio quando vi vide glorificato con la chiarezza della divinità, vi prego ad illuminarmi con i doni dello Spirito Santo acciocché in tutti i giorni di mia vita possa adempiere la volontà di voi, che vivete e regnate con Dio padre nella vita dello Spirito Santo per tutti i secoli de’ secoli. Amen.
I Sommi Pontefici Bonifazio VIII e Benedetto IX concedono ottantamila anni di indulgenze a ehi reciterà la suddetta Orazione, come si vede in S. Giovanni Laterano di Roma in un marmo.
2. ORAZIONE DI S. GREGORIO PAPA, CHE SI TROVA A LETTERE D’ORO SCRITTA IN S. GIOVANNI IN ROMA.
Bonifazio Papa concede a chi confessato e comunicato la dirà, la remissione di tutti i peccati, e ogni volta che la dirà ottanta mila anni, e 40 quarantene, e chi la dirà 30 giorni continui avanti l’Immagine di M. V., otterrà qualunque grazia, e chi la dirà vita durante ogni giorno otterrà la grazia di morire fedelmente.
ORAZIONE
Stabat Virgo iuxta Crucem
Videns pati veram lucem
Mater Regis omnium
Vidit Caput coronatum
Spinis latum perforatum
Vidit mori filium. Vidit Caput inclinatum
Totum Corpus cruentatum. Pastor pro Ovibus
Vidit potum felle mixtum. Natum suum Crucifixum
Gubernantem omnium Christum pati flagello
Virgo mater et ancella. Vidit et obbrobria
Amen.
3. Orazione alla santa Croce da dirsi anche in sollievo delle anime sante del Purgatorio
Io vi adoro Croce Preziosa che con le delicate membra del mio Signore Gesù Cristo foste adorata, ed aspersa del suo Preziosissimo Sangue. Adoro te Dio mio posto in lei, e te Croce Santissima per amor suo e così sia. Questa orazione a dirla ogni Venerdì 5 volte si cavano 5 anime dal Purgatorio, ed il Venerdì santo se ne cavano 33. Divozione dell’incognita e dolorosa Piaga della Sacra Spalla di N. S. G. C. da lui patita nel portare la pesante Croce.
Dimandando una volta S. Bernardo Abate al nostro Signore nell’orazione qual sia stata la sua maggior doglia occulta sentita nel corso della sua passione; rispose il Signore: Io ebbi una piaga sulla spalla, profonda tre dita, fattami nel portare la Croce: questa mi è stata di maggior pena e dolore di tutte le altre, quale dagli uomini è poco considerata, perchè è incognita; ma tu abbila in venerazione: e sappi che qualunque grazia mi chiederai per tal Piaga te la concederò, e tutti quelli che per amor di essa mi onoreranno io loro perdonerò i quotidiani peccati, rimetterò loro i mortali, e conseguiranno la mia grazia e misericordia.
Eugenio III, ad istanza di S. Bernardo, ha concesso 3000 anni d’Indulgenza a chiunque dirà tre Pater e Ave ad onore della Piaga della Spalla di Gesù Cristo, e delle tre ossa prominenti, come si dice che sia stato rivelato a detto Santo.
ORAZIONE A DETTA PIAGA
Dilettissimo Signor Gesù Cristo, mansuetissimo Agnello di Dio, io povero peccatore saluto, e riverisco la vostra Santissima piaga, che patiste sulla spalla dal portar la pesante Croce, laonde per causa delle tre ossa prominenti, che quivi sporgevano in fuori vi si cagionava intensissimo dolore sopra tutti gli altri del vostro SS. Corpo. Vi adoro mio appassionato Signore, vi lodo, vi onoro, e vi glorifico con l’intimo del mio cuore e vi ringrazio per quella SS. profondissima e dolorosissima Piaga della vostra spalla, supplicandovi umilmente per quel gran dolore che in essa sentiste, e per quel grave peso della Croce, ad aver misericordia di me peccatore, a perdonarmi tutti i miei peccati, sì veniali che mortali, e di ac compagnarmi sul sentiero della Croce per i vostri Sanguinosi Vestigi alla eterna Beatitudine.
Tre Pater, Ave e Gloria.
ORAZIONE
Sacro Cuore di Maria
Voi siete gran Regina
Tutto il mondo a voi s’inchina
Voi salvate l’anima mia. — Un Pater ed Ave.
Pio VI concesse Indulgenza plenaria nell’anno 1787 a chiunque reciterà la detta orazione.
Siena 1888 — Tip. S. Bernardino.
Foliolum VIII
LETTERA DI GESÙ CRISTO.
DELLE GOCCIE DI SANGUE CHE SPARSE N. S. G. C MENTRE ANDAVA AL CALVARIO.
Copia di una lettera di Orazione ritrovata nel Santo Sepolcro di N. S. G. C. in Gerusalemme, conservata in una cassa d’argento da S. Santità, e dagli Imperatori ed Imperatrici cristiani. Desiderando S. Elisabetta Regina d’Ungheria, Santa Matilde e Santa Brigida sapere alcune cose della Passione di Gesù Cristo, facendo fervorose e particolari Orazioni, mercè le quali gli apparve Gesù Cristo favellando con esse e cosi dicendo: Sappiate che i soldati armati furono 150, quelli che mi condussero legato furono 23, gli esecutori di giustizia 83, i pugni che ricevei alla testa furono 150 e nel petto 108, i calci nelle spalle 80, e fui trascinato con corde e per i capelli 23 volte, natte e sputi nella faccia furono 180, battiture nel corpo 6666, battiture nel capo 110, mi diedero un urtone, notate nel cuore, fui alzato in aria per i capelli ad ore 21, ad un tempo mandai 120 sospiri, fui trascinato e tirato per la barba 23 volte, piaghe nella testa 20, spini di giunchi marini 72, punture di spine nella testa 100, spine mortali nella fronte 3, dopo flagellato e vestito da re di burla, piaghe nel corpo 1000. I soldati che mi condussero al Calvario furono 908, quelli che mi guardavano 3, goccie di sangue che sparsi furono 28430 e chi ogni giorno recita 7 Pater, Ave e Gloria per lo spazio di 15 anni per compiere il numero delle goccie di sangue che ho sparso, gli concedo 5 grazie:
1° . L’indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati;
2°. Sarà liberato dalle pene del purgatorio;
3°. Se morrà prima di compire detti 15 anni, per esso sarà come li avesse compiti;
4°. Sarà come fosse morto ed avesse sparso il sangue per la Santa Fede ;
5°. Scenderò io dal cielo a prendere l’anima sua e quella dei suoi parenti fino al quarto grado.
Quegli che porterà questa Orazione non morirà annegato, né di mala morte, né di morte improvvisa, sarà liberato dal contagio e dalla peste, dalle saette, e non morirà senza confessione, sarà liberato dai suoi nemici, e dal potere della Giustizia, e da tutti i suoi malevoli e da falsi testimoni. Le donne che non possono partorire, tenendola addosso, partoriranno subito e usciranno di pericolo. Nella casa ove sarà questa Orazione non vi saranno tradimenti nè di cose cattive, e 40 giorni prima della sua morte quello che l’avrà sopra di sè vedrà la Beata Vergine Maria, come dice S. Gregorio Papa.
Un certo Capitano spagnolo viaggiando per terra vide vicino Barcellona una testa recisa dal busto che gli parlò cosi: Giacché vi portate a Barcellona, o passeggiero, conducetemi un confessore acciò possa confessarmi essendo già da tre giorni che sono stata recisa dai ladri, e non posso morire se non mi confesso. Condotto al luogo il Confessore dal Capitano suddetto, la testa vivente si confessò ed indi spirò, trovando addosso al busto da cui era stata recisa, la seguente orazione la quale in quella occasione fu approvata da vari Tribunali della S. Inquisizione di Spagna. I suddetti 7 Pater, Ave e Gloria si potranno recitare e applicare anche per qualsivoglia anima. Altra simile copia della suddetta lettera è stata miracolosamente ritrovata nel luogo chiamato Porsit, tre leghe lontano da Marsiglia, scritta a lettere d’oro e per opera divina portata da un fanciullo di 7 anni del medesimo luogo di Porsit. Con un’aggiunta e dichiarazione il 2 Gennaio 1750 che dice : Tutti coloro che travaglieranno nei giorni di Domenica saranno maledetti da me, perchè nelle Domeniche dovete andare alla Chiesa
POLIOLUM IX.
Proscribitur etiam foliolum quoddam ex charta vel etiam ex lino confectum et diversis linguis exaratum, quod “Breve S. Antonii Patavini„ appellatur, hisce ultimis temporibus late diffusum, in quo, post relatam oratiunculam ex Breviario Romano desumptam: “Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae. Vicit Leo de tribu Juda, Radix David. Alleluja! Alleluja! „, hæc leguntur:
Sancte Antoni magne Taumaturge (alibi: Dæmonum effugator, ora pro nobis.
R). Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
Ecclesiam tuam, Deus, Beati Antonii confessoris tui commemoratio votiva lætificet ut spiritualibus semper muniatur auxiliis et gaudiis perfrui mereatur æternis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
[Proscritto pure il cosiddetto “breve” di S. Antonio.]
Foliolum X
Demum proscribitur libellus cui titulus « Corona del Signore, sua origine, significazione ed indulgenze, ed alcuni metodi di recitarla con divozione e spirituale profìtto. » — Faenza 1871, Ditta tipografica Pietro Conti „ eo quod contineat plures apocryphas Indulgentias, nimirum pro Oratione “Deus qui nobis in Sancta Sindone etc. „ et pro alia: “Dio ti salvi, Santissima Maria, Madre di Dio, Regina del Cielo ecc. „ iam damnatas per Decretum u Delatæ sæpius „ anni 1678 (n. 18); nec non pro sequentibus qæe nunc reprobantur;
Innocenzo VIII concesse indulgenza Plenaria a chi recita la seguente.
« Il Cielo ti Salvi, o Vergine Sovrana,
Stella del Sol più chiara,
Di Dio Madre pietosa,
Del mel più dolce, e rara;
Rubiconda più che Rosa,
Candida più che Giglio,
Ogni virtù t’infiora
Ogni santo ti onora,
Nel Ciel la più sublime. Così sia»
Clemente XIV concede l’Indulgenza plenaria a chi reciterà l’orazione seguente al glorioso Patriarca S. Benedetto che ha rivelato alla Magna Badessa S. Geltrude di assistere nell’ora della morte, per opporsi potentemente agli assalti del nemico infernale, chi divotamente l’avrà agni giorno ossequiato colla seguente:
PREGHIERA.
Benedetto, mio caro Padre, vi prego per quella dignità, con la quale il Signore si degnò di cosi glorioso fine onorarvi e beatifìcarvi, che vogliate trovarvi presente alla mia morte, eseguendo in me tutte quelle promesse fatte alla Vergine S. Geltrude.
MEMORIA DEL GLORIOSO TRANSITO DI S. BENEDETTO.
Ant. Stans in oratorio dilectus Domini Benedictus Corpore et Sanguine Dominico munitus, inter Discipulorum manus imbecillia membra sustentans, erectis in coelum manibus inter verba orationis spiritum efflavit. Qui per viam stratam palliis et innumeris coruscam lampadibus coelum ascendere visus est.
- Gloriosus apparuisti in conspectu Domini.
R). Propterea decorem induit te Dominus.
Deus, qui pretiosissimam mortem SSilii Patris Benedicti tot tantisque privilegiis decorasti : concede quaesumus nobis, ut cuius memoriam recolimus, eius in obitu nostro beata praesentia ab hostium muniamur insidiis. Per Christum etc.
Chi non sa leggere, potrà dire tre Pater ed Ave con l’intenzione predetta.
# # #
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romæ ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 26 Maii 1898.
HIERONYMUS CARD. GOTTI Præfectus.
f. ANTONIUS Archiep. Antinoen. Secretarius.
A firma del Prefetto
Fr. Girolamo Card. Gotti.
In data 26 maggio 1898
Il decreto seguente ha una straordinaria importanza per chi volesse esser sicuro che le preghiere che recita non siano false, sacrileghe, superstiziose e peccaminose.
Acta Sanctæ Sedis n. 32 (1899-1900) a pagina 243: decreto“Inter cetera” [3 agt. 1899] qui leggiamo le norme suggerite per discernere le vere indulgenze dalle false ed apocrife:, onde prevenire le calunnie verso l’istituzione delle indulgenze, e così impedire la dispersione del celeste tesoro.
URBIS et ORBIS. Decretum de regulis seu normis ad dignoscendas veras Indulgentias ab apocryphis.
Inter cetera quæ huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositæ munera sunt tributa, illud supereminet secernendi nimirum veras Indulgentias ab apocryphis easque proscribendi. Cui quidem muneri satis ipsa fecit plurimis editis ad haec usque tempora decretis de apocryphis Indulgentiis in authentica Decretorum collectione contentis. Verum etsi haec S. Congregatio vigilans ab ipso suæ institutionis exordio semper exstiterit quoad Indulgentiarum publicationem, ne falsæ in Christianum populum irreperent, nihilominus, quum hac etiam nostra aetate non desint, qui, vel mala voluntate, aut etiam irrationabili zelo perculsi, falsas, vel ut minimum valde suspectas, Indulgentias sive orationibus, sive piis exercitiis adnexas propalare inter fideles non vereantur, hinc factum est ut plures Antistites hanc S. Congregationem adfuerint, ut de aliquibus Indulgentiis suum iudicium ederet. Id potissimum praestiterunt ea causa permoti ut non solum verae a falsis Indulgentiis discernerentur, sed praesertim ut Ecclesiæ hostibus via praecluderetur eam calumniandi, et aspernendi coelestem Indulgentiarum thesaurum. Porro S. Congregatio ut huic malo, quoad fieri posset, præsens remedium adhiberet, regulas seu normas quasdam statuere excogitavit, quibus prae oculis habitis nedum locorum Ordinariis, sed et ipsis Christifidelibus facilis aperiretur via ad dignoscendum quodnam sit ferendum iudicium de aliquibus Indulgentiis, quae passim in vulgus eduntur, dubiamquè praeseferunt authenticitatis notam.
Hoc vero S. Congregationis propositum SS.mo D.no Nostro Leoni XIII delatum, eadem Sanctitas Sua illud approbavit iussitque quam primum executioni mandari.
Quare S. Congregatio, adhibito studio Rmorum Consultorum, Indicem prædictarum regularum elucubrandum curavit; quem deinde in generali Congregatione ad Vaticanum coadunata die 5 Maii 1898 examini Eiîiorum PP. Cardinalium subiecit. Hi vero postquam praefatum Indicem mature perpenderint, eumdem, in aliquibus immutatum, in altera Congregatione denuo expendendum sibi reservarunt.
Quod quidem actum est in generalibus Comitiis ad Vaticanum habitis die 3 Augusti 1899, in quibus Emi et Rmi Patres Indicem uti infra proponendum censuerunt:
REGOLA I.
Authenticæ sunt omnes indulgentiæe, quæ in novissima Collectione a S. Indulgentiarum Congregatione edita continentur.
[Sono autentiche tutte le indulgenze contenute nell’ultima collezione edita dalla Congregazione delle Indulgenze.]
REGOLA II.
Indulgentiæ generales, quae in supradicta Collectione non exhibentur, vel quae concessae feruntur post editam Collectionem, tunc solummodo habendae erunt ut authenticae, cum earumdem concessionis authographum monumentum recognitum fuerit a S. Indulgentiarum Congregatione, cui, sub nullitatis poena, exhibendum erit antequam publicentur.
[Le indulgenze generali che non si trovano nella succitata collezione edita, o che saranno concesse dopo l’edizione della collezione, sono da ritenersi autentiche solo se munite di concessioni autografate dalla Congregazione delle S. Indulgenze, che dovranno essere esibite, pena nullità, prima della pubblicazione]
REGOLA III.
Authenticæ habeantur Indulgentiæ concessæ Ordinibus et Congregationibus religiosisj Archiconfraternitatibus, Confraternitatibus, Archisodalitas, Sodalitiis, piis Unionibus, piis Societatibus, nonnullis Ecclesiis celebrioribus, Loeis piis et Obiectis devotionis, quae continentur in Summariis recognitis et approbatis a S. Congregatione Indulgentiarum, eiusque auctoritate vel venia typis editis.
[Sono da ritenersi autentiche tutte le indulgenze concesse agli Ordini ed alle Congregazioni religiose, alla Arciconfraternite, alle Confraternite, agli Archisodalizi, ai Sodalizi, alle pie unioni, alle pie società, ad alcune delle chiese più popolose, ad oggetti di devozione che sono contenute nei sommari recogniti e approvati dalla S. Congregazione ed edite con la loro autorità]
REGOLA IV.
Non habeantur ut authenticae Indulgentiae sive generales, sive particulares, quae continentur in libris, in libellis, in summartis, in foliis, in chartulis, sive etiam in imaginibus, impressis sine approbatione auctoritatis competentis; quae approbation concedenda erit post diligentem recognitionem et distincte exprimenda.
[Non si considerino autentiche le indulgenze, generali o particolari, contenute in fogli, libelli, libri, o anche in immagini, senza approvazione delle autorità competenti, da concedere solo dopo una diligente ricognizione chiaramente espressa.]
REGOLA V.
Apocryphæ, vel nunc prorsus revocatæ, sunt omnes Indulgentiæ mille vel plurium millium annorum quocumque tempore concessæ dicantur.
[Apocrife o revocate ora sono tutte le indulgenze ove si dicano concessi svariati millenni ovunque esse siano state concesse.]
REGOLA VI.
Suspectæ habeantur Indulgentiæ plenariæ quæ asseruntur concessæ recitantibus pauca dumtaxat verba: exceptis Indulgentiis in articulo mortis.
[Sono sospette tutte le indulgenze plenarie che si asserisce esser concesse recitando solo poche parole, tranne che in “articulo mortis”.]
Regola VII
Reiiciendæ sunt ut apocryphæ Indulgentiæ, quae circumferatur in libellis, foliis seu ehartulis impressis vel manuscriptis, in quibus ex levibus aut etiam superstitiosis causis et incertis revelationibus, vel sub illusoriis conditionibus promittuntur Indulgentiæ et gratiæ usum et modum excedentes.
[Sono da considerarsi apocrife quelle indulgenze che circolano in volantini ed opuscoletti (… oggi anche libri, internet, you-tube etc. … visto la grande diffusione che ne fanno –ndr.-) contenenti dubbie rivelazioni che quasi sfociano nella superstizione, che, con illusorie condizioni, promettono indulgenze e grazie spropositate.]
Regola VIII
Ut commentata reiicienda sunt folia et libelli, in quibus promittitur fidelibus unam alteramve precem recitantibus liberatio unius vel plurium animarum a Purgatorio: et Indulgentiae quae dictae promissioni adiici solent ut apocryphæ habendæ sunt.
[Sono da rigettare tutti i fogli o libelli in cui si promette ai fedeli, con le recitazione di una o d’altra preghiera, la liberazione di una o più anime del purgatorio: e le indulgenze collegate a dette “ promesse” sono da rigettarsi e ritenersi apocrife.]
REGOLA IX.
Apocryphæ, vel saltem ut graviter suspectæ, habeantur, Indulgentiærecentioris assertæ concessionis, si ad inusitatum numerum annorum vel dierum producuntur.
[Apocrife, o almeno gravemente sospette, sono tutte le indulgenze presunte di più recente concessione, che promettono un numero inusitato di anni o di giorni di indulgenza]
Datum Romæ ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 10 Augusti 1899.
Fr. HIERONYMUS M. CARD. GOTTI, Praefectus.
f A. SABATUCCI ARCHIEP. ANTINOEN. Secr.
Congr. Indice
# # # #
A PROPOSITO DELLE “promesse” annesse alle ORAZIONI S. BRIGIDA
Abbiamo un monito del Santo Officio, del gennaio 1954, che si occupa di esse espressamente:
III
MONITUM
In aliquibus locis divulgatum est opusculum quoddam, cui titulus « SECRETUM FELICITATIS »- Quindecim orationes a Domino S. Birgittæ in ecclesia S. Pauli, Romae, revelatae », Mceae ad Varium (et alibi), variis linguis editum.
Cum vero in eodem libello asseratur S. Birgittæ quasdam promissiones a Deo fuisse factas, de quarum origine supernaturali nullo modo constat, caveant Ordinarii locorum ne licentiam concedant edendi vel denuo imprimendi opuscula vel scripta quae prædictas promissiones continent.
[In alcuni diversi luoghi viene divulgato un opuscolo con il titolo “Secretum felicitatis” con le quindici orazioni date dal Signore a Santa Brigida nella chiesa di S. Paolo in Roma, edito in varie lingue. Poiché in questo libricino si asserisce per vero che a Santa Brigida siano fatte da Dio delle promesse delle quali non risulta in alcun modo l’origine soprannaturale; si diffidano gli Ordinari dal concedere licenza di edizione o stampa ad opuscoli che contengano le predette promesse.]
Datum Romæ, ex Ædibus S. Officii, die 28 Ianuarii 1954.
Marius Orovini, Supremæ S. Congr. S. Officii Notarius
# # #
Attualmente, rimosso il freno del Santo Uffizio, preghiere ed indulgenze apocrife circolano innumerevoli, ispirate anche dalle eresie della setta del “novus Ordo”, che si spaccia per Chiesa Cattolica, da falsi sacrileghi prelati, da falsi religiosi e religiose, o addirittura da laici fanta-teologi “fai-da-te”, incontrollate, di carattere sentimental-sdolcinato, suggerite dal poetico-liberal-pensiero, con libertà dottrinale e teologica “neomontanista”, come ad esempio l’empio movimento satanico del c. d. “rinnovamento dello spirito” (in realtà si elimina lo Spirito Santo, e si dà spazio agli spiriti demoniaci … ). Per i pochi Cattolici in comunione con il Santo Padre Gregorio XVIII, il “pusillus grex”, valgono le regole, da osservarsi con somma attenzione e maniacale prudenza, del decreto del Santo Uffizio 3 agosto del 1899 “Inter cætera”. Si recitino solo le preghiere approvate dalla Chiesa Cattolica, antecedenti al novembre 1958, ed indulgenziate come da Raccolte Ufficiali della S. Congregazione delle Indulgenze. Nel caso opposto, si commette come minimo sacrilegio, e le preghiere rigettate ancor prima di essere concluse. Attenti fedeli, il lupo maledetto si è travestito da Angelo di luce ed inganna oggi soprattutto con la falsa spiritualità, le false devozioni, i falsi riti ed i sacrileghi pseudo-sacramenti. A noi Cattolici, non è permesso cedere al nemico travestito, anche se il suo travestimento è una talate nera, rossa o bianca, … dai frutti li riconoscerete …