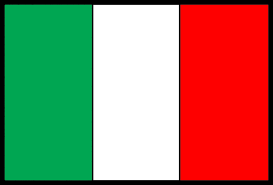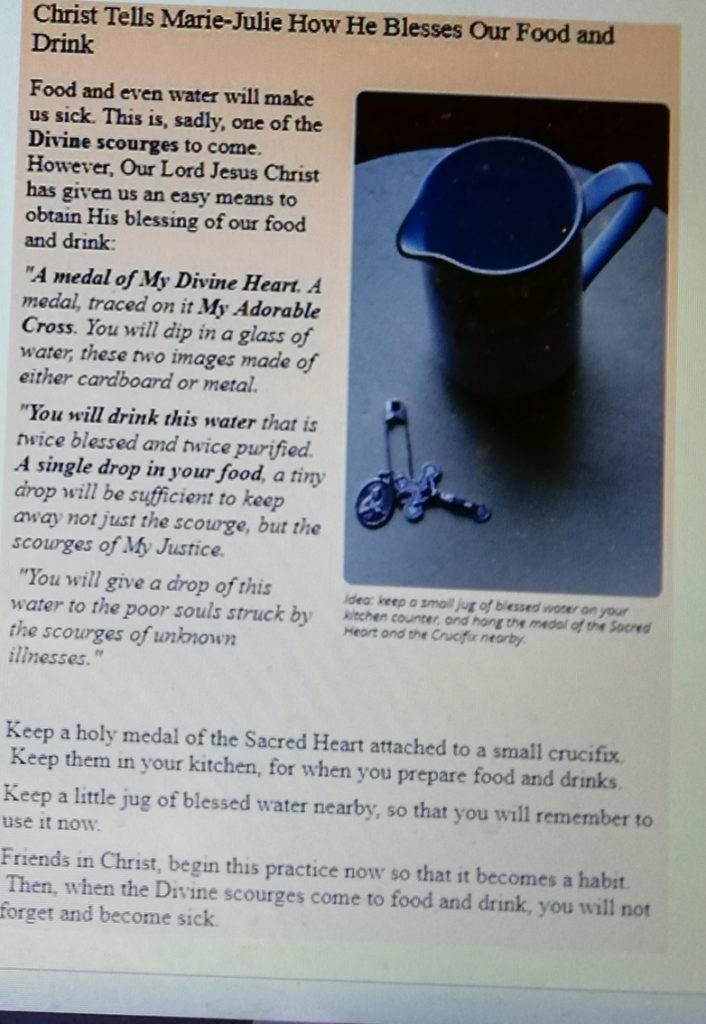CONOSCERE SAN PAOLO (48)
LIBRO SESTO
I frutti della redenzione.
CAPO I.
La vita cristiana.
[F. Pratt: La teologia di San Paolo – Parte SECONDA, S.E.I. Ed. – Torino, 1927 – impr.]
I. I PRINCIPI DELLA MORALE.
1 — FONDAMENTI DELLA MORALE CRISTIANA. — 2. L A VOLONTÀ DI DIO. — 3. LA RIGENERAZIONE BATTESIMALE. — 4. RELAZIONI NUOVE.
1. Invece di svolgersi in periodi lunghissimi, intralciati da incisi e da congiunzioni causali, ripieni di digressioni e di parentesi che non danno tregua alla mente e all’occhio, come sono le parti dommatiche, le sezioni morali delle lettere di Paolo, tagliate, sminuzzate in brevissimi incisi, trascorrono per lo più come una monotona litania senza nesso apparente, senza legami grammaticali, senza una relazione con l’idea principale. Non vi è nulla di più sconcertante che tale contrasto. Il lettore si sente talora respingere da quella parenesi scucita che si direbbe fuori proposito e che pare adatta a tutte le situazioni ed a qualunque destinatario. Se la morale delle due Epistole agli Efesini ed ai Colossesi forma un piccolo codice familiare abbastanza ordinato, se quella dell’Epistola ai Romani riassume i principali doveri dei cittadini verso l’autorità e verso i loro simili, non si vede perché l’Apostolo le metta in queste lettere piuttosto che nelle altre. Soltanto nell’Epistola ai Galati la morale scaturisce dal dogma; ma anche qui non vi è nulla che ricordi l’arte perfetta dell’Epistola agli Ebrei, dove il dogma e la morale si fondono armonicamente. Quasi sempre troviamo delle litanie di consigli e di precetti come questi:
“Riprendete gl’indisciplinati;
incoraggiate i pusillanimi;
sostenete i deboli;
siate sempre tolleranti con tutti
Non estinguete lo spirito;
non disprezzate le profezie;
provate tutto, attaccatevi al bene;
evitate ogni apparenza di male”
(I Tess. V, 14; 19-221).
Questo fenomeno non è affatto speciale delle lettere minori, e anche le maggiori ce ne danno molti esempi:
“Dare l’elemosina con semplicità,
aiutare gli altri con sollecitudine,
fare misericordia con allegrezza.
Carità senza ipocrisia.
Abborrite il male, attaccatevi al bene…
Allegri per la speranza,
pazienti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera.,
provvedendo alle necessità dei santi,
praticando l’ospitalità.
Benedite i vostri persecutori;
benedite e non vogliate maledire.
Rallegrarsi con quelli che sono nella gioia,
piangere con quelli che piangono”
(Rom. XII, 8-15).
In questa lunga serie di frasi senza nesso grammaticale e senza unità logica, è difficile scorgere un principio direttivo d’insegnamento morale. Ecco precisamente il punto delicato — stavo per dire il punto debole — della morale di Paolo: dopo che ha fatto tabula rasa della Legge mosaica, non dice mai chiaramente con che cosa intenda sostituirla. La Legge di Mosè è abolita per sempre: il Cristo ne è il fine, lo scopo al quale essa certamente tende, ma ne è anche il limite dove essa spira (Rom. X, 4). Il codice del Sinai è stato lacerato, inchiodato sopra la croce (Ephes. II, 15; Col. II, 14). — I cristiani sono morti alla Legge, e la Legge per loro è morta (Rom. VII, 4, 6; Gal. II, 19; Col. II, 20). Figli della donna libera, e non della schiava, essi hanno il diritto e il dovere di perseverare nella libertà che Gesù Cristo ha loro acquistata (Gal. IV, 21, 31; V, 1). Nel vedere Paolo che si accanisce a distruggere tutto l’edificio della legge antica, senza che sembri darsi pensiero di ricostruirlo, si domanda con inquietudine dove mai si fermerà tale opera di demolizione e su quale base poggerà l’obbligazione della nuova economia. Poiché la distinzione immaginata da certi esegeti, tra la legge morale e la legge cerimoniale, delle quali l’una sopravviverebbe e continuerebbe a servire di norma, mentre l’altra sarebbe colpita di morte dal Cristo che essa per la prima avrebbe ucciso, tale distinzione sottile è sconosciuta all’Apostolo. Per lui il codice del Sinai è indivisibile, è un edificio che resta o che cade tutto di un pezzo. Non occorre neppure esaminare se il suo atteggiamento verso la Legge si sia venuto modificando con l’età, o nel senso dell’intransigenza, o nel senso della conciliazione: le sue idee già pienamente determinate fin dalla riunione apostolica dell’anno 50, prima che egli scrivesse una sola riga delle sue lettere (Gal. II, 3-7, 14-21), non si mutarono mai in seguito. In ogni tempo egli seppe mostrarsi condiscendente, tollerando pratiche indifferenti consacrate dall’uso e dai ricordi religiosi, imponendole anche a se stesso, quando occorreva (Act. XVI, 3); ma dal principio alla fine della sua carriera egli sostenne sempre come tesi fondamentale l’abolizione totale della Thora, così per gli Ebrei come per i Gentili. – Siccome la luce sempre più viva, proiettata su la legge naturale dalla rivelazione, è un fatto indiscutibile, si potrebbe tentare di ricostruire, sopra le rovine della Thora, un codice nuovo il quale altro non sarebbe che la legge naturale illuminata, nei suoi punti oscuri, dalla rivelazione divina. Questo sistema, per quanto possa essere ingegnoso, non è quello di Paolo. L’Apostolo riconosce benissimo l’esistenza della legge naturale; dichiara che sono inescusabili i pagani per averla violata (Rom. I, 32); descrive la coscienza che cita l’uomo al tribunale e, secondo i casi, lo assolve o lo condanna (Rom. II, 14-15); ma a questa norma interna non dà il nome di legge (la Legge di S. Paolo è sempre la legge positiva), perché la legge è per lui l’espressione di una volontà positiva. E poi egli non ammetterebbe mai che il Cristiano, liberato dal giogo della Legge, venga retrocesso allo stato di natura: la Legge mosaica segna necessariamente una tappa nell’ascesa dell’umanità e, se deve scomparire, bisogna che venga sostituita con qualche cosa di meglio. Perciò nel momento stesso in cui oppone il regime della Legge a quello della grazia, insinuando che questi due stati sono incompatibili tra loro, protesta energicamente di essere sciolto da ogni legge ed afferma di dipendere dalla legge del Cristo. Questo è il paradosso: il Cristiano è così essenzialmente libero, che non può essere sotto il giogo della Legge, ed è tuttavia soggetto a una legge. La ragione è che l’economia nuova è una vera legge, se si considera il suo carattere obbligatorio, e non è una legge, se si pensa alle imperfezioni della Legge mosaica: se la chiamiamo legge di grazia, siamo nello spirito dell’Apostolo; se la chiamiamo legge del Cristo, ci conformiamo al suo linguaggio. (Ga. VI, 2).
2. La libertà dei figli di Dio non è la licenza, e la liberazione dal giogo mosaico non è l’esenzione da qualunque freno (Gal. V, 13). Paolo dovette protestare mille volte contro la falsa interpretazione del suo pensiero (Rom. III, 8; VI, 1-15); lo capivano male: egli non disse mai che Dio abbia abolito l’economia antica senza sostituirne una più perfetta. Nel momento in cui Gesù aboliva il regime della Legge, poneva le basi del regime della grazia (Matt. V, 7).Non vi fu soluzione di continuità: il Nuovo Testamento prende per conto suo la legge morale dell’Antico che esso soppianta: non contento di sanzionarla, la perfeziona e la completa: « Tutto ciò che è vero, scrive san Paolo ai Filippesi, tutto ciò che è onorevole, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è puro, tutte ciò che è amabile, tutto ciò che è di buona fama, virtuoso e degna di elogio, formi l’oggetto delle vostre meditazioni ». Ecco tutta la legge naturale, sotto i suoi diversi aspetti, proposta ai fedeli; ma essa non obbliga più soltanto come legge naturale: « Tutto questo, soggiunge l’Apostolo, voi l’avete appreso e ricevuto (da noi); voi lo avete sentito dire da noi e l’avete visto fare da noi; praticatelo (Fil. IV, 8-9) ». In grazia della rivelazione evangelica, la legge naturale — coma pure il codice sinaitico nella sua parte morale — torna ad essere una legge positiva. La relazione però tra la legge e l’uomo non è più la medesima. Il difetto capitale della Legge antica era quello di essere esteriore all’uomo e poco proporzionata al nostro stato attuale di decadenza (Rom. VII, 14). Per ristabilire l’equilibrio, bisognava o abbassare la Legge fino al livello dell’uomo caduto, oppure innalzare l’uomo fino all’altezza della Legge divina. Essa era stata imposta agli Israeliti, col doppio intermediario di Mosè e degli Angeli, in mezzo ai terrori del Sinai (Gal. III, 19); nascendo soggetto alla Legge, come membro del popolo eletto, l’Ebreo fin dal primo destarsi della sua ragione, ne subiva, volere o no, il fardello reso più pesante dal sentimento della sua impotenza (Rom. VII, 5-11); nulla di spontaneo, di libero, di generoso, di filiale: lo schiavo della Legge non poteva nutrire altri sentimenti che quelli dello schiavo, timore, diffidenza e noia. Ben diversa è la condizione del cristiano: con l’atto di fede e col Battesimo che ne è il sigillo, egli si ò messo liberamente al servizio di Dio e si è fatto soldato del Cristo. Egli si libera dal giogo della Legge soltanto col rinunziare alla sua indipendenza: la volontà di Dio, accettata di cuore e nella misura in cui si manifesterà, diventa la sua regola di condotta: « Non sapete che dandovi a qualcuno come schiavi per obbedirgli, voi diventate schiavi di colui al quale obbedite! … Ora, liberati dal peccato ed asserviti a Dio, voi avete come frutto la santificazione e come fine la vita eterna. Poiché lo stipendio del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna nel Cristo Gesù nostro Signore (Rom. VI, 13-23) ». Si può quasi essere sicuri che Paolo, nello scrivere queste parole, pensava allo schiavo ebreo ed al soldato romano. Presso gli Ebrei, la schiavitù era poco diversa dalla servitù ordinaria; per i compatrioti non poteva mai prolungarsi oltre i sei anni, senza l’espresso consenso dell’interessato; dato poi questo consenso, lo schiavo entrava di pieno diritto e per sempre nella casa del suo padrone, ma la sua condizione non aveva nulla di umiliante e di degradante; egli faceva parte della famiglia, godeva dei privilegi religiosi della nazione, era uomo e cittadino, e non già, come presso i Gentili, una bestia da soma. Perciò Paolo che con tanta energia respinge ogni sospetto di bassezza e di servilismo, non esita a chiamarsi lo schiavo del Cristo e persino lo schiavo dei suoi fratelli, peramore del Cristo. Schiavo del Cristo, egli è pure soldato del Cristo. È noto che le legioni romane assoldavano soltanto uomini liberi: l’arruolamento dei servi, anche quando erano stati fatti liberi e nei casi di forza maggiore, era sempre considerato come un fatto da non imitarsi e cosa poco compatibile con la maestà delle aquile romane. Le reclute, nel prestare il giuramento, votavano la loro vita all’imperatore e si obbligavano ad un’obbedienza assoluta, molte volte più dura che quella della schiavitù, ma elevata e nobilitata dalla loro qualità di cittadini e dal sentimento di un dovere abbracciato spontaneamente. Per questo l’Apostolo adopera tanto volentieri il linguaggio militare che gli ricorda l’impegno contratto col Battesimo e lo stato di dipendenza in cui volontariamente si è messo con l’atto di fede che lo ha fatto Cristiano. Al suo discepolo prediletto dà il titolo di soldato del Cristo (II Tim. II, 3), il titolo più onorevole che egli conosca; scongiura i Tessalonicesi a rivestire l’armatura delle virtù teologali, la corazza della fede e della carità, e l’elmo della speranza (I Tess. V cfr. Is. LIX, e Sap. V, 17-20); in una famosa panoplia egli descrive agli Efesini tutta l’armatura del legionario, la corazza e l’elmo, la spada corta a due tagli e lo scudo lungo coperto di pelle, e non dimentica neppure la calzatura ed il cingolo di cuoio, ein tutto questo vede altrettanti simboli di virtù cristiane (Ephes. VI, 13-17). Se le metafore di armi, di combattimento, di stipendio, di milizia e altre simili ritornano continuamente sotto la penna dell’Apostolo, è perché egli ha sempre in mente il giuramento col quale si è votato al Cristo, giuramento che lo obbliga a « non impacciarsi nelle sollecitudini di questa vita, per pensare unicamente a piacere al suo capo (II Tim. II, 3-4) ». Soldato del Cristo e schiavo volontario, il Cristiano non appartiene dunque più a se stesso: la regola da cui dipende, poiché l’ha accettata liberamente, è la volontà di Dio, la volontà del Signore (Rom. XII,; Ephes. VI, 6). Tale è pure la norma esteriore che nessun Cristiano può ignorare. Uno dei fatti più certi dell’età apostolica, benché i critici abbiano impiegato assai tempo a constatarlo, è l’esistenza di una catechesi morale abbastanza uniforme nel suo contenuto. San Paolo vi allude chiaramente quando scrive ai Corinzi: « Timoteo vi ricorderà le mie vie nel Cristo, come io insegno dappertutto ed in ogni chiesa (I Cor. IV, 17) ». Le vie di Paolo non sono la sua condotta, ma come indica abbastanza la parola e come lo mette fuori di dubbio l’inciso esplicativo, la sua dottrina morale soprannaturale. Si facciano pure le meraviglie, se si vuole, perché un carattere così libero e di primo impeto si sia legato ad un metodo d’istruzione regolare e per così dire stereotipato; ma qui vi è la sua testimonianza formale: egli insegnava « dappertutto, in ogni Chiesa », le stesse cose e nella stessa maniera, tante che più tardi gli bastava mandare uno dei suoi discepoli per rinfrescarne la memoria. Ma vi èdi più: questa catechesi esiste anche nelle altre chiese, e san Paolo scrive ai Romani che non sono stati evangelizzati da lui: « Voi avete obbedito al tipo di dottrina che vi è stato trasmesso », o forse con maggior forza: « al tipo di dottrina al quale foste dati (Rom. VI, 17) ». Tutto il contesto fa vedere che questo tipo di dottrina è un insegnamento morale, e il nome stesso di tipo dice che la trasmissione non era abbandonata al capriccio o all’ispirazione individuale. Paolo interdice ai Tessalonicesi ogni relazione coi fratelli che si allontanassero dalla tradizione ricevuta da lui; la stessa ingiunzione fa ai Romani riguardo ai fedeli che trasgredissero la dottrina che loro fu insegnata (II Tess. III, 6 e Rom. XVI, 17). Via, tradizione, dottrina, tipo di dottrina, didascalia — e persino la parola con cui si è formata catechesi (Gal. VI, 6) — sono tutti termini che con sorpresa si trovano negli scritti dell’Apostolo, ed in un senso assai vicino a quello delle generazioni seguenti. Dunque la volontà di Dio, proclamata dal Cristo, promulgata dagli Apostoli (II Cor. V, 20), destava nei neofiti un’idea abbastanza concreta. Quando Paolo diceva laconicamente: « Non fate come i Gentili che non hanno Legge, né come gli Ebrei che hanno soltanto la Legge; la vostra condotta sia degna dei santi, degna della vostra vocazione, degna del Vangelo, degna del Cristo, degna di Dio (Rom. XVI, 2) »; queste brevi parole dicevano molto: esse riportavano il neofito al momento in cui, abbracciando la fede, l’aveva rotta col passato, si era abbandonato a Dio e sottomesso alla legge del Cristo; esse riassumevano con una frase la catechesi apostolica della quale certamente nulla ci può dare un’idea più approssimativa che le Vie, ossia il piccolo compendio morale inserito in due dei più antichi monumenti della letteratura cristiana, la Dottrina degli Apostoli e l’Epistola di Barnaba.
3. All’obbiezione che noi con un sotterfugio mettiamo il Cristiano sotto il giogo della Legge da cui il Cristo lo aveva liberato, e che la condizione del bambino battezzato che eredita degli obblighi prima di averli conosciuti, è identica a quella del bambino ebreo che nasce soggetto alla Legge, rispondiamo che ciò non è vero affatto. Certamente l’Apostolo, rivolgendosi a convertiti di data recente, parla della fede attuale degli adulti; ma la sua dottrina si può applicare anche alla fede abituale del bambino Cristiano. La fede, attuale o abituale, ha sempre la medesima tendenza; essa è per sua natura uno slancio spontaneo della mente e del cuore, col quale l’uomo rinunzia nelle mani di Dio la sua intelligenza e la sua volontà. Se vi è qualche differenza, questa è tutta a vantaggio della fede abituale, perché qui lo Spirito Santo opera da solo, e non vi è nulla che ne ostacoli l’azione. Ora l’impulso intimo dello Spirito Santo non si può paragonare ad una costrizione esteriore; essa solleva e non opprime l’uomo; essa toglie all’obbedienza il carattere servile. Col Battesimo il Cristiano diventa soggetto alla legge della grazia, come nasce soggetto alla legge di natura; ma parlando propriamente, egli non è sotto la legge perché non è, come Israele, sotto il giogo della Legge. Nessuno infatti vorrà sostenere che la legge naturale, inerente al nostro essere, sia per l’uomo un giogo estraneo: ora la legge del Cristo è per il Cristiano quello che è per l’uomo la legge naturale. La nostra incorporazione col Cristo mistico non è soltanto una trasformazione e una metamorfosi, ma è una vera creazione, la produzione di un nuovo essere (II Cor. V, 17), soggetto di nuovi diritti e perciò di nuovi doveri: « Non sapete dunque che tutti noi i quali fummo battezzati nel Cristo Gesù, fummo battezzati nella sua morte? Noi fummo con Lui sepolti col Battesimo nella sua morte, affinché, come Egli è risuscitato da morte per la gloria del Padre, così noi camminiamo nella novità della vita. Poiché se fummo innestati su Lui dalla somiglianza della sua morte, lo siamo anche da quella della sua risurrezione; sapendo benissimo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato sia annientato, perché non serviamo più al peccato (Rom. VI, 3-6) ». Per chi è familiare col pensiero di Paolo, questo periodo intraducibile non ha nulla di oscuro. Il rito del Battesimo, operando quello che significa, ci genera alla vita divina; ci fa morire a noi medesimi immergendoci nella morte del Cristo; c’infonde il succo divino innestandoci su Lui; ci avvolge della sua grazia e del suo spirito immergendoci nel suo corpo mistico. E allora « non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me ». È evidente che questo essere nuovo richiede operazioni nuove: Operatio sequitur esse. Per conoscere la natura e l’estensione dei nostri obblighi, ci basta che riflettiamo al mistero della nostra nascita soprannaturale. Che cosa vediamo nel Battesimo? Una morte, una risurrezione, una sepoltura, un ritorno alla luce: e queste quattro cose prodotte dal rito sacramentale che le simboleggia, sono destinate a durare sempre, e non solo a durare, ma a crescere ed a svilupparsi. – La morte al peccato è per se stessa consumata e definitiva; perché Gesù Cristo morendo spezza lo scettro del peccato e, facendoci morire con Lui, ci associa alla sua vittoria; ma a differenza della morte fisica, la morte al peccato è suscettibile di più e di meno: non basta mantenerla, ma bisogna condurla alla perfezione: « Voi siete morti e la vostra vita è nascosta col Cristo in Dio… mortificate dunque le membra terrestri: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi (Col. III, 5) ». L’ideale è questo: portare sempre più lontano lo stato di morte di Gesù. La vita della grazia, eterna di sua natura, vuole anch’essa essere continuamente fortificata e rinnovata: « Se voi siete risuscitati col Cristo, cercate le cose dell’alto… aspirate alle cose dell’alto, non alle cose della terra (Col. III, 1-2) ». La nostra sepoltura nel Cristo deve seguire un progresso analogo; perciò l’Apostolo, dopo di aver detto: « Voi tutti che foste battezzati nel Cristo avete rivestito il Cristo », soggiunge: « Rivestite il Signore Gesù Cristo (Gal. III, 27; Rom. XIII, 14)», perché taleatto ammette dei gradi indefiniti. Finalmente Paolo implora per i neofiti illuminati dal Battesimo, lumi sempre più vivi, e li invita a camminare di chiarezza in chiarezza (Ephes. I, 18; II Cor. III, 18).
4. La morale di Paolo, come si vede, sta su basi salde: essa si appoggia, da una parte, sopra la volontà positiva di Dio, proclamata da Gesù Cristo, promulgata dagli apostoli, liberamente accettata dai neofiti nel primo atto di fede; e dall’altra parte, sopra la rigenerazione battesimale e sopra le nuove relazioni che questa produce; poiché dall’essere soprannaturale ricevuto nel Battesimo, derivano speciali relazioni con ciascuna delle tre Persone divine:
Relazione di filiazione verso il Padre;
Relazione di consacrazione verso lo Spirito Santo;
Relazione d’identità mistica con Gesù Cristo.
Analizzare queste tre relazioni e dedurne i corollari equivarrebbe adesporre minutamente tutta la morale dell’Apostolo, enon è questo il nostro scopo: noi vogliamo soltanto tracciare la via; ma questo rapido sguardo ci farà vedere a quali altezze Paolo innalzi se stesso e innalzi anche noi con sé. Tra la filiazione adottiva del Nuovo Testamento e la filiazione teocratica dell’Antico corre un abisso. Quest’ultima era collettiva ed arrivava all’individuo soltanto mediante il popolo eletto; il figlio di Dio era propriamente Israele, e non l’Israelita. Se qualche personaggio dell’antica alleanza riceve eccezionalmente questo titolo, è perché porta su la sua fronte un riflesso profetico del Figlio per eccellenza. Il Cristiano invece è figlio di pieno diritto e personalmente; lo Spirito Santo gli mette su le labbra il nome di Padre che indica le sue nuove relazioni con Dio; ma con le prerogative di figlio egli ne riceve pure i doveri di gratitudine, di fiducia e di amore (Rom. VIII, 15-17). La presenza dello Spirito Santo che ci consacra come un santuario, crea tra lui e noi un nuovo vincolo che è difficile a definirsi, ma che è impossibile negare. Ora ogni nuova relazione è fonte di nuovi obblighi: di qui, per il Cristiano, il dovere di non contristare lo Spirito (Ephes. IV, 30), di non estinguere lo Spirito (I Tess. V, 19), e soprattutto di non distruggere o profanare il suo tempio (I Cor. 16-17; VI, 19; II Cor. VI, 16; Ephes. II, 21). Ma qui abbiamo anche la fonte di privilegi gloriosi: ospite dell’anima giusta, lo Spirito non vi rimane inoperoso, ma in essa produce i carismi, i doni, le grazie dello stato; versa in essa l’unzione e la luce; vi scolpisce la legge di Dio in caratteri indelebili. Così si spiega quella espressione che sembrerebbe enigmatica: « Se siete guidati dallo Spirito, voi non siete sotto la legge (Gal. V, 18) ». Il Cristiano può obbedire alla legge senza essere sotto la legge, perché la legge per lui non è più un giogo esterno che l’opprime, ma un principio interno che lo guida e lo spinge innanzi: ben lungi dall’asservirlo e dall’opprimerlo, « la legge dello Spirito di vita lo libera dalla legge del peccato e della morte (Rom. VIII, 2) ». La dottrina del corpo mistico, il capolavoro di Paolo, non è meno feconda per lamorale che per il dogma. La prima volta che la propone, egli stesso ne fa l’applicazione con una chiarezza che non lascia nulla adesiderare. Nel dimostrare che la diversità delle membra e l’unità di vita sono essenziali a questo corpo di cui Gesù Cristo è il capo e lo Spirito Santo è l’anima, egli ne deduce i doveri reciproci di carità, di giustizia, di solidarietà, con l’obbligo, per ciascun membro, dicollaborare al bene generale (I Cor. XII, 12-27). È tutto un programma di morale sociale compendiato, la cui originalità consiste nel conciliare le esigenze del bene comune non certamente con l’egoismo, ma con la ricerca istintiva dell’interesse personale. Non pare che si possa attribuire al caso ilfatto che le altre tre descrizioni del corpo mistico servano precisamente come di prefazione alla seconda parte delle lettere in cui la morale è nettamente separata dal dogma (Rom. 4,5; Ephes. IV, 12-16; Col. II, 19). L’intenzione appare manifesta nell’Epistola ai Romani, e allora non fanno più meraviglia le raccomandazioni eteroclite di cui abbiamo dato sopra un saggio. Precetti e consigli, in apparenza disparati, trovano la loro unità in questo principio: « Noi siamo un solo corpo nelCristo e, individualmente, le membra gli uni degli altri ». Non è allora evidente che questo principio ha come corollario il dovere « di amarsi con amore di fraternità » e di « prevenirsi a vicenda con l’onore (Rom. XII, 10) ». La dottrina del corpo mistico si presenta sotto un aspetto alquanto diverso nelle Epistole agli Efesini ed ai Colossesi. L’obbligo che ne deriva per ciascun membro è quello di aspirare alla perfezione del capo (Col. II, 19), perché ciascun fedele, affinché vi sia armonia e perfezione, deve sforzarsi di crescere secondo la misura del Cristo.