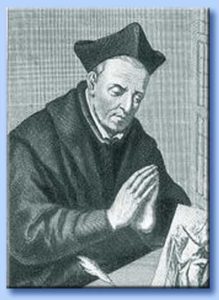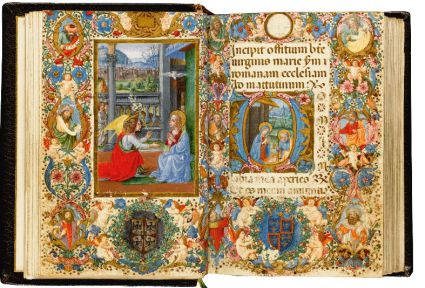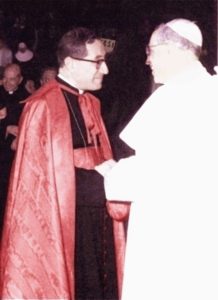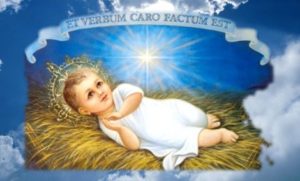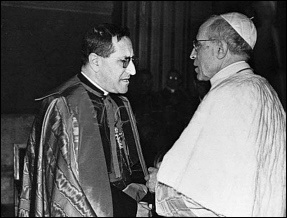
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
[Lettera pastorale scritta il 17 dicembre 1967; «Rivista Diocesana Genovese»,1968. pp. 28-63 ]
(2)
La morale soggettiva ha allargato il campo delle sue esperienze
Delle azioni di un uomo due giudizi occorrono: quello oggettivo, ed è il confronto tra l’atto in se stesso e la Legge; quello soggettivo, ed è il confronto tra l’atto medesimo ed il modo o il limite con il quale era appresa la legge nel momento di offenderla obiettivamente. Questo indiscusso principio ammette la possibilità di un divario tra il giudizio morale oggettivo ed il giudizio morale soggettivo, tanto è vero che esiste un peccato meramente materiale ed un peccato formale. Il primo giudizio deve essere sempre completato dal secondo, ma non deve il secondo mai perderlo di vista, avendolo invece come base e criterio. – In altri termini: la situazione soggettiva in concreto (di uno che non sapeva o addirittura non capiva, od era comunque in stato di ignoranza o di disattenzione), può essere diversa da quella che deciderebbe la obiettività della Legge. – Su questo divario si possono inserire gravi abusi ed è necessario chiarire doverosamente la questione. Ecco taluni punti in proposito.
1. – Che una situazione soggettiva modifichi il giudizio dato secondo la legge obiettiva non lo si presume mai, se non ci sono ragioni per presumerlo od almeno per generare il dubbio. L’essenziale è sapere che cosa modifichi soggettivamente il valore oggettivo dell’atto. La risposta è semplice: modifica il valore oggettivo dell’atto tutto ciò che modifica sufficientemente il «volontario». E il «volontario» dipende dal grado di conoscenza intellettuale e dal grado di intervento della volontà. Sono esse le due radici della imputabilità e della responsabilità. Ciò significa che anche uno stato patologico influisce nella valutazione soggettiva dell’atto compiuto, tanto quanto influisce sul «volontario». Il confessore potrà constatare che esiste uno stato patologico, potrà averne soltanto il dubbio e formularne la ipotesi, ma il punto divisorio tra il suo ufficio e le competenze specifiche in fatto di patologia resta sempre e solo il volontario. – Nessuno nega che chiare ed organiche cognizioni di psicologia e di una prudente psicanalisi gli possano giovare, ma il suo ministero non è né quello dello psicologo, né quello dello psicanalista. Questo deve essere affermato con estrema chiarezza, per evitare delle situazioni ibride, quali sorgono allorché si vuole entrare in un campo dove non si ha specifica e vera competenza e dove, spesso, non hanno competenza sufficiente neppure quelli che se ne intendono sul serio. In altri termini, la morale soggettiva ha come confine il limite di coscienza, che è dato intellettuale. Al di là ci saranno cose interessanti e strane, ma che non entrano di per sé nelle valutazioni necessarie alla amministrazione del sacramento della Penitenza. Il dato soggettivo sta nel tener conto di quello che uno ha intellettualmente creduto ed ha voluto. Il rimanente è oggetto di un altro discorso.
2. — Non si può negare che la esperienza e lo studio moderni abbiano attirato l’attenzione su molti fatti interni all’uomo. Un tempo era difficile sentire parlare del «subcosciente»; oggi il subcosciente» è diventato addirittura un mondo. Dell’uomo sappiamo qualcosa di più. Ciò significa che potremo trovare relazioni tra i fatti, scoprire meglio loro cause o concause. E per ciò che al giudizio del confessore sul dato soggettivo, questo presenta oggi elementi più vari, maggiori e più profondi. Per tale motivo i l Concilio Vaticano II ha ripetutamente inculcato l’uso delle nozioni scientifiche circa la pedagogia e la psicologia, chiedendo un progressivo allargamento delle nozioni solite a darsi ai futuri sacerdoti. [In questo il Sommo Pontefice si è tenuto cauto, viste le circostanze, ma egli ben sapeva che la psicoanalisi moderna è solo una congeria gnostico-giudaica di natura luciferina, quindi di nessuna utilità per il “vero” sacerdote … tutt’altro! Ne riparlerà più avanti. -ndr. -] Una migliore conoscenza del «soggetto», portata da questa più ampia prospettiva, sarà certamente utile al confessore. Egli non capirà molte cose, se non avrà cercato di allargare il campo delle sue nozioni. Tuttavia l’oggetto proprio del ministero della Penitenza resta quello che è indicato sopra: la situazione determinata dal volontario. Se il campo soggettivo, utile a conoscersi, si è indubbiamente allargato, non ne viene che il ministero della Penitenza debba adottare una complicazione di procedura, che si converrà all’onesto psicanalista [anche qui “onesto” psicoanalista è una parila molto grossa! -ndr. -], non al confessore. L’allargamento delle nozioni è per capire» e per poter, con la maggiore comprensione, essere più utili al penitente. Né pedagogia, né psicologia, né psicanalisi hanno mutato l’animo umano. Tutt’al più registreranno meglio i suoi fatti superficiali e reconditi. L’esperienza e lo spirito soprannaturale restano per i confessori i primi necessari piloti della loro azione sacramentale.
3. – C’è un senso nel quale il giudizio sul valore morale soggettivo allarga affatto la sua esperienza. Pertanto è falso e va evitato. Ecco di che si tratta. C’è un modo di considerare il comportamento dell’uomo che ha le seguenti caratteristiche:
– è generico, e pertanto non realizza gli aspetti e i particolari definienti e determinanti;
– è collettivista, ossia considera le azioni dei singoli come attività della massa, con l’effetto di trasferire almeno parte della responsabilità dal singolo alla folla, che è come dire farla svanire. Questa caratteristica è il frutto di un modo sbagliato e forse non avvertito di parlare della socialità;
– è farcito di termini e di slogans alla moda; tali termini hanno il potere di sfrangiare talmente tutto, di coprirlo sotto un suono talmente gradito da allontanare tutti i confini tra il bene ed il male. In tali condizioni tutto passa e lo vediamo benissimo. – Ora tutti i confessori sono in pericolo di giudicare molte azioni del penitente nel modo falso sopra denunciato. Stiano attenti.
La finalità sacramentale della Penitenza non muta.
– Il sacramento della Penitenza deve attuarsi attraverso un giudizio. Il giudizio deve rifarsi ad un criterio. Per questo motivo ci siamo preoccupati di avvertire che il criterio, ossia la legge obiettiva, non cambiava e che l’aspetto soggettivo delle azioni umane, pur cangianti in se stesse, doveva farsi con principi che sono immutabili. Ma ora dobbiamo guardare al Sacramento ed agli effetti che come tale gli convengono.
Perché questi effetti non mutano?
Perché la loro esistenza è legata al dogma, alla dottrina cattolica certa ed immutabile. Infatti per ammettere una evoluzione del sacramento della Penitenza bisognerebbe ammettere la evoluzione del dogma. Ora il dogma si approfondisce e approfondendolo se ne aumenta la ricchezza, la efficacia, la applicazione, ma in sé non muta. La considerazione degli effetti del Sacramento come tale merita un discorso serio e porta a conclusioni assai impegnative.
1. – Materia prossima del sacramento della Penitenza sono gli atti del penitente. Ciò significa che, ove mancano gli atti sufficienti del penitente, non esiste il sacramento e che la mancanza di compitezza negli atti menzionati per lo meno mette a repentaglio la efficacia della confessione. Quindi il soggetto è estremamente attivo. Deve esserlo in modo sufficiente, pena il non raggiungere l’effetto del sacramento. Questo dà la retta indicazione sulla pedagogia e sulla procedura della confessione, come vedremo. – Il penitente dovrà accusare, per quanto sa, specie morale e teologica, il numero dei peccati mortali. Infatti senza cognizione non si può fare giudizio. La umiliazione che porta con sé la accusa dei propri peccati è lievissima espiazione, meritata, per il peccato commesso. Tutto ciò che reintegra nella giustizia, anche se è doloroso, non mortifica, ma completa la personalità umana. La quale senza questa reintegrazione di giustizia resterebbe sempre nella ipocrita situazione di chi è coperto, ma incompleto. La accusa deve essere completata dal pentimento o manifestato o tale che dalle circostanze possa essere supposto. Questo pentimento deve essere serio. Non occorre trascriviamo qui una pagina del catechismo. Questo pentimento serio, e pertanto completato dal proposito di non ricadere nel peccato, è il più importante, anzi essenziale concorso che il penitente dà alla effettuazione del Sacramento. Esso è l’atto che deve esigersi più di tutti gli altri ed alla cui verità tutto deve concorrere nella preparazione del sacramento, nella elaborazione delle disposizioni, nella cauta e ferma esigenza da parte del confessore. Dio con atto sovrano di Sua competenza distruggerà il peccato, dopo che l’uomo libero peccatore lo avrà rinnegato nelle forme debite. Non prima. – È chiara la conseguenza di metodo: la catechesi della Penitenza, la metodologia di una preparazione, debbono puntare soprattutto sulla verità dell’atto di dolore, ornato delle ben note caratteristiche. – Ora, la pedagogia di preparazione del penitente su questo punto è gravemente trascurata: non se ne parla quasi mai (ed è senza fallo una colpa), non si creano (salvo che nelle confessioni dei collegi e dei bambini) quasi mai le condizioni di stimolo, di istruzione, di avviamento per la preparazione agli atti della confessione; pochissimi mettono facilmente a disposizione gli strumenti che richiamano un tempo ed efficacemente alla preparazione seria. Non si va errati se si afferma che la maggioranza delle confessioni non sono preparate. La gravità della cosa sta nel fatto che il pericolo di non portare la sufficiente penitenza dell’animo nelle confessioni non preparate è veramente grande. Per la santa Messa almeno si preparano i paramenti, la materia del sacrificio, le candele; per la penitenza, in genere, si prepara e si insegna a preparare nulla. Ripetiamo: la mancanza della penitenza, ossia del dolore ornato di tutte le caratteristiche fissate dal catechismo, compromette tutto il sacramento della Penitenza. – È questo il punto delicato per cui il sacramento della Penitenza viene tenuto ben lontano dal puro formalismo, dalla mera e meccanica tradizione, dal semplice gesto esterno che soddisfa la opinione di chi vede. Se la pastorale non torna ad occuparsi fino in fondo della preparazione delle disposizioni del penitente, si cancella in parte la efficacia di un fondamentale sacramento. – Il luogo adatto è condizione preliminare; per questo i confessionali non si possono mettere dove la gente ciarla e si distrae. I sussidi per la preparazione, tabelle e libretti, devono essere considerati non meno necessari delle candele per celebrare la Messa. Una disciplina osservata nel luogo ove si attende e ci si prepara la si deve inculcare a tutti, cominciando dai bambini. Insomma il sacramento, che è un atto divino, è anche un atto compiuto da uomini (penitente e confessore), umano, e che impegna a fondo tutta la responsabilità e la dignità degli uomini. Anche i peccatori hanno una dignità, nonostante la colpa; quella dignità superstite che hanno la devono portare integra e con solennità al compimento dell’atto divino. Le azioni fatte per direttissima sembrano essere entrate nel margine morale della esperienza moderna. Ma questo è un errore, perché l’uomo impreparato ad un atto, il quale di per sé esige preparazione, è veramente e non nobilmente incompleto. Il che non vale solo per il sacramento della Penitenza.
2. – Il principale effetto del sacramento della Penitenza, ricevuto con tutte le condizioni richieste è la remissione del peccato. Consideriamo anzitutto questo: la stima del sacramento della Penitenza sarà sempre proporzionata al concetto severo che si ha del peccato. – L’orientamento di non parlare di peccato, di non allarmare ed allarmarsi, di non temerlo e vergognarsene è orientamento deleterio della vita cristiana. Non c’è amore del mondo che tenga, rispetto per i non credenti che valga, a questo proposito. Il peccato grave è la morte dell’anima e la conclusione, almeno per il momento, negativa della stessa ragione della propria esistenza. A che prò, in fin dei conti, un sacramento della Penitenza, se il peccato è una trascurabile cosa, è una organizzazione del complesso di inferiorità che distrugge la persona umana, che la dissolve in un mito pietoso e ridicolo, etc? – La valutazione del peccato e del sacramento della Penitenza sono perfettamente correlative: insieme stanno, insieme cadono. Né basta che la valutazione del peccato la si tiri fuori per i bambini, allo scopo di impaurirli e contenerli, in certi momenti in cui brandelli di pratica cristiana istillano o richiedono una certa stima dell’Inferno. No, o questa valutazione sta intellettualmente e coscienziosamente alla base della vita o prende le dimensioni della ipocrisia e la inconsistenza della semplice paura. Tutta la educazione impartita, tutto il contegno, tutti gli enunciati intellettuali debbono fedelmente concorrere alla perfetta valutazione del peccato. – Bisogna spiegarsi. Chi maneggia senza alcun ribrezzo certa stampa, senza dare chiaramente a vedere quale motivo di dovere lo spinge a maneggiarla, educa chiunque lo vede alla svalutazione del peccato. Chi apre incautamente il video, senza ragione e senza cautela, mostrandosi stranamente tranquillo davanti ad esibizioni che per molti temperamenti sensibili possono costituire occasione grave e prossima di peccato, ottiene lo stesso risultato ed è inutile che tuoni contro la ingiustizia o la immoralità. Chi copre con i facili slogans azioni ed orientamenti al tutto alieni in qualsivoglia comandamento di Dio aiuterà tutti coloro che cadono nel raggio della sua influenza a farsi una idea di minimizzazione della colpa e ad ammetterla con allegria comunitaria. – Chi rimane non solo impassibile di fronte a certe esibizioni, ma tenta quasi di sembrare galante semplicemente non crede più al peccato, almeno in modo sufficiente. – La valutazione del peccato ha taluni particolari che debbono colorare sempre la catechesi abituale. Per esempio: è verità certa ed indiscutibile che la persona macchiata dal peccato mortale è incapace di qualsiasi vero merito, retribuito soprannaturalmente nella eternità. Infatti il merito soprannaturale ha per base lo stato di grazia, che non coesiste con il peccato grave. Ciò significa che una volta in peccato mortale è inutile agli effetti della gloria eterna, tanto qanto per essa si è esteso od è durato lo stato di peccato. Potrà non essere inutile ad altri effetti di minore e diversa portata. – Ancora: la valutazione del peccato grave non si separa dal senso di incombente pericolo della dannazione eterna. Sappiamo bene che questa parola da taluni la si pronuncia sottovoce o la si sottace. Non credano per questo di abolire l’Inferno, dato che, mentre per andare in Paradiso bisogna assolutamente crederci, per andare all’Inferno non occorre in alcun modo crederci. – È facile e doveroso prevedere che con questa moda di «non far caso al peccato del mondo», magari per poter meglio gettare ponti con esso, il sacramento della Penitenza avrà zone e livelli di paurosa desuetudine. Nessuno si metta in grado di doverne rispondere a Dio. A forza di far mostra che il peccato non esiste, non macchia e non contamina, se ne distrugge la valutazione, con le conseguenze sopra esposte. – Il peccato non muta nelle sue condizioni essenziali, nella sua fisionomia ontologica, nelle sue conseguenze teologiche. Pertanto muta la principalità del sacramento della Penitenza nel mondo del peccato. E credere che quello in cui viviamo sia diventato mondo di angeli e di profeti è semplicemente una stupidità.
3. – Non muta la grazia sacramentale della Penitenza. Essa è obiettiva nella grazia attuale, erogata per causa sua durante e dopo il sacramento, per un certo tempo con uno scopo ben determinato. Eccolo: contenere la debolezza per cui si pecca, aumentare le capacità reattive alle pericolose attrazioni della colpa, irrobustire la perseveranza alla quale si è impegnati nell’atto di dolore, emesso nel sacramento stesso. Ciò significa che il sacramento della Penitenza, mentre restituisce la santità essenziale, aiuta a perseverare nel bene ed è uno dei più grandi rimedi con i quali si provvede alla propria debolezza. È difficile, in circostanze ordinarie, esista la continua fuga del peccato, almeno grave, senza la periodica immissione della grazia sacramentale della Penitenza. Chi crede di essere intangibile per i propri filosofemi, superbamente affermati, per la propria intoccabile dignità personale, è sull’orlo della caduta tutti i giorni e probabilmente cadrà nel modo più stolido e pacchiano. Ha bisogno del Sacramento. Qui non ci si dimentica affatto della grazia sacramentale della santa Comunione; ma resta vero che, per divina istituzione, i due sacramenti non si sostituiscono in modo da lasciare – per chi ha peccato – una libera alternativa. Essi si integrano. – Finché la debolezza degli uomini non cambierà, ci sarà bisogno della grazia sacramentale del sacramento della Penitenza. Cambierà forse la debolezza degli uomini? Credete? Perché stanno aumentando le suggestioni, tanto che sono l’astuto fondamento della politica di massa, i conformismi, la corruzione di tutti gli organismi umani? Il discorso sarebbe lungo, la risposta è una sola ed è ora di farsela risuonare alle orecchie, prima che sia troppo tardi: la debolezza aumenta, per lo meno nella proporzione con cui aumentano le apparecchiature che impressionano gli uomini oltre misura. – In conclusione: la clientela bisognosa della Penitenza non è diminuita, è spaventosamente aumentata. Abbiamo detto e ripetiamo: «spaventosamente».
4. – Il rito sacramentale è finora immutato.
Infatti il rituale è tradotto in volgare, ma non ha ancora subito una vera riforma. Il rituale costituisce una Legge che obbliga in coscienza e che nessuno può a suo arbitrio alterare. Il Concilio Vaticano [il conciliabolo, il falso concilio c. d. Vaticano II, scomunicato con largo anticipo dalla bolla Exsecrabilis di Pio II, e che come tale non possedeva alcuna autorità ed i cui documenti sono da rigettare in blocco cme abominio della desolazione, cosa che Gregorio XVII sapeva molto bene da profondo teologo e canonista quale egli era, e che lascia sottoindendere a chi ha occhi per vedere ed orecchie per ascoltare – ndr. – ] nella Costituzione Liturgica, ha disposto una «recognitio», ossia un ritocco ed eventualmente una riforma dei libri liturgici, ma non ha dato a nessuno l’autorità di innovare. La «recognitio» è affidata ad un Consilium, che trae il suo potere dalla suprema Autorità pontificia [quella vera, che allora come oggi è esautorata ed in esilio –ndr. – ]. Ci sono poi elementi che una qualunque «recognitio» non potrà mai toccare, perché non sono soltanto elementi rituali, passibili di mutazione, sono invece richiesti dalla sostanza teologica del Sacramento della Penitenza, così come lo ha concepito Cristo e il Magistero della Chiesa ha finora insegnato [fino cioè al 1958, finché c’è stato in successore di Pietro liberamente operante – ndr. – ]. I due campi: quello liturgico e quello – più grave – teologico sono chiusi alle libere iniziative dei privati e dei Vescovi stessi, le cui conferenze dovrebbero, in ogni caso, avere il benestare della Sede Apostolica [quella vera, naturalmente – ndr. – ]. Quello teologico e sostanziale è chiuso alla innovazione di chicchessia nella Chiesa, la quale non può mutare la dottrina certa e acquisita [questa è una chiara allusione ed un avvertimento per far comprendere da quali mani fosse gestita l’«apparente» chiesa dell’apostasia vaticana – ndr. – ]. Non ci consta che qui da noi ci siano stati abusi o innovazioni risolubili nell’esercizio del Sacramento della Penitenza. Da noi però si è parlato assai di innovazioni indotte o tollerate altrove e, se abbiamo scritto, ciò è anche perché i cattivi esempi non attecchiscano là ove Noi abbiamo responsabilità davanti a Dio. – Eleviamo la nostra accorata protesta contro tutti gli abusi che sono stati fatti: eleviamo tale protesta perché è nostro il diritto di difendere dai cattivi esempi i nostri figli. I sacerdoti si sappiano regolare secondo quello che abbiamo qui esplicitamente richiamato. – Non siamo disposti a tollerare abusi, qualunque sia il luogo da cui si importano. Sia ben chiaro che certi tentativi illegittimi di innovazioni sono solo la testimonianza di una inquietudine, di una deficienza di criterio teologico e forse di ignoranza, da ispirare vera e profonda pietà. – Il mondo attende da noi un ancoraggio, non delle avventure.
La soprannaturalità deve dominare la amministrazione del Sacramento
Cerchiamo di fissare gli elementi concreti, con i quali si attua questa soprannaturalità.
– Lo spirito di Fede.
Nell’amministrare il Sacramento della Penitenza lo spirito di Fede, per intervento positivo e virtuoso della volontà, obbliga a vedere, con la chiarezza della luce di Dio, alcune cose. Eccole:
– La dignità dell’anima del penitente, chiunque egli sia, dato che per redimerla Cristo è morto in Croce:
– l’avverarsi, a proposito della stessa anima, in quel momento di tutto il mistero della Redenzione;
– la enormità della macchia dalla quale Dio in quel momento libera; anche quando si tratta di colpe veniali, valutandole nella eterna luce della grandezza di Dio, appare chiara la infinita misericordia;
– l’avvenire glorioso dell’anima, che viene ristabilito;
– la debolezza alla quale la grazia sacramentale provvede;
– il passo compiuto verso il compimento del numero degli eletti.
Certo, perché questa visione soprannaturale si componga nell’anima del confessore, siccome richiede il rispetto al Sacramento, occorre che egli faccia «sempre», prima di ascoltare qualunque penitente, uno sforzo di raccoglimento, magari per un solo attimo, e veda l’immenso sfondo sul quale egli in quel momento agisce. Riteniamo che il proponimento di un attimo di raccoglimento faccia parte del dovere sacerdotale e che solo il rispetto a quel proposito lo possa portare al livello, al quale sta un Sacramento. – L’effetto certo sta nella devozione, ossia nella pietà profonda, con cui agisce nel Sacramento.
2. – Combattere la «abitudine», che può prevalere nella amministrazione del Sacramento. Spesso i penitenti sono numerosi e si succedono. Spesso i casi si succedono ripetendosi con monotonia. Raramente salta fuori un complesso spirituale che sveglia l’attenzione, acuisce l’interesse. Tutto questo, unito alla immobilità, al dispendio fisico, ad altre circostanze di fatto o di ambiente, conduce ad una sorta di ripetizione meccanica. Questa lascia intatto il Sacramento in sé e nel suo effetto, tuttavia non si potrebbe dire che il confessore abbia assolto bene e reverentemente il suo compito. Egli deve reagire alla meccanicità con tutte le forze dell’anima sua, aiutandole con una preparazione di preghiera e con il ricorso brevissimo alla stessa preghiera, allorché avverte l’infiacchimento psicologico, che tende a pervaderlo. Solo con queste pie avvertenze egli circonda di ambiente soprannaturale il Sacramento che amministra. Questi piccoli consigli sono «determinanti» per avere una degna amministrazione della Penitenza.
3. — Non confondere il Sacramento con qualcosa di profano.
Non si può ammettere l’esercizio della curiosità. Questa è facile, perché si è nel momento in cui un’anima apre se stessa. Essa è generalmente disposta o rassegnata a lasciarsi «leggere». Questo rende facile la soddisfazione della curiosità. Ma tale soddisfazione nulla ha a che vedere con il Sacramento, perché in esso si rappresenta tutto di Dio e nulla di noi stessi ed il servirsene per uso proprio, per lo meno, prepara una possibile profanazione. Per lo stesso motivo non è ammissibile la divagazione della chiacchiera. La chiacchiera, ammesso che sia onesta, non trova assolutamente il suo collocamento nella Penitenza, deve andare altrove. Resta inteso che quanto è necessario alla integrità della accusa ed all’espletamento del multiplo dovere del confessore non è mai chiacchiera. Questa spesso è desiderata da taluni penitenti e da tutto un settore di penitenti, facilmente individuabile. Ma si deve risolutamente resistere, anche se la resistenza può esser fatta – finché hanno effetto — con modi contenuti, sereni e dolci. La chiacchiera ha la capacità di insinuarsi come l’aria e tutto può esser buona scusa per non ostacolarla: conoscenza, direzione, stanchezza, un po’ di varietà in tanta monotonia. Attenti, quanto entra la chiacchiera, altrettanto se ne va quella soprannaturalità, che dipende dal contegno dei due attori, penitente e confessore. – Il discorso della chiacchiera che sfiora o insozza la sfera dei sentimenti verrà appresso. Il senso soprannaturale del Sacramento esclude nel confessore una certa anche confusa mentalità psicanalista. Cerchiamo di mettere le cose in chiaro. Molti ingenuamente e per fare qualche elogio al Sacramento della Penitenza lo avvicinano alla psicanalisi; qualcuno anzi asserisce che la psicanalisi è una profana imitazione della confessione. La differenza tra i due istituti è netta, totale, enorme. Ed ecco il perché. Anzitutto la psicanalisi ha un presupposto ideologico che non può accordarsi né con la natura obiettiva delle cose, né con la dottrina cristiana. Anche se quel presupposto ideologico è piuttosto tramontato, continua però a sostenere tutta la travatura della pratica psicanalitica e facilmente la contamina. In secondo luogo esiste una linea precisa di demarcazione: la confessione comincia dal «cosciente» in su; la psicanalisi comincia dal «subcosciente in giù». Quindi, anche per chi non credesse al Sacramento, sono due «livelli» al tutto diversi. Spieghiamoci. La confessione considera solo il peccato e questo comincia solo da un atto cosciente e libero. Quanto si è svolto prima o al disotto della attuale coscienza responsabile non interessa direttamente la confessione. – La psicanalisi pesca in tutte le costruzioni fatte al disotto del livello di coscienza e, se anche qualche volta lo psicanalista ascolta il racconto di un fatto libero, non è quello che lo interessa, per definizione. – La psicanalisi sguazza in tutto quello che è istinto, reminiscenza, fantasia e sentimento; ama i fondali dove la umanità conserva ed accumula tutte le testimonianze della sua miseria. La confessione tratta il peccatore in quanto ha mancato per un atto interno di consenso spirituale e non rimescola quanto può umiliarlo. – E qui c’è un punto importante a considerarsi: la persona sottoposta a psicanalisi uscirà dalla seduta sapendo di aver rivelato vergogne, che forse non sono neppur sue perché fluiscono da una registrazione subcosciente di sensazioni dall’esterno; il penitente che esce dal confessionale ha rivelato il peccato, non la deformazione costituzionale, alza la testa e si sa redento. – Nella confessione la persona è rispettata e non solo per il sigillo del segreto, ma per una valutazione teologica; nella psicanalisi il soggetto si trova ravvolto dal manto innominabile delle anomalie patologiche e indicibili. [In pratica la falsa scienza psicoanalitica, che non ha nessuna caratteristica di scienza sperimentale, non essendo dimostrabile in nessun modo, tanto meno con i risultati clinici, è piuttosto “ideologia gnostica”, nella quale la “scintilla divina”, cioè l’essenza divina ingabbiata nella materia “corpo”, e che secondo la gnosi è parte stessa di Dio, sua emanazione, non è corruttibile, per cui i conflitti si instaurano sulla componente “anima”, che viene lasciata ed incitata ad estrinsecarsi libertinamente, soprattutto attraverso il peccato, che per tale ignominiosa pratica, è metodo terapeutico liberatorio da nevrosi, psicosi ed altre psicopatie … una vera idiozia di origine luciferina, in assoluto e diametrale contrasto con la teologia cattolica, quindi da respingersi in toto e sotto ogni aspetto, come ci suggerisce opportunamente il Sommo Pontefice Gregorio XVII! – ndr. – ] I confessori chiariscano bene le loro idee e non indulgano mai alla tentazione di fare un po’ di psicanalisi, quasi che questo aggiungesse un prezzo umano ad un deficiente valore divino. Netta separazione: si tratta infatti di assurde e imperdonabili contaminazioni. La vera cura contro tali contaminazioni consiste in una chiara coscienza dell’argomento e in un solido rispetto a tutte le regole, ben strette, che la tradizionale teologia morale ha dettato e circa i limiti di accusa del penitente e circa i limiti di interrogazione da parte del confessore. – La psicanalisi ha già infettato teste, pratiche, costumi, letteratura, politica, ogni mezzo di comunicazione sociale: sta a noi impedire che infetti il sacramento della Penitenza. La preoccupazione non è fuor di luogo perché taluni moralisti, che sono senza alcun dubbio fuori di ogni consenso teologico, le hanno aperte le porte. – I sacerdoti della nostra Diocesi [e del mondo intero -ndr. -] sono avvertiti. Noi non neghiamo affatto che la terapia psicanalista possa dare dei risultati. No. Ma parliamo di terapia, non di filosofia. Quello che importa è che il possibile onesto nella psicanalisi venga lasciato ai medici specialisti e che i preti non pretendano sostituirsi a detti medici, tanto più contaminando un Sacramento.