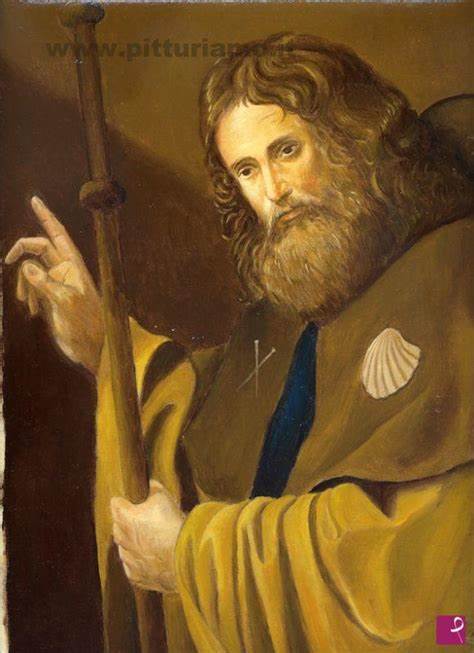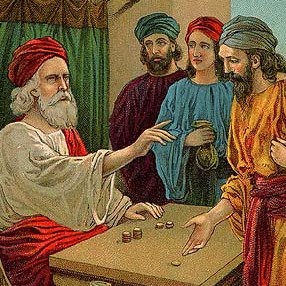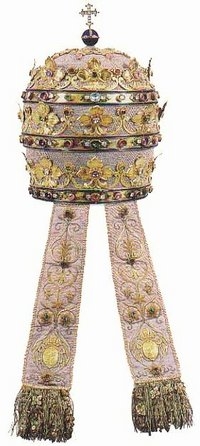

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (44)
HENRICUS DENZINGER
ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT
ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.
ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM
De rebus fidei et morum
HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI
Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar
B. – DIO SUSSISTENTE UNO E TRINO
1. DIO “uno” secondo natura.
B1. a. – ESSENZA DIVINA
Si definisce l’Essenza metafisica di Dio (sec. i Tomisti), Essere sussistente, 3623; si spiega 3601-3604 3623s. Identità (reale) tra essenza e perfezioni di Dio. ogni perfezione di Dio ne è l’essenza: Dio è verità, sapienza etc., non una sola è participe 285; di Dio infatti è essere quanto volere, similmente volere quanto sapere 566; cf. e la semplicità di Dio, sotto B lbb. Riprov. asserzioni che peccano per eccesso 973s.
B 1b. b. – ATTRIBUTI DIVINI
1ba. AttributI trascendentali. Unità di Dio: Fedes in un solo Dio (per quanto in alcuni simboli, l’ “unum” omesso si riferisce a singole Persone divine) 3-5 42//50 71 108 125 150 800 3001 3021 3875; Dio è una sostanza singolare 3001; è similmente uno del Vecchio e del Nuovo Testamento 198 325 790 854 1334 1336.
Verità (ontologica) di Dio: Fede nel “vero” Dio 3 42/150 60 125 1800 1862 3001 3021 3026; Dio è la fonte di ogni verità 2811;
Bontà (ontologica) di Dio: Dio è il bene infinito, o il sommo bene (62) 240 285 .287 470 621 1333 (3002) 3004s .3251; ripov. l’asserzione che concepisce Dio come bene extra ragione 978.
1bb. Attributi quiescenti. Dio è: increato, incomposto 75 501; -: infinitamente perfetto (in ogni perfezione) 2751 3001 3623; add. infinitamente buono: B lba; in Lui niente è imperfetto 569; non abbisogna di nessuna partecipazione 285 358; non si lascia vincere nel numero dalla ragione della sostanza 530 -: eccelso sopra ogni cosa 3001; Maestà 73 75 293 529 1331; add. C 2a.
– incomprensibile ed ineffabile 294501 525 800 804 3001
– semplice (non composto, indiviso) 297 800 b805 ab1880 3001
-: personale 3542 3875 3890; sussistente in tre persone: vd. B 2.
– immutabile 285 294 297 501 569 683 800 853 1330 2901 3001
inconvertibile 197 358 416; in Dio non c’è emanazione o evoluzione 3024; nulla aumenta o sminuuisce 285 569.
– sostanza spirituale 3001; infatti Dio (Padre: Dio) è invisibile a16 a21 a39 b293s 683 853 3001; non può esprimersi con colori o figure 1825.
— : immenso 75 800 1330 3001; non circoscritto ed incontenibile 504:
nulla si estende fuori da Dio 204; pertanto Dio è dappertutto ed onnipresente (per potenza, presenza, essenza) 2185 a3330.
– eterno (sempiterno) 27 71 74s 147 173 284s 291 293 441 683 800 853 1330 1337 2828 3001; è senza inizio 501: Deus (aPater; bFiglio di Dio) è immortale a21s b294 b297 b358 b681 b801 b852 b1337; Dio (Padre) è il re dei secoli 21s; errore dei Teopaschitari: [Dio Figlio che soffre sec. divinità mortale] 359; vd. et E la.
1bc. Attributi operativi. Vita di Dio in genere 40 (173) 3001.
Vita intellettiva: Dio è (infinitamente) sapiente 2901 3001 3004 3009 3781; onnisciente 164 169 3009 3646;
In specie: ha la scienza dei cuori e dei segreti 670 2866; conosce in anticipo (scienza della visione) le future libere scelte delle creature (333 419) 621 625-629 646 685 3003 a3646 3890; queste quindi hanno verità determinata 1391-1395;
Dio non può fallire 3008.
Vita volitiva: Dio è —: volontà infinita 3001;
— libero da necessità 526 3890;
— volontà razionale, non preveniente la sapienza 526;
— giusto 285 621 1547 1549 1672 2216 3781:
— buono e misericordioso verso gli uomini 62 236 248 309 1534 1548s 1562 1576 1668 1696;
— verace: non può fallire 3008; Dio è la fonte di ogni verità 2811:
— onnipotente (referendosi solo ai luoghi più importanti di Dio in quanto uno. 680 683 685 800 851 1330 1880 3001; le singole Persone si dicono “onnipotente” 29 75 164 169 173 441 490; massimamente nei simboli l’onnipotenza si attribuisce al Padre 2//64 71 115 125 150 191 290 297 441; alla volontà di Dio niente può resistere 647; si riprov. l’asserzione che restringe la potenza di Dio 410 721 726s.
Vita affettiva : Dio è (in e fuori da Sè) beato 415 441s a3001.
Dio è impassibile ed inviolabile (soprattutto affermato contro i Theopaschiti la passione del Figlio incarnato che ripugna all’essenza della stessa Trinità)
16 166 0196s 284 293s 297 0300 318 358 0359 0367 504 635s 681 801 852 2529; si può pure dire “Dio che soffre nella carne”: vd. E 2ba.
2. Dio trino secondo le Persone.
B 2a a. — ESISTENZA DELLA TRINITÀ DELLE PERSONE IN DIO.
2aa. Testimonianze della fede. Fede nelle singole Persone divine, nel Padre, Figlio, Spirito Santo 1//30 36 40//51 55 60-64 71 73 75 105 125 144s 150 188 300 325 367 421 441 451 470 485 490 501 525 542 546 680 790 851 1330; add. forma Battesimo: J 3a.
Fede nella Trinità divina come tale: 3s 6 71 73 75 112 115 177 188 325 367 421 525 528s 546 568s 680 790 800 851 1330 1880.
Sono esclusivamente le tre Persone: al di fuori di Esse nessun altro possiede la divina natura 188 851; si riprovano i Priscilliani introducenti altri nomi della divinità fuori dalla Trinità 452; questa Trinità non moltiplica di numero 367; queste tre Persone in sé non si ridimensionano o diminuiscono, permangono 144;
Il Verbo di Dio, pertanto non ha mai fine 160.
2ab. Applicazione della ragione umana alla rivelazione della Trinità divina: è mistero incomprensibile all’intelletto, ineffabile, inenarrabile 167 367 525 616 619 2669; nella Trinità è inesplicabile la generazione 114; riprov. dell’assunto circa la dimostrabilita’ della Ss. Trinità e della sua identificazione con la realtà, l’idealita’, la moralità 3225s.
B 2b. b. — PROCESSIONI DIVINE
Pater. Sue proprietà: è senza principio 1331; da nessun altro è fatto o creato o generato c60 abc075 e441 ac485 bc490 be525 bc527 569 c572 c683 800 1330s; ciò che ha lo ha da sé 1331.
È principio generante 71 284; è fonte ed origine o principio di ogni divinità a490 a525 a568 b3326; il Padre genera il Figlio non per volontà, non per necessità, ma per natura a71 526; il Padre genera da Sè, dalla sua sostanza 470 485 525s 571 617 805 1330; senza sua diminuzione trasferisce la sua sostanza al Figlio 805; pertanto non è solo che per il Padre (sec. Ario) che si debba dire “Dio” 176 1332.
Attributi (appropriati al Padre): onnipotente 21/64 71 115 125 150 191 290 297 441; riprov.: [al Padre propriamente appartiene l’onnipotenza, non anche la sapienza e la bonta] 734.
Il Creatore ossia il fondatore di ogni cosa 27-30 36 40//51 60 125 150; “dal quale viene ogni cosa” 60 421 680 (851) 3326; ogni cosa fece per mezzo del F. e dello Sp. Sancto 171; è il dominatore dell’universo 1 5.
Re dei secoli immortale 21s.
Invisibile 16 21s 29.
Riprov. del predicato: [Croce del Figlio è la passione del Padre] 284; [Al Padre si può attribuire l’avvento alla fine del mondo] 737.
2bb. Figlio. Sue Proprietà: è principio dal principio 1331; è (veramente e propriamente) generato o nato dal Padre 40//51 71 75 113 125 144 150 163 a168 188s 272 284 485 490 503 526s 547 554 564 568s 572 681 851 1830 1337 2526.
È della sostanza o natura del Padre (non da altra sostanza) c43 a44 c45 a48 c49 a76 a125 c126 c144 a163 ab441 c526 c900 a2526; ciò che il Figlio ha, lo ha dal Padre 1331; il Padre da al Figlio tutto il suo “essere Padre” (900) 01301 01986 3675; è al Padre consustanziale: vd. B 2cba.
Non è parte (particola) del Padre 526 805; non è estensione o continuazione del Padre 160.
Non è fatto o creato dal nulla 042//50 60 75 113s 125 a126 a130 150 155 209 485 490 a526 536 1332 a2526; nel senso sec. Prov. 8,22, Figlio si dice “creato” 114; non è sostantivo 160.
È unico (unus) Figlio (oltre il quale non ce n’è altro) 4s 12/130 36 62s 0105 502; pertanto unigenito 2s I I 25 27 40//51 60 125 150 178 258 266 272 291 300 302 318 357 538 683 900 2526 3350 3352; solo Figlio da solo Padre 75 800 1330.
È generato dal Padre non per volontà o necessità, ma per natura 71 526.
È generato senza inizio o principio 357 470 526 536 572 617 1331; eternamente (atemporalmente) a490 504 (611) a617 681 852 900 1300s 1331 (3274); è dal principio con il Patre 61; sussiste dall’eterno in eterno
(126) 147; fu prima di ogni secolo (prima di ogni principio, ab aeterno) 40-42 48 50s 60 76 b126 b147 150 a189 272 294 a297 301 357 427 a441
485 0490 503s 526 538 547 554 568 571 (611) 617 681; è primogenito di ogni creaturae 40 50s 60 (490); riprov. l’asserzione ctr. l’eternità del Figlio [avrà fine; è mortale] e futura mutazione 43 45 47 49 113 126 130 a160 b359 2526.
Appellativi (oltre al nome “Figlio Dei” il più frequente): “Verbo di Dio” (Logos) 40 55 113 144 147 178 250/1263 427 502s 852 3326; Che invero non è da concepire come Verbum parlato 144 147; disapprovato come termine principale il titolo “Verbum” 2698; “Sapientia” (113) 148 476; “Sermo” 148; “Virtus” 113.
Predicati (appropriati al Figlio): Figlio rapportato alla creazione come “per il quale tutte le cose” 40//51 60 125 150 421 680 3326; “per il quale sono compaginati i secoli” 50s; si dice “creator di ogni cosa” 485.
2bc Spirito Sancto. Sue Proprietà: non è né ingenito né generato ab71 ab75 b485 b490 b527 b617 ab683; procede d Padre e dal Figlio [“Filioque”] 42 44 a48° 51 64 (a64) 71 (a71°) a75 (147) 150 (gr.) a150 (lat.) 178 (188) a284 441 a470 a485 a490 a527 546 a568s a617 a682s a800 a850 a853 a1072 a1300 a1330 a1986 a3807; lo Spirito è del Padre e del Figlio 178 527s 441 490; “Filioque” razionalmente è aggiunto al simbolo (perché si può provare) 1302 1986 a3553.
Sp. S. Procede come da un tanto principio o spirazione, non da due principii a850 a1300 ab1331 1986; si può dire: Sp. S. Procede dal Padre per mezzo del Patre Figlio 1300; lo Sp. S. è concepito dal Figlio sec. i Greci per causa, sec. i Latini come principio di sussistenza 1301 1986; lo stesso procede in quanto Spirito S. dal Figlio, il Figlio stesso lo ha dal Padre 1301.
Un solo tanto Spirito, che solo procede 40s 51 71 108 a1330. Sp. S. è fin dall’inizio 568 800 1331; procede eternamente (atemporalmente) 441 617 850 1300 1331 1986; è sempre e senza fine 800.
È di sostanza divina 168; riprov.: [non è della sostanza del Padre] 722; si rivendica la sua divinità increata ctr. errori: [Sp. S. è servo, creatura fatta per mezzo del Figlio] 44-49 71 75 145 a152 155 a170 485 490 527 617 1332 2527.
Appellativi: Paraclito 1 41 44 46 60 64 188; Dono 570 1522 1529s 1561 1690 3330.
Predicati (appropriazione allo Spirito S.): Sp. S. riferito alla creazione come, “in quo tutte le cose” 421 680 3326; riprov.: [Sp. S. è l’anima del mondo] 722.
Amore, in particolare tra Padre e Figlio 3326 3331; volontà 573 nella storia della salvezza allo Spirito S. si attribuisce— : l’ispirazione o locuzione per mezzo della Legge, i Profeti, gli Apostoli 41//48 150 682 790; —: incarnazione del Verbo: vd. E 5ba; non veramente è da credere Padre del Figlio 533; —: disceso al battesimo di Cristo 44 46 48 – — : sacrificio di Cristi 3327; —: riposare in Cristo 178; in modo peculiare si dice “Spirito di Cristo” 3807.
Nella vita della Chiesa lo Sp. S. è concepito come —: anima della Chiesa 3328; abitante in essa 600; congiungente le membra 3808; —: assistente ai concili e nelle preghiere nelle decisioni circa la fede e gli ordini 102 265 444 631 1500s 1600 1635 1667 1726 1738 1820.
Nella vita della grazia dei fedeli è concepito come —: fonte della grazia creata 3807; per i suoi doni si dice Sp. settiforme, Sp. di sapienza etc. 178 183 1726; ad Esso si appropriano i carismi 3328 3342; —: vivificante 3s 42 51 62 150 62 150 546; —: purificante 62s; — cooperante alla giustificazione illuminando e muovendo 374-378 387 1525 1552 1678 3009s; è lo stesso dono (altissimo) delle giustificazioni 1527 1529s 1561 1690 a3330; agisce nei Santi dell’eternità 60; inabita nei Santi e giusti 44 46 48 1962 3329-3331 3814s; i loro corpi sono tempio dello Sp. S. 1822; —: cooperante ai sacramenti 123 183 320 793 1774; —: alla perfezione delle virtù 3343.
Il peccato contro lo Spirito Santo è facente parte della potestà della Chiesa di rimettere qualsiasi peccato 349.
B2c. c. — LE PERSONE DIVINE TRA DI LORO COMPARATE.
2ca. Distinzione delle Persone tra loro. Esistenza della distinzione (ctr. la posizione del modalismo): Dio è uno, ma tuttavia, no è solitario 71 451 490; la Trinità divina non è sussistente in tre nomi 284-546; le Persone non sono da identificare, pertanto come Dio si nomina in egual modo il Filio, lo Sp. S. 73 75 112 154 188 192-194 284 451 530 569 1330; non il Padre incarnato è morto 105; uno è il Padre, non tre, etc. 75 421.
Ragione della distinzione: Padre, Figlio, Sp. S. sono nomi relativi 528 532 570; per quanto attiene al relativo, discretamente sono da predicare le proprietà delle tre Persone 570 573 800; altro è il Padre, altro il F. etc., non tuttavia altro è il P., altro F. etc. 573 80; nel Nome relativo sono designate anche le altre Persone 532 570; al nome “Spirito S.” Per questa relatività non si può sostituire pienamente il nome “Dono” 570.
Proprietà delle Persone tra loro comparate: il Padre è dall’eternità senza nascita, il Figlio è dell’eternità con la natività, lo Sp. Santo e procedente senza natività con l’eternità 532; oppure: il Padre è generante, il Figlio è generato o nascente, lo Sp. S. procedente 71 188 284 367 470 (526) 800.
Conseguenze logiche della distinzione delle Persone: Non è trasferibile all’essenza divina, quello che è proprio delle Persone 367; non pertanto “la cosa ” (sostanza divina) è generante, generata, procedente, ma il Padre è generante, il Figlio generato etc. 803s.
2cb. Eguaglianza delle Persone tra loro. Comparazione del Figlio con il Padre: il Padre non è generato da nessuno, è da se stesso 525; al Figlio da tutto ciò che è suo (senza diminuzione) tranne l’ “essere Padre” a470 b526 a805 1301 1986; il Figlio pertanto è (co)eguale al Padre per tutto, in nulla dissimile 74(76) ab144 164 b290 441 470 485 a490 491 a526 536s 572 617 a681 a852 1337; è della stessa natura 144 297 470; è consustanziale al Padre 42/151 55 125 138 150 272 301 357 430 441s 504 526 547 554 617 619 681 852 1337 (1880) 2526 2529 3350 3675.
In particolare si predica di questa eguaglianza per la — divinità 74 144 149 168 295 318 357; il Figlio è infatti Dio da Dio 40/151 125 144 150 490 (525); luce da luce 40//48 125 144 150 525; vita de vita 40; —: onore, gloria, maestà 74 290 318; —: eternità (coeterno) 27 74 290s 297 357 441 526 (611) 617 1337; —: sapienza o scienza 164 169 566 573; —: volontà ed (onni)potentia 144 164 169 290 566 573 681n852; add.: Gesù Cristo perfetto Dio: E la.
Comparazione dello Spirito Santo col Padre e col Figlio: lo Sp.S. è veramente dal Padre come dal Figlio 168; è al Padre e al Figlio — : consustanziale 29 46 55 (152) 441 853; —: (co)eguale 71 175 441 527 569 853; e lo stesso in onore e maestà, quindi a da coadorare, b da conglorificare ab42 147 ab150 a174 ab546; —: coeterno (sempiterno) 71 441;
—: eguale in potenza e virtù (29) 145 147 152; è in ogni luogo come il P. ed il F. 169.
Comparizione simultanea delle tre Persone: P., F., Sp. S. sono di una medesima natura 297; quindi a consustanziale o b coessenziale a3 ab325 a415 421 a442 a501 502 a516 a542 b547 554 a616-618 ab680 b682 ab790 a800 a805 ab851; in sè coeguali 4 75 169 173 415 441 537 616-618 682 800; pertanto nella Trinità nulla è inferiore, superiore, maggiore, minore 75 569 618.
In particolare si equiparano P., F., Sp. S. —: in divinità (sono Dio a pieno, b perfetto) 4 73 75 176 a325 b441 a529 a790 ab851; —: in gloria, maestà 73 75 501 529 1331; — in eternità (nella Tr. nulla è primo o posteriore) a75 a144 162 173 284 a618 1331; sono tra sè coeterni 75 147 325 546 616-618 680 682 790 800s 853; nessuna esiste prima o dopo l’altra o senza l’altra 531; — immensità (sono ovunque, contengono ogni cosa) 75 169 173; —: potenza 75 173 325 529 680 790 800 853; non sono di diverso grado di diverso grado di potenza nella Tr. 144 721 1331.
Riprov. errori ctr. l’eguaglianza delle Persone e dello Sp. S. sono creature] a155 721s 734 a1332.
2cc. Esistenza mutua (circumincessione) della Persone. Il Figlio sempre è nel Padre (e viceversa) 113 115; il Verbo necessariamente è unito a Dio 112 115; lo Sp. S. rimane in Dio ed inabita 112; il Padre tutto è nel Figlio, tutto nello Sp. Santo, etc. 1331; questo stesso procede dal Figlio, lo stesso Figlio lo ha dal Padre 1301.
B 2d d. — PERSONE DIVINE COMPARATE CON L’ESSENZA DIVINA.
2da. Identità reale dell’essenza divina nelle tre Persone. Principi: le tre Persone sono un solo Dio 71 73 75 112 325 530 546 680 683 853 1330; il numero in Dio concerne solo la ragione delle Persone 530; unica divinità è il nome delle tre Persone 188 441; trina Unità— una Trinità 441 501 546.
Nelle tre Persone è una (a medesima, b comune, c singolare) la divina sostanza (o essenza, natura) 3 71 73 75 144s 147 153 172 177 188 a284 c367 415 421 441 451 b470 485 490 501 525 527-529 535 542 546 616 683 800 804s 806 1330 2527; lo stesso è il Padre come il Figlio, lo stesso il Padre ed il Figlio come lo Spiruto S., id est: di natura è uno Dio 573 805; Dio non solo in senso ablativo si dice di essenza divina, ma pure in senso nominativo 745.
La forza dell’essenza divina esclude in Dio una quaternità 804.
L’unità della sostanza nella Trinità è così forte, che non è minore nella singola quanto in tutte le Persone. (441) 490 529.
Nelle tre Persone c’è —: una gloria 73 172 542 546; —: una maestà 144s 172 177 490 525 542 618 680 851; —: una verità 172; —: una volontà.; 172 501 542 545s 572s 680 851; —: una virtù 73 144s 415 421 441 451 490 501 525 542; —: una potestà (potenza) 3 71 73 (144) 153 172 177 415 421 441 451 490 501 546 680 851; —: una operazione 415 441 501 531 542 545s; —: una dominazione, un regno 172 501 542 548 3350; —: una beatitudine 415 441.
Tutte le cose in Dio sono uno, ove non si trova opposizione di relazione 1330; la sola natura divina è principio dell’universo 804.
La Trinità è la divinità consustanziale 284s 415.
Nelle tre Persone divine c’è la a individuale, b indivisa (indivisibile) c inseparabile, d indistinta (indiscreta) essenza divina bc73 c144s b188 b284 b290 d318 d367 bd415 d490 c505 b529 c531s c538 c542 c545s c561 c571 c569 c616
a683 a800 d805 d2697 bc3326 b3815.
Sequele logiche dell’essenza identica una indivisibile in qualunque Persona divina: “Dio” non è un nome relativo o di proprietà, ma nome di potestà che si applica in modo speciale 71 528;
Quanto si dice essenzialmente della natura della Trinità, si può dire per il singolo numero che per le tre Persone 542; infatti per il singolare numero si dice:
Deus Pater, Deus Filius etc. 529; non “tre Dii” 71 73 75 176 529 546 683 853 1330; non: “tre onnipotenti, increati, immensi etc.” 75 529 (pecca ctr. questa regola 173: “omnipotenti”); non: Dio (deitas) è triplice, ma: trino (trina) 528; non: Dio distinto in tre Persone, ma: distinti (2696) 2697 2830; non: battezzato nei nomi del Padre etc., ma: nel nome del Padre etc. 415 441.
Conseguenze cultuali: la Sostanza della Trinità indistinta è distintamente adorabile 367; non conviene riferire il culto ad una singola Persona trinitaria, ma offrire un culto comune alla Trinità 3325; infatti non esiste una festa propria delle singole Persone 3325.
2db. Distinzione della ragione tra essenza divina e le Persone. Non è da stabilire la divisione tra la natura divina e le Persone 745 803; il Trideismo è riprovato il trideismo che separa la natura unica delle Persone, introducendo tre dii, volontà ed operazioni personali 112 115 367 545 1880 3325; tuttavia non è da negare ogni distinzione in Dio 973s.
e. — OPERAZIONE DI DIO TRINO AD EXTRA.
2ea. Unità delle operazioni delle Persone all’esterno. Pater. F. et Spirito S. sono di operazione unica (171 325) 415 441 501 531 542 545s; per forza di principio: tutto in Dio sono un unico, ove non lo contrasti opposizione di relazione 1330.
Le opere della Trinità sono inseparabilmente indivise, comuni 491 531 535 538 571 618 3326; nessuna Persona opera prima o dopo l’altra o senza l’altra 531; le Persone divine a non sono tre principi di creatura, ma uno solo, cioè. b una sola natura divina 800 b804 a1331.
Pertanto l’Incarnazione è operata in comune da tutta la Trinità 491 535 57 I 801 3327; Sp. Sanctus si inserisce nell’operazione e remissione dei peccati col Padre ed il F. 145; l’inabitazione e l’opera di salvezza nelle anime dei giusti, per quanto attribuita allo Spirito S. sono comuni alla Trinità 3331 3814.
2eb. Appropriazioni fatte alla singole Persone. Fondamento: una certa similitudine ed affinità tra l’opera e la proprietà della Persona divina 573 3326.
Quindi la creazione è riferita alle singole Persone sec. la formula: Padre, dal quale tutte le cose, Figlio per cui tutte le cose, lo Sp. S., in cui tutte le cose 421 680 (851) 3326; oppure: P. ha fatto tutte le cose per mezzo del Figlio e dello Sp. S. 171.
Facoltà dell’anima riferite alla Trinità: al Padre la memoria, al Figlio l’intelligenza, allo Sp. S. la volontà 573.
Al Padre sono appropriate le opere nelle quali eccelle la potenza 3326; creazione dell’universo. 171 3326; cf. Il predicato “onnipotente” è attribuito solo al Padre”: vd. B 2ba. Al Figlio sono appropriate le opere nelle quali eccelle la sapienza (causa esemplare delle cose) 3326; la riconciliazione degli uomini con Dio 3326; vd. anche B 2bb.
Allo Spirito Santo sono appropriate le opere nelle quali eccelle l’amore e la bontà divina 3326; l’incarnazione del Verbo: vd. E 5ba; le opere completanti la santificazione dell’anima, inabitazione nel giusto: vd. B 2bc.
2ec Missioni delle Persone divine. Missione di Gesù Cristo Figlio di Dio 101 145 527 538 1522 3806.
Missione dello Spirito Santo: è mandato dal Padre e dal Figlio 60 145 527 681 3325 3327s: la sua missione è doppia: manifesta nella Chiesa, segreta nell’anima del giusto. 3327; la festa della sua missione è il giorno di Pentecoste 3325.
TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA (45): “INDICE DEGLI ARGOMENTI -IV-“