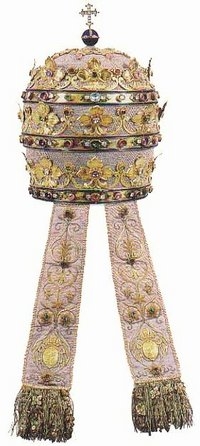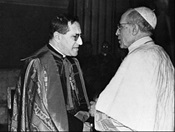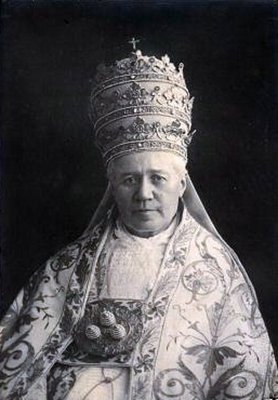IL SILLABARIO DELLA MORALE CRISTIANA (8)
FRANCESCO OLGIATI,
IL SILLABARIO DELLA MORALE CRISTIANA.
Soc. ed. Vita e Pensiero, XIV ed., Milano – 1956.
Imprim. In curia Arch. Med. Dic. 1956- + J. Schiavini Vic. Gen.
Capitolo terzo (3)
LA LEGGE DELL’AMORE
III. – L’AMORE DI NOI STESSI
E’ famosa nella storia della Chiesa la polemica svoltasi un giorno fra Bossuet e Fénelon. Il Vescovo di Cambrai, nel suo Livre des maximes des Saints, sosteneva che il timore dell’inferno o la speranza del paradiso corrompevano la purezza dell’amore e che non v’era amore vero, se non quando l’anima amava Dio esclusivamente per Lui stesso, senza pensare a sé. « V’è uno stato abituale d’amore di Dio — diceva Fénelon — che è una carità pura, senza miscuglio alcuno dei motivi di interesse nostro. Nè paura di castighi, né desiderio di premio hanno parte a questo amore ». Un’anima, anzi, può essere persuasa, d’una convinzione invincibile e riflessa, che è riprovata da Dio ed in pari tempo amare Dio e fargli il sacrificio assoluto della propria eterna felicità. La ricompensa è il motivo specifico e l’oggetto formale di un’altra virtù: la speranza. – Il Vescovo di Meaux, invece — ed il suo Traité sur les états d’oraison sviluppa la sua idea, appoggiandosi su tutti i Padri, e specialmente sui due suoi preferiti, san Bernardo e sant’Agostino, ragionava press’a poco così: se noi amiamo Dio, dobbiamo volere tutto ciò che Egli vuole ed amare tutto ciò che Egli ama; orbene, Dio ama noi e vuole la nostra beatitudine; perciò, il vero e puro amore di Dio comprende l’amore di noi stessi, l’aspirazione alla nostra beatitudine, il timore di perderla. « E’ dunque chiaro che tale desiderio e la domanda della felicità futura, malgrado le raffinatezze dei nuovi mistici, secondo i sentimenti di tutti i santi cominciando dagli Apostoli, appartengono alla carità ed alla carità perfetta ». Gesù, del resto, nel Vangelo continuamente ci incita a pensare alla salvezza della nostra anima, ad agire bene per conquistare la vita eterna, a fuggire il male per non cadere nell’inferno. Noi sappiamo come la Chiesa sia intervenuta nella polemica ed abbia dato ragione a Bossuet, mentre Fénelon umilmente s’inchinava e si sottometteva al giudizio della Santa Sede. Ma sappiamo anche come l’episodio sia il simbolo d’un conflitto, che nel campo della morale dura da secoli, tra la felicità e la virtù, tra l’utile ed il bene. Questi due concetti hanno dato del gran filo da torcere ai moralisti ed intorno a questo problema, da Socrate a Platone, da Aristotele sino a Hobbes ed all’utilitarismo inglese, da Cartesio e da Leibniz sino a Rousseau, a Kant ed a Hegel, si è travagliata la filosofia e si è suscitata viva la discussione fra coloro stessi che sono profani ai dibattiti filosofici. Da un lato, è innegabile che esiste in noi una tendenza irresistibile alla felicità. Per quanto i filosofi discordino nel resto, nota il Cathrein, su questo punto si trovano tutti all’unisono. Scegliamo alcune testimonianze dalle più svariate tendenze filosofiche. Aristotele, che in tutte le sue indagini muove da fatti sperimentali sicuri, nel primo capitolo della sua Etica a Nicomaco prese come punto di partenza di tutta la sua teoria la tendenza naturale alla felicità. Egli affermò esser manifesto che tutti aspirano alla felicità perfetta. Allo stesso fatto accennò spessissimo Platone nei suoi Dialoghi, specialmente nel Convito, nel Gorgia e nel Politico. Cicerone, nell’Ortensio, partiva dalla massima assolutamente costante, di cui nessuno può dubitare: cioè, dal desiderio ardente di essere felice, comune a tutti gli uomini. Gli stessi Stoici, del resto avversi a ogni genere di soddisfazione, qualificavano la felicità come fine etico dell’uomo. Ad essi tenne dietro lo stoico dell’età moderna. « Esser felice, pensava Kant, è necessariamente il desiderio di ogni creatura ragionevole, finita; conseguentemente un motivo inevitabile del suo appetito.. Che abbia seguito la medesima opinione tutta la turba degli eudemonisti moderni, i quali rappresentavano la felicità possibile ed immaginabile con la suprema norma morale, è inutile ricordarlo. Anche il padre del pessimismo moderno, Schopenhauer, fu della stessa opinione: « L’uomo vuole incondizionatamente conservare la sua esistenza; vuole esser assolutamente libero di dolori; vuole la maggior quantità possibile di benessere ed ogni godimento di cui è capace ». Lo stesso Fénelon riconosceva che « l’inclinazione naturale e indeliberata alla beatitudine è invincibile come l’amore alla vita »; e solo aggiungeva che si può non seguirla negli atti deliberati, alla stessa guisa che, nonostante l’inclinazione spontanea alla vita, si può risolvere deliberatamente di morire. Tutti, dunque, vogliono essere felici; e l’utile è voluto da tutti, anche dai filosofi che cercano di deprezzarne il valore a vantaggio del bene. Dall’altro lato, però, non si può neppure negare che la coscienza morale, se non fa le necessarie distinzioni, quando uno aspira alla propria utilità e tende al suo vantaggio personale, si rifiuta di parlare di atto virtuoso. Molti, anzi, restano perplessi e scombussolati dinanzi a certi disinteressatissimi pensatori e scrittori dei giorni nostri, i quali accusano Cristo di avere insegnato una morale interessata, basata sul paradiso e sull’inferno, e dicono: « Si deplorano gli strozzini, quando fanno dei prestiti al cinquanta per cento; ma che si deve dire del Cristiano, che, agendo per una felicità eterna, fa dei prestiti a Dio all’infinito per uno? Il motivo utilitario del cielo o del fuoco infernale altera il carattere morale di un’azione e ci spinge fra le braccia dell’egoismo. È immorale agire per l’inferno o il paradiso. V’è un’etica più alta, più nobile, più disinteressata, che ripudia cupidità di calcoli, volgarità di compensi, tenebre di paure, e vive nelle serene regioni del disinteresse.
Come si vede, l’argomento non potrebbe essere più interessante.
1. – L’utile ed il bene
Per non giocare con le parole e per non cadere negli equivoci, gioverà premettere un’osservazione. L’utile può essere considerato in due modi: in astratto ed in concreto.
1. In astratto, il concetto di utilità nulla dice pro e contro la morale. È ridicolo confondere l’utilità con l’egoismo, tant’è vero che si può ricercare la propria utilità, senza essere egoisti. Ad es., gli operai di una grande società anonima odierna vanno all’officina, lavorano e sudano non già perché si sdilinquiscano d’amore per gli azionisti che non conoscono neppure, ma per avere il loro salario giornaliero o settimanale, ossia per il loro utile; c’è forse qualche puritano che vuol scagliare pietre contro questi lavoratori, accusandoli di egoismo? – L’aspirazione alla nostra felicità è stata posta da Dio nei nostri cuori ed è fonte di mille benefiche conseguenze: sveglia, eccita, suscita energie: sprona, suggerisce ed incoraggia iniziative; e quando è regolata, ossia subordinata alla morale, è una delle forze umane più provvidenziali. Oh, che dovremmo forse agire per essere infelici? Ciò non sarebbe la negazione dell’egoismo; sarebbe uno schietto cretinismo.
2. In concreto, possiamo tendere alla nostra utilità in due maniere: o facendo di noi il centro della realtà (concezione antropocentrica); o ponendo a centro dell’universo Iddio (visione teocentrica). Nel primo caso, sì, abbiamo un utile egoistico, e che perciò contrasta con la morale. L’egoismo consiste nell’erigere il proprio io ad Assoluto, a Dio, e nel sacrificare gli altri a noi. Mi è utile avere un’automobile: e la rubo. Mi è utile stracciare un trattato: e lo definisco un pezzo di carta. Si scorge allora la miseria, intellettuale e morale, dell’etica utilitarista. Sia che si tratti d’un utile individuale, oppure d’un utile nazionale o collettivo, non è mai riducibile il concetto morale a quello di utile e, quando si tenta una simile operazione, si nega la moralità. Mi è utile avere un milione; ma posso forse appropriarmelo indebitamente, pur sfuggendo alle reti del codice penale? Mi è utile opprimere un’altra nazione libera ed indipendente; ma è forse morale questo? Fra l’altro, la morale deve dirmi se un’azione è buona o cattiva, prima che io la compia. Se avessero ragione gli utilitaristi, io non potrei sapere se un atto è buono o cattivo, se non dopo averlo compiuto, perché solo allora è possibile giudicare della sua utilità. Ad es., la Germania nel 1914 ha invaso il Belgio per passare in Francia: era lecito un simile procedimento? Secondo gli utilitaristi, il governo tedesco sarebbe stato moralissimo facendo invadere il Belgio, se la ciambella fosse riuscita col buco; dato che l’invasione del Belgio ha cominciato a rovinare tutto il piano prestabilito dagli invasori, bisognerebbe oggi concludere che quel governo ha agito in modo immorale. È forse lecito un simile sragionamento?.-Nel secondo caso, quando poniamo non solo teoricamente, ma anche praticamente Dio al centro della realtà, il cercare la propria utilità, ossia la propria felicità, non solo non fa a pugni con la morale, ma non ci può essere atto morale che non sia utile e non ci orienti alla felicità. Si può concepire un Dio, Ragione perfetta e perfetto Amore, il quale costituisca un universo, in cui chi agisce moralmente debba affrontare quaggiù mille sacrifici e battaglie e che poi in compenso, debba andare incontro alla propria infelicità? Può un Dio-Amore crearci per renderci infelici, non per colpa nostra, ma per suo volere? Essenzialmente diverse sono l’utilità egoistica e questa felicità che consegue all’amore nostro per Dio. La prima fa del proprio io l’Assoluto; l’altra considera come fine ultimo Dio e la propria felicità come fine subordinato. La prima è l’aspirazione all’utilità immediata (anche scevra d’onestà), che passa e sfuma; l’altra è l’utilità immedesimata con l’onestà e giudicata dal punto di vista di Dio, ed è la sicurezza che l’atto morale conduce alla gioia nonostante le angustie, i sacrifici, i dolori del presente. L’uno ripone la felicità nelle piccole cose transeunti; l’altra la ripone (come vedremo, parlando della sanzione della morale) in Dio, ossia nella visione intuitiva e nell’amore di Dio, che saranno il massimo perfezionamento soprannaturale del nostro spirito e della nostra personalità.
2. – Amore perfetto ed imperfetta di Dio
Quali sono, adunque, i principi della morale cristiana a proposito delle azioni fatte con l’aspirazione alla felicità? Si possono ridurre a due. Li esporremo con semplicità.
1. Se uno dovesse fare il bene od evitare il male escludendo l’amore di Dio, ma unicamente per amore di sè, non compirebbe un atto naturalmente onesto, nè un atto cristianamente buono. E quando Ippolito Taine ha definito la virtù: « Un egoismo, munito di cannocchiale lungimirante », ha semplicemente preso un grazioso granchiolino.
2. Perchè ci sia un atto cristianamente buono, occorre l’amore o imperfetto o perfetto di Dio. Supponiamo che una persona ci aiuti, ci soccorra disinteressatamente, ci dimostri un vero amore. Nel cuore nostro noi distinguiamo due sentimenti, che si intrecciano insieme, che anzi si fondono in una sola cosa, tanto che solo all’analisi minuta si mostrano distinti. Noi, cioè, siamo contenti per i benefici ricevuti da quella persona (e ciò si riferisce a noi) e sentiamo gratitudine per il benefattore (e ciò riguarda non noi, ma l’altra persona). Questa gratitudine è amore, che non è confondibile col vantaggio ricercato, che resta anche quando io non abbia più bisogno di aiuto, che ci fa amare quella persona in quanto è buona in sè e buona per noi. La sua bontà noi l’abbiamo conosciuta attraverso l’utile nostro; e fu l’utile nostro ciò che ha suscitato in noi l’amore; ma l’amore che portiamo poi alla persona non è proporzionato alla quantità di bene che ci ha fatto, ma alla sua intima bontà. Noi l’amiamo, quindi, e perché è degna in sé di essere amata e perché ci ha beneficato. Tale amore noi lo chiamiamo imperfetto, perché, pur non essendo riducibile all’egoismo né ispirato al gretto utilitarismo, ha però come motivo anche il proprio utile. Qualora invece noi, da questo primo gradino dell’amore, dovessimo ascendere più in alto ed amare quella persona prescindendo dai benefici avuti, solo per se stessa, perché è degna di essere amata, avremmo un amore perfetto e d’amicizia. – Amare Dio per i beni ricevuti, per la rugiada di grazie naturali e soprannaturali che ha fatto piovere sopra di noi, per il paradiso che ci prepara; amarlo perché gli siamo grati di essere morto per noi sulla Croce e d’averci redenti; non offenderlo, e perché gli siamo riconoscenti ed anche perché non vogliamo perdere la nostra vera felicità ed anzi la speriamo da Lui, non è un male; anzi è buona ed ottima cosa; e l’azione immorale calpesta tutti questi nobilissimi motivi, che il Vecchio ed il Nuovo Testamento ci inculcano, ci raccomandano, ci ingiungono; ma in questo caso noi amiamo imperfettamente Iddio. Il nostro diventa amore perfetto, quando — da questo trampolino della riconoscenza, del santo timore suo (da non confondersi col timore servile), dalla speranza, in una parola dall’amore per Dio che implica anche, subordinatamente, l’amore giusto e ragionevole per noi — spicchiamo il salto a Dio amato unicamente per sé, per le sue perfezioni infinite. – Si tratta di due categorie di amore, nelle quali l’amore perfetto racchiude l’imperfetto e lo supera. Io le paragonerei al raggio ed al sole. Con l’amore imperfetto noi guardiamo Dio nei suoi benefici, ossia nei raggi del suo Amore; con l’amore perfetto noi ci tuffiamo nel Sole, dal quale partono bensì i raggi, ma è infinitamente più bello in se stesso ed è la pienezza dell’Amore. Felicità nostra (utile) e amore non son cose che contrastino tra loro, né se ci poniamo a guardarle in rapporto a Dio, né in rapporto a noi, né in rapporto all’atto morale. Dio, perché Amore, deve volere la nostra felicità e la vuole; e noi volendo Dio e amandolo, vogliamo la nostra felicità, che consiste in Lui e in Lui si assomma. Noi, se amiamo Dio, ossia se viviamo moralmente e cristianamente bene, siamo felici: abbiamo, nello stesso periodo della prova, la tranquilla dignità della nostra coscienza e la convinzione del vantaggio che al prossimo nostro deriva dal dovere compiuto e dall’amore fraterno praticato; avremo, nell’altra vita, il coronamento supremo degli sforzi fatti, ossia il paradiso, in cui la felicità consiste nella visione e nel possesso di Dio e nell’amore. Là, nel paradiso, utile e bene coincidono. In se stesso, l’atto morale è sempre utile, come la vera utilità (non effimera e passeggera) è sempre morale, procedendo l’utile ed il bene dall’unico Dio, che essendo Amore, ci vuole felici e buoni e che, quanto più noi dimentichiamo il nostro piccolo io e trascuriamo noi stessi per amor suo, tanto più ci rende e ci renderà felici e contenti. Chi è più felice del vero e perfetto Cristiano? Colui che ama Dio solo per Dio, ogni volta che ha un dolore lo santifica e lo cambia in un atto di amore; ogni volta che ha una gioia, invece di fermarsi al raggio, sale al Sole e benedice ed ama Dio in se stesso, ed in questo raggiunge la massima gioia.
3. – Conclusione
Nei laboratori di biologia si fanno tante volte esperimenti sopra animali che si uccidono e si tagliano a pezzi. Uccidere un cane, un gatto o un coniglio, non è difficile per lo scienziato; ma ciò che nessun laboratorio riesce a fare, è l’operazione inversa: raccogliere, cioè, le varie parti divise in un tutto unico e vivificarle ancora. press’a poco, se non erro, ciò che capita in morale. I filosofi prendono l’atto morale, vivo, uno ed unico, e lo uccidono, lo tagliuzzano, lo esaminano pezzo a pezzo, e sovente conservano un pezzo solo, gettando via le altre parti. Ed ecco allora pullulare i sistemi, ognuno dei quali ha nelle sue mani un lato dell’atto morale e si illude di possedere il tutto unico, già precedentemente rovinato. E chi si sofferma sulla materia dell’atto morale, chi sulla forma; chi parla dell’utilità dell’atto buono e chi discorre di ciò che costituisce la moralità dell’azione; chi guarda il vantaggio sociale dell’atto morale e chi mira al perfezionamento intimo della personalità umana da esso causato. E, di divisione in divisione, si vanno moltiplicando i punti di vista, i metodi d’indagine, le costruzioni sistematiche. Queste ultime, non possono abbracciare l’azione etica nel suo complesso e nelnfremito della sua vita: la sintesi è impossibile, quando nel processo analitico si è perduta l’anima unificatrice.
Il Cristianesimo, mi pare, è più profondo, più comprensivo. Nessun punto di vista è da esso trascurato. Materia e forma dell’atto morale, utile e bene, natura e soprannatura formano un unico tutto, dove Dio, l’amore del prossimo ed il nostro bene sono tre punti organicamente congiunti. Non si può amare Dio, senza amare noi e gli altri; non è possibile raggiungere la felicità, se non nell’amore di Dio e del prossimo; non è possibile considerare gli altri, prescindendo da Dio e da noi. Le verità parziali degli altri sistemi sono qui raccolte, e non in una somma; ma in una sintesi vivente. Anche per questo motivo i sistemi di morale, persino i più alti, hanno avuto un’efficacia scarsissima nella formazione delle coscienze; mentre da venti secoli Cristo è il grande educatore dell’umanità.
Riepilogo.
Gesù stesso ha sintetizzato la sua morale nel precetto dell’amore: dobbiamo amar Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come noi stessi. E’ necessario, perciò, analizzare questa legge suprema dell’etica cristiana, studiando l’amore di Dio, l’amore del prossimo e l’amore che dobbiamo a noi.
I. – L’AMORE DI DIO. – Il vero amore di Dio, nel quale consiste la morale di Cristo, non è il semplice amore della creatura per il Creatore, bensì l’amore soprannaturale, il cui principio ci è infuso dallo Spirito Santo, col quale amiamo Dio come Padre. Tale amore presuppone quaggiù la fede ed implica la speranza. Di conseguenza, l’amore di Dio, voluto da Cristo:
a) non è l’amore sensibile, ossia non può essere confuso col sentimentalismo
b) non è un amore di pure parole. Esso, al contrario esige:
a) che si ami Dio con tutto il cuore;
b) con tutta la mente;
c) con tutte le forze, ossia con la volontà e le azioni nostre.
E si distingue:
a) in un amore comandato, che ci dà il campo del dovere o dei precetti;
b) e in un amore consigliato, che è il campo dei consigli.
L’amore di Dio implica che si faccia la sua volontà. Di qui deriva sia il vero concetto della rassegnazione cristiana e della santa indifferenza ignaziana, come altresì la valutazione esatta intorno alla vita attiva o contemplativa.
II. – L’AMORE DEL PROSSIMO. — E’ un comandamento « nuovo», portato da Cristo, perché non consiste solo in un amore umano, a base di pura umanità, ma in un amore umano divinizzato. Essendo tutti i Cristiani uniti a Gesù Cristo e formando con Gesù un unico organismo, noi:
a) siamo tutti fratelli in Cristo;
b) amiamo con Cristo — ed il nostro amore umano per il prossimo è sublimato dalla sua grazia soprannaturale;
e) amiamo Cristo nei nostri fratelli, né potremmo dire di amare Gesù, se non amassimo anche il nostro prossimo.
III. – L’AMORE A NOI STESSI. — I filosofi discutono da secoli intorno ai rapporti esistenti fra l’utile e il bene, fra la felicità e la virtù, cioè fra l’amore a noi e l’amore a Dio o agli altri. La morale cristiana risolve tali questioni osservando che noi possiamo tendere alla nostra felicità in due modi: o amando noi sopra ogni cosa, facendo del nostro io il centro dell’universo e subordinando tutto a noi (ed in questo caso siamo egoisti, non Cristiani); ovvero amando Dio sopra ogni cosa. È evidente che amare Dio significa volere ciò che Egli vuole; e siccome Egli vuole e non può non volere la nostra felicità, anche noi dobbiamo tendere a quest’ultima, come a fine subordinato. Quindi:
a) chi dovesse fare il bene od evitare il male unicamente per amore di sé escludendo l’amore di Dio, non compirebbe un atto morale, cristianamente buono;
b) chi fa il bene od evita il male solo per amore di Dio, agisce moralmente, con amore perfetto.