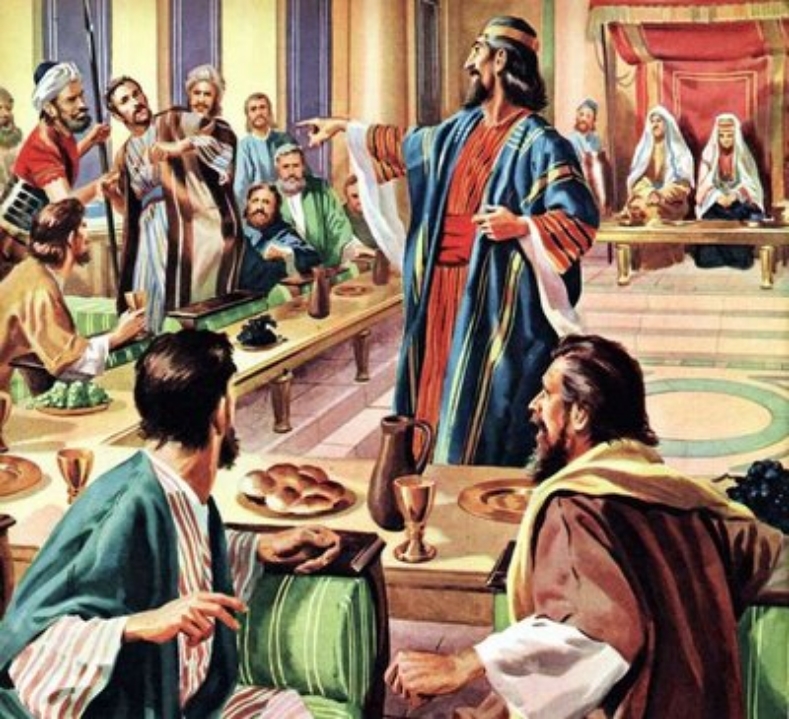IL CATECHISMO DI F. SPIRAGO (XVI)
CATECHISMO POPOLARE O CATTOLICO SCRITTO SECONDO LE REGOLE DELLA PEDAGOGIA PER LE ESIGENZE DELL’ETÀ MODERNA
DI
FRANCESCO SPIRAGO
Professore presso il Seminario Imperiale e Reale di Praga.
Trad. fatta sulla quinta edizione tedesca da Don. Pio FRANCH Sacerdote trentino.
Trento, Tip. Del Comitato diocesano.
N. H. Trento, 24 ott. 1909, B. Bazzoli, cens. Eccl.
Imprimatur Trento 22 ott. 1909, Fr. Oberauzer Vic. G.le.
PRIMA PARTE DEL CATECHISMO:
FEDE (12).
9. Art. del Simbolo: la Chiesa (2)
5. LA CHIESA CATTOLICA È INDEFETTIBILE ED INFALLIBILE.
1. L’INDEFETTIBILITÀ DELLA CHIESA.
La stessa religione mosaica non poteva essere distrutta né dalla cattività babilonese né dagli sforzi dei tiranni per costringere gli ebrei all’idolatria. Strepitosi miracoli (i tre giovani nella fornace, Daniele nella fossa dei leoni) hanno sempre preservato la sinagoga. Lo stesso vale per la Chiesa cattolica. Essa ha come tipo l’arca di Noè, inaffondabile nelle piene del diluvio e tranquillamente depositata da esse sulla roccia delle montagne dell’Armenia.
La Chiesa cattolica è preservata e diretta dallo Spirito Santo Spirito, che la rende indefettibile ed infallibile nel suo insegnamento. La Chiesa, dice Sant’Ambrogio, è un carro guidato da Dio stesso.”
La Chiesa cattolica è indefettibile, cioè ci sarà un Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti, dei fedeli, e il Vangelo sarà predicato fino alla fine dei tempi.
Cristo ha detto: “Le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa”. (S. Matth. xvi, 18) e inoltre: “Il cielo e la terra passeranno, ma le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa” (S. Matth. XVI, 18). Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.”. (S. Luc. XXI, 33).
Le opere di Dio non possono essere distrutte, come disse Gamaliele al Sinedrio. (Act. Apost. V, 38). Le parole di Cristo: “Le porte dell’inferno…”, ecc. significano che il potere di tutti i demoni non sarà sufficiente a rovinare la Chiesa.
L’Angelo Gabriele aveva già annunciato a Maria che il regno del Figlio suo non avrebbe avuto fine. (S. Luc. I, 33). – La Chiesa è come la luna: sembra che stia tramontando e in realtà non sta tramontando.
È oscurata, ma non annientata. (S. Ambr.) La barca di
essere coperta dalle onde, ma non naufragare, perché contiene Cristo.
(S. Ans.) Chi attacca la Chiesa non la sconfiggerà, perché il Dio che la protegge è più potente di tutti gli uomini.
(S. J. Chr.) Chi attacca la Chiesa non la sconfiggerà, perché il Dio che la protegge è più potente di tutti gli uomini.
con Dio, ma non trionfare su di lui.
1. QUANDO LA CHIESA È IN PERICOLO IMMINENTE, CRISTO VIENE MERAVIGLIOSAMENTE IN SUO AIUTO, SIA CON MIRACOLI, SIA CON UOMINI PROVVIDENZIALI.
La Chiesa è come la barca di Pietro: al culmine della tempesta, Cristo si sveglia e le ordina di calmarsi (S. Gir.) Come si rallegrarono i farisei e gli scribi quando fecero crocifiggere Cristo e sigillare e custodire la sua tomba con le guardie! Ma il terzo giorno Gesù è risorto nella gloria e i suoi nemici sono stati confusi.
Questo stesso fenomeno si è ripetuto nei secoli. L’imperatore Diocleziano (+313) aveva perseguitato così violentemente i Cristiani che gli furono eretti monumenti con questa iscrizione: “All’imperatore Diocleziano, distruttore del nome cristiano”. E cosa accadde? Costantino il Grande gli succedette e fece del Cristianesimo la religione dell’impero. La gioia dei pagani per la rovina del Cristianesimo era finita. – La persecuzione provocata da Napoleone non durò a lungo. Per la Chiesa, la festa di Pasqua, della Risurrezione, segue infallibilmente il Venerdì Santo delle persecuzioni. Nei momenti critici, Dio ha sempre suscitato nella Chiesa uomini provvidenziali. (Vedi art. VIII del Simbolo, 2. IV).
2. TUTTI I PERSECUTORI DELLA CHIESA HANNO SPERIMENTATO LA VANITÀ DEI LORO SFORZI; MOLTI DI ESSI SONO FINITI TRISTEMENTE.
La misera morte di Giuda è l’immagine della fine dei persecutori del Cristianesimo e della Chiesa. Erode, l’uccisore dei S.S. Innocenti, il persecutore di Gesù Bambino, fu divorato da una massa di insetti che erano penetrati nelle sue viscere e gli causarono un violento dolori r gli impedirono di mangiare (Flav. Gius.) Erode, l’assassino di San Giacomo e il carceriere di San Pietro, fu mangiato vivo dai vermi. (Act. Ap. XII; 23). Pilato fu bandito dall’imperatore romano a Vienne, nelle Gallie e si suicidò lì nell’anno 41. (Flav. Gius.) Il destino di Gerusalemme nell’anno 70 non fu meno terrificante. Un milione di ebrei morì di fame, malattie, guerra civile e sotto la spada dei romani; la città stessa fu ridotta in cenere e 100.000 Giudei furono fatti prigionieri. (Flav. Gius.) L’imperatore Nerone, crudele persecutore della Chiesa, fu deposto e bandito da Roma. da uno schiavo e morì esclamando: “Quale artista scompare con me?” Anche l’imperatore Diocleziano omeo finì la sua vita in disgrazia; la sua famiglia fu bandita, le sue immagini spezzate e lui stesso si gonfiò a dismisura, mentre la sua lingua veniva mangiata da vermi puzzolenti. Non meno tipica fu la fine di Napoleone. Egli aveva tenuto prigioniero Pio VII per 5 anni; lui stesso fu tenuto prigioniero per 7 anni all’Elba e a Sant’Elen. Nello stesso castello di Fontainebleau dove aveva estorto al Papa la rinuncia ai suoi Stati in cambio di una rendita di 2 milioni, egli stesso fu costretto a firmare la sua abdicazione in cambio di un’analoga rendita. Il 17 maggio 1809 diede l’ordine di riunire lo Stato Pontificio alla Francia e, quattro giorni dopo, la sua stella cominciò a impallidire nelle battaglie di Aspern e di Esslingen. Napoleone aveva deriso la scomunica dicendo che essa non avrebbe fatto cadere le armi dei suoi soldati, e durante la campagna di Russia, in cui morirono quasi 500.000 dei suoi soldati, il freddo strappò le armi dalle loro mani. Il 21 maggio 1821 Napoleone morì a Sant’Elena, e quello stesso giorno Pio Vil celebrò la sua festa a Roma. È un pensiero che fa riflettere, e un proverbio francese dice: “Qui mange du Pape en meurt!” – La sorte degli eresiarchi e dei grandi empi non fu diversa: Ario morì in mezzo ad una processione solenne (+335); Voltaire, il filosofo miscredente, ripeteva spesso: “Sono stanco di sentir parlare di 12 pescatori che hanno fondato la Chiesa; dimostrerò al mondo che io da solo sono in grado di distruggerlo. Morì in un impeto di rabbia e disperazione, dopo aver sofferto una sete orribile ed essersi bagnato le labbra con un liquido disgustoso.(+ 27 febbraio 1778). E la chiesa è ancora oggi in piedi! Curiosamente, fu il 25 febbraio 1758, esattamente vent’anni prima della sua morte, che egli aveva scritto all’amico d’Alembert: “Tra vent’anni, avrò eliminato Dio”. – Alla fine della sua vita, l’empio Rousseau fu torturato da un’angoscia tale da porre fine alla sua vita. – Tutti questi empi sperimentarono la verità di questa frase: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente (Eb. X, 31). Hanno subito la sorte di un uomo che si infrange contro una roccia. Cristo si è dato questo nome e ha detto: “Chiunque cadrà su questa roccia sarà schiacciato”. (S. Matth. XXI, 44).
3. È una caratteristica della Chiesa che non fiorisce se non nelle persecuzioni (s. Hil.).
Le persecuzioni educano i grandi Santi (S. Aug.), e la nostra santa madre Chiesa può applicare a se stessa le parole dette a Eva: “Partorirai con dolore”. (Gen. III, 16). Come l’arca di Noè, più il diluvio si alza, più si slancia verso il cielo. La persecuzione moltiplica i fedeli; la Chiesa è il campo che è fecondo solo quando viene lavorato dall’aratro; è la vite la cui fruttificazione si ottiene con la potatura. Le piante crescono sotto l’influenza dell’irrigazione, la fede fiorisce quando è perseguitata. (S. Giovanni Cris.) Il fuoco si accende quando viene soffiato su di esso e la Chiesa cresce attraverso la persecuzione. (S. Rup.) – Le persecuzioni purificano la Chiesa: sono la fornace in cui viene ripulita dalle sue scorie. (S. Aug.); Sono il vento che spazza via i frutti marci. Migliaia di defezioni non danneggiano la Chiesa, ma la purificano. – Le persecuzioni sono un’opportunità per Dio di fare miracoli, per dimostrare la divinità della Chiesa, come fece al tempo della sinagoga al tempo della cattività. Quante volte i Cristiani sono fuggiti e al sicuro dalla tortura! 1 I nemici della Chiesa sono costretti a dirsi: “In verità, il Dio dei Cattolici è potente!” – La Chiesa esce trionfante da tutte le persecuzioni. Il Venerdì Santo è sempre seguito dall’alba della Pasqua. – La Chiesa in Germania è stata crudelmente perseguitata circa trent’anni fa. I vescovi vennero imprigionati, gli ordini religiosi banditi, l’amministrazione dei Sacramenti proibita, ecc. e tutte queste tribolazioni hanno provocato una magnifica rinascita della vita religiosa tra i Cattolici tedeschi. Il numero dei deputati cattolici salì a 100, il numero dei giornali cattolici da 400 a 500, i congressi cattolici annuali, le associazioni cattoliche si moltiplicarono, le convinzioni dei fedeli si rafforzarono, e i Cattolici tedeschi poterono essere additati a modello al mondo intero. “Quanto più la Chiesa è oppressa, tanto più essa sviluppa la sua forza; quanto più è abbattuta, tanto più si innalza. (Pio VII). È proprio della Chiesa che essa comincia a vivere veramente quando viene sacrificata (S. Ilar.). Questo è un privilegio che non appartiene a nessuna istituzione umana, è da questo che si riconosce la figlia di Dio onnipotente, la sposa di Cristo.
2. L’infallibilità della Chiesa.
Dio ha messo nei nostri cuori una sete di verità e l’uomo è in ansia finché questa sete non viene soddisfatta. I nostri primi genitori non hanno avuto difficoltà nella ricerca della verità. Nel loro stato di innocenza era impossibile per loro credere nell’errore (S. Thom. Aq.). Dopo il peccato originale la situazione è ben diversa: l’uomo può errare , e per comunicargli di nuovo la verità dopo la caduta, Dio gli ha mandato un maestro infallibile, il suo unico Figlio. “Sono venuto nel mondo – disse Gesù a Pilato – per rendere testimonianza alla verità” (S. Giovanni XVIII, 37). Cristo doveva essere la luce per la nostra intelligenza oscurata dal peccato (ibid. III, 19). Ma poiché non doveva rimanere sempre qui sulla terra, istituì al suo posto un maestro infallibile dell’umanità, la Chiesa, e gli concesse le grazie necessarie per questo ministero, l’aiuto dello Spirito Santo, come aveva promesso ai suoi Apostoli al momento dell’Ascensione.
Cristo ha affidato agli Apostoli e ai loro successori il Magistero dottrinale e ha promesso loro l’assistenza divina.
“Andate – disse loro mentre saliva al cielo – insegnate a tutte le nazioni… e siate certi che Io sarò sempre con voi, fino alla fine del mondo (S. Matth. XXVIII, 20). Nell’ultima cena aveva già detto: “Pregherò il Padre mio ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre: lo Spirito di verità”. (S. Giovanni XIV, 16j. A Pietro aveva promesso che le porte degli inferi non avrebbero prevalso contro la Chiesa. (S. Matth. XVI, 18). Se Cristo è Dio, le sue parole devono essere la verità: se la Chiesa potesse insegnare l’errore, Cristo non avrebbe mantenuto la sua parola. Che bestemmia! – S. Paolo chiama quindi la Chiesa colonna e fondamento della verità (I. Tim. III, 15) e gli Apostoli riuniti nel Concilio di Gerusalemme del 51 misero a capo della loro decisione la seguente dichiarazione: “è sembrato buono allo Spirito e a noi” (Act. Ap. XV, 28). – La convinzione dell’infallibilità della Chiesa è di tradizione immemorabile. Origene diceva: “Ci sono due stelle che illuminano i nostri corpi, il sole e la luna, ce ne sono due per illuminare le nostre anime, Cristo e la sua Chiesa. Cristo, luce del mondo la comunica alla Chiesa, che a sua volta illumina noi, tutti noi che camminiamo nell’errore. Dove c’è la Chiesa, dice S. Ireneo, c’è lo Spirito divino.
1. LA CHIESA CATTOLICA È INFALLIBILE NEL SUO INSEGNAMENTO, CIOÈ È ASSISTITA DALLO SPIRITO SANTO IN MODO TALE DA NON POTERE ERRARE NE NELLA CONSERVAZIONE NE NELL’INSEGNAMENTO DELLE VERITÀ RIVELATE.
La ragione, in linea di principio, ci impedisce di produrre affermazioni contrarie ad alcune verità primordiali, e lo Spirito Santo, con la sua assistenza, impedisce alla Chiesa di dare una decisione contraria alla rivelazione di Cristo (Deharbe). Molti hanno creduto di trovare un errore nelle dottrine della Chiesa. È accaduto loro ciò che accadde ai pescatori che volevano catturare le stelle con le loro reti: le tirarono su vuote, avendo scambiato l’apparenza per la realtà. (Gôrres). – – Attribuendosi l’infallibilità, la Chiesa non è uguale a Dio, perché non pretende di essere infallibile in sé, come Dio, ma attribuisce la sua infallibilità al sostegno divino.
2. LA CHIESA PRENDE DECISIONI INFALLIBILI ATTRAVERSO I CONCILI GENERALI ED IL PAPA.
In ogni Stato c’è un tribunale superiore che emette sentenze inappellabili. La saggezza di Dio richiede che Egli abbia istituito un tribunale simile nella sua Chiesa. Questa autorità risiede soprattutto nell’Episcopato nel suo insieme, perché Cristo, prima di salire al cielo, gli ha affidato il magistero dottrinale e gli ha promesso di assisterlo dall’errore. (S. Matth, XXVIII, 18). Questo è ciò che esprime san Cipriano quando dice “La Chiesa è nei Vescovi”. Ma poiché i Vescovi non possono sempre incontrarsi o rimanere insieme, Dio ha dovuto prendere altre misure per fornire decisioni definitive. – I Sacerdoti, che possono esercitare le funzioni di insegnamento solo con il permesso del Vescovo, non hanno la promessa di essere aiutati a preservare dall’errore, anche se Dio concede loro le grazie per l’esercizio delle loro funzioni. Per questo l’Episcopato li utilizza talvolta come consulenti, ma non hanno voce deliberante nel pronunciare sentenze dottrinali. – Non appena la Chiesa ha preso una decisione definitiva, tutti sono obbligati in coscienza a sottomettersi ad essa. Chi si rifiuta di farlo si separa dalla Chiesa. Per questo motivo la Chiesa sancisce i suoi decreti dottrinali con la scomunica contro tutti coloro che li rifiutano, cioè si rifiutano di riconoscerne la verità.
Il Concilio generale o ecumenico è l’assemblea dei Vescovi di tutto il mondo sotto la presidenza del Papa.
Gli stessi Apostoli tennero un concilio a Gerusalemme nel 51 e proposero la loro decisione come emanata da Dio. Parlando dei primi quattro Concili ecumenici S. Gregorio Magno disse: “Accetto e riverisco le decisioni dei Concili come i quattro Vangeli.”. – Dopo il Concilio Apostolico ci sono stati 20 concili generali. Il primo si tenne a Nicea (325) contro l’eresia di Ario; l’ottavo a Efeso (431), dove fu definita la maternità divina di Maria; il settima a Nicea (787), che approvò il culto delle immagini; il dodicesima in Laterano (il quarto con questo nome) nel 1215, dove fu emanato il decreto della comunione pasquale; il 19° a Trento contro gli errori della Riforma; il 20° in Vaticano (1870), che definì l’infallibilità del Papa. – La presenza di tutti i Vescovi non è essenziale per la natura ecumenica di un concilio. È sufficiente la maggioranza morale. Al Concilio Vaticano erano presenti 1044 Vescovi, all’inizio ne erano presenti solo 750, alla fine solo 580. – L’unanimità dei voti non è necessaria per una decisione, basta una maggioranza che si avvicini all’unanimità. L’infallibilità del Papa, ad esempio, ha ricevuto 533 voti; due Vescovi hanno votato contro e 55 non hanno partecipato alla sessione. – Non è richiesta nemmeno la presidenza personale del Papa, che viene rappresentato da legati, come è avvenuto nel 1°, 3° e 4° Concilio Generale. Ma è necessario per la validità delle decisioni che il Papa le approvi. – I cardinali, i generali (degli Ordini), i prelati con giurisdizione episcopale (ad esempio alcuni abati), hanno diritto di voto nel Concilio, così come i Vescovi. (in partibus) quando vengono convocati. – I Concili generali prendono decisioni solo dopo un’attenta deliberazione, che si concentrano principalmente sull’insegnamento della Chiesa nei secoli passati. – Oltre ai Concili generali, ci sono i concili nazionali, in cui si riuniscono i Vescovi di una nazione, di uno Stato o di un Paesesotto la presidenza del primate; i concili provinciali o assemblea dei Vescovi di una provincia ecclesiastica sotto la presidenza dell’Arcivescovo o del Metropolita; e i sinodi diocesani, in cui si riunisce il clero di una diocesi sotto la presidenza del Vescovo. A parte i Concili generali, nessun altro concilio gode dell’infallibilità.
Anche le decisioni dell’Episcopato disperso sono infallibili.
Queste decisioni possono avvenire quando il Papa consulta i Vescovi su un punto di dogma o di morale. È il caso del 1854, quando Pio IX chiese a tutti i Vescovi del mondo la loro testimonianza sulla fede nell’Immacolata Concezione della Madre di Dio. Quasi tutte le risposte furono affermative e l’8 dicembre 1854 Pio IX proclamò solennemente il dogma per tutta la cristianità. Le decisioni dell’Episcopato non sono meno infallibili di quelle di un Concilio, perché l’assistenza dello Spirito non è legata a un luogo specifico. – Non è nemmeno necessaria una decisione esplicita dell’Episcopato disperso, è sufficiente che su un punto tutti i Vescovi insegnino la stessa dottrina. Anche in questo caso è impossibile che l’Episcopato si sia allontanato dalla verità. altrimenti tutta la Chiesa sarebbe caduta nell’errore, il che è contrario alla sua indefettibilità. Ecco perché il Concilio Vaticano (3, 3) ha dichiarato che dobbiamo credere non solo le verità solennemente proclamate dalla Chiesa, ma anche quelle che ci vengono proposte come rivelate dalla dottrina ordinaria e universale (dall’Episcopato in generale).
La decisione del Papa è infallibile quando promulga per la Chiesa universale, in qualità di capo e maestro supremo dei fedeli, una verità riguardante la fede o la morale. Queste decisioni sono chiamate dottrinali o ex cathedra.
Il Concilio Vaticano (1870) ha definito l’infallibilità delle decisioni dottrinali (ex cathedra) come un dogma. Questa infallibilità _ può essere dedotta dalle parole di Gesù Cristo a San Pietro: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa ” (S. Matth. XVI, 18). Se colui che è il fondamento della Chiesa potesse condurla all’errore, non sarebbe una roccia, ma un banco di sabbia su cui l’edificio crollerebbe. S. Pietro è inoltre costituito pastore e capo degli gli Apostoli e dei fedeli con queste parole di Cristo: “Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle”. (S. Giovanni XXI, 15) e Cristo gli ha dato la forza di confermare i suoi fratelli nella fede. (S. Luca XXII, 32). Se il papa potesse insegnare l’errore, la parola di Cristo sarebbe vana, il che è impossibile. – Le decisioni del Papa hanno sempre goduto di un’alta autorità. Quando la S. Sede aveva condannato l’errore dei Pelagiani, Sant’Agostino esclamò: “Roma ha parlato, la causa è finita!” – “Gli eretici – diceva San Cipriano – non hanno accesso alla Chiesa romana”. Gli stessi Concili generali chiamano il Romano Pontefice Padre e Dottore di tutti i Cristiani (Conc. di Firenze. 1439) e la Chiesa romana madre e maestra di tutti i fedeli. (IV Concilio Lateranense, 1215). Ovviamente il Concilio intendeva con questo la Chiesa docente (romana), perché la Chiesa discente non è stata mai considerata come autorità dottrinale. L’infallibilità, inoltre, appartiene al Papa per il fatto stesso che egli ha il pieno potere di governare tutta la Chiesa (Conc. Flor.), poiché la suprema autorità dottrinale è necessariamente parte di questa pienezza di potere di governo. Ora, la suprema autorità dottrinale è protetta per diritto divino attraverso la suprema assistenza dello Spirito Santo. L’autorità dottrinale suprema è infallibile. Per questo le decisioni ex cathedra del Papa sono infallibili di per sé, indipendentemente dall’assenso dei Vescovi (Conc. Vatic. 4, 4), altrimenti la roccia, il successore di Pietro, trarrebbe la sua forza dall’edificio che poggia su di lui, mentre l’edificio trae la sua solidità dalla roccia su cui poggia. – Tuttavia, egli non può essere infallibile in tutto; perché è un uomo e può sbagliare come noi nelle cose umane, nel leggere, nello scrivere, nel calcolare, eccetera; può anche peccare, come ogni uomo, e non neghiamo che ci siano stati Papi viziosi. Ma quando egli prende una decisione dottrinale, è Cristo che agisce su di lui attraverso lo Spirito Santo e lo preserva dall’errore. Inoltre, il Papa non emette mai
un decreto dottrinale senza aver prima consultato l’Episcopato. – Non c’è nessuna decisione ex cathedra, ad esempio, nei discorsi del Papa ai pellegrini, nelle sue lettere ad un sovrano, nella soppressione dei Gesuiti (1773). Gli insegnamenti ex cathedra sono di solito sanciti dalla minaccia di scomunica nei confronti di coloro che li negano: sono quindi obbligatori per tutti i Cattolici. – L’infallibilità del Papa, ex cathedra, non rende superflui i Concili generali. Le decisioni infallibili dei concili hanno un peso maggiore a causa della loro solennità, e le deliberazioni dei Concili permettono di andare a fondo delle ragioni della dottrina ecclesiastica. In alcune circostanze, queste assemblee sono molto utili, persino necessarie: gli Apostoli ritennero opportuno tenerne una a Gerusalemme, anche se tutti godevano del dono dell’infallibilità.
3. LE MATERIE IN CUI LE DECISIONI DELLA CHIESA SONO INFALLIBILI SONO: GLI ARTICOLI DI FEDE, LE LEGGI MORALI ED IL LORO SIGNIFICATO, LA SCRITTURA, LA TRADIZIONE E LA LORO INTERPRETAZIONE.
Quando, dunque, la Chiesa definisce l’eternità delle pene dell’inferno, questa decisione è infallibile, perché è una questione di fede. Quando dice che la santificazione della domenica è ordinata da Dio, ci promulga la volontà di Dio in modo infallibile, perché la sua decisione riguarda un punto di moralità. Cristo ha promesso ai suoi Apostoli che lo Spirito di verità avrebbe insegnato loro tutta la verità (S. Giovanni XVI, 13), cioè almeno tutta la verità relativa alla religione. Ora, le parole di Gesù Cristo dimostrano che la religione comprende le verità di fede e la legge morale; Egli disse infatti ai suoi apostoli: “Andate e ammaestrate tutte le nazioni… e insegnate loro a fare tutto ciò che vi ho comandato”, (S. Matth. XXVIII, 20) e fu proprio questo comando a conferire loro l’infallibilità.
Poiché la Chiesa attinge le sue verità religiose dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione, essa è necessariamente infallibile nella loro interpretazione. – Da quanto detto sopra possiamo dedurre l’assurdità dell’affermazione fatta dai giornali anticlericali, secondo cui la Chiesa potrebbe definire come dogma la proposizione: Il Papa deve essere sovrano temporale.
Secondo la convinzione comune, la Chiesa è anche infallibile nella condanna degli errori e nella canonizzazione dei Santi.
Secondo la convinzione comune, la Chiesa è infallibile quando definisce una dottrina contraria alla verità rivelata. Se, dunque, la Chiesa condanna l’opinione darvinista che l’uomo discende dalla scimmia, sta definendo qualcosa che è intimamente connesso con le verità rivelate, e rimane nell’ambito della sua infallibilità. Infatti, se per assistenza divina la Chiesa conosce la verità, deve anche conoscere l’errore. Per questo motivo, da sempre, ha condannato gli errori, sia che fossero professati oralmente o per iscritto: i padri del Concilio di Nicea (325), ad esempio, condannarono gli errori di Ario. È così che i papi condannano i libri che sono contrari alla fede e alla morale. Ora, la Chiesa non prenderebbe queste decisioni se non fosse consapevole della sua infallibilità in questo campo. L’infallibilità nella canonizzazione dei Santi non è meno fondata, non solo per il lungo e serio processo che precede ogni canonizzazione, ma anche perché il culto dei Santi è un atto di Religione. (S. Thom. Aq.) Attraverso la canonizzazione, la venerazione di un Santo è, per così dire, raccomandata dalla Chiesa come una professione di fede, perché il santo è ufficialmente onorato nelle preghiere della Messa e del breviario. Quindi, se si fosse canonizzato un defunto che non era un santo, tutta la Chiesa parteciperebbe a un errore. Questo è tanto meno possibile se si considera che Benedetto XIV sostiene di aver, nel corso di lunghi processi di canonizzazione quasi toccato con mano l’intervento dello Spirito Santo: “si produssero all’improvviso testimonianze straordinarie che risolvevano le difficoltà o hanno fatto sì che il processo venisse abbandonato. E di fatto la Chiesa, nella canonizzazione dei Santi, giudica una delle questioni più strettamente legate alla virtù della fede e della morale; Dio ha infatti rivelato ciò che costituisce la santità. Tuttavia, questa infallibilità non è ancora un dogma, perché la santità di un determinato santo non è stata rivelata; dobbiamo aspettare una definizione da parte della Chiesa. (Ben. XIV).
6. GERARCHIA NELLA CHIESA.
Gerarchia significa ordine, subordinazione dei vari gradi nella Chiesa. La Chiesa è come un esercito in cui i soldati ordinari sono soggetti a ufficiali che a loro volta sono soggetti agli ufficiali superiori e generali (S. Clem. di Roma). Nella Chiesa c’è una subordinazione tra Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, come tra i cori degli Angeli. (Clem. Aless.).
1 . I ministri della Chiesa sono divisi in tre classi di grado e potere diversi: Vescovi, Sacerdoti e Diaconi. (Concilio di Trento 23, cap. 4, can. 6).
Questa gerarchia è rappresentata nell’Antico Testamento dal sommo sacerdote, dai presbiteri e dai sacerdoti e leviti, e nel Nuovo Testamento da Gesù Cristo, i 12 apostoli e i 72 discepoli. Cristo fa una differenza nella missione che affida agli Apostoli e ai discepoli; a quelli disse: “Come il Padre mio ha mandato me, anch’Io mando voi”. (S. Giovanni XX), a questi altri dice semplicemente: “Andate, io vi mando”. (S. Luca X). Egli manda gli Apostoli in tutto il mondo, i discepoli solo in quei luoghi in cui Egli è passato (ibidem). I Vescovi hanno preso il posto degli Apostoli (Conc. Tr. 23, 4); essi sono superiori ai Sacerdoti, perché hanno ricevuto un ordine superiore e perché hanno un potere maggiore, ed il diritto di governare la Chiesa (da qui il loro pastorale).
A rigore, il Vescovo è il pastore, il capo del gregge, e spetta a lui decidere chi, e in che misura, deve partecipare a questo governo. dando la giurisdizione. Il Vescovo è il capo della sua chiesa, senza il cui permesso non si può fare nulla in materia sacra. (S. Ign. Ant.) Il Vescovo fa le veci di Gesù Cristo, il buon pastore. Egli ha un potere di ordine superiore; solo lui può ordinare i Sacerdoti (S. Gir.), solo lui è il ministro ordinario della Cresima (S. Cyp.), solo lui esercita certe funzioni ad esclusione di qualsiasi altro ministro inferiore (Conc. Tr. 23, 4), solo lui ha il diritto di voto nei Concili. – I Sacerdoti sono superiori ai diaconi; hanno un ordine superiore e un potere maggiore, in particolare possono offrire il Santo Sacrificio e perdonare i peccati. I diaconi hanno solo il diritto di battezzare, predicare e distribuire la Santa Comunione. I diaconi sono solo i servitori del Vescovo nella Chiesa (S. Cipr.), sono spesso chiamati mani, piedi e occhi della Chiesa (S. Cipr.). La superiorità dei sacerdoti ai diaconi è dimostrata dalla pratica della Chiesa primitiva di scegliere i Vescovi tra i sacerdoti e non tra i diaconi. (S. Gir.).
2. Questa gerarchia è di origine apostolica.
S. Paolo nell’epistola ai Filippesi parla di Sacerdoti e diaconi, ma ne nomina solo uno, il fedele compagno dei suoi lavori (IV, 3). Già allora esisteva in ogni chiesa qualcuno che doveva giudicare i Sacerdoti (1, Tim. V, 19), ordinarli (I, Tim. V, 22), impiegarli in determinate città (Tt. I, 6). S. Anche S. Ignazio di Antiochia distingue una triplice gerarchia tra i ministri della Chiesa:
“Obbedite a tutti”, scrive ai Filadelfi, “al Vescovo come Gesù obbediva a suo Padre, ai Sacerdoti come agli Apostoli, e i diaconi come la legge divina”. Vedere più in alto le comparazioni di Clemente di Roma (+ 100) e Clemente di Alessandria (+ 217). Tuttavia, in epoca apostolica, i termini non erano ancora stati fissati. I Sacerdoti erano talvolta chiamati anziani (presbitero) o sorveglianti (episcopus, vescovo). Tra gli ebrei si usava il nome di anziani (presbyter) presbiteri, perché gli ebrei avevano degli anziani nel Sinedrio e nelle sinagoghe, e quindi avevano familiarità con questa espressione. A questo è stato preferito il termine “sorvegliante”, perché la parola “anziano” sarebbe sembrata loro strano, visto che anche i giovani diventavano sacerdoti. In ogni comunità c’erano diversi sacerdoti (1. Tim. IV, 14), ma uno di loro li presiedeva, era come il sommo sacerdote, ed era il “capo” della comunità; era come il sommo sacerdote, ed è a lui che in seguito è stato riservato il titolo di Vescovo. Il Vescovo è spesso chiamato solo sacerdote, perché è davvero un sacerdote per eccellenza, così S. Pietro (I, V, 1) e S. Giovanni (U. I, 1) si danno questo nome.
3. CRISTO HA ISTITUITO IL SACERDOZIO IMMEDIATAMENTE, IL DIACONATO MEDIATAMENTE ATTRAVERSO GLI APOSTOLI.
Gli Apostoli eleggevano i diaconi per essere sostituiti da loro nella distribuzione delle elemosine; conferirono loro quest’ordine con l’imposizione delle mani. (Act. Ap. VI). I diaconi, infatti, avevano anche funzioni sacre da svolgere: predicavano (Santo Stefano), battezzavano (San Filippo che battezzò il tesoriere della regina d’Etiopia). – Le diaconesse della Chiesa primitiva erano vedove o vergini a cui veniva affidata la cura dei malati e delle donne catecumene. Non facevano parte della gerarchia, perché la Chiesa si è sempre attenuta al principio di B. Paolo: “Le donne tacciano nella Chiesa”. (1. Cor. XIV, 34); esse sono condannate al silenzio, perché Eva ha sedotto Adamo e quindi perse il diritto di insegnare nell’assemblea dei fedeli (I. Tim. II, 12 ecc.).
4. OLTRE A QUESTO TRIPLICE ORDINE, NELLA CHIESA ESISTE UN’ALTRA GERARCHIA SECONDO LA SUBORDINAZIONE DEI POTERI: Il Papa, i Cardinali, gli Arcivescovi.
Abbiamo già parlato di queste dignità (le ultime due non sono di istituzione divina). – Questa gerarchia è importante perché si basa sull’obbedienza. Gli inferiori la devono ai superiori. Tutti devono obbedienza ai loro superiori. Tutti devono obbedienza al Papa; i Sacerdoti e i laici al Vescovo, i diaconi ed i laici al Sacerdote (I. S. Pietro V, 5; Eb. XIII, 17). La gerarchia ecclesiastica è quindi come l’ordine di battaglia di un esercito (Conc. Tr. 23, 4). La Chiesa è un corpo in cui il capo influenza i membri superiori e questi ultimi influenzano i membri inferiori; senza questa influenza la Chiesa non sarebbe altro che un rigido cadavere, non resisterebbe alle persecuzioni con il successo che conosciamo. Tutta la forza risiede in questa organizzazione.
7. I SEGNI DELLA VERA CHIESA.
Quando lo spirito maligno vide i falsi dei in rovina e i loro templi abbandonati, escogitò un nuovo stratagemma ingannando gli uomini sotto la copertura del nome cristiano e provocando eresie (S. Cipr.). Da Cristo in poi, ha fondato quasi 200 nuove chiese, tutte diverse per dottrina. Ora, poiché Cristo ha istituito una sola Chiesa, ne consegue che di tutte queste chiese solo una è quella vera. Dio ha quindi voluto che la verità, e di conseguenza la vera Chiesa, fosse riconosciuta da alcuni segni infallibili.
1. LA VEA CHIESA È QUELLA CHE È STATA PIÙ PERSEGUITATA DAGLI UOMINI E LA PIÙ GLORIFICATA DAI MIRACOLI DIVINI.
Cristo ha spesso predetto queste persecuzioni ai suoi discepoli. Disse loro: ” Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi” (S. Giovanni XV, 20); annunciò loro che sarebbero stati portati davanti a re e governatori per rendere conto della loro dottrina (S. Matth. X, 18), disse loro addirittura: “Verrà l’ora in cui tutti quelli che vi hanno messo a morte crederanno di aver fatto bene” (S. Giovanni XVI, 2), e “perché vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia”. (ibid. XV, 19). Inoltre la Chiesa non è mai senza persecuzioni; la storia ci insegna che tutti i Sacerdoti e i Vescovi che hanno lo Spirito di Gesù Cristo hanno dovuto soffrire, anche il carcere. – Quanti Paesi hanno visto una persecuzione aperta! (In Germania le persecuzioni sono state chiamate Kulturkampf, cioè la lotta per la cosiddetta civiltà, ad esempio nel 1837 e nel 1874, quando molti vescovi, centinaia di Vescovi e centinaia di Sacerdoti furono imprigionati per aver detto Messa, per aver amministrato sacramenti ai moribondi, per aver condannato o non aver osservato le leggi persecutorie). La Chiesa ha subito questi assalti quasi ovunque nel corso dei secoli. Anche le sette che si combattono l’un l’altra, si uniscono nell’odio contro la Chiesa, proprio come Erode e Pilato si riconciliarono e divennero amici il giorno della condanna di Cristo. – Il mondo intero sa che tutte le opere cattoliche, gli ordini religiosi, le associazioni, i congressi cattolici, le missioni, incontrano sempre i più violenti ostacoli, che in quest’epoca di libertà di stampa ci sono Paesi in cui la pubblicazione di decreti pontifici è vietata e mentre i mandati episcopali sono soggetti al placet, i nemici della Chiesa hanno una libertà di stampa e di associazione illimitata.. Che odio c’è, soprattutto in certi Paesi, contro gli ordini religiosi! che possono essere così odiati e perseguitati! Quindi non sono le chiese che favoriscono lo spirito del mondo che possiede la verità. – Non c’è miracolo se non all’interno della vera Chiesa, e ce ne sono innumerevoli nei pellegrinaggi cattolici, ad esempio a Lourdes; sono prodotti dalle reliquie, dai corpi dei santi preservati dalla corruzione. Nessun’altra Chiesa può affermarlo e sappiamo che i miracoli sono il sigillo con il quale Dio conferma la verità.
2. LA VERA CHIESA È QUELLA IN CUI C’È IL SUCCESSORE DI SAN PIETRO.
La Chiesa poggia su una roccia, che è Pietro, perché è a lui che Gesù Cristo ha detto: “Tu sei Pietro ecc. “
Dove c’è Pietro, c’è la Chiesa. (S. Amb.). Durante la pesca miracolosa nel lago dove Gesù predicava, parlò sulla barca di Pietro. (S. Luc. V, 3). La ragione di ciò è ovvia, ora il successore di Pietro si trova solo nella Chiesa cattolica. Si noti in effetti la successione dei papi: Leone XIII successe a Pio IX, Pio IX a Gregorio XVI e così via fino al primo Papa, San Pietro.
3. La vera Chiesa si riconosce anche da quattro marchi principali: essa è una, santa, universale o cattolica e apostolica. Solo la Chiesa cattolica possiede questi quattro segni. È curioso vedere. quali titoli altisonanti si attribuiscono le altre chiese al loro posto. Una è ortodossa (ha la vera fede), un’altra è evangelica (aderisce strettamente al Vangelo), una terza è vetero-cattolica (proveniente dalla Chiesa primitiva). Questi titoli sembrano essere come un trucco.
1. LA VERA CHIESA È UNA, CIOÈ IN TUTTI I LUOGHI ED IN TUTTI I TEMPI HA LO STESSO CAPO, LA STESSA DOTTRINA, GLI STESSI SACRAMENTI E LO SPESSO SACRIFICIO.
La verità non può essere che una sola; la dottrina della Chiesa non può quindi cambiare. Gesù Cristo ha voluto questa unità della Chiesa; lo dimostra con le sue parole e le sue azioni Egli ha pregato per l’unità della Chiesa nell’Ultima Cena (S. Giovanni XVII, 20), ha voluto che nella sua Chiesa non ci sia che un solo gregge ed un solo pastore (ibid. X, 16).
Come tipo di unità della Chiesa
troviamo Nell’Antico Testamento il tempio unico di Gerusalemme, gli ebrei come unico popolo eletto; nel Nuovo Testamento, la veste senza cuciture di Cristo. – La Chiesa cattolica è una sola: tutti i catechismi del mondo concordano nella dottrina, si celebbra il Santo Sacrificio, i sacramenti vengono amministrati allo stesso modo, le stesse feste principali e le stesse cerimonie importanti, e riconoscono il primato del Papa romano. – Se ci sono stati antipapi (come attualmente dal 26 ottobre 1958 – ndr. -), solo lui era il vero capo della Chiesa, eletto regolarmente; un pretendente alla corona non toglie i diritti al capo legalmente stabilito nello Stato. La Chiesa rimane una anche nonostante le eresie, perché un eretico che rifiuta un dogma da essa definito è escluso dal suo seno. – L’immutabilità della dottrina e delle istituzioni della Chiesa non è una mancanza di progresso, poiché la ragione non può chiamare progresso l’abbandono della verità per adottare una novità, un errore. La verità dogmatica è immutabile come la verità matematica, che non ammetterà mai che il principio secondo cui 2 e 2 fanno 4 possa essere cambiato”. – È quindi impossibile riconoscere l’unità di una chiesa che accetta la libera interpretazione della Bibbia da parte del primo che capita, che accetta come ugualmente veri i significati più molteplici e contraddittori come ugualmente veri, che permette a ogni teologo di sostenere qualsiasi dottrina, che ammette a volte cinque, a volte tre, a volte solo due sacramenti. “Protestantesimo, esclama con ragione Bossuet, tu hai delle variazioni, quindi non sei la verità.
2. LaA CEERA CHIESA È SANTA, CIOÈ HA I.MEZZI ED IL DESIDERIO DI SAABTIFICARE TUTTI GLI UOMINI.
La santificazione degli uomini è proprio lo scopo per cui Cristo ha fondato la Chiesa, che ha dotato di tanti mezzi di grazia. Solo un santo può suscitare santi. (Stôckl. – La Chiesa cattolica è santa. Tutte le sue dottrine sono severe e sublimi; tutta la sua morale è fondata, dopo l’amore di Dio, sull’amore del prossimo e sull’abnegazione. Ha due sacramenti, la Penitenza e l’Eucaristia, eminentemente adatti a elevare il cuore umano alla perfezione morale, alla quale si può ancora lavorare attraverso la sincera osservazione dei consigli evangelici. Ha anche prodotto legioni di santi, la cui santità è stata confermata da Dio con innegabili miracoli. – I singoli vizi dei Cattolici, gli scandali e gli abusi che talvolta si verificano nella Chiesa non possono essere imputati ad essa; sono il risultato di umane passioni. Una cosa util come un coltello, un martello, ecc. può essere usata per un crimine; non è la cosa che diventa cattiva, ma è l’uomo che ne ha abusato. Gli stessi apostoli avevano un uomo malvagio tra loro, e Cristo ha rappresentato alcuni membri della sua Chiesa come erbacce e pesci cattivi. – Al contrario, la santità manca alla. chiesa che insegna che la sola fede salva, che le opere sono inutili (Lutero, a quella che insegna che certi uomini sono predestinati in anticipo da Dio all’inferno (Calvino), a quella che, per sua stessa ammissione, non riesce a indicare nessuno dei loro membri che abbia vissuto con santità che Dio ha garantito con i miracoli.
3. LA VERA VERA CHIESA È UNIVERSALE E CATTOLICA, CIOÈ HA LA. FACOLTÀ E LA DESTINAZIONE DI ACCOGLIERE NEL SUO AENO UOMINI DI OGNI EPOCA E RAZZA.
Cristo è morto per tutti gli uomini e dopo la sua morte ha mandato i suoi Apostoli agli uomini di tutto il mondo che sarebbero vissuti fino alla fine dei tempi (S. Matth. XXVIII, 20); la Chiesa deve quindi esistere per tutti i popoli. L’unione di tutte le nazioni nella Chiesa è stata indicata dal miracolo delle lingue a Pentecoste. – La Chiesa romana è universale. Le sue dottrine sono tali da poter essere insegnate a tutte le nazioni ed ha accolto nel suo seno le razze più diverse: i greci con la loro cultura, i romani con il loro spirito di conquista e i loro sudditi, I Germani barbari ed avidi di bottino, gli slavi, lontani da tutti gli stranieri, ecc. Oggi è diffusa in tutto il mondo. San Agostino dice: ci sono eretici ovunque, ma non sono uguali dappertutto.
La sola Chiesa cattolica ha 260 milioni di membri, più di tutte le altre chiese. Inoltre, invia costantemente i suoi missionari nei paesi come messaggeri della fede. – Le altre chiese al contrario si identificavano con lo spirito nazionale o locale e diventavano chiese nazionali. Una chiesa, ad esempio quella russa, che dipende assolutamente da un sovrano, non può essere la vera Chiesa., così come non può esserlo colui (Lutero) che ha dichiarato la lettura della Bibbia come indispensabile per la salvezza (secondo lui, infatti, la salvezza dipende dalla fede e questa deriva dalla lettura della Bibbia), né quelli che non hanno missioni tra i popoli o le cui missioni non hanno successo.
4. LA VERA CHIESA È APOSTOLICA, CIOÈ DEVE RIISALIRE AGLI APOSTOLI, CHE LE SUE. ISTITUZIONI DEVONO ASSOMIGLIARE A QUELLE.DEEIU. TENOI. APOSTOLICI E CHE I SUOI CAPI DEVONO ESSERE I LEGITTIMI SUCCESSORI DEGLI APOSTOLI.
Le parole di Gesù al momento della sua ascensione dimostrano che Egli volesse la perpetuità delle sue istituzioni fino alla fine dei tempi; la Chiesa è costruita sugli Apostoli, con Gesù come fondamento e pietra angolare (Efesini II, 20).
La vera Chiesa è quindi l’unica che, fondata dagli Apostoli, dura da 1900 anni. Lutero stesso concordava sul fatto che la Chiesa cattolica è la più antica delle chiese: “tutti i fedeli – disse, “hanno ricevuto la loro religione dai cattolici – I Padri più antichi hanno già insegnato ciò che contengono i nostri catechismi, e il nostro culto differisce da quello dei primi cristiani solo per cerimonie accessorie. I nostri Vescovi e gli Aapostoli sono uniti dall’Ordinazione come gli anelli alle estremità di una catena. – Una Chiesa che esiste solo da 400 anni (Lutero è sorto nel 1520), o solo da pochi anni, non può essere la vera Chiesa. Alcuni protestanti ammettono di essersi separati dalla vera Chiesa. – Il vecchio maresciallo Moltke è citato per aver detto: “Noi protestanti dovremo tornare ad essere Cattolici”. Un gran personaggio. Si permise sui dire all’illustre conte di Stolberg, dopo la sua conversione al Cattolicesimo: “Non mi piace chi abbandona la. religione del padre”; egli rispose maliziosamente: ” Non piace nemmeno a me. Se i miei antenati non avessero cambiato religione, non avrei avuto bisogno di rientrare nella Chiesa cattolica”. – Lo studio dei segni della vera Chiesa ha riportato nel corso degli anni nel suo seno una schiera di uomini illustri. È sorprendente che si tratti di uomini di grande cultura e virtù, come i futuri cardinali inglesi Newmann e Manning nel diciannovesimo secolo, che si sono convertiti, anche a loro discapito temporale, nonostante la perdita dei loro uffici. D’altra parte, coloro che si sono allontanati dalla Chiesa hanno sempre dimostrato, con la loro vita successiva, quanto poco valessero. – È quindi per noi motivo di gioia di appartenere alla vera Chiesa, tanto più che la fede cattolica ha questo immenso vantaggio di darci la massima consolazione nei momenti di disgrazia e nel momento della morte. Melantone, il principale discepolo di Lutero, scrisse alla madre cattolica: “È più facile vivere nel protestantesimo, ma è più dolce morire nel Cattolicesimo”, e a un’altra: “La nuova religione è più apparentemente, la cattolica è più sicura”.
8. FUORI DALLLA CHIESA CATTOLICA NON C’È SALVEZZA.
La Chiesa cattolica è un fiume che ha la sua sorgente nelle acque vive che sgorgano dalla bocca di Cristo, nella sua dottrina (parole di Gesù alla Samaritana – S. Giovanni IV) e scorre da 18 secoli. Chi si imbarca in questo fiume (si lascia guidare dalla Chiesa) galleggia verso il porto della felicità eterna. Chi si imbarca su altro fiume (che appartiene a un’altra chiesa) non arriverà al porto, a meno che non torni indietro nel fiume. In altre parole: fuori dalla Chiesa, non c’è salvezza.
1. LA SALVEZZA SI TROVA SOLO NELLA CHIESA CATTOLICA, CIOÈ SOLO ESSA POSSIEDE I MEZZI DI SALVEZZA: la dottrina di Cristo, le fonti della grazia e le guide da Lui nominate per insegnare e governare la Chiesa.
Non si può rimproverare alla Chiesa di aver proclamato il principio: “All’infuori di me non c’è salvezza”; essa non può dichiarare che la verità e l’errore siano vie ugualmente sicure verso il cielo. Non esitiamo a mettere alla gogna l’opinione di commercianti che vendono merci adulterate, a maggior ragione dobbiamo mettere in guardia dalle chiese che hanno deviato ed avvelenato il pane dell’anima. La Chiesa, non dice chi andrà in cielo, ma cosa porta in cielo. Dio solo, che sonda le menti e i cuori, sa chi si salverà o meno. Il principio cattolico non contiene nessuna intolleranza, nessun fanatismo contro le persone, ma piuttosto l’intolleranza della verità contro l’errore, l’intolleranza di Dio, che non sopporta nessun idolo accanto a sé. (I. Re V.). La Chiesa odia così poco coloro che non sono nel suo seno che il Venerdì Santo implora la misericordia di Dio su di loro. L’uccisione degli eretici nel Medioevo (ad esempio il rogo di Giovanni Huss nel 1415) non è stata un’opera della Chiesa, che non vuole che il peccatore muoia, ma che si converta; era opera del potere secolare e della legislazione civile che perseguiva gli eretici perché, perché di norma attaccavano anche il potere, la morale e la pace pubblica. – La Chiesa cattolica è quindi la via del Paradiso. In questo si distingue dalla Sinagoga, che mostrava questa via solo nell’oscura distanza, mentre essa stessa è la via; si distingue anche dall”eresia che tronca la dottrina di Cristo e sopprime le fonti di grazia, come la Santa Messa e il Sacramento della Penitenza. Le vie di queste chiese sono false e tortuose.
Un paralitico va meglio sulla strada giusta che un carro con ottimi destrieri su una falsa strada (S. Aug.). Chi non confessa la vera fede, fa grandi passi, ma fuori dal sentiero; più cammina, più si allontana dalla meta. (S. Aug.) Possiamo andare a Roma passando per Costantinopoli, ma quando ci arriveremo e a quale costo? Più di uno non ci arriverebbe.
2. Ogni uomo che vive fuori dalla Chiesa ha l’obbligo serio di essere accolto nella Chiesa, non appena ne riconosca la verità.
Di solito si dice: un uomo onesto non cambia religione. Questa massima è un’assurdità. Un figlio onesto non può tenersi i guadagni illeciti del padre, solo perché li ha ereditati. Allo stesso modo non può vivere in una religione che riconosce essere falsa, solo perché l’ha ricevuta dai suoi antenati, per nascita o per educazione. (Deharbe). Altri dicono: “Crediamo tutti nello stesso Dio, tutte le religioni sono buone e si può andare in paradiso in ognuna di esse” (Deharbe).
Questi principi sono chiamati indifferentismo. Sono falsi, perché una sola fede può essere la rivelazione divina, come c’è un solo Dio e la ragione stessa ci impone di cercare sempre la verità e la perfezione morale. Siamo quindi obbligati a cercare la vera fede e tenerla stretta. È assurdo pensare che sia indifferente per Dio adorarlo, o adorare idoli di legno e di pietra; riconoscere Gesù come suo Figlio, o considerarlo come i giudei un bestemmiatore. Perché Cristo, e dopo di Lui gli apostoli, avrebbero dovuto soffrire tante tribolazioni per annunciare il Vangelo, se non importava che ci credessero? Perché gli Apostoli si sarebbero sollevati con tanta energia contro coloro che falsificavano la dottrina di Cristo? (Gal. I, 8; II, S. Giovanni 1, 10). Perché Gesù avrebbe convertito San Paolo? O inviato un Angelo e un Apostolo a Cornelio? (Ac. Ap. IV 42). Gesù ha detto espressamente: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. (S. Giovanni XIV, 6). – Così troviamo tra i convertiti le anime più nobili; la loro conversione spesso costa loro i sacrifici più duri. Christine, l’unica figlia di Gustavo Adolfo, il grande persecutore dei Cattolici, si convertì, si convinse della verità del Cattolicesimo grazie alle sue letture. Le leggi svedesi non tolleravano il Cattolicesimo, per cui depose la corona dopo tre anni, pose fine al suo regno (1654) e finì i suoi giorni a Roma (1689), dove è sepolta a S: Pietro. È un comportamento eroico! Il conte Fréd. de Stolberg, che tenne una condotta analoga (1800); questo brillante scrittore rinunciò alla sua carica. Nell’ultimo mezzo secolo l’Inghilterra ha visto la conversione in massa di quasi 50o0 importanti figure tra le quali Newmaun (1845) e Manning (1851), che sono poi diventati Cardinali. In Germania, ci fu nel XIX secolo, la conversione di quasi 20 membri di case sovrane e quasi 120 membri della nobiltà. Ci furono anche conversioni dall’ebraismo, tra cui quelle del viennese Veit, che divenne predicatore della cattedrale, e degli alsaziani Ratisbonne e Libermann.
3. CHI PER COLPA PROPRIA, RIMANE AL DI FUORI DELLA CHIESA CATTOLICA NON PUÒ ESSERE SALVO.
Gesù ha detto: “Il servo che conosce la volontà del padrone e non la esegue sarà severamente punito“. (S. Luc. XII, 47). Terribile, dunque, sarà il destino di chi conosce bene la divinità della Chiesa e che, ad esempio, per contrarre matrimonio con un protestante, per fare un buon affare, lascia la Chiesa.; lo stesso dicasi per chi, avendo riconosciuto la verità della religione cattolica, rifiuta di aderirvi per viltà, per paura di ciò che la gente dirà o per disprezzo. Lo stesso giudizio va dato di chi ha dubbi fondati sulla verità della sua religione e trascura di illuminarsi, che soffoca i suoi scrupoli per paura di riconoscere la divinità della Chiesa cattolica. Questi uomini danno più importanza ad un interesse passeggero che all’amicizia di Dio e alla loro felicità eterna; preferiscono le tenebre alla luce. (S. Giovanni III, 19). Coloro che rimangono fuori dalla Chiesa sono perduti come quelli che erano fuori dall’Arca di Noè (San Cipriano). Non può avere Dio come Padre, colui che non ha la Chiesa come madre (id.). Non ci si può salvare quando non abbiamo Cristo come capo; e questo avviene quando non facciamo parte del corpo di Cristo. (S. Aug.). Separarsi dalla comunione della Chiesa è separarsi da Cristo (IV Concilio Lateranense).
4. CHI, SENZA COLPA, RIMANE FUORI DALLA CHIESA, PUÒ SALVARSI SE CONDUCE UNA VITA PIA: È CATTOLICO DI VOLONTÀ.
Un gran numero di coloro che sono nati e cresciuti nell’errore e credono di appartenere alla vera Chiesa e di essere cattolici per volontà. Essi appartengono alla vera Chiesa e si immaginano di essere veri Cristiani. Si sbagliano non per odio, ma, per così dire, per amore di Dio (Salviano). Colui che conduce una vita pia ha in sé la carità; essa serve come Battesimo di desiderio e lo rende membro della vera Chiesa; si salverà non per l’errore, ma per l’appartenenza alla Chiesa (Bellarmino). “Di qualsiasi nazione – dice S. Pietro – Siete graditi a Dio se lo temete e praticate la giustizia”. (Act. Ap. X, 35). La Chiesa comprende tutti i giusti da Abele fino all’ultimo eletto prima della fine del mondo. (S. Greg. M.). Tutti coloro che vivevano secondo ragione erano Cristiani, nonostante le apparenze, come Socrate tra i greci, Abramo ed Elia tra gli ebrei. (Giustino). Quelli di cui abbiamo appena parlato non appartengono al corpo della Chiesa, cioè alla società costituita dalla professione di fede esteriore, ma all’anima della Chiesa, per i sentimenti interiori che devono animare i suoi membri.
Nella Chiesa, quindi, ci sono membri visibili e invisibili.
Le membra visibili sono quelle che sono entrate nella Chiesa attraverso il Battesimo, che professano la vera fede e sono soggetti ai legittimi pastori. Non sono membri visibili della Chiesa gli infedeli (pagani, ebrei, maomettani), gli eretici (protestanti) e gli scismatici (greci), gli scomunicati, cioè coloro che sono esclusi dalla Chiesa. I membri invisibili della Chiesa sono coloro che non vi appartengono per loro colpa e sono in stato di grazia: come Abramo, Mosè, Davide, Giobbe, ecc.
I membri visibili della Chiesa si dividono a loro volta in vivi e morti, a seconda che siano o meno in stato di grazia.
È un errore credere che si sia esclusi dalla Chiesa per un peccato mortale. La Chiesa è come un campo dove crescono grano e zizzania (S. Matth. XIII, 24), come una rete dove ci sono pesci buoni e cattivi (ibidem, 47), somiglia all’arca di Noè che conteneva animali puri e impuri, ad un’aia dove si trova del buon grano e della pula (S. Aug.), ad un albero con rami verdi e rami appassiti. – Non basta essere membri della Chiesa per essere salvati, bisogna vivere secondo la religione, altrimenti questa qualità servirebbe solo per una condanna più rigorosa.
9. IL RAPPORTO TRA CHIESA E STATO.
Lo Stato può essere definito un’istituzione il cui scopo immediato è la prosperità temporale dei cittadini di un Paese. – La Chiesa e lo Stato perseguono obiettivi analoghi: la felicità temporale dei cittadini e la prosperità temporale lo Stato, la Chiesa non solo la prosperità temporale, ma soprattutto la felicità eterna. Entrambi i poteri provengono da Dio; la Chiesa ha ricevuto la sua autorità da Cristo, lo Stato ha ricevuto la sua, non dalla moltitudine ma da Dio, Autore della società (Leone XIII). – La Chiesa, tuttavia, è distinta dallo Stato; gli Stati sono molti, la Chiesa è una; lo Stato comprende solo uno o più popoli, la Chiesa tutti i popoli della terra. Gli Stati nascono e muoiono, la Chiesa è immortale. La Chiesa riconosce tutte le forme di governo, purché in esse non ci sia nulla di contrario alla Chiesa Cattolica (Leone XIII); per questo Leone XIII non ha mai smesso di esortare i monarchici francesi a riconoscere la forma repubblicana del governo esistente. (1892). Cristo, inoltre, aveva già insegnato che dobbiamo rendere a Cesare ciò che è di Cesare. (S. Matth. XXII, 21).
1. LA CHIESA NEL SUO AMBITO È COMPLETAMENTE INDIPENDENTE DALLO STATO, POICHÉ CRISTO HA CONFERITO IL MINISTERO DOTTRINALE, SACERDOTALE E PASTORALE SOLO AGLI APOSTOLI E AI LORO SUCCESSORI, MA NON AI PRINCIPI TEMPORALI.
Lo Stato non è quindi competente a prescrivere ai Cristiani ciò che debbano o non debbano credere, né ai Sacerdoti ciò che debbano o non debbano fare, ai Sacerdoti ciò che debbano predicare, quando e come debbano amministrare i Sacramenti, offrire il Santo Sacrificio, ecc. La Chiesa ha quindi sempre rifiutato energicamente qualsiasi interferenza dello Stato in questioni puramente religiose. Il Vescovo di Cordova, Osio, che si era distinto nel Concilio di Nicea, dichiarò coraggiosamente all’imperatore, che voleva intromettersi nelle questioni dogmatiche: “Qui, non hai nulla da comandare a noi, ma piuttosto da prendere i nostri ordini”. – Lo Stato da parte sua, è indipendente dalla Chiesa: entrambi hanno un proprio dominio chiaramente delimitato, all’interno del quale ciascuno è libero di agire come meglio crede (Leone XIII). – Tuttavia, ci sono questioni in cui i due poteri si toccano e in cui è necessaria un’intesa comune, perché se ogni potere decidesse in modo opposto all’altro, si creerebbero dei conflitti e i sudditi non saprebbero a chi obbedire. (Leone XIII). Quando la Chiesa e lo Stato sono in conflitto, non solo le piccole cose ne soffrono, ma vengono rovinati grandi interessi (id.). I due poteri devono essere uniti come il corpo e l’anima (id.). – La Chiesa e lo Stato concludono spesso dei trattati; si chiamano concordati. La Chiesa mostra sempre un magnanimo amore materno, facendo le più ampie concessioni possibili con la sua condiscendenza
2. LA CHIESA CONTRIBUISCE FORTEMENTE ALLA PROSPERITÀ DELLO STATO. ESSA INSEGNA LA SOTTOMISSIONE AI POTERI. IMPEDISCE I CRIMINI, SPINGE GLI INDIVIDUI AD AZIONI GENEROSE E FAVORISCE L’UNIONE TRA LE NAZIONI.
Lo Stato è protetto meglio dalla religione che dalle mura (Plutarco), e la forza di polizia meglio organizzata non è migliore di un semplice catechismo di villaggio. La Chiesa ci insegna che il potere civile trae la sua autorità da Dio (Rom. Xlll) e che è da obbedire anche si cattivi poteri (I. S. Pierre II, 18). – Molti grandi criminali sono stati convertiti dalla Chiesa e trasformati in grandi santi, grandi benefattori dell’umanità; ad esempio Sant’Agostino; molti uomini sono stati allontanati dal crimine grazie agli austeri insegnamenti della Chiesa: su Dio che sa tutto,
che è ovunque presente, e sul giudizio dopo la morte. Quanti guadagni illeciti restituiti, quanti nemici riconciliati, grazie all’influenza del Sacerdote, soprattutto nel confessionale. – Infine, la Chiesa insegna che la felicità eterna si ottiene attraverso le opere di misericordia e rende un dovere rigoroso per i Cristiani aiutare gli sfortunati. Quali istituzioni caritatevoli per i malati, gli orfani, i ciechi, i sordi, ecc. sono state fondate dai suoi ministri. La Chiesa, in conformità con la legge di Cristo, guarda innanzitutto ai bisognosi, che sono i più esposti al pericolo di cadere nel vizio, ed è a questo scopo che ha fondato una miriade di associazioni di soccorso. – Inoltre, la Chiesa cerca di realizzare la fratellanza dei popoli. (S. Aug.), da un lato con l’unità delle prescrizioni morali e della religione, dall’altro con la legge della carità.
I governi seri e i veri statisti hanno sempre hanno sempre cercato di proteggere la Chiesa.
Basti ricordare ciò che Costantino il Grande fece per la Chiesa nell’Impero Romano, Carlo Magno tra i Franchi e i Germani, Santo Stefano in Ungheria, S. Venceslao in Boemia, ecc. – Un buon principe, lungi dal rifiutare l’aiuto della Chiesa, lo ricerca (S. Amb.). I sovrani che perseguitano la Chiesaminano la propria autorità; il popolo non li considera più come rappresentanti di Dio ma come pari, come meri impiegati del popolo: hanno segato il ramo su cui siedono.
Gli Stati che perseguitavano la Chiesa andarono presto in rovina.
Ogni regno diviso contro di sé, disse Gesù Cristo, sarà desolato (S. Luc. XI, 17). La religione e il potere civile sono come l’anima e il corpo: senza anima, il corpo è solo un cadavere, così è lo Stato senza religione. Isaia disse: “Il popolo e il regno che non ti servono saranno distrutti”. (LX, 12). Anche Machiavelli scrisse queste parole: “Il sintomo più sicuro della decadenza degli Stati è il disprezzo della religione”. Nulla lo dimostra meglio della rovina dell’Impero Romano e gli orrori della Grande Rivoluzione. Lo stesso Napoleone disse che è impossibile governare un popolo senza religione. Appena la religione diminuisce, aumenta il numero dei crimini. Il grande Federico, amico di Voltaire, avendo notato questo fenomeno nel suo regno, disse a uno dei suoi ministri: “Cerca di riportare la religione nel paese. Questo è ciò che il profeta Osea disse ai suoi compatrioti: “Poiché non c’è conoscenza di Dio sulla terra, le ingiurie, le menzogne, gli omicidi, i furti e l’adulterio si sono diffusi in essa come il diluvio.”. (IV, 2). La stragrande maggioranza della popolazione carceraria è composta da individui irreligiosi. “Si potrebbe”, dice Plutarco, “piuttosto costruire una città in aria che conservare uno Stato senza religione”.
La ragione e l’esperienza dimostrano che senza religione non c’è moralità, e non è un patriota chi mina la religione, quel potente sostegno della società. (Washington).
3. LA CHIESA È DA SEMPRE LA PROTRETTRICE DELLA SCIENZA E DELLA CIVILTÀ.
È nell’interesse della Chiesa coltivare la scienza, perché l’ignoranza è spesso accompagnata da immoralità e barbarie.
La Chiesa è, per così dire, è costretta a studiare la natura, perché l’universo è il libro di cui ogni pagina proclama la sapienza di Dio. Quanto più l’uomo studia la natura, tanto più impara a conoscere perfettamente Dio e più il suo cuore si riempie dell’amore di Dio (Leone XIII, ancora Vescovo di Perugia). I popoli più civilizzati sono quelli in cui la Chiesa ha potuto esercitare la sua influenza più liberamente. È il Cristianesimo che ha domato i popoli barbari dell’Europa e li ha civilizzati in modo tale da renderli maestri e guide delle altre nazioni.
Fu la Chiesa a occuparsi per prima dell’educazione dei bambini e a fondare scuole.
Sotto Carlo Magno, le scuole nei monasteri, nelle cattedrali e nelle parrocchie erano istituzioni ecclesiastiche, e la maggior parte delle università devono la loro fondazione ai Papi. Intere congregazioni, come i piaristi, i benedettini, i gesuiti, i fratelli e le sorelle di Gesù, si dedicarono all’insegnamento. L’eccellenza dei metodi dei Gesuiti fu riconosciuta anche dai loro nemici; nonostante la loro soppressione (1773), Federico II di Prussia e l’Imperatrice di Russia, Caterina II continuarono ad affidare loro la gestione di alcuni collegi. – Ancora oggi, la Chiesa fonda scuole libere nei Paesi in cui la religione è bandita dalle scuole. In Italia ci sono quasi 16.000 scuole libere, con un milione e mezzo di alunni. (nel 1889 c’erano 9.000 scuole con 800.000 alunni), e in Nord America ci sono 4000 scuole parrocchiali. Curiosamente, ci sono persone anticlericali che mandano i propri figli non alle scuole laiche, ma a quelle cattoliche.
È stata la Chiesa a preservare dalla rovina i monumenti dell’antichità.
Sono stati i monaci del Medioevo a copiare i capolavori letterari dell’antichità e a conservarli per i posteri; nelle biblioteche dei monasteri, nelle biblioteche papali e nei musei, un gran numero di opere d’arte antiche. I Benedettini contano nel loro ordine 16.000 scrittori, i gesuiti quasi 12.000.
È la Chiesa che ha costruito le più belle opere di architettura. Basti pensare alle magnifiche cattedrali del Medioevo: la cupola di Colonia (1249-1880), che ha richiesto sei secoli di lavoro, e Strasburgo (1015), Friburgo (1120), Ratisbona (1275), Vienna (1365), Ulm (1377), Milano (1386), ecc. È alla Chiesa che dobbiamo la famosa basilica di San Pietro a Roma, con la sua gigantesca cupola, la cui costruzione, iniziata nel 1506, durò 150 anni e costò 150 milioni di franchi.
È la Chiesa che ha coltivato maggiormente le belle arti, la musica, la scultura e la pittura.
Il canto liturgico contiene capolavori; fu coltivato da S. Ambrogio di Milano (+ 597), e da San Gregorio Magno (+ 604). I Papi furono i mecenati di un gran numero di musicisti e compositori, tra cui il da Palestrina (+ 1594). – La Chiesa protesse le immagini, prima con il Concilio di Nicea (787) contro l’iconoclastia, sostenuti dagli imperatori bizantini, poi al Concilio di Trento contro i seguaci di Lutero e Zwingle. – Gli artisti più famosi, Leonardo da Vinci (+ 1519), Raffaello (+ 1520), Michelangelo (1564), il Correggio (+ 1534) e Canova (+ 1822) furono protetti dai sovrani Pontefici. I primi pittori e laboratori di pittura provenivano dai monasteri. – È stata la Chiesa a dissodare e a fertilizzare vaste regioni.
I monaci di S. Benedetto e di Citeaux, in particolare in Germania, hanno disboscato immense foreste, prosciugarono paludi, praticarono l’agricoltura, ecc. Questo è ciò che i Trappisti ed altri ordini religiosi stanno ancora facendo nei paesi selvaggi.
È ai Sacerdoti e ai monaci che dobbiamo alcune delle più importanti invenzioni.
È stato un diacono, Flavio Gioja a inventare la bussola intorno al 1300; Guido d’Arezzo ha scoperto la scala e le regole della musica e dell’armonia; il domenicano Spina inventò gli occhiali, il francescano Berthold Schwartz inventò la polvere da sparo (intorno al 1300); il gesuita Kircher, la lanterna magica e un nuovo tipo di specchio concavo (1646); Copernico, canonico di Frauenberg, scoprì il sistema planetario (1507); la Cavalière, la composizione della luce bianca; il benedettino spagnolo Ponzio, trovò un metodo per insegnare ai sordomuti, che fu portato a compimento dall’abate de l’Epée; il gesuita Lana inventò un metodo per insegnare ai non vedenti a leggere (1687); il gesuita Secchi (+ 1878) è famoso per i suoi studi sul sole; e il Sacerdote bavarese Kneipp è diventato famoso per il suo metodo di idroterapia (f 1897). – I nemici della Chiesa sostengono che essa è nemica del progresso e dei lumi; ciò è vero, se con questo nome si intende il declino della moralità e del timore di Dio o lo sviluppo dell’egoismo e del materialismo. – Si dice anche che la Chiesa sia nemica della libertà; senza dubbio, se con questo nome si intende la licenza e la sfrenatezza. “L’eccesso di libertà”, dice Platone, “è licenziosità e porta al dispotismo”.
4. LA CHIESA HA SENPRE FAVORITO LA PROSPERITÀ TEMPORALE.
È essa che ha fondato le istituzioni caritatevoli e le società di soccorso. Non c’è mai stata una miseria o un bisogno a cui la Chiesa non abbia cercato di provvedere. La Chiesa ha fondato istituzioni per i sordomuti, per i i ciechi, gli orfani e i bambini abbandonati; le sue congregazioni ospedaliere di fratelli e sorelle hanno fondato e gestito ospedali per i malati, per i malati incurabili, per le case di riposo, case per i prigionieri rilasciati (S. Vincenzo de Paoli), per i pazzi, case di riposo per anziani, ospizi per trovatelli (Innoc. III), per viandanti (ospizio di S. Bernardo), lebbrosari (oggi in Birmania, in India, dove su 12.000.000 di abitanti ci sono 30.000 lebbrosi rifiutati da tutti, che soffrono crudelmente spesso per lunghi anni). In una parola, la Chiesa è stata ovunque alla alla guida delle opere di carità. – È stata anche la Chiesa a fondare le società di soccorso: la Società di San Vincenzo de’ Paoli, i circoli operai, la Società di San Raffaele per gli emigranti, la società antischiavista, l’opera della B. Infanzia per la redenzione dei poveri, la redenzione, gli asili per domestici nelle grandi città, ecc. – Nella sola diocesi di Colonia, nell’ultimo mezzo secolo sono state create più di 1.200 istituzioni e società caritatevoli. Inoltre, i Papi hanno compiuto gli sforzi più lodevoli per prevenire le guerre. È quindi una calunnia accusare la Chiesa di consolare gli sfortunati solo con le speranze della vita futura, senza preoccuparsi dei loro bisogni quaggiù. – Se la Chiesa – dice Agostino – fosse stata fondata solo per le necessità di questa vita, non avrebbe potuto procurare benefici maggiori di quelli che ha procurato. – Le risorse raccolte dalla Chiesa, dice Thiele, cappellano di corte protestante, vengono restituite al popolo attraverso i numerosi canali della cultura e della beneficenza. Se i ricchi del nostro tempo avessero imitato solo lontanamente l’esempio della Chiesa, molti tristi fenomeni sociali non si sarebbero verificati. Per distogliere l’attenzione dai propri vizi, i nemici della Chiesa li attribuiscono ad essa; come il ladro che depista chi lo insegue, gridando lui stesso: “al Ladro!”.
IL CATECHISMO DI F. SPIRAGO (XVII)