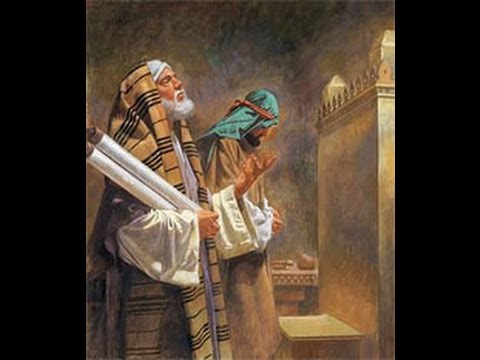FESTA DELLA B. V. MARIA ASSUNTA IN CIELO
15 AGOSTO (2022)
[D. G. LEFEBVRE O. S. B.: Messale romano – L.I.C.E. –R. BERRUTI, TORINO 1936]
Doppio di I classe con Ottava Comune – Paramenti bianchi.
In questa festa, la più antica e la più solenne del Ciclo Mariano (VI secolo), la Chiesa invita tutti i suoi figli sparsi nel mondo a unire la loro gioia (Intr.), la loro riconoscenza (Pref.) a quella degli Angeli che lodano il Figlio di Dio, perché sua Madre è entrata in questo giorno, con il corpo e con l’anima, nel cielo (All.). Nella Basilica di Santa Maria Maggiore si celebra a Natale il Mistero, che è il punto di partenza di tutte le glorie della Vergine ed ancora si celebra oggi l’Assunzione, che ne è l’ultimo. Maria, porta in sé l’umanità di Gesù al momento dell’incarnazione del Verbo; oggi è Gesù, che riceve a sua volta il corpo di Maria in cielo. Ammessa a godere le delizie della contemplazione eterna, la Madre ha scelto ai piedi del suo divin Figlio la miglior parte, che non le sarà giammai tolta (Vang., Com.).
In altri tempi si leggeva il Vangelo della Vigilia, dopo quello del giorno, a fine di dimostrare che la Madre di Gesù è la più fortunata tra tutte, perché meglio d’ogni altra, « Ella ascoltò la parola di Dio ». Questa Parola, questo Verbo, questa Sapienza divina che stabilisce, sotto l’Antica Legge, la sua dimora nel popolo d’Israele (Ep.), è discesa sotto la Nuova Legge in Maria. Il Verbo si è incarnato nel seno della Vergine e ora negli splendori della celeste Sion Egli l’ha colmata delle delizie della visione beatifica. Come Marta, la Chiesa sulla terra si dedica alle sollecitudini delle quali necessita la vita presente ed ancora come Marta, la Chiesa reclama l’aiuto di Maria (Or., Secr., Postc). Una processione fu sempre fatta nel giorno della festa dell’Assunzione. A Gerusalemme era formata dai numerosi pellegrini che andavano a pregare sulla tomba della Vergine e contribuirono così all’istituzione di questa solennità. Il clero di Costantinopoli faceva anch’esso nel giorno della festa dell’Assunzione di Maria una processione. A Roma, dal VII al XVI secolo, il corteo papale, al quale prendevano parte le rappresentanze del Senato e del popolo, andava in quel giorno dalla chiesa di San Giovanni in Laterano a quella di Santa Maria Maggiore. Questo si chiamava fare la Litania.
Assunzione della Beata Maria Vergine.
[Appendice al Messale ut supra]
Doppio di I classe con Ottava Comune. – Paramenti bianchi.
La credenza nell’Assunzione corporea di Maria SS. era già radicata da secoli nel cuore dei fedeli, profondamente persuasi che la Vergine, sin dal momento del suo transito da questa terra al Cielo, era stata glorificata da Dio anche nel corpo, senza che dovesse attendere che questo risorgesse, insieme con quello di tutti gli altri, alla fine del mondo. Cosi la festa dell’Assunzione, celebrata già verso il 500 in Oriente, costituì la più antica e la maggiore solennità dell’anno in onore di Maria SS. Tuttavia la realtà dell’Assunzione corporea di Maria in Cielo non fu oggetto di una solenne definizione da parte del Papa se non il 1° novembre 1950. In tale giorno, il Sommo Pontefice Pio XII proclamò dogma di fede che « Maria, terminata la carriera della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste quanto all’anima e quanto al corpo. – Questa definizione, maturata lentamente, ma incessantemente nei diciannove secoli che seguirono al beato transito di Maria da questa terra, ha ed avrà un’eco incalcolabile nella dottrina come nella vita cristiana. – Una delle sue conseguenze pratiche sarà quella di attirare vieppiù l’attenzione dei fedeli sulla futura glorificazione nostra non solo quanto all’anima, ma anche quanto al corpo. Come Adamo ci rovinò nell’una e nell’altro, così Gesù ci redense non solo quanto all’anima, ma anche quanto al corpo, cosicché l’anima del giusto è destinata ad una beatitudine immensa mediante la visione beatifica di Dio, ed il corpo alla sua volta verrà risuscitato, trasformato e configurato a quello glorioso del Cristo. Per Maria SS. la glorificazione corporea avvenne alla fine della sua carriera mortale; per gli altri giusti non avverrà che alla fine del mondo; ma se devono attenderla, non possono però dubitarne; la loro redenzione è certissima e sarà completa e perfetta (Rom. VIII, 23; Ef. IV, 30). Avendo già realizzato pienamente in se stessa il disegno divino della nostra redenzione, Maria SS. è per noi, colla sua Assunzione corporea, un altro modello, oltre quello di Gesù, della divinizzazione dell’anima mediante la visione beatifica e della glorificazione del corpo cui tutti siamo chiamati e che tutti dobbiamo meritare con le buone opere e con le sofferenze di questa vita cristianamente sopportate. Come del Cristo, così saremo coeredi di Maria SS., se soffriremo con Lei e come Lei (Rom. VIII, 17). – D’altra parte, l’Assunta non soltanto ci ricorda quale sia la nostra meta soprannaturale e la via per raggiungerla, ma ci presta anche il suo validissimo aiuto. A quel modo che una buona mamma mira sempre a rendere partecipi della sua felicità tutti i suoi figli, così la Madre nostra celeste regna in Paradiso sempre sollecita della salvezza di tutti gli uomini. S. Paolo ci rappresenta Gesù che vive alla destra del Padre, sempre pregando per noi (Rom. VIII, 34; Ebr. VII, 25); la Chiesa, alla sua volta, ci dice che la Vergine è stata assunta in cielo, affinché fiduciosamente s’interponga presso Dio per noi peccatori (Segreta della Vigilia). – Affine di perpetuare anche nella Liturgia il ricordo della definizione del dogma dell’Assunzione di Maria SS., la Santa Sede ha pubblicato una nuova Messa in onore dell’Assunta, ordinando di inserirla nel Messale il giorno 15 d’agosto, in luogo di quella antica (A. A. S. 1950, pag. 703-5).
Incipit
In nómine Patris, ✠ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
V. Adjutórium nostrum ✠ in nómine Dómini.
R. Qui fecit cælum et terram.
Confiteor
Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.
M. Misereátur nobis omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.
S. Amen.
S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.
R. Amen.
Introitus
Ap XII:1
Signum magnum appáruit in cœlo: múlier amicta sole, et luna sub pédibus ejus, et in cápite ejus coróna stellárum duódecim
[Un gran segno apparve nel cielo: una Donna rivestita di sole, con la luna sotto i piedi, ed in capo una corona di dodici stelle].
Ps XCVII:1
Cantáte Dómino cánticum novum: quóniam mirabília fecit.
[Cantate al Signore un càntico nuovo: perché ha fatto meraviglie].
Signum magnum appáruit in coelo: múlier amicta sole, et luna sub pédibus ejus, et in cápite ejus coróna stellárum duódecim
[Un gran segno apparve nel cielo: una donna rivestita di sole, con la luna sotto i piedi, ed in capo una corona di dodici stelle].
Oratio
Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui Immaculátam Vírginem Maríam, Fílii tui genitrícem, córpore et ánima ad coeléstem glóriam assumpsísti: concéde, quǽsumus; ut, ad superna semper inténti, ipsíus glóriæ mereámur esse consórtes.
[Onnipotente sempiterno Iddio, che hai assunto in corpo ed ànima alla gloria celeste l’Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio: concédici, Te ne preghiamo, che sempre intenti alle cose soprannaturali, possiamo divenire partecipi della sua gloria].
Lectio
Léctio libri Judith.
Judith XIII, 22-25; XV:10
Benedíxit te Dóminus in virtúte sua, quia per te ad níhilum redégit inimícos nostros. Benedícta es tu, fília, a Dómino Deo excelso, præ ómnibus muliéribus super terram. Benedíctus Dóminus, qui creávit coelum et terram, qui te direxit in vúlnera cápitis príncipis inimicórum nostrórum; quia hódie nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum, qui mémores fúerint virtútis Dómini in ætérnum, pro quibus non pepercísti ánimæ tuæ propter angústias et tribulatiónem géneris tui, sed subvenísti ruínæ ante conspéctum Dei nostri. Tu glória Jerúsalem, tu lætítia Israël, tu honorificéntia pópuli nostri.
[Il Signore ti ha benedetta nella sua potenza, perché per mezzo tuo annientò i nostri nemici. Tu, o figlia, sei benedetta dall’Altissimo piú che tutte le donne della terra. Sia benedetto Iddio, creatore del cielo e della terra, che ha guidato la tua mano per troncare il capo al nostro maggior nemico. Oggi ha reso cosí glorioso il tuo nome, che la tua lode non si partirà mai dalla bocca degli uomini che in ogni tempo ricordino la potenza del Signore; a pro di loro, infatti, tu non ti sei risparmiata, vedendo le angustie e le tribolazioni del tuo popolo, che hai salvato dalla rovina procedendo rettamente alla presenza del nostro Dio. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu la gloria di Israele, tu l’onore del nostro popolo!]
Graduale
Ps XLIV:11-12; 14.
Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam, et concupíscit rex decórem tuum.
[Ascolta, o figlia; guarda e inclina il tuo orecchio, e s’appassionerà il re della tua bellezza.]
V. Omnis glória ejus fíliæ Regis ab intus, in fímbriis áureis circumamícta varietátibus. Allelúja, allelúja.
[V. Tutta bella entra la figlia del Re; tessute d’oro sono le sue vesti. Allelúia, allelúia].
V. Assumpta est María in cælum: gaudet exércitus Angelórum. Allelúja.
[Maria è assunta in cielo: ne giúbila l’esercito degli Angeli. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 1:41-50
“In illo témpore: Repléta est Spíritu Sancto Elisabeth et exclamávit voce magna, et dixit: Benedícta tu inter mulíeres, et benedíctus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut véniat mater Dómini mei ad me? Ecce enim ut facta est vox salutatiónis tuæ in áuribus meis, exsultávit in gáudio infans in útero meo. Et beáta, quæ credidísti, quóniam perficiéntur ea, quæ dicta sunt tibi a Dómino. Et ait María: Magníficat ánima mea Dóminum; et exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo; quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ, ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus, et misericórdia ejus a progénie in progénies timéntibus eum.”
[In quel tempo: Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, e ad alta voce esclamò: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno! Donde a me questo onore che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, infatti, che appena il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bimbo ha trasalito nel mio seno. Beata te, che hai creduto che si compirebbero le cose che ti furono dette dal Signore! E Maria rispose: L’ànima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha guardato all’umiltà della sua serva; ed ecco che da ora tutte le generazioni mi diranno beata. Perché grandi cose mi ha fatto colui che è potente, e santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su chi lo teme.]
OMELIA
(G. Colombo: Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi; VI ediz. Soc. Ed. Vita e pensiero – Milano)
L’ASSUNTA
Le realtà più grandi, le consolazioni più vere quaggiù non si possono vedere, né sperimentare. Dobbiamo crederle con la fede, dobbiamo aspettarle con la pazienza. Potessimo vedere e godere quello che oggi si celebra in cielo! Di tutti i miliardi di corpi umani che ebbero il soffio della vita sulla terra, due soli non conobbero il disfacimento e la corruzione del sepolcro, e sono già lassù, gloriosi: il corpo di Cristo e il corpo di Maria; quello della Madre Vergine e quello di suo Figlio nato da lei per opera dello Spirito Santo, Madre e Figlio non mai disgiunti nell’anima, non potevano essere disgiunti col corpo. E in giro a Maria, radiosa col suo corpo virgineo, tutto il paradiso converge e si fa più bello e più lieto. Gli Angeli a ghirlande infinite volandole intorno ripetono il saluto dolcissimo che fu trovato per primo da uno di loro: « Ave, o piena di grazia! ». I Patriarchi, i Profeti dell’Antico Testamento non si saziano di guardare in quel volto, in quegli occhi misericordiosi, e le dicono: .« Salve Regina! quanto t’abbiamo aspettato senza poterti vedere: e morendo il nostro sguardo estremo si volgeva ad oriente, sospirando che tu sorgessi, mistica aurora che porti il Sole di giustizia e di salvezza, Gesù! ». E gli Apostoli vanno ricordando con Lei i giorni trepidi della vita terrena: quand’Ella premurosa e delicata veniva a trovare Gesù stanco e addolorato. Quando stette quasi sola sotto la croce, quando lo videro risorto, quando discese lo Spirito divino su tutti raccolti in giro a Lei nel cenacolo. E i Martiri avvolti nella fiammante porpora del suo sangue, e i Vergini vestiti di gigli eterni, e tutti i Santi, con tenerissimo amore si svolgono a Lei, perché ciascuno vede che per Lei ha meritato lo gloria che ha, e per Lei è entrato in paradiso. Ella è la mediatrice d’ogni grazia. Ella è la porta del cielo. Ma la parola più soave e più profonda non le può essere detta che dal suo Gesù. L’eterno Figlio di Dio si piega su Lei e le dice: « Mamma! », I trionfi eterni cogli Angeli e coi Santi non fanno però a Maria dimenticare gli altri suoi figliuoli, pellegrini ancora sulle strade dell’esilio. E noi della terra dobbiamo unirci ora con quei del cielo e glorificare il mistero della sua Assunzione. Meditando: come avvenne; qual segno di gloria sia per Lei; qual pegno di misericordia per noi.
1. COME AVVENNE
Delle persone amate noi desideriamo sapere tante notizie, ed anche le più particolareggiate ci sono più preziose e care. E quando non riusciamo ad averne di sicure, cerchiamo con insistenza almeno le più probabili. E quando non ne riceviamo delle nuove, andiamo tra noi ripassando quelle vecchie. Ogni buon Cristiano con questa affettuosa volontà parla o ascolta di Maria, la sua dolcissima e celeste Madre. L’ultima volta che nella Sacra Scrittura si parla della Madonna è negli « Atti degli Apostoli », ove si dice che dopo l’Ascensione in cielo del suo Figlio diletto, Ella tornò con gli Apostoli in Gerusalemme, e si ritirò insieme con loro nel Cenacolo. Essi preferivano stare al piano superiore per darsi con maggiore entusiasmo e con meno disturbo alla preghiera, mentre aspettavano, com’era stato loro promesso, la discesa dello Spirito Santo. Ci possiamo domandare: « Perché mai Gesù Cristo, allorché salì al cielo non si condusse dietro la sua Madre? Lui che la volle insieme sul Calvario, perché non la portò insieme nell’Ascensione; perché gli piacque di prolungarle i giorni della vita terrena, giorni che non potevano essere che sbiaditi per Lei dopo che il suo Gesù non era più sulla terra? ». È che gli Apostoli e i Discepoli avevano bisogno proprio di Lei, del suo incoraggiamento, del suo compatimento materno, del suo consiglio. Infatti, la Madonna mise su casa insieme a S. Giovanni, e, con tutta probabilità, almeno nei primi tempi abitò in Gerusalemme. Troppi ricordi, dolorosi e soavi, la tenevano legata alla città di Davide. E poi Gerusalemme era un centro donde gli Apostoli partivano per le loro prime esperienze evangelizzatrici e dove si davano di quando in quando appuntamento. Così Ella poteva essere presente ad ogni loro partenza, ad ogni ritorno. Così essi potevano raccogliersi intorno a Lei, raccontarle i primi risultati, ed anche gli insuccessi, forse lasciavano curare da Lei le ferite ricevute dagli ingrati uomini. E la Madonna li ascoltava con tenerissima comprensione materna, benediceva affettuosamente quegli evangelizzatori gagliardi e pronti alla morte, e sapeva dir loro una parola piena di forza e di soavità, parola in cui sensibilmente tremava l’eco della voce di Gesù. – Ma poi i viaggi degli Apostoli si fecero sempre più lunghi, i loro ritorni sempre giù rari. Qualcuno non ritornava più: l’avevano ucciso. Sicché la sua missione di attrice e di madre amorosa verso la Chiesa nascente era ormai finita; l’altissima santità, nella quale Ella doveva risplendere nei secoli eterni, era ormai raggiunta. Perciò, prima che gli Apostoli si disperdessero per l’ultima volta e per sempre per le strade del mondo, Ella, avendoli quasi tutti intorno a sé, li salutò, poi chiuse gli occhi come se dormisse dolcemente. Ma era morta. Quanti anni aveva la Madonna quando morì? secondo la tradizione e il calcolo più probabile, doveva aver superato la sessantina, ma di poco. Di che male morì la Madonna? Tutta una tradizione santa è concorde nell’assicurare che l’Immacolata non morì se non d’amore, avverando così alla lettera le parole della Sacra Scrittura: « Dicite Dilecto meo, quia amore langueo ». (Cant. V, 8). A noi, così materiali e rudi di cuore, può recar meraviglia che si possa morire consunti da una fiamma d’amore divino. Ma pensate che anche un amore semplicemente umano può consumare ed estenuare la vita. Quanto più lo potrà un amore divino, incomparabilmente più ardente e forte! S. Filippo Neri conobbe un monaco d’Aracoeli che continuamente stava a letto tutto languido, e s’andava spegnendo a poco a poco, senza aver altra infermità che d’amore. E lui stesso, S. Filippo Neri, per un impeto d’amore divino sentì gonfiarsi talmente il petto, che due costole gli si incurvarono grandemente. E la cosa fu documentata da medici valenti, tra cui quell’Andrea Cesalpino, che fu tra i primi a scoprire e a indagare la circolazione del sangue. E S. Teresa d’Avila, non ebbe il cuore ferito sensibilmente da un trafittura d’amore divino? Ora se queste cose sono potute avvenire nei Santi, che cosa fu di Maria, il cui amore da solo superava quello di tutti i Santi messi assieme? Se Dio non avesse impedito che il suo amore soprannaturale ridondasse nel corpo, una vampa immensa l’avrebbe consunta fin dai primi anni di sua vita, perché fin dal principio Ella era colma d’amore divino. Orbene, quando a Dio piacque, quando nei suoi disegni eterni giunse il tempo di liberarla dall’esilio, l’eterno immenso amore non più impedito comunicò una scintilla al cuore di Maria. Fu abbastanza per metterla in una dolcissima consumazione d’ardore febbrile e santo. Sempre più irresistibile le risonava nell’anima una voce che la chiamava incessantemente: « Vieni, levati, o unica prediletta! Passato è l’inverno, dileguate son le nebbie gelide: sono apparsi i fiori nella nostra contrada, i fiori della tua corona. Levati, e vieni: sarai incoronata ». Veni coronaberis! Di comunione in comunione, (ed era probabilmente S. Giovanni che a Lei porgeva suo Figlio sotto il velo eucaristico), crescendo sempre a dismisura gli assalti d’amore, finirono per vincere la sua fibra. Le membra virginee si sciolsero, e spirò. Ma quel corpo, dal quale era nato il Salvatore del mondo, non doveva corrompersi nella sepoltura. – Un racconto antichissimo che già passava sulla bocca dei cristiani del V secolo, ed anche prima, così narra: « Come gli Apostoli, che le stavano intorno, la videro addormentarsi nel sonno della dolce morte, pieni di riverenza portarono il corpo ad un sepolcro già preparato e ve lo chiusero. Intanto s’udiva per l’aria un canto soavissimo, una melodia celestiale, che durò per tre giorni. Al terzo giorno, arrivò S. Tommaso. Dolente di non esser giunto a tempo per dare l’estremo saluto alla Vergine morente, bramò di vedere ancora una volta la sacra spoglia della Madre di Gesù. Andarono tutti insieme al sepolcro e lo discopersero: invece della salma videro fiori. Allora s’accorsero che la Vergine Madre era giaciuta nella tomba quanto era durata l’angelica melodia: tre giorni come il suo Figlio divino. Poi era risorta e salita al cielo. Perciò resero con gaudio ineffabile gloria a Colui che chiamava in paradiso quel corpo dal quale s’era degnato di nascere ». Dunque per virtù e grazia divina la Madonna risuscitò, e viva in anima e corpo trionfa lassù, al fianco del suo Unigenito. La terra non possiede più nulla di Lei, ma da tutti i cieli piove incessantemente la sua misericordia e la sua consolazione sulla nostra valle del pianto.
2. SEGNO DI GLORIA PER MARIA
Nel mistero che oggi celebriamo sono da considerarsi particolarmente tre aspetti come quelli che ci rivelano tre glorificazioni della virtù di Maria.
a) Maria risuscita. La risurrezione fu il trionfo del suo immacolato concepimento, e della sua verginità perpetua. Noi sappiamo come la morte e la conseguente corruzione del sepolcro siano un castigo dovuto al peccato. Orbene Maria è senza peccato: senza la più lieve ombra d’imperfezione trascorse i suoi giorni sulla terra; e perfino dal peccato originale che tutti i discendenti d’Adamo contraggono necessariamente, Ella fu esente per sommo privilegio. Era giusto dunque che la corruzione della morte non toccasse quel santo suo corpo. Anche tutti gli altri corpi degli uomini peccatori risusciteranno alla fine del mondo, quando le tremende trombe angeliche squilleranno. Ma questo corpo verginale e castissimo di Maria meritava d’essere svegliato molto tempo prima, e in più dolce maniera. Il suo diletto Figlio non la lasciò a lungo preda della morte, ma dopo tre giorni soltanto andò a destarla: « Svegliati, t’affretta: l’eterna primavera per te è già venuta ». Infine, scrive S. Giovanni Damasceno, conveniva che questa oliva sempre verdeggiante, simbolo della pace tra cielo e terra, mai non si sfrondasse e fosse trapiantata intatta dalla triste riva del mondo alla sponda del fiume d’eternale dolcezza che irriga la santa città del paradiso.
b) Maria sale in alto. L’ascesa fu il trionfo della sua umiltà. Non si era Ella chiamata la serva del Signore, quando un Arcangelo stesso si chinava a riverire la sua altissima elezione e santità? Non visse, la Regina del cielo, povera e ignota a tutti, nella casa d’un fabbro, ubbidendogli, servendolo, accudendo alle quotidiane umili faccende domestiche? E Lei che non si lasciò vedere nelle poche ore di trionfo durante l’ingresso in Gerusalemme, rimase sotto la croce segnata a dito e derisa forse come la madre d’un falso profeta, d’un preteso re, d’un seduttore di folle. Era giusto dunque che quel Dio, che dà la sua grazia agli umili e la ritoglie ai superbi, esaltasse la Vergine umilissima sopra tutti i cori degli Angeli e dei Santi.
c) Maria entra in cielo. Quest’ingresso in paradiso col suo corpo è il trionfo della sua maternità divina. Che cosa può mai essere la gioia d’una madre terrena nel riabbracciare dopo dieci o quindici anni un figlio carissimo, confrontata con l’abbraccio eterno di Maria col suo Gesù? Poté rivedere quel volto che tante volte aveva accarezzato, quegli occhi amorosissimi e profondi in cui tante volte aveva spiato le divine volontà, quelle mani che ella aveva, adorando, baciate… Tutto lo strazio subìto durante la settimana di passione le veniva incomparabilmente ricompensato e per tutta l’eternità. Sempre vicino al suo Figlio e al suo Dio, beata della sua infinita beatitudine. Tutto il cielo ora la segnava a dito: « Ecco, ecco la gran Madre di Dio! ».
3. PEGNO DI MISERICORDIA PER NOI
In una terribile siccità, dalla terra arida e screpolata, Elia vide levarsi una nuvoletta, che sull’orizzonte dapprima non pareva più vasta d’un piede d’uomo. Ma ecco quella nuvoletta dilatarsi meravigliosamente, occupare tutto il cielo e poi disfarsi in pioggia fresca, ristoratrice, benefica. Simile a quella nuvoletta saliente è la Madonna Assunta. Ella, andando in cielo non ha dimenticato i suoi figliuoli rimasti sulla terra, ma su tutti fa piovere un’onda incessante di grazie. Perciò il mistero dell’Assunzione è per noi un pegno di misericordia: è un aiuto, una speranza, un conforto.
.a) È un aiuto nei bisogni. Ora infatti abbiamo presso: Dio la Vergine, la Vergine ch’è potente, ch’è Madre. Se ella; al banchetto delle nozze di Cana potè piegare la volontà di Gesù a favore di due sposi, oggi seduta al banchetto del cielo, collocata nell’atto del suo grande ufficio di mediatrice, può ottenerci ogni bene che noi le chiediamo. Ella ha ricevuto tutti i poteri per donarci grazie, e solo desidera di esercitarli. Infelici quelli che non sanno chiedere a Maria! I cuori che non la pregano mattina e sera, che non l’invocano nell’ora del pericolo, che hanno dimenticato le sue novene e feste, non sanno che cosa può Maria.
b) È una speranza di santificazione e di salvezza. La Vergine è stata portata in alto perché tutti abbiano a rispecchiarsi in Lei, ad imitarla. Leviamo gli occhi nostri alla sua eccelsa perfezione e poi abbassiamoli sulla nostra miseria. Se confrontassimo la sua fede ardente con la nostra incredulità, la sua umiltà col nostro egoistico orgoglio, e specialmente confrontassimo il suo candore liliale e perenne con la nostra sensualità, quanto dovremmo arrossire! Almeno oggi, da codesto confronto, s’accenda in noi un desiderio veemente e uno sforzo costante d’imitare le sue virtù. Se abbiamo veramente un tale desiderio e facciamo un tale sforzo, non c’è che da nutrire la più grande speranza di santificazione e di salvezza. Maria è la Madre nostra ed è più desiderosa Lei d’accorrere in aiuto della nostra debolezza e insufficienza, di quanto lo possiamo essere noi. Diciamole dunque frequentemente: « Sancta Domina Dei Genîtrix, sanctificationes tuas transmitte nobis ».
c) È un conforto. Perché la Vergine fu assunta nel più eccelso gaudio del paradiso anche col corpo? Perché ebbe forza e generosità d’accettare i dolori più profondi. Il suo esempio e il suo aiuto ci conforti a portare ogni giorno, con cristiana serenità e fiducia, la nostra parte di dolore. Il premio che accanto a Lei ci è riserbato illumini le nostre ore di oscurità e di abbattimento. Non ci sia cruccio nel cuor nostro che la Madonna ignori: a lei tutto come a una mamma bisogna confidare. Confidiamole specialmente le angustie e le lotte spirituali dell’anima nostra: Ella che ha vinto il male in ogni parte, che ha schiacciato sotto il suo calcagno il capo del serpente, non può lasciare inesaudita l’implorazione di certi trepidi istanti. – Ma l’istante in cui soprattutto avremo bisogno del suo conforto è quello estremo dell’agonia. Istante d’abbandono straziante, d’angoscia indicibile, di tremori. Nessuno di questo mondo ci potrà confortare in quell’istante da cui dipende il nostro eterno destino. Nessuno, ma la Madonna lo potrà. E lo farà. Con una vita pura e devota meritiamo che la Madonna ci assista, e ci stringa al suo seno nel momento dell’estremo passaggio. Sul cuore di Maria, nessun timore. Poggiati su un cuore risorto scenderemo nella tomba con la certezza di rivivere. Poggiati al cuore di Lei che è morta d’amore, sarà concesso anche a noi almeno di morire nell’amore di Dio, cioè nella sua grazia. È ben questa la preghiera che ogni giorno, che più volte al giorno, i figli rivolgono alla Madre: « Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi: ora, e nell’ora della nostra morte, Così sia ». — O DOLCE VERGINE MARIA ASSUNTA. Dal domma dell’Assunzione sgorga una preziosissima grazia, che fa dolce il nostro vivere e fa dolce il nostro morire.
1. FA DOLCE IL NOSTRO VIVERE.
.a) Per noi che abbiamo una natura sensibile, riesce molto duro pensare a persone intensamente amate senza poter dare loro un volto e una figura. Ora, se pensando alla cara e santa Madonna le diamo un volto per sorriderci, mani per prenderci per mano o carezzarci maternamente, e pupille lucenti per vederci, questo non è un’illusione fantastica del sentimento, ma è la consolante realtà assicurataci incrollabilmente dalla definizione dommatica del 1° novembre 1950. Riflettete. Quel volto che ha sorriso sulla povera culla del piccolo Verbo Incarnato provocandone il primo sorriso, quel dolce volto c’è ancora. E sorride anche a noi ogni volta che riportiamo vittoria sui nostr duri egoismi, sulle nostre sensibilità torbide. Col suo sorriso ci infonde il desiderio della castità, ci provoca a compiere atti di fede, di speranza e di carità, ci sprona ad essere ogni giorno più buoni e più generosi. Quelle mani che si posarono tante volte sulla testa del Figlio di Dio, il Quale le cresceva in casa, che diligenti e puntuali gli preparavano la parca mensa e gli rammendavano le umili vesti, quelle mani ci sono ancora. E sono vive: vanno in cerca della nostra testa per disperdervi con la loro carezza ogni ombra di malinconia che non è secondo Dio; vanno in cerca delle nostre mani per renderle pure, pronte al gesto di carità, agili nelle opere buone. Quegli occhi che contemplarono le ferite e gli squarci che i peccati di ciascuno di noi hanno fatto nel corpo liliale del suo Unigenito, quando le giaceva disteso sulle ginocchia, esanime e insanguinato, quegli occhi ci sono ancora. E ci guardano, ci seguono dappertutto, dolenti, amorosissimi, supplichevoli. Ci supplicano di non rendere inutili le atroci piaghe che il suo Gesù ha sopportato per noi.
b) Un secondo pensiero ci aiuta a sentire la dolcezza che dall’Assunta piove sul nostro vivere. La Madonna tutta viva, anima e corpo, è in cielo. Che fa in cielo? Gode la visione beatifica di Dio. Nella luce di questa visione, Ella partecipa della scienza infinita del Signore. Perciò conosce tutti e ciascuno di viso, di nome, personalmente. Di ciascuno di noi sa il passato, il presente e l’avvenire: ogni momento del nostro vivere è davanti a Lei con una chiarezza maggiore della nostra. Ci sono quaggiù ore di gioia o di angoscia, di successo o di accasciamento in cui ogni uomo dice tra i sospiri: « Lo sapesse la mia mamma! » Nessuna gioia nostra è piena, nessun dolore è consolato, se la nostra mamma è assente e ignora. Orbene, che dolcezza il domma dell’Assunzione corporea di Maria ci infonde, dandoci di poter dire con verità in quelle ore trepide: « La Madonna lo sa. Il suo materno cuore di carne palpita di gaudio o di dolore all’unisono col mio inquieto cuore di figlio ». La Madonna è in cielo, tutta viva, anima e corpo. Che fa in cielo? Quello che ci ha detto che Gesù, risorto e asceso, sta davanti al divin Padre semper vivens ad interpellandum pro nobis (Hebr., VII, 25). E la Madonna, risorta e assunta, sta davanti al divin Figlio similmente semper vivens ad interpellandum pro nobis. La grande orante! Prega per la Chiesa universale, militante e purgante; prega per l’umanità intera, santa e peccatrice; prega per il Papa, per i Vescovi e i sacerdoti; prega per i poveri, per gli ammalati, per i tribulati, per i tentati, per gli infermi, per gli abbandonati, per i disoccupati… Prega per ciascuno di noi, non già con una preghiera generica e confusa, ma precisa e specifica, perché Ella sa ad uno ad uno i nostri bisogni, anche i più segreti. c) La Madonna, assunta in cielo, ci è sempre vicina. Occorre liberarci da un’illusione fantastica che potrebbe diminuire assai la dolcezza del domma dell’Assunzione: quella di pensare il cielo come una regione remota; stupenda, sì, ma lontana da noi, in alto, oltre le nuvole, oltre le stelle. No, non è così. Il cielo è dove è Dio, e Dio è dappertutto. Nella Sacra Scrittura il cielo appare vicino, vicinissimo all’uomo. Forse l’uomo ci vive in mezzo senza poterlo vedere, sentire, gustare. Giacobbe è nel deserto: e il cielo si spalanca al suo fianco in guisa di scala che dalla terra sale a Dio. Dei pastori vegliano sui monti a custodia del gregge: il cielo si chiude su quei pascoli con l’annuncio del Natale. Giuseppe dorme nel suo povero letto: la porta del cielo s’apre proprio in quella cameretta per lasciar uscire un Angelo a comunicargli un avvertimento divino. Saulo cammina verso Damasco: il cielo gli attraversa con irruenza la strada e lo rovescia a terra. La Madonna è stata assunta in cielo, ma ciò non le può togliere di stare accanto ai suoi figliuoli. Non c’è solitudine, non c’è lontananza di oceani o di deserti, non ostacolo di monti, di muraglie o di porte sbarrate che possa impedire all’Assunta di starci vicini tutta viva com’è, in anima e corpo. Quando il sangue ribolle per fermenti di corruzione, quando il corpo coi ribelli istinti appesantisce il volo dell’anima, Ella ci è vicina e dalla incorrotta carne, dal suo virgineo sangue emana una virtù che placa i sensi, spegnendo gli impuri ardori. Quando le creature ci incantano colle fosforescenze della loro opaca bellezza, colle promesse fallaci d’arcane felicità, Ella ci è vicina e dai suoi occhi purissimi emana una luce che rende persone e cose trasparenti come un velo, dietro al quale appare Dio: Dio solo e la sua gloria congiunta alla nostra vera felicità. – 2. FA DOLCE IL NOSTRO MORIRE. La singolare nobiltà e tragicità dell’uomo è di essere l’unico vivente che sa di dover morire. Pensate a quello che fu la cupa tristezza di tutti i secoli antichi di fronte alla morte. La sopravvivenza dell’anima era generalmente conosciuta, ma era immaginata come un’esistenza umbratile, squallida, senza nessuna delle intense vibrazioni di cui è ricca questa vita, un’esistenza colma soltanto di struggenti rimpianti verso i beni terrestri perduti per sempre. E non soltanto nei popoli pagani, ma in quel popolo stesso che era il detentore della vera religione nell’Antico Testamento il pensiero della tomba diffondeva un tragico orrore, di cui abbiamo ripetute e chiare testimonianze nei libri ispirati. «Lascia, — gemeva Giobbe (X, 2-5) — che io un poco mi rassereni ancora, prima che vada, per non più ritornare, nella regione delle tenebre e delle ombre funeree, regione buia e nebulosa ove è cupa confusione e fosco bagliore ». E l’Ecclesiaste constata amaramente che la vita anche più diseredata sulla terra è sempre preferibile allo squallore d’oltre tomba. « A ognuno che vive resta almeno qualche speranza, perciò val meglio un cane vivo che un leone morto… I morti non sanno niente, né più attendono ricompensa, essendo dimenticata la loro memoria » (IX, 5). Ed è ancora Giobbe che sente d’invidiare la sorte delle piante che, tagliate alla radice, rimettono i polloni nella carezza dell’aria azzurra e del tiepido sole. « L’uomo invece, morendo, è finito… una volta coricatosi, più non si alza finché durino i cieli, né dal suo sonno più nessuno lo sveglia » (XIV, 7-12). Ma dopo che Gesù è venuto e ci ha parlato, dopo che è morto per noi e per noi è risorto, la morte è tutt’altra cosa. Per il Cristiano, nel confronto tra la vita di là e la vita di qua, è questa che ci scapita, tanto quella è intensa di gioia, di luce e di bene. Noi sappiamo che val meglio un attimo di là che cento anni in questa valle d’esilio. Noi non invidiamo le piante che, una volta tagliate, ripullulano con virgulti dalle radici, perché, falciati dalla morte, siamo certi di ripullulare incomparabilmente più vivi e più integri. S. Paolo sospirava: « Potessi disciogliermi da qui e stare con Cristo, quanto sarebbe meglio! Tuttavia, se è per il vostro bene, mi rassegno a stare quaggiù » (Fil., 1, 23-24). – Il vecchio Vescovo d’Antiochia, S. Ignazio, supplicava i Romani a non brigare per evitargli la condanna e il martirio. « Una cosa sola concedetemi: lasciate che io sia immolato a Dio! È bello tramontare al mondo per risorgere in Dio… lasciate che io raggiunga la pura luce! Un’acqua viva mormora dentro di me e mi dice: vieni al Padre » (Lettera ai Romani, passim.). – S. Teresa d’Avila esclamava: « O morte, o morte, in te è la vita, e io non so come ti possa temere » (Opere, Milano, 1932, pag. 1632). S. Teresa di Lisieux rispondeva a chi la voleva confortare nell’agonia: « Ci vuol coraggio per vivere, e non per morire » (Autobiografia, c. XII). – E ora il domma dell’Assunta è stato definito per renderci più chiare, più presenti, più sensibili queste cristiane e consolantissime certezze. La morte non esiste più, esiste unicamente la vita eterna. Già Una che era in tutto simile a noi, tranne che nel peccato, è stata risuscitata e assunta in cielo per la virtù del suo Figliuolo. Con Lei la nostra risurrezione è incominciata. Tra poco risorgeremo anche noi; risorgeranno tutti. È solo questione di un po’ di tempo: e i millenni, visti dall’eternità, sono brevi come un giorno già trascorso. Sicut hesterna dies quæ prateriit. È indubitabile che questa Madre risuscitata e assunta ci sarà vicina nel momento della morte. Migliaia di volte l’abbiamo invitata per quell’ora … et in hora mortis nostræ. Non sarebbe Madre, non sarebbe Lei se mancasse all’appello che le fu ripetuto innumerevoli volte. Dunque l’Assunta verrà, non mancherà in quell’ora. E con le sue labbra risorte bacerà la nostra fronte sudata e gelida, con le sue mani risorte ci prenderà le mani stanche e inerti. Dolce morire di noi risorgendi fra Gesù e Maria risorti! – Per un figlio non c’è gioia più grande di quella di sapere sua madre felice. Se vogliamo bene alla Madonna come a madre, se per lei alberghiamo in cuore tenerezza di figli, sopra le dolcezze che la sua Assunzione può dare al nostro vivere e al nostro morire, dobbiamo sentire che ve n’è un’altra più grande: quella di sapere con assoluta certezza che Maria nostra Madre è felice, già tutta felice, anima e corpo. Dalla pienezza della sua felicità questa nostra dolcissima Mamma pensa a noi e trepida per noi. Ci vuole vicino a Lei, nella sua gioia, per sempre. Perciò ci supplica: « Fuggite il peccato, vivete in grazia, Salvate l’anima se volete salvare anche il corpo, e trasfigurarlo come il mio nella beata Assunzione al cielo ».
IL CREDO
Offertorium
Orémus
Gen III:15
Inimicítias ponam inter te et mulíerem, et semen tuum et semen illíus.
[Porrò inimicizia tra te e la Donna: fra il tuo seme e il Seme suo.]
Secreta
Ascéndat ad te, Dómine, nostræ devotiónis oblátio, et, beatíssima Vírgine María in coelum assumpta intercedénte, corda nostra, caritátis igne succénsa, ad te júgiter ádspirent.
[Salga fino a Te, o Signore, l’omaggio della nostra devozione, e, per intercessione della beatissima Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori, accesi di carità, aspirino sempre verso di Te.]
Præfatio …
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et justum est.
… de Beata Maria Virgine
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Et te in Assumptione beátæ Maríæ semper Vírginis collaudáre, benedícere et prædicáre. Quæ et Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concépit: et, virginitátis glória permanénte, lumen ætérnum mundo effúdit, Jesum Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:
Sanctus,
Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
Preparatio Communionis
Orémus:
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:
Pater noster
qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:
R. Sed líbera nos a malo.
S. Amen.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
COMUNIONE SPIRITUALE
Communio
Luc 1:48-49
Beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna qui potens est.
[Tutte le generazioni mi diranno beata, perché grandi cose mi ha fatto colui che è potente.]
Postcommunio
Orémus.
Sumptis, Dómine, salutáribus sacraméntis: da, quǽsumus; ut, méritis et intercessióne beátæ Vírginis Maríæ in coelum assúmptæ, ad resurrectiónis glóriam perducámur.
[Ricevuto, o Signore, il salutare sacramento, fa, Te ne preghiamo, che, per i meriti e l’intercessione della beata Vergine Maria Assunta in cielo, siamo elevati alla gloriosa resurrezione.]
PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)
RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE (2)
ORDINARIO DELLA MESSA