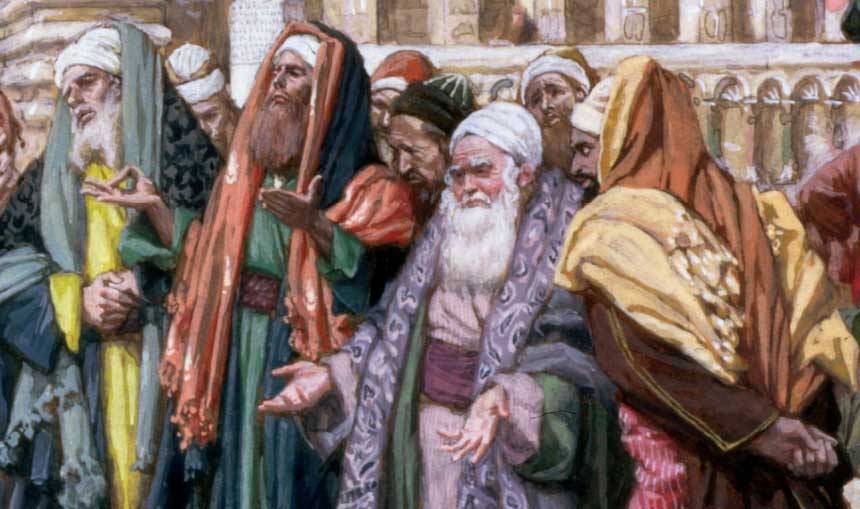LO SCUDO DELLA FEDE (211)
LA VERITÀ CATTOLICA (IX)
Mons. ANTONIO MARIA BELASIO
Torino, Tip. E libr. Sales. 1878
ISTRUZIONE IX
L’uomo
Siamo creati da Dio, che ci ama da padre; e siamo creati, per conoscerlo, amarlo, per adorare insomma il Creatore, il Padre, il Sommo Bene che è Dio, e per essere con Lui beati per sempre in Paradiso. Ecco tutto quello che ci debba più importar di sapere; questo è il principio della vera sapienza. La ragione nostra, contenta di aversi sentito a dire dalla cara parola di Dio che il Signore creò tutte le cose nel mondo, per sua bontà, per avere poi noi sempre con Lui felici, allarga il cuore consolandosi di questa speranza, che poi infine è poi tutta la grande nostra speranza. Ben potrei dirvi qui: o figliuoli, andate là, conservatevi sempre nel cuore questa gran verità di Dio. Non ci resta che attaccarci a Gesù Cristo, Figliuol di Dio, che, come vi ho detto, si è fatto uomo e morì sulla croce, per condurci salvi con Dio. Viviamo secondo la sua santa legge: e in tutto quello che facciamo nella nostra vita diamo gloria a Dio, che vuole usarci tanta misericordia. Ma ahi, che alcuni disgraziati, abbandonato Iddio che è benedetto in eterno, come il demonio, si arrabattono per strascinare anche noi col demonio lontani da Dio! Non par da credersi, ma è pur troppo vero, gli svergognati!… tentano di darci d’intendere, che veniam dalle bestie noi! e ci vorrebbero avvoltolare nel fango con loro. – Oh i tristi! non pensano che ci renderebbero troppo più miserabili delle bestie istesse; perché, almeno le bestie non conoscendo niente, non si trovano disperate alla morte. Ma noi uomini!… senza Dio in vita!… ma noi uomini… senza Dio poi nella morte!… Ah Gesù benedetto, salvate me e questi miei cari figliuoli dalla disperazione di morir senza fede in Voi! Noi sì, noi vogliamo morire nel bacio del vostro amore! E Voi con quella parola che vien dai palpiti del Vostro cuore, fatemi spiegar chiaramente, quanto sia contro la fede, contro la ragione, contro il buon senso, il dir che la terra si sia da se sola trasmutata in piante, che le piante si siano poi mutate in animali, e che gli animali si siano cambiati in uomini. Oh Maria nostra Madre benedetta, ma sentite, che tenterebber di farci!…. Eh vorrebbero strapparci via da Gesù nostro che vuol condurci con Voi al Padre in Cielo, e buttarci giù colle bestie nel fango, e mandarci a perdere in vita bestiale! – E voi, o figliuoli, fissatevi ben in mente ciò che io voglio dimostrarvi, cioè che Dio, creato il mondo, le piante e gli animali, creò noi superiori a tutte le creature in terra ad immagine sua per servirlo in terra, e poi per averci seco beati in Paradiso. Fatemi grazia a ripeterlo (si fan ripetere) vi ho da dimostrare che Dio creato il mondo; le piante, gli animali, creò noi superiori ecc. Intanto ascoltatemi con attenzione, perché qui si tratta d’imparare a difendere le nostre persone contro questi nemici del genere umano, che tentano di farci il più indegno insulto, col confonderci colle bestie, e farci imbestiare con quelle. Io vi ho già spiegato nella istruzione precedente come Dio creata e disposta la terra, per mantenere in essa tutte le creature terrene, creò poi le piante e gli animali. Ma lì per creare l’uomo, per farci intendere come l’uomo è tutt’altra creatura ben diversa dalle altre tutte, e come le altre cose create in terra sono anzi ordinate per l’uomo, prima di crearlo (per parlare umanamente), Dio Stesso sì consigliò col Figliuol suo e coll’Eterno Amore, lo Spirito Santo col dire « Ora che son create tutte queste cose, facciamo l’uomo che comandi a loro; ma facciamolo ad immagine e somiglianza nostra – faciamus hominem ad immaginem et similitudinem mostram, quasidire « egli creato così, ci conoscerà, eseguirà i nostricomandi; e Noi ammetteremo lui servo fedele, agodere della nostra eterna felicità. »Per questo, tutt’altro che confonderci colle bestie,e farci dell’istessa natura, ci creò anzi ad immaginesua per poter Egli amar Noi, come padre; e noi amare Lui, come i figli amano naturalmente i padri loro. Quindi ci collocò in mezzo di questo mondo di cose, da Lui preparate, come un padre colloca i suoi figliuoli in mezzo ai possedimenti suoi che provvide per loro. Volendo poi Egli che noi le governassimo vivendo secondo la sua santa volontà, la quale fu tanto buono di farci conoscere, ci mise in mezzo a questo visibilio di creature terrene e senza ragione; quindi per metterci in relazione a trattare con loro, ci diede il corpo; ma poi ci diede l’anima ragionevole, per innalzarci a trattare con Lui e rendergli onore e gloria, e adorazione in nome ditutto. Onde noi pel corpo camminiamo coi piedi in terra; ma coll’anima siam destinati a comunicare con Dio in cielo. Siamo, è vero, grevi qui col peso del corpo materiale attaccati alla terra; ma coll’anima nostra spirituale voliam oltre le basse cose del mondo, liberi e ragionevoli, come gli Angioli, capaci con essi ad amare il sommo bene Iddio in Cielo. Così tutte noi creature insieme, cominciando dai granelli di polvere (atomi) e salendo su sempre le une sopra le altre, fino a’ più grandi Angioli Serafini in Cielo, formiamo una gran catena, che dal più basso della terra, arriva fino a’ piedi del Trono dell’altissimo Iddio. Su, su, dunque noi di grado in grado, su dal tempo all’eternità sempre a lodare, ad amare la somma bontà di Dio. Ah via da noi la brutta gente, che ci vuol gettar giù a vivere, come le bestie. E per tutta ragione ci dicono che siam simili agli animali. Ben è vero che tutte le creature hanno una certa somiglianza fra di loro; ma restano divisi in ordini diversi nella diversa natura lor propria: si avvicinano, dirò così, tra di loro per somiglianza; ma si allontanano per l’essere lor naturale tutto diverso. Quindi non si mischiano mai, né si confondono da cambiarsi le une nelle altre di specie di diversa classe. E siccome abbiamo detto che tutte le creature formano come una catena; bene appunto, come gli anelli di una catena avvicinandosi gli uni agli altri si legano insieme, ma non sì confondano; così le diverse specie di creature si trovan vicine, si aiutano, si sostengono le une colle altre, sempre distinte e diverse fra loro: sicché sassi e terra la materia morta insomma non diventano mai piante: né le piante non si cambian in bestie: e tanto più poi le bestie non si trasmutano in uomini. – Ora vi spiegherò, come una classe di creature può essere simile, ma resta sempre diversa dalle creature di altra classe. Vedete difatti che le piante sono vicine alla terra, anzi vi penetran dentro, e paiono talvolta simili alla terra; ma non son terra morta, no; perché le piante sono vivaci, e germogliano altre simili piante: così gli animali hanno delle somiglianze colle piante, poiché han dentro di loro tanti fili, fibre, costole, e vene come quelle; ma non son piante, no; perché gli animali senton di vivere, vanno da loro in cerca, coll’inclinazione, che si sentono dentro, (istinto), di tutto quello che li può soddisfare. Quindi pure noi uomini abbiamo un corpo animato, come hanno gli animali; ma siam ben al tutto diversi e da loro lontani, perché abbiamo la forza della ragione da dominar sopra di loro. Sicché al considerarci tanto superiori a quelli, noi siamo obbligati ad esclamare « Oh! Signore, quanto è ammirabile la vostra bontà con noi! – Domine quam admirabile est Nomen tuum: Voi avete assoggettate a’ nostri piedi tutte le creature della terra, e poco men che gli Angioli ci avete innalzati verso il Cielo; minuisti paulo minus ab Angelis (Psal. VIII.). Eh noi, collocati in tanto onore da Dio, vorremmo noi lasciarci mettere insieme colle bestie brutte senza ragione? Homo cum in honore comparatus est iumentis ‘insipientibus? (Sal.) Figliuoli di bestie voi, che m’intendete per bene, spiegherò meglio e metterò sott’occhio come le creature di specie diverse e di ordini superiori possono aver somiglianza fra loro; benché sieno di tutt’altra natura. Voi forse avrete veduto come d’inverno l’umidità e i vapori gelati hanno sui vetri delle finestre la somiglianza di tanti rami, e saprete come dentro le montagne, dove si scavano i metalli, il rame, l’argento, l’oro si trovano dispersi in mezzo del sasso in forma di ramificazioni, che somigliano le piante: ma anche voi sapete però che quei giri giri di gelo sui vetri, che quei rami di metallo sparsi nelle viscere dei monti non sono né rami, né piante; poiché non hanno dentro quella forza di crescere, di vegetare, di far sementi, di germogliare altre piante simili a loro. Hanno un bel somigliare alle piante; ma sono cosa morta e non mai pianto vivaci. Ascoltate ancora: le piante hanno filamenti sottili di dentro che sembrano nervi, hanno delle vene come i corpi degli animali: e vi sono delle piante che hanno costoline e fili così sottili, che, appena toccate, restano scomposte e piegano giù le foglie, (come fa l’erba sensitiva, che si chiama sensitiva appunto, perché par che senta; benché non senta in modo alcuno) Ma perché non vi è dentro quella forza di vita animale, per cui gli animali hanno l’istinto di conservarsi, e vanno a cercare ciò che sentono che fa bene a loro, si ritirano da ciò che fa male, così mostrano di sentirsi di vivere: le piante con tutte le lor fibre e vene saran sempre piante; e non animali mai. Finalmente possono gli animali imitar le operazioni degli uomini. Lo stordo e il pappagallo possono articolare parole, altri animali fan versi e moine che somigliano agli atti degli uomini; ma perché non hanno la forza della ragione, saranno sempre bestie. Questa forza poi di germogliare nelle piante non può venire in loro dalla terra; perché la terra non l’ha; ma viene dalla parola di Dio Che le creò: questa forza degli animali di sentire ciò che vedono, toccano, fiutano, assaggiano, e di muoversi al piacer loro, non può venir dalla terra e dalle piante; perché esse non l’hanno; ma viene da Dio che li creò tali. Così questa forza della ragione per cui noi siam creati sopra gli animali e li dominiamo è una comunicazione di un Lume che viene da Dio. Sì veramente è Dio che diede all’uomo colla sua parola, che creò la potenza di eseguir quello che Egli vuole, e di comandare a tutte le creature. E fu sempre così. Mentre non vi fu mai animal così svelto, così ardito, così forte, da poter neppure tentare di assoggettare il più meschinello di uomo, a prestargli i suoi servigi. Gli uomini sempre maneggiarono le cose create secondo la lor volontà, gli uomini dominarono sempre sugli animali. – Eppure ci vorrebbero darci d’intendere che discendiam dalle bestie!… Oh! ma voi, mi direte, chi è matto così da poterlo sognare? — Chi?… Vel dico io, per non lasciarvi ingannare. Sono uomini, che si vantano di essere sapienti, e perdono la testa, da parlar come stolti — dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt. E siedono fin sulle cattedre delle più grandi scuole (le università), e vendono certi lor strani sogni, come fossero oro colato di prette verità da loro scoperte. E a vederli! e a sentirli! con quel loro gran fare in robone da professori, dettare in nome della scienza, stranezze da far spiritare i nostri più eletti giovani. Buon, che i giovani non sono come i paperi, i quali bevono grosso nel guazzo fangoso delle loro grandi oche. Quindi è vero che i bravi giovani danno la berta a quei venditori di favole; ma è poi anche purtroppo vero che alcuni pochi, e voi li conoscete che sono i più grami, ritornati da quelle scuole, per darsi l’aria di sapere un gran che più che la buona gente, la quale ha più giudizio di loro, pretendendo di far aprire gli occhi agli ignoranti dicono le più brutte, le più matte cose del mondo. Quasi il buon popolo non avesse, per grazia di Dio, tanto di cognizione, da non sapere distinguere gli uomini dalle bestie; si vantano di aver tanto studiato, figuratevi! fino a credersi bestie essi stessi. Per me, mi consolo con voi, benedetti figliuoli, perché venite alla dottrina; poiché fin anco quel povero incredulo di Voltaire, ci dice chiaro, che in fatto di sapere come furono create le cose, e per qual fine siamo creati noi uomini, ne sa più la vecchiarella contadina, che va tutte le feste alla dottrina del Parroco, e ne sanno di più anche i fanciulletti, che cinguettano appena il catechismo. Sì proprio, ne sanno di più di coloro che si vantano di saperlo di propria testa; i quali, se si ascoltassero, ci farebbero disperare coi loro, lasciatemi dire, spropositi da cavallo: come questo che dicono che la terra si mutò in piante; e che le piante si mutarono in animali; e poi gli animali in noi: così da trovarci poi noi uomini belli fatti dalle bestie in noi trasformate! Ebbene ecco adunque quel che insegna la dottrina cristiana: e voi lo intenderete bene; perché va tanto d’accordo colla nostra ragione. La quale ben debba restar soddisfatta nel conoscere come fummo creati noi, consolandosi dal sentirci tanto amati da Dio. Vi ricorderete che nella passata istruzione vi ho già detto, come Dio creò la terra, le piante, gli animali: ed ora per non lasciare darvi d’intendere che dalla terra vennero le piante e che dalle piante gli animali e che da loro poi nascessero gli uomini; vi dirò come è Dio Onnipotente, che creò nelle piante e negli animali la forza di produrre altre piante, altri animali della istessa natura di loro, quando disse colla sua parola: che crescessero e si moltiplicassero; ma ciascuno di essi nella loro propria specie, secondo il proprio genere: in species:… secundum genus suum; cioè secondo lanatura in cui Egli ha creato le diverse classi diloro. Dimodoché dalle piante si producessero altre piante, dagli uccelli nascessero simili uccelli, daipesci simili pesci, da tutti gli altri animali animali di simil natura. E poi già anche voi colla vostra ragione e col vostro buon senso conoscete, come vedete coll’esperienza di tutti i di, che le cipollenon producono mai cavoli, che dai cavoli non nascono serpenti, né dai serpenti nascono colombe, come da tutte bestie nascono sempre bestie della natura di quelle che le generarono. Questo sì è sempre veduto dacché mondo è mondo. Si trovano difatti negli antichi sepolcri (massime nelle montagne d’Egitto, dove si scavarono degli antichi sepolcrico sì grandi che si chiamano necropoli, cioè le città de’ morti) si trovano grani, serpenti, gatti e scimmie. Ebbene? sono proprio gli stessi grani, che ancor seminati da noi danno gli stessi grani, gli stessi serpenti, che strisciano ancor là nelle sabbie abbruciate dell’Africa, sono gli stessi gatti delle nostre cucine e le scimmie colle quattro zampe istesse, che sì arrampicano sugli alberi ai nostri dì. Le quali, si vede, che non si sognarono mal nel lunghi, almeno sei mila anni, di farsi scimmie un po’ migliori. – Ma insomma anche noi, per poco che vogliamo pensarvi, vedendo che le piante e gli animali sono così ben formati, e come dentro di loro son così ben congegnate tutte le parti, che formano i loro organi con cui possono vivere, ben conosciamo che tutto fu disposto da chi li voleva far vivere nel loro modo; cioè furono creati da Dio, che solo poté pensarle colla sua Mente Divina e colla sua Onnipotenza le poté formare. Eh si che dobbiamo esser ben certi, che la terra, per sognarsi un dì di cambiar se stessa in piante, che prima non aveva, bisognava bene che avesse pensato avanti come dovevano essere fatte le piante (figuratevi se la terra poteva pensare!): poi che le piante, per sentirsi la voglia di diventare animali, bisognava, che avessero anch’esse pensato che cosa fossero gli animali, e che avessero potuto crearli animati così, mentre esse animate non erano. Ascoltate ancora: anche gli animali poi per sentir l’ambizione di diventare uomini, sì che dovevano studiar ben la maniera di crearsi dei figliuoli un po’ migliori, e di quella bellezza, che non avevano ancora mai veduto tra quei brutti ceffi, e che inventassero delle anime le quali avessero la ragione, da mettervi dentro: perché già di ragione gli animali non seppero averne mai. Bisognava insomma che la terra, le piante, gli animali avessero una mente capace d’immaginarsi col pensiero creature al tutto nuove, diverse, e che poi avessero la forza onnipotente da poter essi crearle!….. Oh vedete disgrazia di coloro che non vogliono credere in Dio Eterno Creatore di ogni cosa! diventano matti così, da credere che la terra sia essa l’onnipotente creatore; creatori sian le piante, e creatori degli uomini, sian le bestie! non sono pazzi frenetici che hanno perduto il bene della ragione? Noi, che per grazia di Dio siamo ragionevoli ancora, facciamo il più bell’uso della ragione umana col dire insieme con tutto il genere umano « io credo in Dio Creatore del cielo e della terra. » Via adunque tante stranezze mostruose, cui si trovano ridotti ad inventare quei poveri disgraziati che non vorrebbero confessar che Dio creò noi uomini tanto superiori, come v’ho detto finora, a tutti gli animali: poiché ci creò ad immagine sua: come vi spiegherò adesso. – Vi ho già detto come Dio ci ha fatto intendere che ci voleva creare superiori a tutte le creature in terra, da comandare ad esse. Perciò volendoci creare colla ragione ad immagine sua, ci formò un corpo appunto adattato a servire all’anima ragionevole: parlerò del corpo nostro e poi dell’anima. – Anche qui Dio, per adattarsi al modo di pensare di noi, ci fa intendere come volendo creare l’uomo ragionevole gli formò, o quasi per dir così, impastò di sua mano la creta, per formare questo corpo nostro. Dio fece come un ingegnoso architetto. Questi nel costruire un grande edifizio, dispone in esso in bell’ordine tutte le membra di dentro, per servire ai bisogni di chi è destinato ad abitarlo; ma poi il bravo, di fuori in sulla facciata, coi più belli ornamenti esprime tutto il suo pensiero, e fa sì, che al solo contemplar quella, s’intenda e il fine per cui l’edificio è fabbricato, e s’indovinino le membra ben disposte di dentro: improntando così su di essa tutto il suo pensiero, e lasciandovi vedere sopra un lampo del suo genio. Così Iddio formò di terra il corpo umano facendo, che tutte le parti del corpo fossero esattamente adattate a servire ai bisogni dell’anima che pensa, che ragiona, e dispone di tradurre in atto i suoi pensieri, diversa in tutto dall’anima sensitiva degli animali. Egli lasciò in tutto in tutto quello l’impronta della sua sapienza, ma nel volto come una figura dell’Immagine sua, però la fece trasparire più viva. Contemplate di fatto come ebbe formato il corpo; in modo di stare sulla pianta de’ piedi fermo e sicuro, colla vita dritta che posa sui larghi fianchi con dignità; colle braccia snelle e le mani pronte ad eseguire i più industriosi e delicati lavori; con quella bella testa che posa con grazia sulle spalle in aria di comandare, e la gira con scioltezza a tutto d’intorno in ogni a lì per dire, che egli ha da tener d’occhio i suoi interessi per tutta la terra, e poi fare eseguire i suoi comandi a tutte le creature. Ci ha fatto poi il petto più largo in proporzione, perché il cuore dovea palpitar più forte, quanto sarebbero più vivi gli affetti dell’anima, capace di amar senza fine. Ma sul volto poi vuol che si esprima tutto che vi è dentro nell’uomo. Nel volto quegli occhi che girano inquieti sopra tutte le creature; ma per essi l’anima uscirà fuori ben sovente, come a cercare nel cielo il ben che non trova sopra la terra. Sul volto poi i più teneri sentimenti di lei ed i gravi pensieri ed i dolori di lei che non ha consolazione qui e la maestà di re della terra: mentre in quel sorriso di pudica bellezza si esprime l’anima innocente che ride in terra, come un angelo in cielo. Insomma nel volto traluce un raggio della bellezza di Dio, perché Dio v’infuse dentro ad abitarvi un’anima immagine di sé medesimo, poiché è ragionevole. Formatolo così, quando poi l’ebbe vivificato poté pigliarlo per mano, farlo sorgere in piedi, e dirgli: « piglia possesso e signoria di questo mondo che io assoggetto al tuo dominio.» – Ora vi ho da cercar di spiegarvi come l’anima è immagine di Dio e ragionevole. Dio bontà infinita voleva avere delle creature in terra, come vi ho già spiegato, le quali lo conoscessero e lo amassero; per potere amarle anch’Esso coll’amore di padre. Ora vedete ben voi come i padri amano nei figli l’immagine propria, e come sono capaci di far tutto il bene per loro, care immagini di sé medesimi; ebbene, Dio appunto creò noi uomini proprio ad immagine sua, per amarci, come il padre ama i suoi figliuoli. Fa Iddio di noi come tanti ritratti di Sé, piccole immagini, e come in miniatura; ma veri ritratti, che al possibile in qualche modo gli somigliamo. Ora vi spiegherò alla meglio come siamo creati somiglianti a Dio. Come nella piccolissima pupilla dell’occhio umano si vedono in piccolo tutte le cose dell’orizzonte, e fino una parte del cielo di sopra; così nell’anima, quale è creata da Dio si vede un’immagine proprio sua, e fino una somiglianza degli attributi di Lui. Difatti Dio è un Lume Eterno che conosce Se Stesso; e noi abbiam le anime, che conoscono anch’esse. Creandole par dica Iddio « creature mie, voi mi conoscete colla ragione in qualche modo, almen che Io sono: ebbene, cercatemi, che Io mi vi lascerò trovare; diliges Dominum ex tota mente tua » Dio è una Volontà benevolissima, é tutto amore eterno: ebbene Dio ci ha creati capaci d’amare, e par che ci dica « amatemi, che io vi amerò ». Dio fa tutto colla sua santa volontà, a sua libera elezione; ebbene Dio nel crearci, affinché gli diamo la prova di amarlo di buona volontà, ci mise in mezzo a queste cose create, che domandano anch’esse di essere da noi amate; onde noi dicessimo alle creature « tacete, tacete perché noi più che voi, vogliamo amare Iddio, l’amiam più di tutto, più di noi stessi; poiché Egli è il Sommo Bene diliges ex toto corde tuo ». Dio è somma Giustizia, e ci dice« siate giusti; perché, se non siete giusti, non possoamarvi: » e noi per essere giusti, dobbiamo amare più Dio, che lo merita più che tutte le creature.Ma io voglio dirvi qui ciò, che veramente deve farci tremare il cuore della tenerezza più viva. Voi lo sapete che Dio è così grande nella sua Divina Bontà da amarci tanto, fino a farsi uomo e morire per noi. Ebbene anche in questo ha voluto che l’anima nostra gli rendesse immagine della sua bontà. Poiché quando colla grazia sua divina conosciam Dio che merita d’essere stimato, d’essere amato infinitamente, più di noi medesimi: pere ssere giusti verso di Lui, lo vogliamo amare ditanto amore, da voler morire e dare la vita per provache l’amiam più di noi medesimi!…. Ora potremo capire un poco come Dio creandoci con tanta bontà così, ci debba dire (lasciatemi parlar così col cuore n mano) « creature del mio amore, care immaginette di Me Medesimo, figliuoli miei, la mia bontà divina non è contenta mai, per vostro riguardo, finché Io non vi avrò a vivere con me beati in Paradiso ». Ma come potrete farlo, o Signore?… E Diorisponde: « V’immergerò nella mia beatitudine infinita, eterna, vi darò tutto Me Stesso, Ego ero merces tua ». Ecco adunque che siam creati ragionevoli, cioè coll’anima capace di conoscere, di amare e di essere beati con Dio: ah maledetta la bestemmia che troppo insulta Dio ed insulta noi creati che siamo come figliuoli di Dio, capaci d’imitarlo nella sua bontà, destinati a vivere eternamente con Dio, maledetta a bestemmia, che ci dice figliuoli di bestie! No: gli uomini non soffrirono mai un insulto peggiordi questo di sentirci a dire figliuoli di bestie. AImeno i pagani, benchè, meschinelli! non adorassero il vero Dio tutt’altro, che far bestia l’uomo, volevano dell’uomo fare un dio; e quando volevano adorare il dio della bellezza dicevano che quel dio era una bella creatura umana: e quando poi volevano figurarlo, non scolpivano l’immagine d’una brutta scimmia, no; ma scolpivano un’immagine di persona umana risplendente di tale bellezza, che per loro pareva divina. Quando poi essi volevano rappresentare il dio re del loro cielo, non scolpivano un gran bestione, no!….; ma si scolpivano nel Giove di Fidia un uomo sfavillante di un lampo di bellezza ancora che pur pareva divina. Adunque anche i poveri pagani credevano anch’essi, o almeno avevano un sentore, che I’uomo creato da Dio rappresentava l’immagine di Dio Stesso. E noi Cristiani abbiam da star lì tranquilli e senza sdegno a sentirci dire, che noi siamo le più grandi bestie? Ah costoro che non vogliono intendere, che noi uomini ragionevoli capaci di essere amati come figliuoli da Dio, costoro sì, che meritano di esser chiamati, come li chiama s. Paolo uomini animali: animalis homo non percipit quæ Dei sunt. – Deh! facciamo almeno il viso dell’armi, e vogliodire, ributtiamo da noi questi indegni bestemmiatori; e se li sentiamo abbaiarci appresso tali bestialità, corriamo a coprire le venerate immagini deinostri Santi; affinché non vi mettano su il grugnoquesti uomini imbestiati, ad insudiciarle della loro orrida bava! Deh, che s. Luigi Gonzaga, quell’angelo in carne, com’era, non si senta dire che egliè figliuolo dello schifoso macaco! Deh, che quella grand’anima di s. Carlo Borromeo tutto carità,com’era, immagine della bontà di Dio, non si senta dire che egli è figliuolo di quell’orsaccio di orangotano! Deh che quelle angeli che vergini sante,Agnese, Cecilia, Catterina e Rosa, fiori del Paradiso che spuntarono su questa aiuola della terra innaffiate dal Sangue di Gesù Cristo, non si sentano dire che sono sorelle carnali di quel mostro di scimpanzè,che fa orrore a vederlo! E quelle sante Margherita ed Elisabetta, care madri dei poveri e tutti i santi immagini viventi di Dio, che Egli fece veder sulla terra nella sua misericordia, per guidarci col loro esempio per mano dove ci aspettano in Paradiso, deh deh che non si sentano a dire di Paradiso che esse sono carne d’ossa dei feroci gorilla, che hanno il grugno di jena! Eh noi figliuoli di questi orrendi mostri? ah no! Dio li ha fatti troppo brutti e schifosi e troppo orrendi, per avvisare noi, che noi siamo da loro al tutto diversi, e che le dobbiamo sdegnosamente ributtare lontane da noi come brutte bestie; mentre noi siamo immagini viventi di Dio. Noi, che abbiamo, come figliuola di nostra famiglia, e per madre dell’anime nostre, Maria. Oh Madre benedetta Maria, la più bella immagine del Ss. Iddio in persona umana! Certo che pensava a voi il Creatore Iddio, quando impastava, per dir così, la creta da formare il corpo umano da infondervi poi l’anima ragionevole, e così creare l’uomo ad immagine di Sé Medesimo. – Dio fin d’allora nel principio del tempo contemplava Voi, che sareste nata Immacolata, e si compiaceva di Voi, come dell’opera sua più bella in figliuola dell’uomo. Noi pensiamo che Dio dicesse « questa creatura sarà così santa, e al possibile degna di Voi, o Figliuol mio, sicché Voi la potrete pigliare per Madre e formarvi in quel seno, puro come il Paradiso, il Vostro Corpo e infondervi Anima per opera del Nostro Amore Eterno; e così nascere Uomo e Dio in una sola Persona: come l’uomo in anima ed in corpo forma una persona sola. Ah intendiamo adesso che cosa è l’uomo! è creatura ragionevole, immagine viva di Dio, destinato a mostrar sulla terra una figura, un’immagine insomma, che aiutasse a fare intendere in qualche modo il miracolo più grande della bontà di Dio: e come noi siamo anima e corpo in una sola persona umana, così rappresentassimo Dio fatto Uomo in una sola Persona Divina, Gesù nostro Salvatore benedetto, Dio fatto uomo, per far noi uomini beati in Dio. Viva Dio! che per Gesù suo Figlio siamo immagini non solo di Dio; ma siamo anche figliuoli del Sangue suo Divino.
Pratica.
Amiamo Dio sopra ogni cosa e viviamo come Figliuoli uniti di sangue al Figliuolo Eterno Sostanziale di Dio.