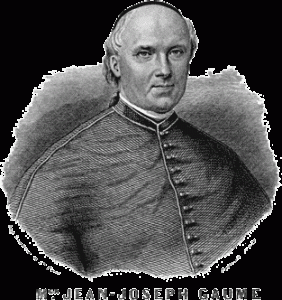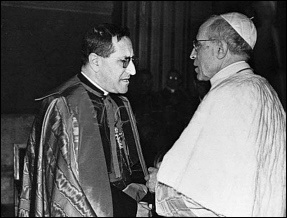IL PAGANESIMO ANTICO E MODERNO (7)
OTTO DISCORSI DETTI DAL P. CARLO M. CURCI D. C. D. G.
NELL’OTTAVA DELL’EPIFANIA DEL 1862 IN ROMA
ROMA – COI TIPI DELLA CIVILTÀ CATTOLICA – 1862
DISCORSO SETTIMO
ARGOMENTO
Amore patrio alla pagana. Quell’amore si fonda nella natura, e pei Cristiani è carità del prossimo. Sacrifizio pel bene comune. Veri patrioti. Come il Paganesimo formasse della patria un idolo. Tirannide di questo e schiavitudine universale. Cristo ne francò il mondo. Solo Signore dei Cristiani è Cristo. Amor patrio e sudditanza nel concetto evangelico. Diritto divino. Politica erodiana.
I. Se non il più giusto, certo il più splendido orgoglio dell’antichità pagana fu quel caldissimo amore di patria, onde gli uomini alla grandezza di lei ogni loro cosa e sé medesimi, alacri, volenti ed in tanto numero, sacrificarono. E pari allo splendore di quella gloria furono le ammirazioni, colle quali i secoli appresso la celebrarono, per opera soprattutto dei retori e degli umanisti. E chi è di noi, signori miei, che alle rimembranze della sua fanciullezza non associi gli stupori e la riverenza pei Temistocli e per gli Epaminondi, pei trecento Spartani e pei diecimila di Senofonte, per Maratona e per Salamina? Chi di noi non ha celebrato, per esercitazione di scuola, gli Orazii e i Curiazii , i Camilli e gli Scevoli, gli Scipioni, i Pompei ed i Cesari, senza che vi mancasse, quando il pedante pizzicasse un poco del libertino, qualche fiore poetico, aggiunto dalla nostra musa balbettante alle civiche corone dei Gracchi, o dell’uno e dell’altro Bruto? Io non cercherò se e quanto siano ben consigliate quelle ammirazioni; questo dico solamente, che quando a quelle ammirazioni poco meno che puerili, vengano dietro insegnamenti, foggiati sulla stampa del Segretario fiorentino, non consolati da un alito di Cristianesimo o da un fiato di Fede, allora non ne può venire altro che lo spettacolo che abbiamo visto noi, che ne stan vedendo i popoli europei da un paio di generazioni, e ne vedranno, chi sa per quante altre! i nostri nipoti. Non ne può venire altro che una storpiata parodia del vecchio fanatismo pagano, tra il goffo e l’atroce non sapreste qual più, ma goffo ed atroce in supremo grado: parodia, per la quale popoli, che anelavano ad una felicità portentosa, si videro travolti in un mare di guai, e che in vece di diventarne gloriosi, furono fortunati, quando ne divennero solamente ridicoli. Né voi, o Romani, per esserne persuasi, avete uopo di risalire alle storie di Pierleone, di Cola da Rienzo o di Arnaldo da Brescia. A voi basta recarvi alla memoria ciò, di che, già poc’oltre a due lustri, voi medesimi foste parte e testimoni. Deh! che era divenuta a quei di questa vostra alma città, Capo dell’Orbe, centro del Cattolicismo, patria spirituale di quanti sono credenti, e gloria e stupore dell’universo mondo? Abbandonata alla balia d’una falange di forsennati, che, come paese di conquista, la correvano qual cosa loro; perduta ogni sicurezza della vita, ogni tutela delle sustanze, ogni riguardo ai diritti, vedea ogni pace, ogni decoro, ogni tranquillità cittadina tolta via; e dolorava intanto allo scorgere esule il suo Pontefice, disertati i suoi templi, perseguiti e manomessi i suoi Sacerdoti, e la pubblica cosa a tali termini divenuta, che essa dovette salutare con gaudio il fulminare delle artiglierie, che, battendola in breccia e squarciandole un fianco, venivano a liberarla da tanti dolori e da tante vergogne. E pure vi è chi vorrebbe cominciare da capo! E che altro chiedereste per convincervi, che sono pur troppo superstiti alla sconfitta quei fanatismi, dai quali eziandio le anime buone sogliono talora sentire qualche offesa? Nondimeno quanto non ci sarebbe agevole lo schermircene, se ci tenessimo saldi alle norme del santo Vangelo! Né credeste già che il santo Vangelo togliesse un pregio al mondo sterpandone quel fanatismo; esso anzi lo liberò dalle esorbitanze di un orgoglio feroce e dall’avvilimento di una schiavitudine codarda. Signori sì! Signori sì! non è a prenderne meraviglia: il tanto vantato amor patrio dei Pagani, salvo i rari casi in cui poté avere qualche naturale rettitudine, come era socialmente professato, era un indistinto di orgoglio e di schiavitudine, in cui solo non può definirsi chi fosse più misero, se chi opprimeva o chi era oppresso. Ma Cristo Redentore, chiamando il Paganesimo alla luce della sua verità, lo sciolse da quel fascino, e ritenendone il naturale fondamento, raddrizzò, ridusse alla sua vera misura, nobilitò e consacrò il medesimo amore della patria, come fece di tutti i legittimi amori. Questo mi studierò di mostrarvi nel presente discorso; e, senza più, prendo le mosse e comincio.
II. Come dunque io vi diceva testè, il fanatismo patrio dei Pagani, con tutte le sue forsennate esorbitanze, avea un fondamento legittimo nella natura. E qual cosa più naturale all’uomo, che amare di tenerissimo affetto il luogo natio? quel luogo natio, a cui si associano tante rimembranze della inconsapevole infanzia e della vaga puerizia; che accoglie tanti nostri beneamati o per vincolo di sangue, o per lunga consuetudine di dolci ami che in ogni via, in ogni piazza, in ogni tempio, starei per dire in ogni zolla ed in ogni sasso ha legata una qualche memoria degli anni che furono, e sembra ripeterci in sua favella i favori onde fummo lieti, le allegrezze e i dolori che partecipammo coi nostri o domestici o concittadini, e fino i lieti sogni della spensierata giovinezza e le speranze! Di questo poi soavissimo sentimento, se di altro mai, si avvera quello che a rispetto di tutti gli altri beni della vita suole avvenire; che cioè si cominciano ad apprezzare, quando si perdono. E voi che ora neppure avvertite gli agi, il decoro, le affezioni che vi circondano in questa nobilissima patria vostra; oh! voi li avvertireste davvero e con ismisurato desiderio li sospirereste, quando (che il cielo non voglia!), esuli da lei, vi aggiraste stranieri tra stranieri sembianti, visitando città, castella e borgate, che, poco dicendo al pensier vostro, affatto nulla non direbbero al vostro cuore; quando sorpresi in luogo solingo dal declinare del giorno, vi avvenisse di ascoltare una squilla da lungi: oh! allora, al rimembrare il nido natio e i cari lontani, sentireste serrarvisi il cuore e gli occhi vi si gonfierebbon di lagrime. Ed ora che questa Roma, sempre ospitale, accoglie tante vittime onorate delle ire civili, chi sa in quanti cuori avranno trovata un’eco affettuosa queste mie parole! – Che se alcuni per divino servigio abbandonano la patria loro, non credeste per questo che essi l’abbiano in poco pregio, o ne siano disamorati e indifferenti, come alcuni odiatori della pietà ne li hanno calunniati. NO! davvero! E quale sacrifizio farebbero essi a Dio, se per niente l’amassero? il sacrifizio consiste appunto nel lasciare per suo amore, e forse per sempre, cosa tanto caramente diletta. – O cielo ammantato d’azzurro! o fulgidi soli e dorati! o tranquille marine! o pendici fiorite, che sorrideste benigne alla mia culla, e forse alle stanche mie ossa non vi farete pietose! oh! Patria mia! Quanto non me li fece più cara la tua sventura! Tu, per ignavia e perfidia di pochi tuoi, di donna, che fosti e reina di province, sei fatta serva; e del servaggio stai cogliendo frutto amarissimo, nelle insidie che si tendono alla gemma dei pregi, che ti fanno cara ai presenti e dai lontani ammirata, alla Fede santissima dei padri tuoi! Sicché vedete che l’amore della patria è cosa legittima, naturale, che nulla non può avere di riprovevole, e che anzi può essere degno di molta commendazione, quando si mantiene nei limiti a lui segnati dalla ragione. Ma deh! questi limiti in quale amore seppe conoscerli e mantenerli la ragione umana, come giacque abbandonata a sé stessa nel Paganesimo? Neppure li sospettò quei limiti: tanto fu lungi dal non preferirli! Ma noi nati alla grazia, noi formati alla scuola dell’amore, noi sappiamo bene onde si origina quell’amore della patria, quanto largo si stende, quai doveri c’impone; ed insomma, illustrati la mente dalla Fede, lo possiamo quasi notomizzare, come colla scorta di san Tommaso ci è agevole a fare di tutte le altre umane affezioni. Ora, come insegna l’Angelico, l’amore della patria non si origina da altra fonte, che dalla carità verso del prossimo; la quale carità, benché nessuno non escluda dal suo affetto, deve nondimeno, per essere ordinata, pigliare la sua norma, appunto dalla prossimità; ed i più vicini amare più e prima, che i più lontani. Così il luogo, ove nascemmo e fummo educati, e gli uomini che lo abitano dobbiamo amare più, che non quelli della nostra Provincia, e questi più di quelli del nostro Stato, e questi più di quelli della nostra Nazione; e così via via, senza che una ragione di amare non manchi mai, quanlunque quell’attinenza, coll’allontanarsi dal centro, si vada facendo sempre più rimessa: appunto come avviene nel simbolo più espressivo dell’amore, che è il fuoco, dal quale quanto più vi allontanate, e tanto meno vi viene di calore. Di che si vede che l’amore della patria non è altro finalmente, che un’ampliazione dell’amore di famiglia, in quanto sono appunto le famiglie, le quali raggruppandosi fanno i Comuni, e questi, congiungendosi tra loro, costituiscono le Province, dalla cui riunione con altre, sotto l’Autorità medesima, è formato lo Stato. E quinci apparisce quanto sia insipiente il nostro secolo, il quale predica tanto l’amore della patria, e poi, col debilitare per tutti i modi l’amore della famiglia, ne scalza e ruina il primo fondamento e forse l’unico. Anzi è così naturale quella genesi dell’amor patrio, che le condizioni di questo si debbono ragionare, appunto per analogia all’amore della famiglia.
III. Ed il primo sentimento cristiano, che in questa materia ci si offre al pensiero, è questo: non essere cioè ordinato l’individuo al bene della famiglia, o della società civile, ma essere la famiglia e la società civile ordinata al bene dell’individuo; e ciò consuona perfettamente con quell’alta dignità, che la nostra Fede riconosce nella umana persona. Che se tutta questa gran macchina del mondo sensibile è costituita ed ordinata a servigio dell’uomo; crederemo poi che l’uomo sia come morto strumento, e mezzo quasi inanimato, pel bene di un essere collettizio, poniamo pure che voluto dalla stessa natura? E perché altro volle natura, che l’uomo nascesse in famiglia, vivesse in società, se non perché gli fossero assicurati i mezzi di ogni suo bene religioso e naturale, morale e fisico? Vero è che il bene della famiglia e della società rifluisce nei particolari soggetti, che compongono l’una e l’altra; ed in questo modo chi fa servigio a quelle lo fa a questi, e tanto più ampio lo fa, quanto la comunanza è più vasta. In tal caso è manifestissimo il principio, che il bene comune deve prevalere al privato, essendo certo che il bene di mille o di diecimila è cosa assai più rilevante, che non è di uno o di dieci. Ma quando si trattasse di vantaggi, i quali o veri beni non sono, o fossero tenuissimi e di pochi, il sacrificare a quelli l’individuo sarebbe uno sconoscere la dignità umana; sarebbe una tirannide in chi lo pretendesse da altri; sarebbe una pazza fantasia, scusabile appena per l’ignoranza, in chi si contentasse di patirlo per sé medesimo. E che direste di un uomo, il quale, per aggiungere un vano titolo alla sua casa, o per crescerne di alquanti scudi il patrimonio, vi rimettesse di sanità, di onore, e quasi che non dissi, vi sacrificasse la vita temporale e l’eterna? Ora ragionate alla stessa maniera della patria, la quale è appunto una grandissima famiglia, di cui siamo membri. Il vero bene di questa consiste nella pace, nell’ordine, e specialmente nella giustizia in tutto e per tutti, senza la quale l’ordine sarebbe fittizio, e la pace saria bugiarda. Ed è naturale che a procurare quei beni alla patria ogni sacrifizio dalla nostra parte saria ben collocato; stantechè se è bello trasandare le proprie utilità, per assicurare quei beni al fratello, al congiunto, all’amico; quanto sarà più il trasandarle per la patria, che vuol dire per l’accolta vastissima di tutti i parenti, di tutti gli amici, di tutti i congiunti, e di quegli altri innumerevoli, che, quantunque sconosciuti, ci sono pure legati col vincolo del medesimo consorzio civile? E quindi si origina la giusta ammirazione, che circonda quei generosi, i quali per assicurare alla patria loro qualche grande e vero bene, e più per liberarla da qualche grande e vera calamità, non dubitarono di esporre ad ogni sbaraglio la propria vita. Questo è propriamente il ponere animam pro fratribus, del quale Cristo insegnò non vi essere atto di carità più eccelso. Di che vedete che, per noi Cristiani, l’amore della patria appena è altro dalla carità verso il prossimo; e se non fosse prostituita la significazione di questa voce, come la voce stessa non è italiana, vorrei dire che i più grandi patrioti furono gli uomini apostolici, i quali spesero tutta la loro vita pel bene morale e spirituale dei popoli, nel cui mezzo vissero ed operarono. Furono, per figura di esempio, per questa Roma il vostro Filippo Neri, per Firenze il suo Antonino, il suo Carlo per Milano, per la mia Napoli il suo Francesco di Girolamo, e così di altri per altre città e regioni diverse. A questa stregua veri patrioti sono, esempli di grazia, que’ benemeriti professori che, decorando la patria della loro scienza, coll’insegnamento e coll’esempio, le apparecchiano, in una gioventù istruita e cristianamente morigerata, ottimi cittadini; sono quei pubblici ufficiali che, col pieno ed accurato adempi mento dei propri doveri, mantengono la buona contentezza nell’universale, guardando il proprio ufficio, non come un beneficio semplice, ma come un vero carico di servire al pubblico: della quale tutto cristiana parola meno d’ogni altro dovrebbero adontarsi gli uffiziali di uno Stato, il cui Sovrano non disdegna intitolarsi Servo dei Servi del Signore. Così, per la ragione dei contrari, non patrioti, ma parricidi sono quegli scellerati che, alle proprie cupidità ed ambizioni pretendendo non so che gloria e prosperità della patria, apparecchiano a questa giorni procellosi, ne contaminano il costume, ne insidiano la Religione, spogliando, perseguitando, proscrivendo e perfino trucidando i più specchiati e zelanti suoi Ministri.
IV. Ora, chieggo io a voi: questo verace amore di patria come poté aver luogo nel Paganesimo, il quale della carità, non che esercitare i doveri, non conobbe neppure il nome? E quando pure si volesse lasciare da banda la carità, come avrebbe potuto il Paganesimo coll’amore della patria ordinare il civile consorzio, quando esso ignorava di questo le condizioni essenziali e la natura? come già Minucio Felice avea notato: Non potest pulchre gerere rem civilem, quia non cognovit hanc communem mundi civitatem (OCTAVIUS, Cap. XVII). Conviene dunquedire, che nel fondo di questo patrio amore si trovassequell’orgoglio smisurato, che era come l’anima e la vitadel Gentilesimo, il quale per questa via, anelando dislargarsi ad obbietto più grande, riusciva a fabbricarsicolle proprie mani un nuovo idelo, a cui servire e percui sacrificarsi. Mi dichiaro; e voi fate di penetrareintrinsecamente in questo mio pensiero; ché forse ragionandovi del mondo antico, vi rivelerò una piaga bendolorosa del moderno.L’uomo, abbandonato a se stesso e perduta, non cheogni conoscenza, ma ogni rimembranza del suo principio, cercò in sé solo l’appagamento compiuto di ogni sua aspirazione. Ma ristretto alla cerchia del proprio individuo, sentì tosto che era vano cercarvi l’adempimento di desiderii che, lui inconsapevole, lo portavano all’infinito. Pertanto, uscito in certa guisa di sé medesimo, cercò nel mondo esteriore qualche cosa più ampia e più permanente, che non fosse l’individuo, angusto sempre, meschino e labile, come il fumo nell’aria o la spuma sull’acqua. Quest’obbietto credette avere trovato nella patria, nella nazione, nello Stato. Quindi si strinse ad esso; e tanto più ad esso si strinse, quanto sperò che, afferrato, in un modo o in un altro, se non il timone di quella gran nave, almeno un remo, avrebbe esso partecipato la potenza, le ricchezze, la gloria, di che sarebbe la patria depositaria e custode. Così quell’autolatria o adorazione di sé medesimo, la quale era il carattere più espressivo dell’uomo pagano, si amplificava, in certa guisa, e si distendeva in uno smisurato ente collettivo, nel quale tutti, adorando sé stessi, adoravano tutti; ed oltre a ciò se ne acquistava qualche sicurezza contro le invasioni degli altri popoli, i quali, però solo che erano forestieri, erano riputati, secondo le idee di quel mondo, non pure barbari, ma nemici. Eccovi dunque della Patria fatto un verissimo idolo, che s’impadroniva di tutto, che assorbiva tutto, che trasformava tutto in sé medesimo; ed eccovi i popoli trascinati ad immolarsi, a vendersi anima e corpo, per la prevalenza e per gl’incrementi di lei .. Né già, vedete, per gl’incrementi della contentezza privata, del costume, della pace, dell’ordine, della giustizia, la quale della pace e dell’ordine è unica norma e sicura custode; ma sì veramente a fare che la patria allargasse, quanto più si potesse, i suoi confini, annettendosi Stati e Province, quante più potesse (vedete come le annessioni sono cose stravecchie nel mondo); a fare che la patria fosse riverita servilmente dalle vicine nazioni e temuta dalle longinque; che potesse disporre dei destini dei popoli e, se fosse possibile, togliesse e donasse corone ai Regi; senza che in tutto questo entrasse altro motivo che l’orgoglio, altro movente che l’interesse, altro strumento che la forza, altro titolo che il diritto del più forte e la prepotenza. Qual parte si promettesse ciascuno di quella potenza, di quelle dovizie, di quello splendore è inutile a dire, quando è manifesto che tutti i liberi cioè i non mancipii, doveano prometterlasi grandissima, benché quasi tutti ne restassero a denti asciutti; come anche a’ dì nostri si è visto in più di un caso e si vede. Nè altro potea essere, stanteché, dovendosi pure innalzare quella smisurata mole (e tutti vi agognavano i popoli, benché un solo vi riuscisse), fu naturale, che a quella mole si dovesse dare per appoggio, per alimento e per sostegno, tutta la immensa turba dei cittadini, i quali, con isnaturato pervertimento, non più pensarono, la patria essere per bene loro; ma si giudicarono, sé essere per bene della patria, ed a quel mostruoso Moloc tutti doversi immolare i più santi affetti, tutte le più legittime propensioni, tutti gl’interessi, tutti i respiri, tutte le vite. Quindi quelle massime, contro cui la natura freme, e che nondimeno lasciarono eco prolissa infino a noi, i cittadini essere proprietà dello Stato; nulla possedersi in proprio da quelli, che dallo Stato non si possa occupare come cosa sua; i figli appartenere, non tanto ai propri genitori, quanto allo Stato, il quale ne può commettere a cui meglio gli sia in grado l’allevamento: per poco non si aggiungerebbe, i cittadini portare la testa sul collo, per graziosa degnazione dello Stato , il quale per ora non vede ancora nessuna sua utilità nel separarnela; ma se la vedesse, non penserebbe un quarto d’ora a fare loro la festa. Ed una società, a questa maniera costituita, che era dunque, se non un immenso branco di pecore, chiamate cittadini, i quali o le quali, perduta ogni coscienza, non che della propria dignità, ma della personale loro indipendenza, viveano atterrati e conquisi dal dominio assoluto di un essere misterioso e inesorabile, che impinguava di oppressioni, vivea di servaggio e si abbeverava, senza mai dissetarsene, di lagrime e di sangue? che altro era, se non un popolo che assassinava stupidamente sé stesso, perché lo Stato fosse abilitato ad assassinare altri popoli? Leggete con occhio cristiano le storie antiche, e voi non vi troverete altro. Erano popoli che si scannavano l’un l’altro per l’ingrandimento della patria rispettiva; e, finito o piuttosto sospeso il macello, trionfava la patria che più aveane uccisi degli altri, e meno ne trovava uccisi dei suoi; ma sempre uccisi. Direte che quella patria aveanla fabbricata essi: direte che volenti a lei e per lei s’immolavano. Ma che per ciò? forse che gl’idolatri non adorarono e non adorano un fantoccio fabbricato dalle loro mani? forse che il forsennato non si getta nel precipizio menando carole? Dite dunque forsennati quegl’idolatri, ed avrete spiegato il mistero. Nel resto quella medesima illusione di vedere nella patria un essere collettizio e quasi un corpaccio immenso, nella cui smisurata ventraia ognuno potea immaginarsi di carpire un siterello, per fruire potenza e ricchezza, quella medesima illusione sparì col decadere della Repubblica romana, concentratane l’autorità nelle mani di Ottaviano Augusto, il quale, col nome di principale, si prese il tutto. Personificatasi la patria in un uomo, quell’uomo fu Imperatore, fu despota, fu idolo, fu Divo, ed ebbe templi, ed are, ed incensi, e sagrifizii; quantunque i pretoriani si avessero arrogato il diritto di mandare all’altro mondo quelle vituperose divinità, quando diventavano intollerabili, e loro, senza più, sostituirne delle altre, che sarebbero spacciate al modo stesso. E si vide così lo spettacolo, prolungato per alquanti secoli, di quasi tutto il genere umano, almeno per la parte fino allora conosciuta ed esplorata, che, incatenato e pavido, allibiva o fremeva ai piedi di un uomo bestialmente mostruoso, spesso sarmata, talora trace, la cui volontà consideravasi come il fato, e la cui persona era adorata come divina. Oh! non vi pare che l’uomo fosse stato così ripagato con larga usura dell’alterigia, ond’erasi sottratto superbamente al dominio del vero Iddio? Da quaranta secoli il genere umano non era mai dechinato sì basso! e ben si dice, nei Fasti cristiani, che nell’anno quarantaduesimo di Augusto tutto il mondo era in pace: era la pace universale della universale schiavitudine! Ora fu proprio quello l’anno, in cui apparve al mondo il Salvatore, il Liberatore per antonomasia, il grande e vero Sospitatore!
V. Rientrata un’altra volta l’umana famiglia, mercè la grazia del Salvatore, sotto il dominio di Dio, se ne ristorò tosto la dignità, non già, vedete, rifiutando obbedienza a quei tiranni: tutt’altro. Mentre i Cristiani erano così perseguiti e manomessi, in tutte le cospirazioni, che si ordivano contro quegli esosi Imperatori, non si trovò che pigliasse mai parte un Cristiano; e Tertulliano sfidava a fronte alta i Gentili a nominarne un solo che l’avesse fatto! Ma sì veramente fu ristorata, per tale rispetto, la dignità umana, facendo che dalle generazioni redente s’intendessero le intime ragioni dell’ordinamento sociale, e la tanta parte, che il Re supremo ha nell’autorità civile, per quanto sia vero, che i depositarii di essa possano abusarne e talora ne abusino. Non più dunque l’uomo fu tenuto proprietà della patria, schiavo della Repubblica, mancipio del Principe o dello Stato. Oh! no! un’anima ragionevole ed immortale è cosa troppo sublime, sicché possa tributare le sue adorazioni ad altri, che a quel Re sempiterno, di cui sa di essere immagine espressiva; e quasi si sente spiracolo vivo. Il carattere del sacrosanto Battesimo, onde abbiamo insignita la fronte, ci onora assai più, che qualunque corona di Monarca non potrebbe; e l’ambizioso Civis romanus , di cui i padri vostri, o Romani, erano cotanto altieri, spari dai loro occhi, al pensiero di essere rinati per Cristo, come il Magno Leone con esso loro se ne gratulava: Nec tam gloriantur quod in Imperio geniti, quam gloriantur quod in Baptismate sunt renati (S. Leon. Serm. XXXVII). Noi amiamo la patria, riveriamo la legittima autorità civile; ma riveriamo questa ed amiamo quella di riverenza di amore ben diversi da ciò, che ne seppe e ne praticò il Paganesimo. Noi amiamo la patria, non come nostro fine ultimo: a questo modo, la nostra vera città, la vera nostra patria è il Paradiso. Noi amiamo altresì la terrena; ma l’amiamo come uno dei tanti mezzi fornitici dalla Provvidenza ad asseguire l’ultimo nostro fine; e perché questa destinazione si avveri, desideriamo che in essa patria fiorisca la Religione, la giustizia, la pace, l’ordine, senza aggiungere grande importanza al timore che essa possa incutere altrui colle sue forze di terra e di mare; e piangeremmo se vedessimo sperperate le sue ricchezze e versato a torrenti il suo sangue in guerre, di cui non si sapesse neppure il perchè, o si sapesse che sono a sostegno della nequizia; ed arrossiremmo quando sapessimo, che la nostra patria avesse perduta ogni fede nel mondo per le sue menzogne diplomatiche, o fosse da tutti guardata in cagnesco per le sue perfidie. Il prosperare materiale della patria piace anche a noi; ma non possiamo volerlo mai come bene assoluto, quale non è nessun bene creato; e così dobbiamo volerlo, e lo vogliamo subordinato ai beni morali ed agli eterni; e non sarebbe così subordinato, quando, per ragione di esempio, quella prosperità materiale, fattasi squisitamente voluttuosa e sibaritica in alquanti gaudenti del secolo, lasciasse ai più la fame, i dolori, le privazioni, una vita di pene incessanti e di fatiche. Per ciò che si attiene all’autorità legittima, il Cristiano non obbedisce all’uomo: no! il concetto dell’uomo, soggetto all’uomo, in quanto tale, è concetto altamente oltraggioso alla dignità di uomo, e più ancora alla professione di Cristiano. No! il Cristiano non ha altro Re o padrone che Dio, e precisamente il Dio Incarnato, e non obbedisce che a Lui solo. Noi coll’Apostolo Giuda professiamo di credere, a Gesù Cristo essere il solo Signore nostro: » Iesum Christum nostrum (Ephes. VI, 5, 6). E se Egli è Solo, non ve n’è, non ve ne può essere altro fuori di Lui. Qui, nei templi santi di Dio, sotto queste auguste volte, tra i solenni concenti dell’organo armonioso, in mezzo alla maestà dei riti cristiani, la nostra plebe, anche scalza, anche cenciosa, fa coro coi suoi Sacerdoti, che cantano altamente e proclamano uno, uno solo essere il Signore, il solo Altissimo Cristo Gesù: Tu solus Dominus, Tu solus altissimus, lesu Christe. E non vi pare, che questi scalzi, questi cenciosi siano al quanto dappiù di quel dorato servidorame, che, tenendo per unico Dio il suo padrone terreno, è dannato a imputridire nelle anticamere, aspettandone l’insigne onore di un comando, o il favore miracoloso di uno scherno? – Che se il Cristiano, com’è suo dovere, riverisce ed osserva eziandio le autorità terrene, ciò è solo, perché Iddio, nell’ordinamento della società e della famiglia, avendo conferita parte della sua autorità a chi alla famiglia od alla società fu preposto, egli il Cristiano in costui non paventa la forza, non teme l’astuzia, molto meno invidia la potenza; ma con semplice cuore riconosce un Luogotenente di Dio, un investito dell’autorità di Lui. Ed oh! che grande! che sublime parola è quella di Paolo là, dove conforta, non che i sudditi, ma gli schiavi medesimi ad obbedire ai loro preposti: “Servi obedite præpositis vestris sicul Deo …. non ad oculum servientes. Avete udito? Non bisogna fermarsi a quello che ce ne dice il senso; non dobbiamo mirarvi l’ambizione, l’ingiustizia, la prepotenza, la cupidità che spesso vi si trova, e più spesso vi si suppone; ma l’essere essi strumenti di Dio. Che se vi paresse strano, che Iddio pigli talora a strumento uomini inetti od anche malvagi, non ci è uopo di prenderne scandalo, e neppure meraviglia. Forse che Dio non castiga cogli scarsi raccolti, colle inondazioni, colle pestilenze, coi tremuoti? E perché dunque non ha potuto pigliare talora a strumento dell’ira sua, eziandio il mal governo di Reggitori incapaci o tristi, valendosene come il padre si vale della verga? Ché egli con questa corregge il figlio, e poscia al figlio riserba la eredità, e la verga getta ad ardere nel fuoco, secondo la viva immagine che ne dà Agostino. Or vedete fonte perenne di dignità, di pace, di contentezza rassegnata per qualunque sia sommesso a superiore potestà, eziandio quando questa o per incapacità tentenni e sbagli, o per malvolere, o per capricci trasmodi! soprattutto quando, riconosciuto da tutti il Potere come dato da Cristo, il suo Vicario in terra possa stendere la mano paterna, a rattento e correzione dei trascorsi di quello. Ma questa dottrina, che in sostanza è il tanto calunniato Diritto divino, e che mantenne il mondo, a tal riguardo, tranquillo per otto secoli, questo sistema, putiva troppo di sagrestia; ed i razionalisti umanitarii vollero rifare essi a modo loro la società. E che riuscirono a fare? scardinata la società europea dall’imo fondo, col sottrarle il fondamento cristiano, fecero una cotal pazza cosa, che né cristiana non è né pagana, ma va barcheggiando sciancata tra l’uno e l’altro, senza avere i vantaggi di alcuna: non la dignità della prima, non la stabilità e la forza della seconda. Dall’assoluta indipendenza individuale passarono a riconoscere l’autorità nelle moltitudini; nella impossibilità di ritrovare in queste il principio di autorità una ed operante, si gettarono alle maggioranze, ossia alla prevalenza del numero; ma essendo in questo troppi capi, si passò alle elezioni ed all’eletto. Talmente che, in ultima conchiusione, per non prestare obbedienza a Dio, si venne a prestare idolatria alla marmaglia; per iscuotersi da qualche dipendenza dalla Chiesa, si restò alla discrezione della piazza; per non riconoscere gli eletti di Dio, si riuscì ad accettare gli eletti del popolo, che significa, con rarissime eccezioni, i più furbi, i quali sanno meglio abbindolare le moltitudini passionate ed imperite. Voi non avete uopo che io vi dichiari gl’insigni guadagni, che con questi nuovi processi ha fatto la società, soprattutto nel costume e nella pubblica quiete, quando vedete le carceri e le galere sempre più amplificarsi, e le rivoluzioni essersi rese cotanto frequenti, che se il loro ricorrere fosse costante, noi potremmo misurare con esse il nostro tempo, come già i Greci facevano colle loro Olimpiadi. Riposiamo.
VI. Mi guarderei bene dal dire, che tutti i politici del nostro tempo esemplano in loro medesimi il perfido ed empio Erode, persecutore del Redentore fino dalla culla. Ma se l’asserzione, scendendo da quell’ampiezza, si restringesse a quei soli politici, i quali o non mai hanno avuto il dono della Fede, o ne fecero miseramente getto, sicchè appena hanno altra norma del loro pubblico operare, che l’ingrandirsi a tutti i patti ed il prepotere, alla maniera gentilesca; ahimè! che sarebbe purtroppo vero il paragone! E che fece finalmente Erode? volle conservarsi un Regno, a cui pare che avesse un qualche diritto, e volle conservarlosi ad ogni costo. E così, sentendo parlare di non so che nuovo nato Re dei Giudei, si dié a giocare di astuzia per saperne prima per minuto, e poscia per disfarsene in tutti i modi. Pertanto un po’ di politica machiavellica coi Magi, fingendo di volerlo adorare, quando avea in animo di sterminarlo; un po’ di acceso risentimento, quando si vide schernito dai Magi stessi, i quali più dell’Angelo si fidarono che non di lui; da ultimo un po’ di sangue infantile versato, un po’ di scipito guaire di madri piangolose, non erano cose da fare dietreggiare la ragione di Stato, la quale volea salvo il diadema, e segua che può. Or chieggo io: se si tolga quel troppo strepitoso macello d’infanti, cui la mitezza dei tempi moderni non vorrebbe tollerare, e quale è parte della politica erodiana, cui non abbiamo vista adoperata sotto i nostri occhi? colla sola differenza, che Erode lo fece per conservare il suo: noi l’abbiamo veduto fare per prendere l’altrui. Fingere ossequio, quando in cuore si cova odio; promettere amicizia, quando si stanno tendendo agguati; perseguitare qualche innocente , schiacciare qualche ardito, non si curare delle lagrime, delle sventure dei deboli, lasciar correre come acqua il sangue dei popoli, oh! e non sono cotesti i primi elementi della politica anticristiana, e peggio che gentilesca, tenuta in onore nel mondo? Ma Iddio che schernì gli scaltrimenti volpini dell’antico Erode, schernirà, siatene certi, anche quelli dei nuovi: Dominus irridebit eos. E valga a sostenere la nostra fiducia il saggio stupendo, che ci sta dando della protezione, onde Egli copre la Chiesa in maniera così analoga a quella, onde già protesse il divino Autore di lei fino dalla culla; massime chi consideri la qualità dei mezzi di cui si vale. Oh! guardate! Tanta strage d’innocenti dovea servire per ravvolgere in quella il temuto Re neonato; e pure il temuto Re neonato fu il solo, che non fosse ravvolto in quella strage. Ora non sapete come, nei disegni dei nemici di Dio e della sua Chiesa, la tempesta scatenata, in questi due ultimi anni, sopra i troni italiani era ordinata principalmente ad abbattere il trono del Vicario di Cristo? E non dimeno (voi lo state vedendo!) il trono del Vicario di Cristo è il solo, che non sia stato abbattuto da quella tempesta: Unus tot inter funera Impune Christus tollitur (Ecclesia in Officio SS . Innoc. Hymn. ad Matut.)