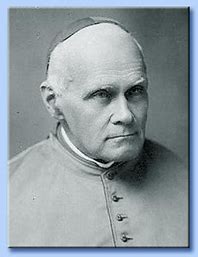CARDINAL LOUIS BILLOT S.J.
LA PARUSIA (8)
PARIS – GABRIEL BEAUCHESNE Rue de Rennes, 117 – 1920 TOUS DROITS RÉSERVÉS
ARTICOLO OTTAVO
LA PAROUSIA NELLE EPISTOLE DEGLI APOSTOLI, GLI ULTIMI GIORNI, IL DECLINO DEI SECOLI.
Bossuet, nel libro IV della sua Storia delle Variazioni, dà un bell’esempio del modo in cui coloro che si impegnano nella lettura della Scrittura e dei Padri diventano confusi, privi di una sufficiente preparazione teologica, ignorando le regole dell’ermeneutica sacra e i suoi principi fondamentali, disdegnando qualsiasi guida dalla tradizione o dal magistero della Chiesa, e per dirlo in una parola, con le sole risorse delle loro belle menti e della comune critica letteraria. L’esempio ci viene offerto nella persona di Melantone, che fu al suo tempo il più rinomato degli umanisti tedeschi, e rappresenta, inoltre, tutto ciò che era più o meno rispettabile tra i grandi capi della Riforma. Questo Melantone, al quale non si poteva negare una certa dose di sincerità e di zelo per la religione senza ingiustizia, aveva iniziato sostenendo con forza la realtà della presenza di Gesù Cristo nel sacramento dell’Eucaristia. Aveva persino composto un libro del “Sentimento dei Santi Padri sulla Cena del Signore“, in cui aveva raccolto molti passaggi esplicitanti la verità del dogma cattolico. Solo che, nel corso del tempo, si era reso conto che, tra il gran numero di testi citati, molti erano falsamente attribuiti a coloro che non ne erano gli autori, e questa spiacevole scoperta era stata la causa della sua prima delusione. Ben presto sorse un altro motivo di imbarazzo, più serio e fondamentale, che Bossuet spiega in questi termini: « Ciò che lo imbarazzava di più era trovare negli antichi molti luoghi dove chiamavano l’Eucaristia una figura. Ha raccolto i passaggi e si è stupito, dicendo di vedere una grande diversità in essi. Egli era un debole teologo che non si rendeva conto che lo stato di fede e di questa vita non ci permetteva di godere di Gesù Cristo allo scoperto, per cui si è dato in una forma estranea, unendo necessariamente la verità con la figura, e la presenza reale con un segno esterno che ce la coprisse. È da ciò che viene nei Padri questa apparente diversità che stupiva Melantone. La stessa cosa gli sarebbe apparsa, se ne avesse preso atto, sul mistero dell’Incarnazione e sulla divinità del Figlio di Dio, prima che le dispute degli eretici avessero obbligato i Padri a definirli con maggior precisione . E in generale, ogni volta che è necessario accordare insieme due verità che sembrano contrarie, come nel mistero della Trinità e in quello dell’Incarnazione, essere uguale ed essere meno (uguale al Padre, e meno di Lui), e nel sacramento dell’Eucaristia – essere presente ed essere in figura (presente sostanzialmente, ma sotto specie estranee) -. L’uso rende naturalmente il linguaggio che sembra confuso, a meno che non si abbia, per così dire, la chiave della Chiesa, e la piena comprensione di tutto il mistero… Melantone non sapeva così tanto… Grande umanista, ma solo un umanista, aveva a malapena potuto imparare l’antichità ecclesiastica dal suo maestro Lutero, ed era tormentato da una strana specie di contrarietà che credeva di vedere nei santi Padri. » Tale fu, secondo Bossuet, la storia dei dubbi di Melantone all’inizio, poi dei malintesi e infine delle palinodie sul dogma dell’Eucaristia. Ora, la storia è degna di nota, da ricordare, perché non è un caso isolato, né un incidente fortuito; è, al contrario, un caso che si ripete con la costanza e la regolarità di una legge, ovunque l’interpretazione delle Scritture sia lasciata, come qui, alle sole risorse della letteratura e della mente privata. È ripetuto, in particolare sul punto preciso della parusia, dai nostri modernisti attuali, che vediamo sconcertati, allo stesso modo e nelle stesse condizioni, dalle contraddizioni che credono di trovare negli scritti degli Apostoli. Infatti, non leggiamo forse in San Paolo, per esempio, per non parlare di altri, che la parusia era vicina, che era alle porte, che non poteva essere ritardata, e d’altra parte che non bisognava dare alcun credito alle voci diffuse sull’imminenza della sua venuta? Nessuno di essi doveva realizzarsi, dico, e per la buona ragione che prima del suo arrivo, dovevano essere realizzati molti degli eventi, ed i più considerevoli. E come possiamo conciliare insieme cose che sembrano così contrarie? … essere vicino ed essere lontano? Ancora nell’ignoto del futuro, e già in vista, già sul punto di essere realizzato? – Quindi ci sarà una doppia spiegazione. Per coloro che usano «la chiave della Chiesa », la chiave che dà « la piena comprensione di tutto il mistero » come previsto dalla Scrittura, riconosceranno senza difficoltà i due punti di vista che abbiamo spiegato a lungo negli articoli precedenti. Diranno che la parusia secondo San Paolo, per quanto remota possa essere stata in relazione all’universalità del mondo, era allo stesso tempo molto vicina in relazione ad ogni uomo in particolare, e a quelli in particolare, la maggior parte dei quali erano arrivati alla fine della loro carriera, che l’Apostolo esortava e aveva direttamente in vista. E questa spiegazione, così naturale e così semplice, finché si comprende il principio su cui poggia, ha il doppio vantaggio di dare da un lato, piena soddisfazione alla mente, e dall’altro, di essere in completo accord con i dati generali della fede, che non soffrono nei libri ispirati di errori di alcun tipo. Ma quanto diversa sarà la soluzione di coloro che, senza alcuna preoccupazione per la chiave di cui la Chiesa è custode, senza alcun riguardo per la regola della tradizione, senza essersi mai presi la briga di sapere che esista un glossario proprio degli Scrittori sacri, sono rimasti, come Melantone, “solo umanisti”! Essi non sapranno dire altro se non: … che le prime generazioni cristiane erano ossessionate dall’idea che il mondo stesse per finire, e che, nonostante certi tratti sparsi che ci mostrano San Paolo affrancato a volte da questa ossessione (Duchesne, Histoire ancienne de l’Eglise, tom. 1, cap. 4, pag. 41 – edizione 1900), bisogna ammettere che ha pesato nella mente degli stessi Apostoli, e anche nella scrittura delle loro lettere, che ogni Cristiano è tenuto a riverire come scritte sotto la dettatura o l’ispirazione dello Spirito di Dio. E questa è la loro spiegazione: una spiegazione che è apertamente contraria alla fede cattolica, ma alla quale li conduce fatalmente la loro ignoranza – in cui essi sono – degli idiotismi della Scrittura, e della maniera propria di alterare le cose. Altrettanto si deve dire ora delle conclusioni che essi traggono da un’altra classe di testi, che la continuazione del nostro soggetto ci porta ad esaminare; intendo quelli in cui gli apostoli chiamano comunemente il tempo in cui vivevano, gli “ultimi giorni” (Act,, II, 16 segg.. ; II Tim,, III, 1 ; Piet. III, 3, etc.), “l’ultima ora” (I Joan., II 18), o “la fine e il declino dei secoli” (I Cor,, x, Hebr., IX, 26).
*****
Certamente, se c’è un punto in cui la Scrittura ha un modo di parlare che è interamente proprio, è quello che riguarda la cronologia del mondo. Per convincersene, basterebbe aprirla dalla primissima pagina, dove si racconta la formazione dell’universo in sei diversi periodi chiamati i sei giorni. È vero che si potrebbero riempire intere biblioteche con le diverse e contraddittorie opinioni che sono state espresse nel corso dei secoli riguardo ai giorni della Genesi. Cosa non è stato detto, cosa non è stato scritto? Tuttavia, sembra che oggi, dopo tante scoperte nelle viscere della terra, dove si conservano intatte le registrazioni autentiche del processo della creazione (almeno dal momento in cui iniziò l’individualizzazione della terra con la sua separazione dalla massa primitiva), sia difficilmente possibile conservare il minimo dubbio sul loro vero significato. Lasciamo dunque da parte l’interpretazione di Sant’Agostino: un’interpretazione alla quale fu portato solo da una versione errata di un testo dell’Ecclesiastico (Ëccl., XVIII, 1 – Sant’Agostino leggeva con la Vutgata: Qui vivit in æternum creavit omnia simul, Colui che vive eternamente ha creato tutto nello stesso tempo. Invece il Greco recita: ha creato tutto, [κοινή = koine], communiter, cioè tutto senza eccezione, ed anche, e principalmente, come egli stesso spiega in varie occasioni, per la necessità di sfuggire a difficoltà di natura fisica, per le quali non vedeva, nello stato delle scienze naturali del suo tempo, alcun tipo di soluzione (De Gen. ad litt , liv. 1, c. 19; liv. IV, c. 28, et alibi passim). Non parliamo nemmeno dell’invenzione di alcuni moderni, per i quali la settimana della Genesi sarebbe stata solo una settimana comune e volgare, durante i sei giorni della quale Dio avrebbe presentato all’Adamo appena creato, in altrettanti quadri distinti, cioè in sei grandi visioni immaginarie, la storia dell’origine delle cose. Questa è una strana idea, perché ci permetterebbe ancora di dire che Dio abbia rivelato la creazione del cielo e della terra in sei giorni, ma non che li abbia fatti in sei giorni, come la Scrittura afferma formalmente in molti luoghi (Esodo, XX, 11; XXXI, 17, ecc.). Non impantaniamoci ulteriormente nella vecchia opinione classica che riteneva che questi giorni della creazione fossero giorni di ventiquattro ore: un’opinione che è stata smentita e dimostrata insostenibile, non tanto dagli scavi effettuati nelle viscere della terra, quanto dalle sorprendenti particolarità del testo di Mosè. Dico: “le particolarità del testo di Mosè”, tra le quali ce n’è una che, più delle altre, deve attirare qui la nostra attenzione. È questa è quella per cui i giorni dei quali si parla sono chiaramente giorni che, lungi dall’essere regolati dal corso uniforme del sole o di qualsiasi altra stella, non hanno altra misura della loro durata che la durata stessa delle opere a cui corrispondono, e secondo le quali si distinguono; essi cominciano con l’inizio di un’opera e finiscono con la fine di quella stessa opera; si dispiegano e si succedono secondo lo svolgimento e la successione delle grandi fasi dell’opera di formazione del mondo, e così si configurano come giorni di una condizione molto diversa da quelli che compongono le nostre settimane, mesi e anni (Dixitque Deus: fiat … et factum est ita. . et factum, est dies unus, dies secundus, dies tertius, etc.). – Restano dunque da considerare grandi epoche cosmiche, che la Scrittura, è vero, ci descrive solo nei loro tratti più generali e salienti; ma anche così, bisogna riconoscere, in tutte le cose almeno suscettibili di passare attraverso il nostro controllo, che in modo meraviglioso concordano con i dati più certi delle nostre scienze moderne, e specialmente della geologia. Infatti, una volta messo da parte l’opera dei primi due giorni, che è estranea alla geologia propriamente detta, « che comprende solo il tempo che va da quando la terra ha cominciato a depositarsi sul fondo dei mari e la vita poté nascere e svilupparsi sulla sua crosta sufficientemente raffreddata. » (A. de Lapparent, trattato di Geologia, Morfologia della Terra), non c’è nulla nella descrizione di Mosè che non sia sostenuto nel modo più chiaro, non dico da ipotesi o congetture, ma dalle conclusioni meglio fondate di questa scienza: sia che si tratti della prima formazione dei mari e dell’asciutto, o in altre parole, dei continenti, con cui inizia l’opera del terzo giorno, o della mirabile vegetazione che ebbe luogo in quel momento sulle terre appena emerse, e ci valse quegli immensi depositi di carbone in cui l’industria moderna ha trovato il principio della sua forza motrice; sia che si tratti della nuova ripartizione del calore e della luce che ebbe luogo al quarto giorno, con l’organizzazione definitiva del nostro attuale sistema solare, e con la quale è iniziata la differenza dei climi; o, infine e soprattutto, dell’ordine secondo il quale la vita animale ha preso gradualmente possesso del nostro pianeta, con la creazione prima degli animali acquatici, poi delle bestie terrestri, e infine dell’uomo (cf. de Lapparent, op. cit., passim). Tali, dunque, sono i giorni della Genesi: epoche di immensa durata, divise tra loro secondo i diversi progressi con cui è piaciuto a Dio di portare il mondo dallo stato informe e caotico in cui la fece nella prima creazione, allo stato di bellezza e perfezione in cui lo vediamo attualmente. Perché “colui che poteva fare tutte le cose, che poteva con un solo decreto della sua volontà creare e disporre tutte le cose, e con un solo tratto della sua mano, per così dire, mettere l’abbozzo e la finitura nel suo quadro, nello stesso tempo disegnarlo, progettarlo e perfezionarlo, ha tuttavia voluto… fare e segnare l’abbozzo della sua opera, prima di mostrare la sua perfezione; e dopo aver fatto prima come lo sfondo del mondo, ha volute poi farne l’ornamento con sei diverse progressioni che ha voluto chiamare sei giorni” (Bossuet, Elevazioni, terza settimana, V). Sei giorni! Certamente, nessuno negherà che c’è un modo di dire che non è simile alla maniera del discorso ordinario; che non comporta le convenzioni usuali, specialmente per quanto riguarda lo stile unitario della narrazione semplice, di cui si cercherebbe invano un altro esempio nella letteratura profana, e che, tuttavia, deve essere riconosciuto come appartenente al glossario proprio della Scrittura, agli occhi della quale, « mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, e come una guardia della notte » (Psal. LXXXIX, 4). Ora, ciò che ora richiede di essere ben considerato, è che questo modo così particolare di distinguere le epoche attraverso la durata dei tempi geologici, è stato poi esteso ai tempi della nostra storia, per quanto riguarda la continuazione della Religione, dal suo primo inizio dopo la caduta originale, al suo termine finale alla consumazione dei secoli. « Vedo – dice S. Agostino – nel testo delle Scritture divine, come sei età di opera che sono distinte l’una dall’altra da certe linee di demarcazione, e hanno un rapporto di somiglianza con i sei giorni nei quali si dice che Dio abbia fatto il cielo e la terra » (August., de Genes. contra Manichæos, liv, I c. 23). Pertanto: « In principio Dio fece il cielo e la terra, e da allora, tempo fino al tempo presente compreso, ci sono sei età, come sapete per averlo spesse volte sentito dire: da Adamo al diluvio, dal diluvio ad Abramo, e secondo quanto continua e distingue San Matteo nel suo Vangelo, da Abramo a Davide, da Davide al ritorno dalla deportazione a Babilonia, dal ritorno dalla deportazione a Babilonia al primo avvento di Gesù Cristo, da lì alla fine del mondo (August, in Joan., tract. 9, n. 6. – Cfr. Contra Faustutn, lib. XII, c. 8; Contra Adimantum, c. 7, ecc.) » E queste diverse età sono divise tra loro, non da una lunghezza o misura fissa del tempo, come i nostri giorni, i nostri anni e i nostri secoli, ma solo – come i giorni della Genesi – secondo i diversi progressi che hanno segnato l’evoluzione della Religione sulla terra, la quale, sempre una e identica a se stessa, quanto alla sua sostanza, ha tuttavia subito varie fasi o stati successivi: « Sotto la legge di natura e sotto i Patriarchi, sotto Mosè e sotto la Legge scritta, sotto Davide e sotto i Profeti; dal ritorno dalla cattività fino a Gesù-Cristo, ed infine sotto Gesù-Cristo stesso, cioè sotto la Legge della grazia e sotto il Vangelo (questa distinzione delle diverse età della Religione dovrebbe essere annotata attentamente come una chiave per la soluzione di molte difficoltà. Quanti ci sono, per esempio, per i quali le cose dell’antica storia sacra sembrano al di là di ogni credenza, per la ragione che vogliono giudicarle solo secondo il criterio proprio dei tempi del Vangelo, simili in questo a persone che pretenderebbero di vedere in inverno ciò che appartiene solo alla stagione estiva, o viceversa. Questo è ciò che Sant’Agostino osserva spesso nei suoi libri contro Faustus il Manicheo, ed altri oppositori della Legge e dei Profeti). » – Innanzitutto c’è l’epoca patriarcale. Vediamo in essa l’inizio della rivelazione nei suoi due articoli fondamentali, riguardanti il fine soprannaturale, da una parte, e la provvidenza che ci conduce ad esso, dall’altra (Heb., VI); poi, non appena il peccato ebbe rovesciato la prima economia, la promessa del recupero da parte del Redentore (Gen., III, 15). Allora, la fede in questo Redentore a venire, unita all’osservanza della semplice legge naturale, formava la base della Religione, che, inoltre, non aveva altra forma sociale che la famiglia, né altro governo che l’antico governo della razza umana, in cui ogni padre di famiglia era un principe nella sua propria casa. Questo stato di cose durò fino al diluvio. – Dopo il diluvio essa fu ristabilita e rimessa in vigore, con le poche aggiunte richieste dalle nuove condizioni dell’umanità rinata. Solo che queste stesse condizioni dovevano peggiorare sempre di più, perché man mano che ci si allontanava dall’origine delle cose, gli uomini confondevano le idee che avevano ricevuto dai loro antenati; i figli ignoranti o non istruiti non volevano più credere ai loro decrepiti nonni che conoscevano appena dopo tante generazioni. D’altra parte, era sorto e già minacciava di infettare il mondo intero un nuovo male, il male dell’idolatria. – Fu allora che, con la vocazione di Abramo, si inaugurò una nuova e memorabile fase della Religione, dopo le due precedenti, l’ante e post diluviana, e l’era patriarcale (Bossuet, Hist. univ., IIe partie, c. 1, passim.). Nella persona di Abramo, dobbiamo vedere il popolo di cui era la sorgente, il popolo che Dio voleva riservare per sé separandolo dagli altri, per conservare le sue leggi e preparare l’avvento del Redentore. Ecco i suoi primi inizi nelle tende di Mamre, Socoth e Sichem; poi la sua emigrazione in Egitto, la sua prodigiosa moltiplicazione, la sua liberazione dalla schiavitù, le sue peregrinazioni nel deserto, il suo ingresso nella terra promessa, le sue lunghe guerre contro le popolazioni palestinesi, seguite infine dal possesso pacifico e tranquillo della terra che Dio aveva designato come sua dimora. Tutto questo per completare la terza età. E questa terza epoca sarà segnata da tre grandi fatti che sono caratteristici tra gli altri: in primis il rinnovo più volte ripetuto della promessa fatta quasi dopo la caduta sulla culla del mondo; in secondo luogo, con l’istituzione della circoncisione come segno e sigillo dell’alleanza stipulata da Dio con i discendenti di Abramo, dai quali doveva uscire il Messia promesso; e infine, e soprattutto, la promulgazione della legge di Mosè, le cui numerose osservanze, tutte figurative del Cristo a venire, dovevano essere innestate per i Giudei sullo sfondo immutabile e sempre presente della legge primitiva. E così alla Religione patriarcale successe la Religione mosaica, che tuttavia era ancora nella sua prima fase, non raggiunse il suo pieno e regolare esercizio fino all’inizio della quarta età, che si apre con l’avvento di Davide. Infatti, durante tutto il periodo dei Giudici ed il regno di Saul che lo seguì, il servizio del culto era stato stabilito solo provvisoriamente. Il tempio, che il Deuteronomio (XII, 5 e seguenti) designava come centro e fulcro della religione d’Israele, mancava sempre, e fu Davide per primo che, dopo aver stabilito il suo trono e completato la pacificazione di tutto il paese, ne decise la costruzione, ne designò il luogo, ne raccolse i materiali, lasciando a suo figlio Salomone il compito di realizzare ciò che aveva solo preparato. La fondazione del tempio fu quindi un evento considerevole. Essa segnò l’inizio del regolare funzionamento dell’istituzione mosaica, e quindi il punto di partenza di una nuova era, che tuttavia doveva distinguersi dalle precedenti per un carattere ancora più rimarchevole ed ancor più nettamente caratterizzato. – Infatti, mentre il culto della vecchia legge raggiungeva il suo pieno sviluppo, il sole pieno della profezia messianica stava anche sorgendo all’orizzonte di Israele. La quarta epoca sarà per eccellenza l’epoca dei profeti « a Samuel e deinceps – da Samuele e da quanti parlarono in seguito » (Act., III, 24): dei grandi profeti, dico, la cui successione si svolge su un periodo di tempo di più di cinquecento anni, con annunci ammirevoli nei quali le caratteristiche del Messia atteso sono sempre più chiaramente definite e determinate diventano sempre. Si tratta di David, Isaia, Michea, Gioele, Osea, Geremia, Ezechiele, Daniele e altri. E che nomi sono questi! Che magnifici oracoli! Che aumento continuo delle luci della rivelazione! Che marcia progressiva verso quella pienezza dei tempi in cui, con tutte le promesse realizzate, la Religione raggiungerà finalmente il suo apogeo! Tuttavia, non siamo ancora arrivati a questo punto. – Rimane, a separarci da essa, tutta la quinta età, che comprenderà i tempi del secondo tempio costruito da Zorobabele dopo il ritorno dalla cattività. Questo è il periodo di attesa. Tre cose sono particolarmente evidenti: la chiusura della profezia dell’Antico Testamento (Mal., IV, 4-6); l’ultimo segnale dato dell’arrivo relativamente vicino del Desiderato da più di quaranta secoli (Agg., II, 7-10; Zach., IX, 9; Malach, III, 1); infine, la diffusione dei Giudei nelle principali parti del mondo, in Asia superiore, nell’Asia minore, nell’Egitto, Grecia, e persino nel centro stesso dell’impero di Roma, per diffondervi le Scritture, per far risplendere il Nome e la gloria del Dio d’Israele tra i gentili, per porvi le prime fondamenta e come il primo innesco della loro futura conversione al Messia che verrà. – Infine, Gesù Cristo è apparso al tempo predetto dai profeti, per adempiere tutto ciò che i profeti avevano predetto. Egli predica la Sua dottrina celeste, … fonda la sua Chiesa, istituisce i suoi sacramenti .., si offre sulla croce come vittima propiziatoria per i peccati di tutti noi, risorge, ascende al cielo, aprendoci le porte della vita eterna per la potenza del suo sangue. Non appena salito al cielo, promulga la sua legge attraverso i suoi Apostoli; per loro mezzo la stabilisce in tutto il mondo, ed ecco ora arriva la sesta età. – Questa è l’epoca della rivelazione ormai chiusa, del compimento di tutte le figure, dell’ultima fase della Religione sulla terra, dopo la quale non ne verranno altre, né potrebbero venirne altre. Infatti la legge evangelica, chiamata anche legge della grazia, portava con sé la pienezza delle ricchezze della redenzione, il dono di tutto ciò che le leggi precedenti rappresentavano in speranza, e contenendone le promesse. Di conseguenza, essa si sostituiva a tutte loro, le abrogava tutte, non per essere abrogata in seguito e sostituita da un’economia migliore, ma per durare in perpetuo, senza alcuna sottrazione, aggiunta o modifica, fino al giorno del Signore che viene a chiudere l’intera serie dei tempi ed inaugura il culmine di tutte le cose nelle glorie della beata eternità. Questo è ciò che San Paolo mostra e sviluppa così magnificamente nella splendida epistola agli Ebrei, che dovrebbe essere qui riportata e commentata dall’inizio alla fine (Heb. VII-XII). – Questo è ciò che chiunque abbia praticato le nostre sacre lettere riconoscerà immediatamente come il carattere proprio della nuova legge e la differenza essenziale che la distingue da tutte le istituzioni delle epoche precedenti. Questa, infine, è la chiave per una chiara comprensione del vero significato di queste espressioni, “gli ultimi giorni“, “l’ultima ora“, “la fine o il completamento dei secoli“, nello stile degli scrittori sacri. Perché queste non erano locuzioni impiegate per significare un breve intervallo di tempo fino alla catastrofe suprema, ma per designare, secondo ciò che è stato appena esposto, l’ultimo e definitive stato della Religione quaggiù, e di conseguenza anche dal punto di vista che è quello della Scrittura, l’ultima età dell’umanità: ma si noti bene, l’ultima età di cui nulla però ne determina la durata, breve o lunga che sia, che fu sempre nascosta nel segreto impenetrabile in cui piacque a Dio di confinarla. Ciò che San Tommaso, seguendo Sant’Agostino, spiega paragonando la vecchiaia, che è l’ultima età della vita umana, e si distingue proprio per questa particolarità che non è come l’infanzia, o la giovinezza, o la maturità, comprese entro limiti precisi; ma essa non ha un termine prefissato, nessun limite definito, nessuna misura determinata che possa essere assegnata in anticipo. E così, possiamo dire, che è, con le debite proporzioni, per questi « ultimi giorni », questa « ultima ora », questa « fine dei tempi », che è così frequentemente menzionata negli scritti apostolici. Invano si vorrebbe vedere in essi un’indicazione che non c’è assolutamente, poiché sarà sempre vero dire che la vecchiaia è l’ultima ora e l’ultima fase della nostra vita; il che non impedisce che talvolta non solo eguagli, ma anche superi in durata ciascuna delle età che l’hanno preceduta. (« Dicendum quod ex hoc quod dicitur, novissima hora est, vel ex similibus locutionibus quæ in Scriptura leguntur non potest aliqua quantitas temporis sciri. Non enim est dictum ad significandum aliquam brevera horam temporis, sed ad significandum novissima ætas quæ quanto spatio duret, non est definitum, eum etiam nec senio quod est ultima ætas hominis, sit aliquis certus terminus definitus », S. Thom, Suppl, q. 88, a. 3 ad 3).
***
Questa è dunque la solida spiegazione che ci fornisce, riguardo alla presente difficoltà, la tradizione patristica. E questa spiegazione, già così ben fondata in se stessa, riceverà ora una nuova e più ampia conferma dalla tradizione della Sinagoga: dalla Sinagoga, dico, la cui autorità, immagino, nessuno penserà di contestare, per quanto riguarda il significato da attribuire alle espressioni usate dagli antichi profeti. Ora, è un fatto ricepito e accettato senza dubbio da tutta l’esegesi rabbinica, che nel linguaggio dei profeti, la formula « gli ultimi giorni » designa puramente e semplicemente i tempi del Messia e della sua legge. « È nella tradizione degli antichi Ebrei – osserva Rosenmüller con la sua ben nota competenza – che con la formula novissimi dies si designano i tempi messianici (Rosenmüller, in Isaia, II, 2; Gerem., XLVIII, 47; XLIX, 39, ecc.). Cosa si deve intendere per tempi messianici? Indubbiamente, come indica il nome stesso, tutto il periodo dalla venuta del Messia fino alla consumazione dei tempi, in altre parole, dal primo al secondo avvento del Signore. Vogliamo di più? Ebbene, ecco ciò che sarà ancora più conclusivo: è che questo stesso significato, come vedremo, è quello che emerge invariabilmente dalla detta formula o dai suoi equivalenti, in tutti i passi degli scritti apostolici che ci oppongono i nostri avversari i modernisti. Quando San Pietro, per esempio, nel discorso inaugurale rivolto alla moltitudine accorsa alle porte del cenacolo dopo il prodigio di della prima Pentecoste, iniziava dicendo: “Quello che vedete è ciò che è stato annunciato dal profeta Gioele: Negli ultimi giorni, dice il Signore, effonderò il mio Spirito su ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, ecc., quale pensiamo possa essere il significato di queste parole, negli ultimi giorni? C’era forse nelle circostanze del momento, c’era nell’evento appena accaduto, c’era nella mentalità presente degli Apostoli o della folla riunita davanti a loro, qualcosa che giustificasse una dichiarazione sugli ultimi giorni come intesa dall’obiezione? Assolutamente niente. E chi allora poteva anche solo pensare alla prossima fine del mondo? Le preoccupazioni erano certamente alte. Essi riguardavano unicamente la questione che era stata lasciata in sospeso dal recente dramma del Calvario, e che era ancora alimentata dalle cose straordinarie che avevano avuto luogo nel cenacolo. Questa questione era quella che San Pietro aveva appena mostrato davanti a Gerusalemme, al suo popolo, ai suoi principi e al suo Sinedrio, proclamando due cose: primo, che i tempi messianici erano arrivati, come dimostrato dall’attuale adempimento della profezia di Gioele sull’effusione dello Spirito Santo negli ultimi giorni (vers. 14-21), e secondariamente, che il Messia era quel Gesù di Nazareth, che era stato da poco inchiodato alla croce e messo a morte per mano degli empi, come testimoniava il miracolo eclatante della sua risurrezione (versetti 22-36). Questo è tutto il discorso del Principe degli Apostoli in questa solenne promulgazione della nuova legge; dove è evidente che gli ultimi giorni da lui menzionati non avevano altro significato che quello che abbiamo dichiarato, stabilito e spiegato sopra. La stessa conclusione è ora da trarre dall’esame di testi simili che si trovano nelle epistole canoniche. Quando San Paolo nell’epistola agli Ebrei mostrò la differenza tra il sommo sacerdote dei Giudei, che entrava annualmente nel santuario con il sangue di capri e tori, con il quale era impossibile che i peccati fossero espiati, e Cristo venuto una sola volta nel compimento dei tempi, [ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνωνepi … epi sunteleia ton aiononeri], per abolire finalmente il peccato con il Suo proprio sacrificio (Eb., IX, 26): che cosa, dunque, poteva designare con questa espressione, [συντελείᾳ τῶν αἰώνων] se non la suddetta età messianica, al momento vista come un necessario epilogo e culmine obbligato delle epoche che l’avevano preceduta, annunciata, preparata e prefigurata? Infatti, come dice subito dopo, all’inizio del capitolo successivo (Eb, X, 1), le epoche precedenti avevano avuto solo le ombre dei beni a venire, umbram enim habens lex futurorum bonorum, non ipsam imaginent rerum; ed è solo nell’era messianica, che attraverso Gesù Cristo, con Gesù Cristo e in Gesù Cristo, le ombre hanno preso corpo, le figure sono diventate realtà. In questo senso, quindi, questa stessa epoca fu davvero, e letteralmente, il completamento (συντελείᾳ – sunteleia) di tutte le altre. Era la loro realizzazione, il loro complemento, il loro termine, io dico, qualunque dovesse essere allora l’estensione della sua durata, limitata al breve spazio di una o due generazioni, o al contrario estesa attraverso una serie indefinita di secoli. Questa è senza dubbio la dottrina più autentica e provata di San Paolo; è il tema che egli sviluppa a lungo, da un capo all’altro dell’epistola agli Ebrei in particolare. E come possiamo allora rifiutarsi di riconoscere il vero significato dell’espressione incriminata, proprio in un luogo dove la figura del sommo sacerdote della vecchia legge, come riportato sopra, è espressamente contrapposta alla realizzazione della figura in Gesù Cristo, dall’altro lato? Riflettiamo su questo, riguardiamolo da vicino, facciamo riferimento al contesto immediato, così come all’argomento generale di tutta la lettera, e si dovrà convenire che il significato suddetto è l’unico possibile, l’unico conforme al soggetto e alla sequenza del discorso, senza che si intravveda il minimo spazio per la questione della imminenza della parusia, anche qui considerate del tutto fuori luogo. Questo è anche il significato di un passaggio simile nel decimo capitolo della Prima Corinzi (X, 11), dove l’Apostolo, dopo aver raccontato i particolari dell’uscita dall’Egitto e del soggiorno degli antichi Israeliti nel deserto, dice che « tutte queste cose accaddero loro in figura e furono scritte per la nostra istruzione, noi che siamo giunti alla fine dei tempi « in quos fines sæculorum (τὰ τέλη τῶν αἰώνων – ta tele ton aionon) devenerunt ». Dove vediamo esattamente la stessa opposizione tra il tempo delle figure sotto Mosè, e quello del loro compimento sotto Gesù Cristo; così questa è ancora l’era messianica, concepita come la fine ed il culmine delle epoche antiche, che la formula “τὰ τέλη τῶν αἰώνων” designa, appena diversa, quanto alla forma, da quella usata da San Paolo nel passaggio precedente. – E quando a sua volta Giovanni scriverà, nella sua prima epistola (II, 18): È l’ultima ora; come avete sentito che l’anticristo sta per venire, così ora ci sono già molti anticristi; da questo sappiamo che è l’ultima ora: anche lui non farà ancora e sempre che designare questa stessa era messianica, sebbene ora con un’altra peculiarità che gli è propria. – Infatti, se, come dice poco più avanti (III, 8), è per distruggere le opere del diavolo che il Figlio di Dio è apparso, va da sé che ciò non poteva avvenire senza che il diavolo si ponesse, o nella sua persona o per mezzo dei suoi suppositi, come antagonista dichiarato di coloro che venivano a spogliarlo del suo impero. Quindi, per quanto riguarda i tempi messianici, c’è un nuovo carattere segnato qui da San Giovanni, che questi saranno i tempi degli anti-messia, cioè degli anticristi, e non solo dell’anticristo per eccellenza, annunciato nell’approssimarsi della catastrofe finale, ma anche degli anticristi precursori, gli anticristi eresiarchi, i capi di sette, i corifei dell’empietà, che sono venuti e verranno prima della lotta suprema e definitiva. – San Giovanni, dunque, non ha una concezione diversa da quella di San Paolo e di San Pietro, e se tutti e tre sono d’accordo nel parlare dell’ultima epoca del mondo come di un’epoca già attuale nel loro tempo, è sempre e ovunque, sia ben ricordato, in virtù di questo principio, che per loro l’ultima età, è l’età che abbiamo detto, che con un altro nome si chiama l’età della “legge Cristiana”, o, ciò che equivale alla stessa cosa, della legge evangelica sotto la quale abbiamo l’onore e la felicità di vivere.
***
Ma ora sorge un’ultima difficoltà. Si obietta una cosa che basterebbe a rendere inutile tutto ciò che è stato detto fino ad ora. È che, qualunque sia il nome con cui può essere chiamata, quest’ultima epoca è stata positivamente ridotta da San Paolo alla pura e semplice durata della prima generazione cristiana, e questo in tre passaggi formali, espliciti e categorici, cioè nella prima ai Tessalonicesi (IV, 13-18), e in altri due luoghi paralleli (I Cor., XV, 51-52, e II Cor., V., 3), dove l’Apostolo, parlando dei viventi che l’ultimo giorno troverà ancora sulla terra, testimonia sufficientemente, con l’uso costante della prima persona plurale, che egli si considerava come personalmente nel loro numero loro, egli e coloro ai quali scriveva. – « Non vogliamo – scriveva ai Tessalonicesi – poi lasciarvi nell’ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Questo vi diciamo sulla parola del Signore: noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al Signore nell’aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. » – Questo è il modo in cui San Paolo parlava, apparentemente a causa della sua ferma convinzione che nella sua vita, nella vita dei fedeli che lui istruiva, sarebbe venuto il grande giorno di Dio. Perché cos’altro avrebbe voluto dire con queste parole molto precise del versetto 15: Nos qui vivimus, qui résidui sumus in adventum Domini, che ripete di nuovo al versestto 17, come per sottolinearne il significato e per meglio focalizzare l’attenzione dei suoi lettori? Noi che siamo vivi, dice. E chi, noi, se non Paolo stesso, con coloro ai quali era indirizzata la sua lettera? È su questo che si basano gli avversari, che considerano una prova decisiva, un argomento senza risposta. Ma noi (c’è bisogno di dirlo?), vediamo qualcos’altro, e ci sentiamo molto sicuri agli occhi di chiunque vorrà pensarvici e guardarlo da vicino, che tutto qui si riduce a un semplice modo di parlare che il contesto mette pienamente in luce, e non senza fornire, inoltre, una nuova e molto positiva conferma di tutte le nostre precedenti conclusioni, come cercheremo di mostrare prima di concludere. Notiamo dapprima qual era l’errore che San Paolo si proponeva di correggere. Era l’errore di coloro che, ancora nuovi alla dottrina della fede, erano stati persuasi che i morti, già giacenti nei loro sepolcri, non avrebbero avuto alcuna parte nella gloria del giorno del Signore, ma che solo i vivi avrebbero dovuto ascoltare ciò che si legge nel Vangelo, che il Figlio dell’uomo, arrivando sulle nuvole del cielo, avrebbe mandato i suoi Angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all’altro del cielo, per renderli partecipi del suo trionfo (Matth., XXIV, 31). E in questa falsa persuasione, essi si affliggevano eccessivamente per i loro morti; essi li piangevano, o come temendo che non risorgessero affatto, o che quantomeno perdessero quella folgorante manifestazione di Cristo nella sua parusia, oggetto, come sappiamo, delle più ardenti aspirazioni dei Cristiani della prima ora. San Paolo li istruisce e li rassicura completamente sia sull’uno che sull’altro punto. La risurrezione gloriosa di coloro che si sono addormentati nella fede e nell’amore di Gesù è una conseguenza necessaria della risurrezione di Gesù stesso; non c’è quindi motivo di piangere per loro come se non dovessero risorgere, nella beata immortalità, dalla polvere delle loro tombe: questa è la prima cosa. La seconda cosa è che coloro che sono vivi nell’ultimo giorno, e che sono riservati per la venuta del Signore, non avranno nessun vantaggio sugli altri per quanto riguarda la partecipazione al trionfo della parusia. Perché i “dormienti” si sveglieranno dal loro sonno alla vita immortale, mentre i vivi, da parte loro, vi entreranno con un rapido cambiamento che non comporta alcuna pausa duratura nella morte, e tutti insieme, tutti nello stesso tempo, vivi e dormienti, saranno portati ad incontrare il Signore, dal quale non saranno mai più separati. Questo, dico, è il preciso insegnamento con cui San Paolo ha combattuto e distrutto la falsa idea che i suoi neofiti avevano sui morti, e non abbiamo bisogno di entrare qui in sviluppi che sarebbero estranei al nostro tema. Ma dobbiamo soffermarci sull’unica cosa che è importante per la soluzione che cerchiamo, cioè il modo in cui l’Epistola designa ciascuna delle due categorie che ha appena esposto come aventi una parte uguale nel trionfo di Cristo al suo ultimo avvento. In primo luogo, qui ci sono i morti, e chi sono questi morti? Ovviamente, non possiamo parlare qui di tutti i morti, intendo di tutti quelli che indiscriminatamente giaceranno nelle tombe all’arrivo del Figlio dell’Uomo. Infatti, tra di loro, quanti sono riservati a quella che il Vangelo chiama la “resurrezione per la condanna”! Mentre qui sono ora in questione solo coloro che risorgeranno alla vita, e alla vita della gloria eterna. È quindi facile da capire perché, parlando di questi morti, San Paolo non dice mai i morti “tout court”, ma piuttosto, i morti in Cristo [v, 16 “οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ” – oi necroi en Cristo], o coloro che si sono addormentati in Gesù, [v. 14 “κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ” – koimetentas dia tou Iesou]; con ciò egli designa i soli eletti, i soli predestinati. Del resto, questo è abbastanza chiaro in sé e non ha bisogno di spiegazioni, e se lo richiamiamo all’attenzione particolare del lettore, è perché servirà ora a chiarire ciò che si dice della seconda categoria, quella dei vivi, laddove sta tutta la difficoltà. I vivi che saranno sulla terra all’arrivo del grande giorno e che, in compagnia dei vivi di cui abbiamo appena parlato, ne condivideranno la gloria, sono designati dalla seguente formula nel versetto 15, ripetuta ancora nel 17: ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου – [emeis oi zontes oi perileipomenoi eis ten parousian tou kuriou], cioè, parola per parola: noi, i vivi, quelli che sono rimasti per la venuta del Signore. Esaminiamo tutti i termini con attenzione, e per maggiore chiarezza, nel seguente ordine: primo – οἱ ζῶντες [oi zontes]; secondo, ἡμεῖς [emeis]; terzo, οἱ περιλειπόμενοι [oi perileipomenoi]. E da questo esame emergerà forse un senso ben diverso da quello in cui trionfano i nostri modernisti, e che a prima vista avremmo potuto supporre noi stessi. Oi zontes [oi zontes] primariamente: i vivi, quelli dell’ultimo giorno, questo si capisce; ma quali? Forse l’universalità di coloro che popoleranno il mondo nel momento in cui cominceranno ad apparire i segni del giudizio? Ovviamente no, perché in quel numero, quanti peccatori impenitenti, quanti miscredenti, quanti reprobi, che, lungi dall’essere trasportati nella gloria per incontrare il Signore, saranno lasciati nella perdizione in mezzo alla distruzione universale! « Come accadde ai tempi di Noè – dice Nostro Signore nel Vangelo – così accadrà alla venuta del Figlio dell’uomo. Gli uomini mangiavano e bevevano, si maritavano e maritavano le loro figlie fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e il diluvio li sorprese. Allora, di due uomini che saranno nel campo, uno sarà preso, l’altro lasciato; di due donne che saranno a macinare al mulino, una sarà presa, l’altra lasciata. » Tale è la separazione che avverrà tra i viventi con i viventi, in quest’ultima ora del mondo! Così come prima non poteva trattarsi dell’universalità dei morti, così ora non può trattarsi dell’universalità dei vivi, e quindi era necessario un determinativo che limitasse la comprensione del termine οἱ ζῶντες [oi zontes] ai soli giusti, ai soli fedeli, ai soli amici di Gesù. E dove troveremo questo determinativo? Precisamente nel termine incriminato, in questo pronome di prima persona plurale, che l’Apostolo ha aggiunto qui e dice: ἡμεῖς οἱ ζῶντες [emeis oi zontes]- Noi, i vivi, nello stesso senso che aveva usato parlando dei morti, “οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ” [oi necroi en Cristo] i morti in Cristo, o coloro che si sono addormentati in Gesù, “κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ” – koimetentas dia tou Iesou]. E, infatti, chi non sa che il detto pronome di prima persona plurale è comunemente usato nel linguaggio abituale per designare, confusamente, e senza altra determinazione particolare, quelli della classe, della categoria a cui appartiene colui che parla, soprattutto se alla stessa classe, alla stessa categoria, appartengono, con lui, coloro che ha di fronte e ai quali parla? Certamente, se io, un francese, dicessi che abbiamo appena vinto una seconda battaglia della Marna, nessuno penserebbe che io personalmente sia stato tra quelli che l’hanno vinta (queste righe sono state scritte nell’ottobre 1918). E se, parlando davanti ad un grande pubblico, aggiungessi che, secondo tutte le probabilità, saremo a Berlino in un futuro più o meno prossimo, nessuno di quelli tra il pubblico, si crederebbe personalmente incluso nell’ampiezza del noi collettivo di cui avrei usato. In verità, sarebbe abbastanza inutile, per una cosa così semplice, moltiplicare gli esempi che mi vengono in mente, e c’è solo da fare l’applicazione al caso che stiamo trattando. Infatti, non sarebbe forse, nel senso appena indicato, che San Paolo abbia usato ora questo noi, “ἡμεῖς”, che causa tante difficoltà per alcuni? Non è forse la categoria, la classe dei fedeli in quanto tali, che aveva in vista qui, piuttosto che il Tizio, il Caio, il Sempronio che la componeva al tempo in cui scriveva? Insomma, quando, per designare i vivi che nell’ultimo giorno si uniranno all’esercito trionfante dei gloriosi risorti, portati in aria per incontrare il Signore, l’Apostolo diceva, parlando ai suoi ferventi seguaci [i neofiti, noi, i viventi, ἡμεῖς οἱ ζῶντες – emeis oi zontes] non è come se avesse detto, senza altra precisazione o determinazione di persone, i nostri allora viventi? – I nostri, cioè quelli della nostra parte, del nostro partito, della nostra comunione, i credenti, gli amici di Gesù e del suo avvento, in contrasto con coloro che la seconda Tessalonicesi presenta (I, 8-10) come non conoscitori di Dio, non obbedienti al Vangelo, e quindi, nel giorno della parusia, sofferenti la pena della perdizione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dallo splendore della sua potenza? Sì, senza il minimo dubbio, questo è il significato della lettera, che è confermato nel più espressivo, dall’intero contesto. Per quanto riguarda il contesto, non potremmo, senza esporci ad una noiosa ripetizione, esaminarne qui le angolazioni e le asperità. Quindi non lo faremo. È comunque un punto che non può assolutamente passare sotto silenzio, e che dobbiamo portare brevemente all’attenzione del lettore. È il passaggio finale con cui l’Apostolo designa gli ultimi fedeli che l’ultima ora del mondo avrebbe trovato vivi sulla terra: “οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου” [oi perileipomenoi ei sten parousian tou kuriou]. Infatti, quanto è significativo questo passo, e quanto bene si adatta al nostro caso, e quale nuova conferma porta alle nostre precedenti affermazioni, distruggendo sempre più a fondo l’affermazione degli avversari, che, con queste parole, “noi, i vivi”, con cui San Paolo avrebbe considerate personalmente se stesso, con coloro ai quali era indirizzata la sua lettera! Tutta l’osservazione riguarda il participio περιλειπόμενοι [perileipomenoi] dal verbo λείπω [leipo] che ovunque sia usato, ovunque entri, sia come radice che come componente, dà l’idea di un resto, un debole resto staccato dalla massa. Per esempio, nella Lettera ai Romani (IX, 27), San Paolo, citando Isaia, scrive: Quando il numero dei figli d’Israele sarà come la sabbia del mare, solo un piccolo resto sarà salvato, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται [to upoleimma sotesetai. E più avanti (XI, 5), paragonando il piccolo numero di Giudei convertiti al Vangelo con i settemila uomini che non si erano inginocchiati a Baal: Anche oggi, dice, c’è un resto secondo una scelta di grazia, λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος [leimma kat’ecloghen karitos]. Ma con quanta più forza questa stessa idea emerge nella frase del nostro testo: Noi che viviamo, lasciamo loro un resto per la venuta del Signore! Essi dovevano dunque essere solo un resto, un residuo; se è permesso parlare in questo modo, un residuo, qui residui sumus, secondo la traduzione esattissima della Vulgata; qualcosa come una retroguardia che arriva all’ultimo luogo, dopo che l’esercito principale è già passato. Questo, in altre parole, significava che nell’idea di San Paolo i fedeli viventi dell’ultimo giorno sarebbero stati solo un numero molto ridotto, una piccolissima minoranza, rispetto alla massa dei Cristiani addormentati in Cristo: proprio il contrario, come è ovvio, di ciò che comportava l’ipotesi del giudizio che arrivava durante l’epoca apostolica. Così l’esegesi modernista è sconfitta nelle sue pretese, e perde una posizione dopo l’altra. Non c’è un solo passaggio nelle epistole degli Apostoli su cui possa stabilire un argomento che sia anche lontanamente fondato con raziocinio. – Rimane ora l’Apocalisse di San Giovanni, che richiede un esame separato, e questo esame sarà il soggetto dei prossimi due articoli.
LA PARUSIA (9)