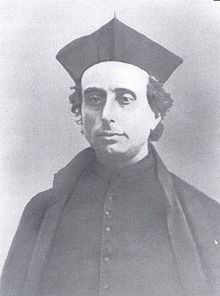
H. Ramière: S. J.
Il cuore di Gesù e la divinizzazione del Cristiano (13)
[Ed. chez le Directeur du Messager du Coeur de Jesus, Tolosa 1891]
TERZA PARTE
MEZZI PARTICOLARI DELLA NOSTRA DIVINIZZAZIONE
Capitolo IX.
IL CUORE DI GESÙ E LA PENITENZA
Eucaristia e Penitenza: Sacramenti del Cuore di Gesù
Attraverso il Battesimo e la Cresima, il Salvatore ci ha dato il Suo Spirito. Attraverso l’Eucaristia ha aggiunto a questo primo dono quello della sua carne, del suo sangue, anima e divinità. Cos’altro ancora può offrirci? Gesù Cristo non avrebbe più nulla da offrirci sulla terra, se ci vedesse solo come creature imperfette da perfezionare. Ma questa non è la nostra condizione: non siamo non solo imperfetti, ma anche peccatori. E l’ufficio principale del Salvatore è quello di liberarci dal peccato. Per realizzare questo, Egli istituisce un nuovo Sacramento, che ci manifesta l’amore del suo Cuore sotto un nuovo aspetto: il pozzo senza fondo della sua misericordia. La penitenza, come l’Eucaristia, merita di essere chiamata il mistero dell’amore, il Sacramento del Cuore di Gesù. L’Eucaristia è il mistero dell’amore, fino al dono completo di sé. La Penitenza è il mistero del perdono, dell’amore che giunge fino a dimenticare se stesso. Il secondo di questi misteri non manifesta con meno splendore del primo l’onnipotenza del Cuore di Gesù. Quando ha voluto istituire il primo, Egli non ha trovato altri ostacoli che le leggi della natura. Ma per istituire la Penitenza, era necessario superare l’infinita ripugnanza al peccato del Cuore infinitamente santo di un Dio e far prevalere su di essa un’infinita condiscendenza verso l’uomo peccaminoso. Gli Sngeli erano stati liberati dal peccato con una grazia di preservazione. Gli infedeli ad essa, già alla loro prima ribellione, erano stati puniti senza alcuna speranza di perdono. Per l’uomo, più debole di loro, Dio doveva agire diversamente: così come non sarebbe stato impeccabile dopo il primo atto meritorio, così sarebbe stato punito dopo la sua prima caduta. La sua lotta contro il peccato durerà quanto la sua vita: né il Battesimo, né la Cresima, né l’Eucaristia lo metteranno al riparo da questo nemico. Dovrà combattere ad ogni passo, ed in ogni momento potrà essere sconfitto. Ma grazie alla Penitenza, avrà una mano per rialzarsi dalle sue cadute, profittare delle sue sconfitte, trasformare in fonti di merito gli stessi peccati, dei quali tutti sarà spogliato. Solo la misericordia infinita del Cuore di Gesù poteva compiere tali meraviglie.
Penitenza: riconciliazione di due opposti interessi
La prima meraviglia operata dal Cuore di Gesù nel Sacramento della Penitenza è la perfetta riconciliazione dei due interessi che gli uomini hanno sempre visto come inconciliabili: quello della gloria di Dio e quello dell’uomo peccatore. La conservazione della legge e la salvezza del trasgressore. La riparazione del crimine e la conservazione del criminale. Prima di Gesù Cristo, come dopo di Lui, gli uomini hanno cercato invano un bilanciere che permettesse loro di avere in equilibrio tali interessi contrapposti. Solo Gesù Cristo, Giustizia incarnata, ha trovato l’equilibrio che gli uomini hanno cercato invano. E lo ha stabilito con un Sacramento che sembrava tendere alla distruzione di ogni santità e giustizia. Supponiamo che un sovrano abbia una legge promulgata in tutto il suo impero che assicuri l’impunità a ladri, assassini, adulteri e criminali di ogni genere, a condizione che, essendo sinceri e pentiti, confessino i loro crimini, nel più inviolabile segreto, ad un magistrato per questo scopo prescelto. La supposizione è assurda. Ammettiamo, però, che sia così. Chi non crederebbe di vedere in una tale legge il sacrificio di tutti i diritti legittimi, la sanzione di tutti i crimini e gli eccessi, la rovina di tutte le istituzioni sociali? Ebbene, Gesù Cristo non ha avuto paura di promulgare una legge così umanamente assurda, ma che non ha cessato di essere in vigore nella Chiesa Cattolica. Nessun crimine, nessun misfatto è esente dal beneficio di questa legge. Non è stato posto alcun limite alla reiterazione del perdono. L’impunità è assicurata in anticipo a tutti coloro che peccano, qualunque sia il numero e l’enormità delle loro offese, dal momento in cui vengono ad accusarsi con sincerità e con vero pentimento. Affinché questa condizione possa essere facilmente soddisfatta, il numero di magistrati incaricati di ascoltare le confessioni e di perdonare le colpe è in continuo aumento. Sono in ogni parte del mondo, in ogni città, in ogni paese e persino in quasi tutti i villaggi. Hanno l’incarico di non aspettare che i criminali vengano a cercarli, ma di andare loro incontro e di portare il perdono a casa loro, se i criminali trovano troppo dispendioso venire in tribunale. Devono ascoltare senza indignazione la narrazione dei crimini più abominevoli; mostrare compassione ai malvagi per i quali la prigione e il patibolo sarebbero pene molto blande. E dopo aver dimostrato la realtà delle più odiose violazioni della legge divina, la loro unica sentenza dovrebbe essere l’assoluzione, a meno che non la si rifiuti rinnegando volontariamente il pentimento. Come potrebbe funzionare una tale istituzione nella Chiesa senza distruggere completamente non solo la Chiesa, ma anche la legge divina su cui poggia?
La penitenza distrugge il peccato.
La potenza del Cuore di Gesù ha fatto questo miracolo! Un vero miracolo, anche se non unico. Aggiungete quindi a questo Sacramento un secondo, ancora più ammirevole, stupefacente. Sacrificare in apparenza tutti i suoi diritti per la salvezza del peccatore, la giustizia misericordiosa di Dio ha guardato, più efficacemente della giustizia degli uomini, alla distruzione del peccato. Con esso, il Sacramento che sembrava essere l’abolizione della legge è, al contrario, la sua salvaguardia e il suo più potente sostenitore. Lungi dal moltiplicarsi dei crimini, ne ha distrutto le radici più profonde. Perché, ovunque sia stato in vigore, ha reso inutilizzabili non solo le guarnigioni, ma anche le carceri. Basta un momento di riflessione per convincersi che debba essere proprio così. Quali sono le cause del crimine? Non sono forse le passioni disordinate, i cattivi sentimenti del cuore? Lascite germogliare una brutta passione nel profondo dell’anima senza ostacoli, e presto vedrete i suoi frutti velenosi germogliare verso l’esterno. Mancherà solo un’occasione favorevole per far scoppiare il crimine. Le considerazioni umane potranno fermare per qualche tempo le eruzioni del vulcano che ruggisce al suo interno. Ma presto questa diga troppo debole non sarà in grado di contenere la colata lavica in aumento. Sfonderà improvvisamente l’ostacolo, e guai a chi lo ostacola! Per distruggere il crimine è necessario scendere nelle profondità dell’anima e prosciugare la sorgente di questo torrente devastante. Per preservare la società dal contagio del vizio è necessario purificare il cuore dal veleno delle passioni depravate. Questo fa e farà sempre con ineffabile efficacia il Sacramento della Penitenza. Esso obbliga il peccatore a penetrare nei recessi della sua coscienza per riconoscere e distruggere non solo gli atti criminali esterni, ma anche i desideri ed i pensieri più intimi che li suscitano. Poiché il penitente si esporrebbe all’illusione se fosse il solo a istruire la sua causa, gli viene dato il Sacramento della Penitenza da un aiutante istruito, gentile e disinteressato, incaricato di vegliare sugli interessi della legge divina e su quelli della sua anima. Con l’aiuto di questo intimo consigliere, egli può scoprire nel suo cuore tutti i semi che sono stati messi nel terreno e rimuoverli prima che portino i frutti della morte. Se sono germogliati, la Penitenza li strappa via e ne impedisce la rinascita. Sotto la sua influenza, il peccatore prende contro se stesso gli interessi della legge. Si fa da sé proprio giudice, e la punizione interiore che impone a se stesso è più efficace, più santificante e più salutare di tutte le punizioni esterne. Potremmo giustamente dire di questo Sacramento che è in realtà un’ammirevole salvaguardia degli interessi della legge. Infatti, non c’è peccato o crimine, per quanto abominevole, che non sopporti e non perdoni. Ma perdonando il peccatore distrugge il peccato. Colui che viene giustiziato dalla misericordia divina, assolto dal Tribunale della Penitenza, si trasforma in un uomo completamente nuovo: da colpevole è diventato veramente un santo, poiché ha appena acquisito la grazia santificante. La penitenza trasforma il male in merito. La misericordia del Cuore di Gesù in questo Sacramento si estende a molto di più. Non solo distrugge tutte le iniquità, ma trasforma i mali in merito e ci fa trovare, anche nella morte, un mezzo di vita. Quando il peccato è entrato nell’anima ha tolto tutti i suoi meriti, perché il merito è il diritto alla vita eterna, che non può sussistere in un’anima condannata alla morte eterna. Ma questi meriti non sono stati distrutti in modo tale da non poter essere rianimati. Avevano cessato di esistere nella persona del loro legittimo possessore, che, rinunciando ad essi, diventava incapace di rivendicarli. Ma anche quando cessano di esistere nella sua persona, rimangono indelebili nella mente di Dio. Così, quando nella Penitenza il possessore di questi meriti torna in vita, essi rinascono con lui e riportano alla sua anima i frutti immortali. Il peccatore si trova in ascesa e ricco com’era prima di cadere. Ma il Cuore di Gesù non si accontenta di questo: vuole che il perdono sia un anticipo, e che il peccato, di cui si confessa colpevole, sia l’occasione e la questione di nuovi meriti. Infatti, il Sacramento che perdona i suoi peccati produce con la sua stessa virtù un aumento di grazia santificante. Ciascuno degli atti soprannaturali che il penitente compie è accompagnato da un aumento di questa grazia proporzionale al fervore con cui li compie. Ora, ad ogni grado di grazia santificante ne corrisponde uno di merito e di gloria per tutta l’eternità.
Conclusione.
Non è senza ragione che attribuiamo questi miracoli di misericordia in modo speciale al Cuore di Gesù. Per Lui, e Lui solo, è sia l’inizio immediato che la causa remota dei buoni effetti prodotti dal Sacramento della Penitenza. Il sacerdote è l’interprete e lo strumento del Cuore di Gesù. L’assoluzione che egli pronuncia non sarebbe altro che una formula vana se non fosse ratificata dal Cuore Divino e se non mandasse all’anima del peccatore l’unica cosa che può purificarla: la grazia. Questa non è altro che l’applicazione degli infiniti meriti acquisiti dai dolori e dall’agonia del Cuore di Gesù. Solo questo può spiegare ciò che altrimenti sarebbe inspiegabile. Se è così facile per noi espiare i nostri crimini è perché il Cuore di Gesù ha espiato per tutti loro ed ha offerto un prezzo sovrabbondante per ognuno di loro. La facilità del perdono non solo non ci renderà meno odiose le nostre colpe, o pentiti meno amareggiati, ma al contrario, ci farà concepire un dolore mille volte più vivo. Non avviciniamoci mai a quel tribunale della misericordia senza ricordare quella terribile notte del Getsemani, in cui il Cuore di Gesù fu tanto schiacciato che un sudore di sangue fuoriuscì da tutto il suo corpo, gli inzuppò le vesti e inondò il suolo. Questo stesso sangue è versato su di noi. E non saremo forse penetrati dall’orrore più vivido, quando lo riceviamo sopra la nostra testa, dal peccato che lo ha fatto germogliare? Ma come possono tanti uomini mostrare così poca gratitudine a questo capolavoro della Sua misericordia? Come possono rifiutare i mezzi infallibili per riconquistare la pace per le loro anime? Misteri di cecità ed ingratitudine non meno impenetrabili di quelli della bontà divina!
Capitolo X
Il CUORE DI GESÙ E L’ESTREMA UNZIONE
L’Estrema Unzione rispetto agli altri Sacramenti.
Nel Sacramento della Penitenza il Cuore di Gesù dispiega tutte le ricchezze della sua misericordia. Prepara la nostra debolezza ad un copioso riscatto e non pone limiti al perdono. Tuttavia, anche se l’anima riacquista la grazia, può non ritrovare la pienezza della sua forza. Questa debolezza potrebbe essere fatale nella battaglia finale: l’agonia che porta all’eternità. È stato quindi degno della bontà e della saggezza del nostro Capo, l’offrirci un ultimo soccorso per questa crisi. Lo ha fatto attraverso l’Estrema Unzione. La penitenza è un secondo Battesimo. L’Estrema Unzione può essere considerata come una seconda Confermazione. La ragione di questa somiglianza tra questi Sacramenti è la grande analogia dei loro effetti. L’unzione del santo crisma nella Cresima prepara i Cristiani alle lotte della vita, l’unzione dell’olio santo nell’Estrema Unzione li prepara alle lotte della morte. La prima dona all’anima la perfezione della grazia santificante, la seconda la prepara a ricevere la perfezione molto più alta della gloria. Come la pienezza della vita cristiana conferita dalla Cresima è un’emanazione del Cuore di Gesù, così la grazia di una morte cristiana, data dall’Estrema Unzione, scaturisce unicamente dalla carità del Cuore Divino.
Significato e scopo della morte.
Prima di tutto, è necessario comprendere il significato e lo scopo della morte. Questa non è altro che una temporanea riparazione per il peccato, così come l’inferno è la sua eterna espiazione. A causa del peccato, l’uomo nega a Dio il suo titolo di Signore sovrano e di fine eterno. È proprio in questa ribellione volontaria contro Dio, non nell’atto materiale in sé, che consiste la malizia del peccato. Per quanto disordinato possa essere di per sé questo atto, non sarebbe peccato se si ignorasse che è contrario alla volontà di Dio. Ma dal momento in cui l’uomo vuole volontariamente togliere il suo essere dal dominio sovrano di Dio, l’infinita maestà del Creatore esige una riparazione, che gli offriamo offrendogli la morte. La morte, infatti, distrugge l’opera del peccato sulla terra. Essa manifesta il supremo dominio di Dio, prostrando ai suoi piedi l’essere orgoglioso e insolente che aveva osato sollevarsi contro di Lui. È proprio la manifestazione del potere assoluto di Dio attraverso la distruzione di tutto ciò che vi si può opporre, che le religioni hanno voluto mostrare con i sacrifici. L’uomo ha sempre creduto che fosse necessario placare Dio offrendogli vittime la cui immolazione era la figura del suo stesso sacrificio. Dio accetta il simbolo, poiché i sacrifici simbolici sono un atto di religione gradito ai suoi occhi, perché vogliono ristabilire l’ordine distrutto dal peccato. Ma quest’ordine non può essere pienamente ristabilito fino a quando il peccato non sarà punito nell’essere che lo ha commesso. La morte è l’unico sacrificio completo, l’atto supremo della Religione, l’ultima ed indispensabile preparazione dell’uomo peccatore alla sua eterna unione con Dio.
La morte è convertita dal Cuore Divino in un sacrificio di grazia e di consolazione.
Si guardi fino a che punto arriva la bontà e la misericordia del Cuore di Gesù! Questo sacrificio di giustizia e di vendetta è convertito dal Cuore Divino in un sacrificio di grazia e di consolazione per i Cristiani. Come ha divinizzato la nostra vita, Egli divinizza pure la nostra morte. Non sappiamo forse che Egli abbia comunicato una dignità e una virtù divina a tutti coloro di cui si è rivestito per la nostra salvezza? Cosa manca, dunque, perché anche la nostra morte sia divinizzata? Che il Figlio di Dio la prenda come ha preso la nostra natura; che, dopo essere sceso sulla terra, scenda nella tomba e muoia per noi dopo essere nato per noi. Così ha fatto! Ha preso la nostra morte, e l’ha presa per noi, perché Egli era immortale. E così, come ha abbracciato tutte le infermità prendendo la nostra natura, ha voluto anche assaporare tutta l’amarezza e i terrori della nostra morte; con l’intento che queste paure ed agonie siano per noi flussi di grazia e strumenti di vittoria. Anche in questo ha seguito un piano: Egli ci salva, non preservandoci dagli attacchi del male, ma dandoci la forza di sostenere i suoi assalti e superare i suoi sforzi. Lascia i nostri nemici interamente liberi e ci dà la gloria di vincerli combattendo e sconfiggendoli Egli stesso con noi. Per questo Gesù ha voluto soffrire, prima di morire, tutti i dolori e i terrori dell’agonia. Tutto ciò sarebbe estremamente inconcepibile in un Dio, se non tenessimo conto del fatto che si è fatto uomo per essere il Capo dell’umanità, e che ha pagato tutti i nostri debiti. Il primo di questi è stato proprio la morte, e quindi era giusto che Lui la pagasse per noi e ci mettesse in condizione di pagarla con Lui. Quando si immerse nelle acque del Giordano, vi seppellì i nostri crimini. Immergendosi nell’Orto degli Ulivi, nell’oceano amaro dell’agonia, ha dato a queste amarezze la virtù di santificare l’agonia e la morte dei suoi fratelli. Di Lui è stato scritto che riceviamo tutto dalla sua pienezza, per grazia. Vivendo per noi ha acquistato per noi la grazia di vivere con Lui, e morendo per noi ha ottenuto per noi la grazia di morire con Lui. Era molto giusto che, per riversare su di noi i tesori di meriti che Egli ha accumulato nell’amarezza della sua agonia, usasse un canale particolare, il Sacramento dei morenti: l’Estrema Unzione.
Effetti dell’Estrema Unzione
La materia di questo Sacramento è mirabilmente scelta per indicare i suoi effetti. L’olio è una sostanza che illumina, fortifica, ammorbidisce ed è usato per ogni tipo di consacrazione. Produce nell’anima del Cristiano che sta per lasciare questo mondo tutti questi effetti: lo illumina spiritualmente, gli fa vedere la verità delle cose, scoprendo il nulla di ciò che accade, il prezzo dei beni eterni, il male del peccato, il bene della morte. Chi non ha ammirato quell’improvvisa chiarezza che brilla negli occhi dei Cristiani morenti, unti con l’olio santo e alla cui presenza le grandi illusioni si dissipano come una nuvola? Da dove possono venire questi raggi luminosi così improvvisi, se non dal Cuore di Gesù e dalla spaventosa oscurità in cui si è avvolto per amore nel Getsemani e sul Calvario? L’olio santo fortifica l’atleta di Gesù Cristo nel momento in cui sta per sostenere l’ultimo combattimento. Forse fino ad allora è fuggito dalla lotta, forse purtroppo ha ceduto. Tuttavia, egli non può essere esonerato dalla legge universale di non raggiungere la corona senza ottenere la Vittoria. Gli viene presentata una lotta con la quale può recuperare ciò che gli è mancato in tutti gli altri combattimenti, una vittoria decisiva che annullerà tutte le sue sconfitte. Ma la sua natura svanisce, la sua energia si esaurisce e tutto il suo essere è avvolto dal terrore della morte. Dove trovare le armi e l’incoraggiamento necessario per sconfiggere i suoi avversari? Nei tesori del Cuore di Gesù, i cui meriti gli saranno comunicati dall’olio sacro dell’Estrema Unzione. Non appena la santa unzione si sarà estesa attraverso le sue membra, egli potrà dire con l’Apostolo: « Quando più debole mi sento, è allora che sono più potente ». La sua amarezza non sarà diminuita, ma da queste torture scaturirà una fonte di pace e di consolazione. Insieme al Cuore di Gesù morente ripeterà la preghiera dell’Orto degli Ulivi: « Padre mio, se è possibile, passi questo calice da me. Ma non sia fatta la mia volontà, bensì la tua. » L’olio non è solo un principio di forza, ma serve anche per ammorbidire: è uno dei principali lenitivi. Un effetto simile è prodotto dall’olio santo nell’anima del Cristiano morente. Spesso elimina gli orrori della morte, e proprio in coloro che ne avevano con più intensità durante la sua vita, questo effetto appare con maggiore evidenza. Se nell’ultima ora si gode una pace che non si è goduta mai, sappiate che lo dovete al misterioso terrore del Cuore di Gesù: « Non pensavo – diceva un santo religioso – che fosse così dolce morire. Non avevo mai pensato che ad ogni amarezza sofferta dal Cuore di Gesù corrispondesse una nostra dolcezza: grazia per grazia ». L’olio è il mezzo universale di consacrazione. Si usa per ungere sacerdoti e re. È proprio per questo motivo che si usa per ungere il Cristiano nel momento in cui sta per offrire il suo ultimo sacrificio e conquistare definitivamente la sua eterna regalità.
Il Cristiano è, sul letto di morte, sia sacerdote che vittima.
Come Gesù sulla croce, il Cristiano è sul letto di morte, sacerdote e vittima allo stesso tempo. I due uomini che egli porta in grembo dal giorno del suo Battesimo, l’uomo del peccato e l’uomo della grazia, saranno definitivamente separati. La loro separazione non può che consumare la glorificazione dell’uomo di grazia nella misura in cui essa consuma la immolazione dell’uomo del peccato. L’Estrema Unzione prepara il membro di Cristo a compiere, con il suo Capo Divino, una gloriosa quanto dolorosa immolazione. Ogni volta che si avvicinava all’altare, annunciava la morte del Salvatore e si univa misticamente al Suo sacrificio. Ora è necessario riprodurlo realmente per poterne raccogliere tutti i frutti. Nel ricevere l’ultima unzione, si prepara, come membro della razza prescelta, della nazione santa, della tribù reale e sacerdotale, a compiere l’ultimo atto delle sue funzioni sacerdotali. Ma questa unzione è molteplice: si applica ai cinque sensi, ai reni e ai piedi. Perché? Perché nello stesso tempo che consacra il Cristiano come sacerdote, e gli dà la forza di consumare il suo sacrificio, lo consacra anche come vittima, e prepara il suo corpo alla gloriosa trasformazione che lo attende. Aveva violato la legge con tutti i suoi sensi, i suoi poteri affettivi e le sue forze motrici gli erano serviti come strumenti di peccato: vittime che la morte immolerà. Ma poiché questo sacrificio deve essere un sacrificio d’amore, la santa unzione purifica la vittima prima della sua immolazione, figura questa della beatificazione che si realizzerà nella prossima vita. Molto presto quegli stessi occhi, quegli stessi orecchi, quello stesso corpo, quella stessa anima, che la mano del sacerdote prepara con l’ultima unzione per sopportare con fede ed amore gli attacchi della morte, saranno inondati dall’olio della gioia, il balsamo della vita eterna.
Capitolo XI
IL CUORE DI GESÙ E L’ORDINE
L’Ordine nel piano del Cuore di Gesù.
Darla agli uomini, attraverso il Battesimo, aumentarla con la Cresima, offrirgli il cibo divino nell’Eucaristia, restaurarla con la Penitenza e l’Estrema Unzione, sono tanti benefici del Cuore di Gesù, tanti canali attraverso i quali si distribuisce la grazia soprannaturale di cui Egli possiede la pienezza. Affinché questi canali non si esaurissero mai e affinché questi benefici fossero a disposizione delle anime fino alla fine dei tempi, era necessario che Egli scegliesse sulla terra ausiliari e cooperatori, per dare ai figli degli uomini non solo il potere di raggiungere la filiazione divina, ma anche di dare figli a Dio. Bisognava renderli capaci di comunicare la vita di Dio, di distribuire il suo Spirito, di far risorgere le anime, di far crescere il loro corpo mistico, e quindi di far crescere Dio stesso, anche se non è di per sé soggetto a qualsiasi crescita. Questa è la meraviglia delle meraviglie che Gesù ha compiuto sulla terra istituendo il Sacramento dell’Ordine. Alle creature di tutti i regni della creazione, Dio concede l’onore di lavorare con Lui. Non solo li rende partecipi del suo essere, ma vuole anche che partecipino alle sue opere. Così li unisce l’uno all’altro, e rende l’universo nel suo insieme così concatenato e armonioso. Egli lavora ovunque, ma in nessuna parte da solo. Egli muove tutti i corpi, ma lo fa attraverso l’azione di altri corpi. Illumina le intelligenze, ma in genere fa intervenire altre intelligenze. Dà vita a tutti gli esseri viventi, ma richiede la collaborazione di altri esseri viventi. Dio Figlio ha voluto seguire nella redenzione una dinamica simile a quello di Dio Padre nella creazione. Anche se avrebbe potuto fare tutto da solo, voleva avere dei collaboratori. Ha concesso agli uomini l’onore di aiutarlo a produrre la vita soprannaturale, la cui unica focalizzazione e fonte inesauribile è nel suo Cuore. Da Lui, e da Lui solo, gli Apostoli ricevono l’impulso e la forza per far nascere le anime, i Dottori per illuminarle, i Pastori per nutrirle. E attraverso l’opera dei vari cooperatori e il fedele adempimento dei loro ministeri, che le anime vengono santificate e il Corpo mistico del Salvatore cresce. Così il mondo soprannaturale diventa più vario e bello, e l’edificio divino si avvicina sempre più alla perfezione.
Il sacerdote è “Alther Christus”.
Se vogliamo sapere che cosa sia un Sacerdote nella Chiesa, dobbiamo prima di tutto immaginarlo come il luogotenente di Gesù Cristo, come il suo interprete e ministro, e non solo a parole, come un altro Gesù Cristo. Perché non c’è una delle funzioni divine esercitate da Gesù Cristo sulla terra che non sia esercitata anche dal Sacerdote. E non esiste un potere divino conferito al Figlio di Dio dal Padre, che il Figlio di Dio non abbia delegato ai suoi Sacerdoti. Come Lui e attraverso di Lui, essi sono per gli uomini, i loro fratelli, la verità, la via e la vita: tre funzioni in cui si riassume la missione del Salvatore. Gesù Cristo, infatti, è prima di tutto la verità, la luce del mondo, un titolo che gli si dà e che gli è dovuto. Solo Lui ha istruito gli uomini su tutti i grandi problemi, la cui soluzione è di fondamentale importanza per essi. Ma, allo stesso modo, dice ai suoi Apostoli: voi siete la luce del mondo! Se il Verbo divino è la luce che illumina, i Sacerdoti sono le torce con il quale, unico mezzo, si diffonde la chiarezza. Gesù Cristo è la via e la porta del cielo: chi non entra da questa porta sarà per sempre escluso dalla vita. Chi non segue questa strada, inevitabilmente si smarrirà. Non è solo il Sacerdozio che può mostrare questa via e aprire questa porta? Non ha ricevuto, nella persona del suo Capo, le chiavi del cielo? Gesù Cristo non ha forse dato l’assicurazione che: tutto ciò che legherete in terra sarà legato in cielo e tutto ciò che scioglierete in terra sarà sciolto in cielo? Non vi ha affidato l’interpretazione dei suoi precetti? Non ha forse detto che avrebbe considerato coloro che non avrebbero ascoltato i suoi ministri come ribelli contro la sua stessa autorità? Gesù Cristo è la vita e il Padre delle anime; il nuovo Adamo che genera per l’eternità, a coloro che Egli dapprima fa nascere alla vita vivendo la morte eterna. Non hanno forse i Sacerdoti il diritto di dire a tutti coloro che essi rigenerano con le acque del Battesimo e nutrono col pane eucaristico, quello che San Paolo diceva ai suoi discepoli: « Non sono solo il vostro maestro, ma anche vostro padre, perché vi ho veramente generati in Gesù Cristo »? Infine, Gesù Cristo risuscita le anime, le libera dalla morte del peccato, spezza le loro catene, ripristina la loro salute insieme alla vita, ed è per questo che merita il nome di Salvatore. Ma un tale potere divino, al cui confronto la resurrezione dei morti ha ben poco valore, non viene esercitato ordinariamente attraverso il ministero dei Sacerdoti? Il Sacerdote non pronuncia ogni giorno la parola che fu uno scandalo per i Giudei (perché sembrava loro propria ed esclusiva di Dio): Io ti assolvo, ti libero dal giogo di satana, ti do la vita che avevi perso, il cielo a cui non avevi diritto? Non invano Gesù Cristo disse ai suoi ministri quando ascese al cielo: « Come il Padre mio ha mandato me, così io mando voi ». Non sono vane le promesse che, se rimarrete uniti a Lui come il tralcio alla vite, darete molto frutto e farete opere simili alle sue, anzi più grandi delle sue. Il Sacerdozio ha compiuto questa missione divina e ha realizzato questa magnifica predicazione. Da quando Gesù è salito in cielo, i suoi Sacerdoti non hanno cessato di fare sulla terra le opere che Egli, nella sua vita mortale, ha compiuto; e hanno convertito incomparabilmente più peccatori, illuminato più infedeli, santificato più anime di quante ne abbia fatte Egli personalmente.
Il sacerdote ha potere sullo stesso Gesù Cristo.
Il Sacerdote è veramente un altro Gesù Cristo. Possiamo dire qualcos’altro? Sì, il potere che esercita su Gesù Cristo: il potere di comandare il Figlio dell’Onnipotente. Gesù Cristo, dalla sua Ascensione, ha tre vite: quella gloriosa in cielo, quella sacramentale nell’Eucaristia e quella mistica nelle anime. La gloriosa non può essere soggetta ad alcun potere, perché è elevata al di sopra di ogni principato e potere. Ma, per quanto riguarda le altre due vite, Gesù Cristo è del tutto subordinato al potere dei suoi Sacerdoti. È da loro che riceve la sua vita sacramentale, perché non scende sull’altare se non quando lo chiamano con le formule della Consacrazione. Egli è alla loro mercé e a loro disposizione come il più umile schiavo; con i loro orari stabiliti ed attende le loro consolazioni. Quando e come lo desiderano, con la maggiore o minore frequenza che conviene, riceverà sull’altare questa nuova esistenza. Quando vorranno toglierlo, si lascerà togliere senza mai mostrare alcuna resistenza. Avete mai visto un servo così docilmente sottomesso agli ordini dei suoi padroni? La schiavitù si definiva dicendo che lo schiavo era una cosa del suo padrone. L’Eucaristia è una delle cose di cui il Sacerdote può disporre a suo piacimento. Infatti, se rinchiude la vittima eucaristica in un oscuro tabernacolo, questa non farà nulla per uscire dagli angusti limiti della sua prigione. La lascerà quando vorrà, andrà dove vorrà, e camminerà in trionfo per le strade e per le piazze di una città, o per entrare in un lurido tugurio, luogo dove la povertà lotta disperatamente contro gli orrori della malattia. Per unirsi ad un’anima angelica o per esporsi ai baci sacrileghi di un nuovo Giuda. Tutte quelle cose che il Sacerdote comanderà a Gesù, Egli le farà come se non avesse altro pensiero, nessun altra volontà, nessun altro potere che non sia quello del suo ministro. Non meno importante è la dipendenza del Salvatore, per quanto riguarda la vita che Egli ha nelle anime. Essa gli appartiene e la stima più della sua vita sacramentale e corporea. Per darla a noi ed accrescerla senza interruzioni, è rimasto presente nell’Eucaristia e non ha esitato un attimo a sacrificare la vita naturale che il suo corpo riceve dall’anima, quando si è visto nella condizione di scegliere questa o quella soprannaturale. Non si può infatti negare che è molto più glorioso avere un corpo mistico composto da anime divinamente vivificate dal suo Spirito, piuttosto che un corpo fisico, i cui elementi materiali sono animati dalla sua anima. Ora, sia questa terza vita che la seconda vita, le riceve Gesù dai suoi Sacerdoti, e per la sua conservazione e crescita dipende dalla libera collaborazione dei suoi ministri. Un sacerdote zelante santificherà molte anime rispetto ad un altro negligente che le lascia languire nell’imperfezione e ad un altro malvagio che le porta alla perdizione. Gesù Cristo riceverà dal primo una vita che il secondo gli darebbe solo in parte, e che il terzo gli toglierebbe. Per mezzo di essi Egli nascerà nelle anime, crescerà, diventerà forte, sarà curato nelle sue infermità e raggiungerà in cielo il loro sviluppo perfetto. In questo modo inizia in tutti i Cristiani una nuova esistenza, esposta a molti pericoli, combattuta da tanti nemici come la prima, e molto più soggetta ai suoi ministri di quanto la sua vita mortale lo sia stata alla Vergine Maria. Non è quindi un’esagerazione dire che il Sacerdote partecipa veramente alla gloriosa maternità della Vergine; un’affermazione che possiamo corroborare con la parola del Salvatore stesso. Un giorno gli fu detto che sua madre e i suoi fratelli lo stavano aspettando: « Chi è mia madre – rispose il Salvatore – e chi sono i miei fratelli? »; e rivolgendosi ai suoi Apostoli: « Ecco – dice – mia madre e i miei fratelli; perché chi fa la volontà del Padre mio questi è mio fratello, mia sorella e mia madre. » La volontà di Dio Padre è la salvezza e la rigenerazione delle anime. Coloro che si dedicano alla realizzazione di questo desiderio del Signore, non sono solo i fratelli di Gesù Cristo, in quanto partecipano alla sua vita e acquisiscono diritti sul suo patrimonio celeste, ma anche « sua Madre », comunicando la sua vita alle anime e dando ad esse una vita completamente nuova.
L’Ordine è un Sacramento del Cuore di Gesù.
Vista alla luce di queste considerazioni l’incomparabile dignità del Sacerdozio cristiano, non dubitiamo che sia un Sacramento del Cuore di Gesù. Il Cuore Divino non ne è solo l’inizio, come per gli altri, ma non c’è nessuno al di fuori di Lui che possa dare a chi sente le spalle appesantite da un carico così formidabile, la forza di portarlo senza soccombere. Ogni potere porta con sé una responsabilità il cui peso è proporzionato alla sua portata e alla sua eccellenza. C’è solo una forza capace di portare un fardello così grande: quella dell’amore divino. Per attirare Gesù Cristo sulla terra e per riceverlo con dignità, il Sacerdote deve mostrargli un amore simile a quello che brucia nel cuore degli abitanti del cielo. Per farlo nascere nelle anime, egli deve essere consumato, come Maria, nelle fiamme il cui fulcro è l’adorabile Cuore di Gesù. Dio Padre ha voluto che la comunicazione della sua paternità fosse accompagnata da quella del suo amore. Sappiamo tutti quanto sia vivo questo amore negli animali che sono insignificanti e deboli di per sé. E se la paternità animale pura è accompagnata da un vero e proprio abbandono, che dire allora della paternità spirituale? Colui che è stato scelto per dare la vita di Dio non amerà forse gli uomini con amore divino? Se l’amore paterno per gli uomini è sufficiente perché essi sopportino i fardelli della paternità umana, ci sarà pure un amore che dia la forza ai ministri di Gesù Cristo di compiere i loro doveri e di uscire illesi dai pericoli che la paternità divina conduce con sé. Non sorprende che Dio abbia proibito qualsiasi altra paternità a coloro che sono investiti da questa incomparabile paternità. La capacità di amare che il cuore di un uomo contiene non è eccessiva, per adempiere a tutti gli obblighi che il Sacramento impone a chi ha ricevuto un tale temibile onore. Per rappresentare davanti alle anime l’infinitamente amorevole Dio che è morto per loro, il Sacerdote deve essere distaccato da tutto ciò che può ridurre le sue forze e impedirgli di dare la vita per le anime a lui affidate. Come può il Sacerdote far capire e fare amare agli uomini l’eccelsa paternità attribuitagli? Per portare a termine il suo compito e attirare le moltitudini ostili, non ha altro rimedio che rinfrescarsi alla fonte del suo Sacerdozio, e attingere dal Cuore di Gesù un amore più ardente di tutti gli odi ed uno spirito di abnegazione in cui tutte le ostilità siano infrante. L’unione con il Cuore di Gesù, che per i Cristiani è il mezzo più efficace di santificazione, è per il Sacerdote la principale condizione di successo nel suo temibile ministero e l’unica garanzia di trionfo nella lotta feroce che deve sostenere. I fedeli non dimentichino: il trionfo del Sacerdozio è il trionfo della Chiesa e i pericoli che minacciano i pastori sono i peggiori e più formidabili attacchi al gregge.
https://www.exsurgatdeus.org/2020/06/11/il-cuore-di-gesu-e-la-divinizzazione-del-cristiano-14/







