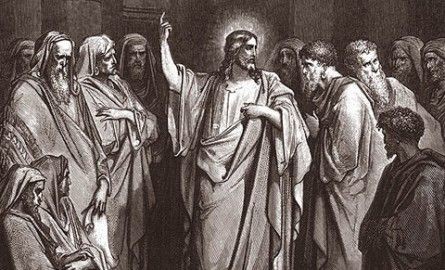DOMENICA V DOPO PENTECOSTE (2019)
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
Ps XXVI: 7; 9 Exáudi, Dómine, vocem meam,
qua clamávi ad te: adjútor meus esto, ne derelínquas me neque despícias me,
Deus, salutáris meus. [Esaudisci, o Signore, l’invocazione con cui
a Te mi rivolgo, sii il mio aiuto, non abbandonarmi, non disprezzarmi, o Dio
mia salvezza.].
Ps XXVI: 1
Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timébo? [Il Signore è mia luce e mia
salvezza, chi temerò?]
Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te: adjútor meus esto,
ne derelínquas me neque despícias me, Deus, salutáris meus.
[Esaudisci, o Signore, l’invocazione con cui a Te mi rivolgo, sii il mio aiuto,
non abbandonarmi, non disprezzarmi, o Dio mia salvezza.].
Oratio
Orémus.
Deus, qui diligéntibus te bona invisibília præparásti: infúnde
córdibus nostris tui amóris afféctum; ut te in ómnibus et super ómnia
diligéntes, promissiónes tuas, quæ omne desidérium súperant, consequámur.
[O Dio, che a quanti Ti amano preparasti beni invisibili, infondi nel nostro
cuore la tenerezza del tuo amore, affinché, amandoti in tutto e sopra tutto,
conseguiamo quei beni da Te promessi, che sorpassano ogni desiderio.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Petri Apóstoli. 1 Pet III: 8-15
“Caríssimi: Omnes unánimes in oratióne estóte, compatiéntes,
fraternitátis amatóres, misericórdes, modésti, húmiles: non reddéntes malum pro
malo, nec maledíctum pro maledícto, sed e contrário benedicéntes: quia in hoc
vocáti estis, ut benedictiónem hereditáte possideátis. Qui enim vult vitam
dilígere et dies vidére bonos, coérceat linguam suam a malo, et lábia ejus ne
loquántur dolum. Declínet a malo, et fáciat bonum: inquírat pacem, et sequátur eam. Quia
óculi Dómini super justos, et aures ejus in preces eórum: vultus autem Dómini
super faciéntes mala. Et quis est, qui vobis nóceat, si boni æmulatóres
fuéritis? Sed et si quid patímini propter justítiam, beáti. Timórem autem eórum
ne timuéritis: et non conturbémini. Dóminum autem Christum sanctificáte in
córdibus vestris.”
Omelia I
[A. Castellazzi: La scuola degli Apostoli – Sc. Tip. Vescov.
Artigianelli, Pavia, 1929]
LA PACE
“Carissimi: Siate tutti uniti nella preghiera, compassionevoli, amanti dei fratelli, misericordiosi, modesti, umili: non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario benedite, poiché siete stati chiamati a questo: a ereditare la benedizione. In vero, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici raffreni la sua lingua dal male e le sue labbra dal tesser frodi. Schivi il male e faccia il bene, cerchi la pace e si sforzi di raggiungerla. Perché gli occhi del Signore sono rivolti al giusto e le orecchie di lui alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro coloro che fanno il male, E chi potrebbe farvi del male se sarete zelanti del bere! E arche aveste a patire per la giustizia, beati voi! Non temete la loro minaccia, e non vi turbate: santificate nei vostri cuori Gesù Cristo”. – (1. Pietr. 3, 8-15).
Anche l’Epistola di quest’oggi è tolta
dalla I. lettera di S. Pietro. E’ naturale che, scrivendo ai cristiani dispersi
dell’Asia minore, tenga sempre presente la condizione in cui si trovano: sono
pochi fedeli tra numerosi pagani, e sono sotto la persecuzione di Nerone. Come
devono diportarsi? devono vivere in stretta unione fra di loro, mediante la
misericordia, la compassione, la condiscendenza; essendo stati chiamati al
Cristianesimo a render bene per male, affinché abbiano per eredità la
benedizione celeste. Non trattino con la stessa misura quelli che fanno loro
del male. La vita felice è per chi raffrena la lingua, evita il male e procura
di aver pace con il prossimo. Del resto i giusti non sono abbandonati dal Signore,
e nessuno può loro nuocere, se sono zelanti del bene. Quanto alla persecuzione,
beati loro se hanno a soffrire qualche cosa per la religione cristiana. Siano, quindi,
calmi, senza ombra di timore: onorino, invece, e temano Gesù Cristo. Anche noi,
dobbiamo procurare di vivere una vita felice, per quanto è possibile tra le
miserie e le persecuzioni di questo mondo. Sforziamoci di vivere in pace, ciò che
ci è possibile con l’aiuto di Dio, anche tra le tempeste di quaggiù. Per avere
la pace:
1 Bisogna astenersi dalle parole e dalle
azioni peccaminose,
2 Vivere nella concordia col prossimo,
3 Non aver paura di soffrire per la
giustizia.
Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici raffreni la sua lingua dal male e le sue labbra dal tesser frodi. Schivi il male e faccia il bene. Chi vuol vivere una vitanon turbata da agitazioni e da ‘rimorsi deve astenersi dalleparole e dalle azioni peccaminose. La vita felice quaggiùconsiste principalmente nella tranquillità della propriacoscienza. Gli uomini più felici sono i Santi. Noi vediamole loro mortificazioni, e, quasi, ce ne scandalizziamo; vediamole loro penitenze, e ci sentiamo come sgomentati.Non vediamo, però, il loro interno. Se vedessimo la pacee la tranquillità della loro coscienza, ci farebbero invidia. – L’affermazione dell’Apostolo: «Quasi tristi, ma pur sempre allegri (“ Cor. VI, 10)), è l’affermazione di tutti i Santi, i quali potrebbero dire: All’esterno siamo stimati come persone viventi una vita di melanconia, eppure viviamo nell’allegrezza. Dove c’è Dio, c’è la pace. Quello che Gesù disse un giorno agli Apostoli, dice a tutti coloro che gli sono uniti per mezzo della grazia: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace; ve la do, non come ve la dà il mondo» (Giov. XIV, 27). – Sul fiume ingrossato o sul lago mosso dai venti, il barcaiolo adopera tutta la sua vigoria e tutta la sua prudenza per condurre la barca a riva, lottando con le onde. Ma il fanciullo che vi si trova, se ne sta tranquillo divertendosi con gli spruzzi d’acqua che v’entrano. Nella barca c’è il padre; perché temere? Quando noi con il peccato, non allontaniamo dall’anima nostra Dio, perché dobbiamo turbarci? – Finché la coscienza è in pace con Dio, vengano pure le tribolazioni da qualsiasi parte: Dio è il rifugio del tribolato che in lui trova consolazione. Ma se il peccato ne ha scacciato Dio, egli non può trovar rifugio o consolazione. Nessuna pena è più grave della rea coscienza. Noi vediamo delle volte piante intarlate o marce esternamente. Chi deve farne uso non si preoccupa tanto della superficie: osserva se la pianta sia sana internamente. Se internamente non fosse sana, a nulla varrebbe, anche se avesse buona apparenza esterna. «Così, quando l’uomo non trova in se stesso una buona coscienza, che gli giova essere in buon stato esternamente, se è putrefatto il midollo della sua coscienza?» (S. Agost. En. In Ps. XLV,3) Se può ingannare l’occhio degli uomini che lo credono felice, non può ingannar Dio. «Dio solo vede il cuore degli uomini» (2 Paral. VI. 30) ed egli ci assicura che «per gli empi non c’è pace» (Is. XLVIII, 22). – Chi vuol vivere giorni felici, oltre essere in pace con Dio, deve procurare di essere in pace con il prossimo. Cerchi la pace e si sforzi di raggiungerla, studiandosi di vivere in concordia col prossimo, e ponendo ogni premura per impedire che la pace non si rompa. È tanto facile rompere la pace con il nostro prossimo! Le sue abitudini, i suoi gusti, le sue parole ci sono frequentemente occasione d’impazienza, di risentimento. Per non rompere l’armonia che deve regnare con tutti, è necessario prender sempre le cose in buona parte; non lasciarsi mai prendere dal cattivo umore; e sopportar pazientemente il cattivo umore degli altri. Io sarei felice, se quel vicino non s’interessasse dei fatti miei, se quella persona non mi portasse invidia, se quell’altra non mi odiasse, tu dici. Sarà verissimo. Ma siccome anche tu sei di carne e ossa come coloro che ti recano noia, è naturale che gli stessi lamenti che tu muovi rispetto a loro, essi potrebbero muovere rispetto a te. Sai bene che cosa dice S. Giacomo : «Tutti manchiamo in molte cose» (III, 2). Via, oggi a me, domani a te. Se oggi sono altri che ti offrono motivo di lamento, domani potresti esser tu a offrire motivo di lamento ad altri. È meglio considerare la partita pari, e sopportarsi a vicenda, avendo sempre in vista la conservazione della pace. Quanto ai sussurroni che cercano di turbare la concordia non c’è che far orecchie da mercante. Un buon paio d’orecchie stancano cento male lingue. Col tempo taceranno anch’essi. Esser indulgenti con i nostri fratelli è condizione indispensabile per conservar la pace e la felicità. Il Signore l’ha inculcata insistentemente questa indulgenza verso il prossimo. E il cristiano non può esimersi dal praticarla. Dimentichi, quindi, i dispiaceri che gli furon dati; non badi alle parole sfavorevoli; non si lamenti delle dimenticanze; passi sopra ai torti ricevuti, ripaghi l’odio con il perdono, anzi con l’amore. Allora soltanto avrà la pace. «Se c’è carità, ci sarà anche la pace» (S. Giov. Cris. In Epist. Ad Eph. Hom. XXIV, 4). Senza abnegazione non si può aver la pace. È una verità troppo dimenticata. Forse mai, come ai nostri giorni, si è sentito parlare di pace; eppure tutti sentiamo che la pace manca. Si vuol la pace, senza cessare di guardarsi in cagnesco; si vuol la riconciliazione, pur mantenendo vivo l’odio; si vuole l’armonia, senza rinunziare all’orgoglio e all’egoismo. Si vuol la pace, mettendo a base non l’amore, ma il timore. La pace si avrà solamente allora che le si metterà per base l’amor di Dio col conseguente amor degli uomini. Senza questa base possono moltiplicarsi i convegni, le riunioni, i tentativi d’ogni genere: tutto, però, finirà con la melanconica constatazione del profeta «E curarono le piaghe della figlia del popol mio con burlarsi di lei, dicendo: Pace, pace; e pace non era» (Ger. VI, 14). E non dobbiamo accontentarci della pace di un giorno, o di una pace molto facile. I tesori si acquistano con grandi sacrifici, e si conservano con molta cura. Altrettanto dobbiam fare con il tesoro della pace. Chi vuol vivere i giorni felici cerchi la pace, e si sforzi di raggiungerla «Non basta cercarla; — commenta S. Gerolamo — se, trovatala, cerca di sfuggire, tienle dietro con ogni alacrità! » (Epis. 124, 14 ad Rost.). – E chi potrebbe farvi del male se sarete zelanti del bene? Nessuno può nuocere a chi conduce una vita irreprensibile,dedita al bene. Tutt’al più può nuocere alcorpo, non all’anima. S u questo punto è troppo chiarala parola del Divin Maestro, perché abbiamo ad aver un momento solo di titubanza. «Non temete coloro che possono uccidere il corpo, e non l’anima: temete piuttosto colui che può mandare in perdizione all’inferno e l’anima e il corpo» (Matth. X, 28). Tutti i patimenti che i persecutori facevano soffrire ai Cristiani, se tormentavano le loro membra, lasciavano imperturbato il loro spirito. «Noi siamo persuasi — offermava S. Giustino M. — di non poter soffrir male di sorta da nessuno, se non quando siamo convinti d’esser caduti in colpa» (Apol. 1, ). Anzi, la persecuzione noi dobbiam considerarla come un bene. E se anche aveste a patire per la giustizia, beati voi!, aggiunge S. Pietro. Quando si soffre per una causa giusta, si è più degni di ammirazione di chi trionfa. Chi soffre per una causa santa, deve fare più invidia che compassione. «Essere prigioniero per Cristo — dice il Crisostomo — è gloria più grande che essere Apostolo, dottore, evengelista. E chi ama Cristo ben intende quel che dico» (In Ep. Ad Eph. Hom. 8, 1). La Beata Giovanna Antida Thouret, non reggendole il cuore di vedere, durante la rivoluzione francese, il suo paese senza culto, senza preghiera, prese a radunar gente in casa sua, nei giorni domenicali e festivi, perché potessero attendere a qualche atto di pietà. Talora poté venire anche qualche sacerdote a celebrare e a ministrare i Sacramenti. – La cosa non poteva sfuggire ai nemici della religione, e la Thouret è chiamata a comparire davanti al comitato rivoluzionario di Baumes-Les-Dames. Mentre si reca davanti ai commissari la gente, che temeva per la sua sorte, le diceva: — Dove andate mai ? — Vado a festa. Non temete; non ho paura; si tratta della causa di Dio — (La Beata Giovanna Antida Thouret Roma, 1926). Quando si tratta della causa di Dio dobbiamo considerare le sofferenze come una vera festa. Anche Gesù Cristo aveva detto, prima di S. Pietro : «Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno» (Matth. V, 11). Qualunque croce, accettata con spirito cristiano ci porta vantaggi incalcolabili. «Beato l’uomo che soffre tentazioni; perché quando sarà stato provato, riceverà la corona di vita, promessa da Dio a coloro che lo amano » (Giac. I, 12). Quindi, in nessuna circostanza della vita c’è motivo di perder la pace, «Si logori pure la mia carne e il mio cuore: — esclama il Salmista — fortezza del mio cuore e mia porzione eterna è Dio» (Ps. LXXII, 26). E quando pensiamo che Dio è nostra porzione eterna, non possono turbarci le privazioni che logorano la vita, i dolori che amareggiano il cuore. Le tribolazioni e le persecuzioni devono, invece, consolarci perché «la momentanea e leggera tribolazione nostra procaccia a noi, oltre ogni misura, smisurato peso di gloria» (II Cor. IV, 17).
Graduale
Ps LXXXIII: 10; 9
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice super servos tuos, [O
Dio, nostro protettore, volgi il tuo sguardo a noi, tuoi servi]
V. Dómine, Deus
virtútum, exáudi preces servórum tuórum. Allelúja, allelúja
[O Signore, Dio degli eserciti, esaudisci le preghiere dei tuoi servi. Allelúia,
allelúia]
Alleluja
Ps XX: 1
Alleluja, alleluja Dómine, in virtúte tua lætábitur rex: et super
salutáre tuum exsultábit veheménter. Allelúja. [O Signore, nella
tua potenza si allieta il re; e quanto esulta per il tuo soccorso! Allelúia].
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii
secúndum Matthæum.
Matt. V: 20-24
“In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nisi
abundáverit justítia vestra plus quam scribárum et pharisæórum, non intrábitis
in regnum coelórum. Audístis, quia dic tum est antíquis: Non occídes: qui autem
occídent, reus erit judício. Ego autem dico vobis: quia omnis, qui iráscitur
fratri suo, reus erit judício. Qui autem díxerit fratri suo, raca: reus erit
concílio. Qui autem díxerit, fatue: reus erit gehénnæ ignis Si ergo offers
munus tuum ad altáre, et ibi recordátus fúeris, quia frater tuus habet áliquid
advérsum te: relínque ibi munus tuum ante altáre et vade prius reconciliári
fratri tuo: et tunc véniens ófferes munus tuum.”
Omelia II
[A. Carmignola, Spiegazione dei
Vangeli domenicali, S. E. I. Ed. Torino,
1921]
SPIEGAZIONE XXXII.
“In quel tempo disse Gesù a’ suoi discepoli:
In verità vi dico che, se la vostra giustizia non sarà più abbondante che quella
degli Scribi e Farisei, non entrerete nel regno de’ cieli. Avete sentito che è
stato detto agli antichi: Non ammazzare; e chiunque avrà ammazzato, sarà reo in
giudizio. Ma io vi dico, che chiunque, si adirerà contro del suo fratello, sarà
reo in giudizio. E chi avrà detto al suo fratello: Raca; sarà reo nel consesso.
E chi gli avrà detto: Stolto; sarà reo del fuoco della gehenna. Se adunque tu stai
per fare l’offerta all’altare, e ivi ti viene alla memoria che il tuo fratello
ha qualche cosa contro di te: posa lì la tua offerta davanti all’altare, e va a
riconciliarti prima col tuo fratello, e poi ritorna a fare la tua offerta” (Matth.
V. 20-24).
Quel celebre discorso che nostro Signor
Gesù Cristo tenne sopra il monte, presso il lago di Genezaret, fu sempre
riguardato, come nota S. Agostino, siccome il compendio di tutta la morale di
Gesù Cristo e la regola esatta e completa di una vita al tutto cristiana.
Perciò non ci deve far meraviglia, se la Chiesa più volte, in varie domeniche
dell’anno, richiama la nostra attenzione sopra qualche tratto di quel discorso
medesimo; poiché di che altro mai la Chiesa, nostra affettuosissima madre, può
essere più sollecita che nutrire noi, suoi figliuoli, del cibo santissimo della
parola uscita dallo stesso labbro del divino Maestro? È dunque uno dei tratti
di quel celebre discorso, che anche oggi la Chiesa ci invita a considerare nel
Vangelo di questa domenica. E noi, assecondando questo invito procureremo di
considerarlo con grande attenzione e con vero profitto per le anime nostre.
1. In quel discorso, tra le altre cose, Gesù disse a’ suoi discepoli: In verità vi dico che, se la vostra giustizia non sarà più abbondante che quella degli Scribi e Farisei, non entrerete nel regno de’ cieli. – Quali erano pertanto questi uomini, che il Salvatore riprova e condanna ad ogni pagina del Vangelo? Gli Scribi erano i dottori della legge incaricati di trascrivere i Libri santi, di tenerli in custodia e di spiegarli al popolo in ciò, che questi avevano di incerto e di oscuro. Costoro esteriormente menavano una vita molto regolata, benché fossero diversi nel loro cuore, onde agli occhi del volgo, che non bada se non all’esterno, godevano una grande riputazione. I Farisei componevano una setta particolare tra i Giudei. Mostravansi scrupolosi osservatori della legge mosaica. Osservavano i giorni di festa, digiunavano due volte la settimana, facevano grandi limosine e lunghe preghiere, pagavano la decima di tutti i loro beni. Affettavano insomma una perfetta regolarità, cosicché tutte le esteriorità parlavano in lor favore. Erano chiamati Farisei, dice S. Girolamo, vale a dire divisi, perché erano separati dal popolo per false apparenze di una singolare pietà. Ma in realtà qual era mai la giustizia di costoro? Era puramente esteriore. Gl’intimi sentimenti non corrispondevano a quell’esteriore di pietà; la legge presso di costoro non conduceva che la mano, ma la grazia non ispirava il cuore. Gli uomini si lasciavano ingannare da quelle apparenze; ma Gesù, che non solo vero uomo, ma pur vero Dio legge nel più intimo del pensiero, scruta le reni e i cuori ed interroga le anime, Gesù ben conosceva quegli orgogliosi Farisei e quegli Scribi ipocriti, e non risparmiandoli punto, diceva loro: « Voi cercate comparir giusti innanzi agli uomini, ma siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità, somigliate a quei sepolcri imbiancati, che paiono magnifici a coloro che li riguardano, e che internamente racchiudono null’altro che corruzione ed ossami di morti ». Ecco quel che erano i Farisei e gli Scribi: praticavano il digiuno e l’astinenza corporali; ma rigettavano la mortificazione del cuore: facevano copiose elemosine, ma per esser veduti, per ottenere la stima e le lodi degli uomini; si facevano scrupolo d’entrare nel palazzo di Pilato, per timor di diventar legalmente immondi, ma con una sfrontatezza incredibile si facevano ad accusare e condannare il Giusto per eccellenza, nostro Signor Gesù Cristo. È adunque facile di comprendere perché Gesù Cristo ci avverta che se la nostra giustizia non sarà più abbondante di quella degli Scribi e dei Farisei, non entreremo nel regno dei Cieli. No, certamente, a guadagnare il Paradiso non basta la bontà esteriore ed apparente, ci vuole la bontà vera e del cuore. Eppure, o miei cari, quanti vi sono tra gli stessi Cristiani, che non hanno che una bontà falsa ed ipocrita! Quanti ve ne sono che della bontà si fanno un’idea tutto secondo la loro passione e fantasia. Taluno, che ama di digiunare, si terrà per molto buono, purché digiuni, sebbene il suo cuore sia pieno di rancore; e non osando soddisfar la sua lingua nel mangiare e nel bere, non avrà poi scrupolo d’imbrattarla nel sangue del prossimo con mormorazioni e calunnie. Un altro si stimerà buono, perché dice una gran moltitudine d’orazioni ogni giorno, sebbene con tutto ciò sia sempre molto fastidioso ed arrogante, e dica facilmente ingiurie al suo prossimo. Quell’altro tira fuori volentieri molti sospiri dal suo cuore quando prega, ma non può cavare un tantino di dolcezza alfine di perdonare ad una persona che l’ha offeso. Un altro sarà esatto nell’eseguire esteriormente gli ordini de’ suoi superiori, ma internamente si adira contro di essi e molto facilmente ne mormora con gli amici. Tutti costoro possono sembrare buoni, ma in realtà non lo sono. Quando i soldati di Saulle cercavano Davide in casa sua, Micol avendo posto una statua nel letto, e copertala colle vesti di Davide, fece loro credere che quello era lo stesso Davide infermo ed addormentato. Cosi molti si coprono di certe azioni esteriori appartenenti alla bontà, e gli altri credono che siano veramente buoni e pii; ma per verità non sono altro che statue e fantasmi di bontà. La vera e viva bontà, o cari giovani e cari Cristiani, presuppone l’amor di Dio, anzi ella non è altro che un vero amor di Dio: quell’amor di Dio, che ci dà forza a ben operare in tutte quante le nostre azioni, e non solo a ben operare, ma ad operare con gusto e con prontezza. La vera bontà non è altro che la vera carità, la quale ci fa osservare esattamente tutti i comandamenti di Dio. Laonde chi non osserva tutti i Comandamenti di Dio, non può assolutamente essere stimato buono. – E perché la vera bontà consiste in un certo grado di eccellente carità, essa non solo ci rende attivi e diligenti nell’osservanza di tutti i precetti di Dio, ma oltre di ciò ci provoca a fare con prontezza ed affetto tutte le buone opere che noi possiamo, ancorché esse non siano in modo alcuno comandate, ma solo consigliate o inspirate. Ed in vero un malato, che di fresco è risanato da qualche infermità, cammina quanto gli è necessario, ma lentamente e con istento; così chi dopo essere stato cattivo viene guarito da’ suoi peccati per qualche grazia speciale di Dio, si mette a fare quanto Dio gli comanda, ma con lentezza e con istento. Invece chi ha la sua bontà, qual uomo ben sano, non solo cammina, e persino corre nella via dei comandamenti di Dio, ma per di più egli si avanza e corre per i sentieri de’ consigli e delle inspirazioni celesti, amando le pratiche di pietà, frequentando con vero profitto i SS. Sacramenti, emendandosi de’ suoi più leggieri difetti e dando esempi di ogni più bella virtù. Pertanto, o miei cari, riflettete alquanto sopra di voi per vedere se in voi vi ha la vera o la falsa bontà, se insomma la giustizia vostra è più abbondante di quella degli Scribi e de’ Farisei, e da questo esame prendete le opportune risoluzioni.
2. Proseguiva poscia il divin Redentore dicendo: Avete sentito che è stato detto agli antichi: Non ammazzare; e chiunque avrà ammazzato, sarà reo in giudizio. Ma io vi dico, che chiunque si adirerà contro del suo fratello, sarà reo in giudizio. E chi avrà detto al suo fratello: Raca, cioè leggero, privo di senno, sarà reo nel consesso. E chi avrà detto: Stolto, sarà reo del fuoco della gehenna. Presso gli Ebrei eravi il tribunale del giudizio, chiamato il piccolo sinedrio, che giudicava le cause criminali e pronunziava ordinariamente le sentenze di morte; poi il tribunale del consiglio ossia grande sinedrio, che giudicava in ultima istanza i delitti contro lo stato e contro la religione. Quando adunque Gesù dice che chi si mette in collera eccessiva, è reo di giudizio, vuol dire ch’egli sarà castigato da Dio con quella severità, che si usava a quanti venivano condannati dal tribunale del giudizio; così chi dice a suo fratello raca, parola siriaca che significa “stolto”, sarà punito da Dio come i giudicati dal tribunale del consiglio, e finalmente chi dice al suo prossimo stolto, il che in istile biblico vuol dir empio, sarà precipitato in inferno. Ecco quale differenza tra il linguaggio dei dottori della legge e quello di Gesù Cristo. I dottori della legge proibivano soltanto l’omicidio, quando all’esterno compimento; il Salvatore invece attacca il principio di sì grave delitto, e vuol tagliare il male dalla sua radice. Egli ben sa, che chi riuscirà a dominare la collera, che chi non si abbandonerà a parole violente ed ingiuriose contro del suo prossimo, non trascorrerà mai neppure a ferirlo e ad ucciderlo, epperò egli si fa a vietare la collera e le ingiurie; e togliendo il nome dai tribunali, che vi erano tra gli Ebrei per le cause più gravi, e dai più gravi castighi, che essi infliggevano, per impedire tutte le tristi conseguenze della collera minaccia al collerico ed a chi insulta il suo prossimo delle pene simili a quelle che venivano inflitte all’omicida. Se è così adunque, quanto gran male deve essere la collera e quanto importa che noi ci adoperiamo ad evitarla! È vero, vi ha bensì una collera santa, eccitata dallo zelo, che ci fa riprendere con forza, chi la nostra dolcezza non poté correggere: e tale è la collera di un padre o di un maestro alla vista dei disordini, che si devono impedire. Lo stesso Gesù fu preso da questo sdegno, quando cacciò dal tempio i profanatori, che ne violavano la santità. Ma la collera e l’ira, come peccato capitale è ben diversa: è un moto impetuoso dell’anima nostra, che trae a respingere violentemente ciò, che a noi spiace Nasce da un cattivo principio, da una passione, che domina il nostro cuore, e che incontra ostacoli. Un orgoglioso s’avventa contro ciò che ferisce la sua vanità od ambizione; un avaro si sdegna, quando qualche cosa sconcerta le sue idee; un incontinente si infuria, quando si attraversano i suoi piaceri. Quest’ira non è secondo Dio, né secondo la retta ragione: essa turba l’anima, e l’alterazione, che vi apporta, si manifesta sul viso, e in tutto l’esteriore dell’uomo, che vi si abbandona; gli s’infiammano gli occhi, gli si altera la voce, gli si gonfiano le gote, gli trema il corpo, e tutto si agita e si dimena convulsivamente. Allora più non sapendo quel che si dica e quel che si faccia, si abbandona ad ingiurie ad oltraggi, a violenze, a percosse e talora a ferimenti, e persino ad uccisioni; insomma non v’ha più alcunché di crudele e di inumano, che nell’impeto dell’ira non osi intraprendere. Guardate quei due uomini che si allontanano dalla città, e chiedono alla foresta un misterioso e funesto ritiro. Eccoli in mezzo al bosco; hanno in mano uno strumento di morte; si scagliano l’un contro l’altro con implacabil furore. Un d’essi vacilla, cade, muore sul colpo; muore nell’atto medesimo del peccato, e l’anima sua vien sepolta negli abissi. Imperocché il duello è un gravissimo peccato, un delitto enorme che, quando non lascia alcuno spazio alla penitenza, Dio non imo più perdonare al di là della vita presente. E quale è stata l’origine di quella dannazione, adesso consumata per l’intera eternità? Un risentimento, uno sfogo di collera, un’ingiuria. Oh quanto è vero che la collera è come scintilla di fuoco lanciata in un mucchio di steppe; la quale se non si soffoca sull’istante, s’apprende e si dilata spaventosamente, né più s’arresta se non quando l’incendio ha cagionato le più gravi rovine. – Ma quali sono le cause della collera? Esse sono varie: la perdita del timor di Dio e della fede; una cattiva educazione e principii perversi avuti fin dall’età giovanile; gli eccessi del giuoco, della gola e della dissolutezza; ma la principale è l’orgoglio. Il che spiega perché non vi ha vizio, che tanto si cerchi di scusare quanto la collera. – Provenendo esso il più delle volte dalla superbia, difficilmente s’incontra chi voglia darsi torto; anzi pretendesi persino aver ragioni d’incollerire. Il mio carattere è così fatto, si dice; non posso contenermi; i compagni, i servi, i maestri son la cagione delle mie escandescenze. Son stato provocato, aizzato, tirato pe’ cappelli… Di questo modo si va accusando gli altri, fuorché il vero colpevole, che è colui stesso, che va in collera. Se adunque vogliamo impedire in noi le vampe dalla collera, dobbiamo gettare acqua sul fuoco della superbia, considerando frequentemente il nulla, che noi siamo, e la miseria e la colpevolezza, di cui siamo ripieni. Chi si umilia a riconoscersi per quello che è, non può essere che tanto facilmente si adiri nell’essere contrariato e ben anche insultato, perché riconoscerà altresì che per i suoi peccati merita quello e peggio. Ma oltre al combattere la nostra superbia bisogna pure combattere direttamente la nostra collera. A tal fine bisogna abituarsi per tempo a dominarla, col resistere ai suoi primi assalti; quando si è alterati bisogna vegliare sulle nostre parole, porre alle nostre labbra una prudente custodia; bisogna esercitarsi nella cristiana dolcezza, virtù che per Iddio ci fa sopportare le contraddizioni, che ci accadono, che frena ogni vivacità e i risentimenti, che ci possono eccitare la collera, che impedisce di dar segno alcuno di acrimonia e d’impazienza, e di lasciar sfuggire parole di lamento o di disprezzo, che fa aver sempre un’aria modesta, usar contegno verso certe persone d’indole difficile e cercare di guadagnarle mediante la compiacenza. E questa sarà la virtù che adornerà il nostro cuore, se ci studieremo di ridurre spesso alla memoria la dolcezza e la mansuetudine di Gesù Cristo. Oh! se ai patimenti del Redentore, scrive S. Ambrogio, si volge la mente, niente sembrerà sì penoso, che non si sopporti pazientemente.
3. Infine il divin Maestro conchiude il Vangelo d’oggi dicendo: Se adunque tu stai per fare l’offerta all’altare, e ivi ti viene alla memoria che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te: posa lì la tua offerta davanti all’altare, e va a riconciliarti prima col tuo fratello, e poi ritorna a fare la tua offerta. Vedete, o miei cari, come egli ama la carità, l’unione tra i fratelli, l’affetto che dobbiamo avere gli uni per gli altri! Egli esige che s’interrompa il culto che gli vien reso, il sacrifizio che gli si offre, per compiere il gran dovere della riconciliazione. Questa riconciliazione tra i fratelli offesi è il sacrifizio più gradito, che gli si possa offrire. I donativi più ricchi per lui non valgono l’adempimento di questo sacro dovere. Che pensare adunque di coloro che lasciano ogni giorno tramontare il sole sopra di un’offesa? che pensare di quelli che passano lunghi anni curvi sotto il peso dell’odio? Che pensar di quelli che vengono, non già solo ad assistere al santo Sacrifizio, ma ad inginocchiarsi alla sacra mensa col risentimento nell’animo? Possono eglino fare delle buone Comunioni? possono essere graditi a nostro Signore? No, non è possibile. Poiché se Gesù ci comanda di lasciar l’altare nell’ora del sacrificio per andare a riconciliarci col nostro fratello, a più forte ragione ci proibisce di accostarci alla sacra mensa, prima d’aver adempiuto al debito della riconciliazione, e più grave altresì sarebbe il nostro mancamento facendo diversamente da quello, che Egli esige da noi. Un tempo, prima di presentarsi all’altare per ricevervi il pane degli Angeli, i fedeli si davano a vicenda nella chiesa il bacio di pace. Deliziosa immagine della carità, che li univa gli uni agli altri! Quindi ancor noi ci guarderemo ben bene dal contristare ed offendere chicchessia volontariamente e senza motivo; tratteremo i nostri simili con la mansuetudine che ci comanda Gesù, il qual era mite ed umile di cuore; ma se qualcuno ci avesse in qualche modo offesi, con una generosità al tutto cristiana tosto gli perdoneremo, specialmente perché il Signore per questo riguardo gradisca le nostre preghiere, i nostri sacrifici, le nostre Comunioni in odore di soavità. E non è forse questo generoso perdono, che Gesù Cristo ci predica col suo esempio nello stesso SS. Sacramento dell’Eucaristia? Nessuno potrà ridire quanti affronti, quanti insulti abbia ricevuto e riceva tuttora in questo SS. Sacramento e dagli infedeli, che non lo credono, e dai Cristiani che non lo temono; eppure sempre pazienta, perdona, e fa del bene ai suoi offensori. Se pertanto vogliamo gloriarci di essere somiglianti a Dio ed al suo Divin Figliuolo Gesù, dobbiamo anche noi perdonare volentieri a chi ci ha offesi ed anzi portargli affetto e fargli del bene. Epperciò se abbiamo ricevuto una qualche ingiuria, dimentichiamola tosto e mettiamoci subitamente a trattare con la stessa benevolenza di prima colui, che ce l’ha arrecata. Non sia mai, o cari Cristiani e cari giovani, che coviamo nel cuor nostro del rancore e dell’odio verso qualcuno. Che se poi ci fosse accaduto di essere stati noi gli altrui offensori, diamoci tosto premura di placare la persona offesa chiedendole in bel modo scusa del nostro mancamento a suo riguardo, ancorché ciò dovesse costarci un grande sacrificio nel vincere la nostra ripugnanza. Allora è certo che Iddio pieno di bontà e di misericordia accoglierà commosso le nostre preghiere, gradirà le nostre pratiche devote e sopra tutto le nostre Comunioni, in cui Egli, dimentico delle nostre passate colpe, ci darà l’amplesso di pace e di amore, pegno certo e caparra sicura di quello, col quale ci terrà poi a Lui uniti per tutta l’eternità.
Credo …
Offertorium
Orémus
Ps XV: 7 et 8. Benedícam Dóminum, qui
tríbuit mihi intelléctum: providébam Deum in conspéctu meo semper: quóniam a
dextris est mihi, ne commóvear. [Benedirò il Signore che mi
dato senno: tengo Dio sempre a me presente, con lui alla mia destra non sarò
smosso.]
Secreta
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris: et has oblatiónes
famulórum famularúmque tuárum benígnus assúme; ut, quod sínguli obtulérunt ad
honórem nóminis tui, cunctis profíciat ad salútem. [Sii propizio,
o Signore, alle nostre suppliche, e accogli benigno queste oblazioni dei tuoi
servi e delle tue serve, affinché ciò che i singoli offersero a gloria del tuo
nome, giovi a tutti per la loro salvezza.]
Communio
Ps XXVI: 4 Unam pétii a Dómino, hanc requíram: ut
inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus vitæ meæ. [Una cosa
sola chiedo e chiederò al Signore: di abitare nella casa del Signore tutti i
giorni della mia vita].
Postcommunio
Orémus.
Quos cœlésti, Dómine, dono satiásti: præsta, quæsumus; ut a
nostris mundémur occúltis et ab hóstium liberémur insídiis.
Per l’ordinario vedi:
ORDINARIO DELLA MESSA – ExsurgatDeus.org