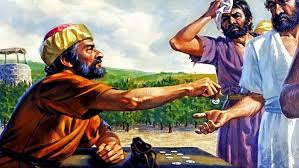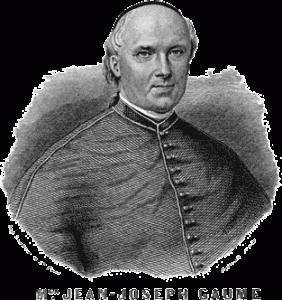
Mons. J. J. Gaume:
IL TRATTATO DELLO SPIRITO SANTO, VOL. I
[vers. Ital. A. Carraresi, vol. I, Tip. Ed. Ciardi, Firenze, 1887; impr.]
CAPITOLO XXIV.
(seguito del precedente.)
Numa, scimmia di Mosè — Nuovo tratto di parallelismo: lo Spirito Santo, custode permanente delle leggi sociali della Città del bene — satana, sotto la forma del serpente, custode permanente delle leggi sociali della Città del male — serpente-dio, adorato dappertutto: in Oriente, a Babilonia, in Persia, in Egitto, in Grecia; le Baccanti ad Atene, in Epiro, a Deio e a Delfo: descrizione dell’oracolo di Delfo — A Roma, i serpenti di Lavinium — Il serpente d’Epidauro nell’isola del Tevere — Culto del serpente nelle Gallie e presso i popoli del Nord — Universalità di questo culto nell’antichità pagana — Sua cagione — I serpenti del tempo d’Augusto — Le vestali — Serpenti di Tiberio, di Nerone, d’Eliogabalo — Delle signore Romane.
Per ciò che risguarda l’ispirazione delle leggi nella futura capitale della Citta del male, niente manca alla parodia del Sinai. Ella va continuandosi nella loro promulgazione, come pure nella sua presenza sensibile e permanente del legislatore primitivo, in mezzo al suo popolo, tanto per assicurarne l ‘osservanza, quanto per darne l’autentica interpretazione. Ognun sa con quale apparato di cerimonie religiose, di sacrifici, di purificazioni solenni, Mosè proclamasse la legge ricevuta dal cielo nel misterioso colloquio della montagna. Ei non agì per altro modo che mediante l’ispirazione divina. Il suo scopo evidente era di rendere la legge rispettabile, facendola ricevere con una sottomissione religiosa, e praticare con una fedeltà costante. Numa ispirato da satana, ricorre agli stessi mezzi. Per farsi accettare dai Romani, egli e le sue leggi, lo vediamo, secondo Plutarco, servirsi dell’aiuto degli dei, di solenni sacrifici, di feste, di danze e processioni frequenti, che celebrava egli stesso; nelle quali oltre alla devozione vi era del passatempo misto al diletto. Qualche volta metteva dinanzi ai loro occhi degli spauracchi di dei, dando loro ad intendere che aveva visto qualche strana visione, o che aveva udito delle voci, con le quali gli dei gli minacciavano di qualche grande calamità, per sempre abbassare i loro cuori sotto il timore dei medesimi. Cosi pure, Numa dava ad intendere che era amato da non so quale dea o ninfa alpestre; ch’ella teneva con esso lui segreto commercio, come si è detto; e che egli conversava con le Muse, e aveva con esse reciproca corrispondenza, e però egli riferiva alle Muse la maggior parte delle sue rivelazioni.(Vita di Numa, come sopra, p. 236). » Che Numa abbia fatte tutte queste cose, niuno lo pone in dubbio. Ma che tutte queste cose non siano altro che una ciurmeria, come Plutarco sembra insinuare, è un’altra questione. Prima di tutto Varrone, il più dotto dei Romani, e sant’Agostino il più dotto dei Padri della Chiesa, affermano positivamente il contrario. Quindi, Plutarco non offre nessuna prova del suo asserto; e finalmente egli stesso si contradice. Non ha egli in una opera ben nota, proclamato la verità degli oracoli? Forse non è altro che una ciurmeria della quale nessuno si è accorto? Ma come mai questa stessa ciurmeria si rinviene presso tutti i popoli? E come tutti i popoli hanno preso una ciurmeria per una realtà? Risolvere queste questioni in un senso non cattolico, è negare la storia e la Rivelazione. Ma negare la storia e la rivelazione è negare la luce, e condannarsi all’abbrutimento. – Passiamo ad un altro tratto di parallelismo. Il Signore non si contenta di dare la sua legge. Egli medesimo se ne fa il custode e l’interprete. Sotto questo aspetto egli rimane in mezzo al suo popolo in un modo sensibile e permanente. Israele sa che vi è, come custode invisibile ma vigilante, un oracolo sempre pronto a rispondere. Se in qualche materia sorge una seria difficoltà, se ne domanda al Signore la soluzione. Occorre dare l’assalto ad una città, intraprendere una guerra, segnare un trattato? a lui pure s’indirizzano. Egli stesso indica i mezzi per ottenere il successo, per fargli i rendimenti di grazie, ed i castighi da infliggere ai violatori della sua legge. – Il serpente legislatore imita tutto ciò nella Città del male. Egli è il custode e l’interprete della sua legge, come Jehovah della sua. Come il Dio del Tabernacolo e del Tempio ricorda sempre con la sua terribile maestà, il Dio del Sinai, cosi satana con la forma sensibile sotto la quale si mostra, tiene a ricordare il vincitore del paradiso terrestre. Pronto sempre a rendere oracoli, egli ispira a quando a quando, il timore e la confidenza, decide della pace e della guerra, indica i mezzi di successo, e segna i sacrifici per rendimento di grazie, o d’espiazione ch’egli esige. Il suo popolo lo sa: e, nelle circostanze importanti, non manca di ricorrere a lui per ottenere lume e protezione. La filosofia dell’istoria dei popoli pagani è scritta in questi versi. Alla catena aggiungiamo la trama, ed avremo il tessuto completo. Fra tutti i fatti strani, consegnati negli annali del genere umano, non sappiamo se ve ne sia uno più strano di quello che noi stiamo per raccontare. Oltre le mille differenti forme sotto le quali i popoli pagani, tanto antichi che moderni, hanno onorato il demonio, tutti lo hanno adorato sotto la forma privilegiata del serpente, serpente vivo, serpente in carne e ossa, serpente che rende oracoli; e ciò non una volta, ma sempre. Lo vedemmo già; per i popoli dell’alto Oriente, vicini al paradiso terrestre, i Persiani, i Medi, i Babilonesi, i Fenicii, il Gran Dio, il Dio supremo, il padre delle leggi, l’oracolo della sapienza, era il serpente con la testa di sparviero. A lui i più bei templi, il fiore dei sacerdoti, le vittime scelte, la soluzione delle difficili questioni. I secoli non gli avevano fatto perdere nulla della sua gloria e della sua autorità. A tempo di Daniele il suo culto si era conservato in tutto il suo splendore. Il celebre tempio di Belo, fabbricato in mezzo a Babilonia, serviva di santuario ad un enorme serpente, che i Babilonesi circondavano delle loro adorazioni. (Dan., XIV, 22 e seg.). Sulla sommità di questo tempio di colossali proporzioni, appariva la statua di Rhèa. Questa statua d’oro, fatta a martello, pesava cento talenti, 31 mila kilogrammi circa. Seduta sopra un carro d’oro, aveva la dea ai suoi ginocchi, due leoni, e accanto a lei due enormi serpenti d’argento, ciascuno dei quali pesava trenta talenti, cioè 330 kilogrammi. (Diodoro di Sicilia, Ist., lib. XI, c. IX) Queste mostruose figure annunziavano di lontano la presenza del serpente vivo, e la gigantesca idolatria della quale era l’oggetto. – Per gli antichi Persi, il gran dio era il serpente con la testa di sparviero. Ora adorato come genio del bene, e ora come genio del male; sotto quest’ultimo aspetto era la causa di tutti i mali dell’umanità. La tradizione gli dava il nome d’Arimane. Questo mostro dopo aver combattuto il cielo, sorge sulla terra alla testa di una turba di geni malefici, sotto la forma di serpente; ricopre la faccia del mondo di animali velenosi, e s’insinua in tutta la natura. Le tradizioni cinesi fanno risalire l’origine del male alla istigazione di una intelligenza superiore, ribellata contro Dio e rivestita della forma del serpente. Tchi-seou è il nome del drago. Finalmente, allorché il Giappone ci dipinge la scena della creazione, prende immagine di un albero vigoroso, intorno a cui si avvolge un serpente. (G. di Mousseaux, Gli alti fenomeni dellct magìa, Parigi, 1864, in-8, p. 45). – L’Egitto ci offre, tratto tratto, lo stesso Dio. e lo stesso culto. « Il simbolo di Cnoufi, ossia l’anima del mondo, dice il signor Champollion, è dato sotto la forma di un enorme serpente, montato su gambe umane, e questo rettile, emblema del buon genio, il vero Agathodæmon è spesso barbuto. Accanto a questo serpente i monumenti egiziani portano l’iscrizione: dio grande, dio supremo, signore della regione suprema. 2 »2 (Panth. egypt., testo 3 e lib. II, p. 4). Molto prima di Champollion, Eliano, parlando della religione degli Egizi, aveva detto: « Il serpente venerabile e sacro, ha in sé qualche cosa di divino; e non è bene trovarsi in sua presenza. Così a Meteli in Egitto, un serpente abita una torre, dove riceve gli onori divini. Egli ha i suoi sacerdoti ed i suoi ministri, la sua tavola e la sua tazza. Ogni giorno versano nella sua tazza dell’acqua di miele, mescolata con farina, e si ritirano. Il giorno appresso essi ritrovano la tazza vuota. « Un giorno, il sacerdote più anziano, spinto dal desiderio di vedere il Drago, entra solo, mette la tavola del nume, ed esce dal santuario. Arriva tosto il Drago, sale sulla tavola e fa il suo pasto. Tutto ad un tratto il sacerdote apre, facendo rumore, le porte, che secondo l’uso aveva avuto cura di chiudere. Il serpente scorrucciato si ritira; ma il sacerdote avendo visto per sua disgrazia, quegli che desiderava vedere, diventa pazzo. Dopo aver confessato il suo delitto, perde l’uso della parola e cade morto. » (Aelian., De natur animal. lib. XI, c. XVII, ediz. Bidot, 1858). – Il celebre papiro Anastasi, recentemente scoperto in Egitto, conferma le asserzioni di Eliano, di Clemente Alessandrino e di Champollion. Esso dice: « Non bisogna invocare il gran nome del serpente altro che in una assoluta necessità, e quando non si ha nulla a rimproverarsi. Dopo alcune formule magiche, entrerà un dio con la testa di serpente che darà i responsi. » Che il demone possa dare la morte, basta a provarlo il ricordare nella sacra antichità l’esempio dei figli di Giobbe; nell’antichità profana, il passo dove Porfirio confessa che il dio Pane, quantunque fosse buono, appariva sovente ai coltivatori in mezzo ai campi, e che un giorno ne aveva fatti perire da nove, tanto essi erano stati colpiti di terrore per il suono terribile della sua voce, e per la vista di quel formidabile corpo che con impeto si slanciava. » (Apud Euseb Prαp. evang lib. I, c. VI. – La testimonianza che abbiamo citata del vescovo di Mantchouria, conferma che presso i moderni pagani, Satana non ha niente perduto della sua autorità omicida. Quanto a quel sacerdote fulminato per aver visto il suo Dio, ricorda in un modo così vivo, la proibizione di Jehovah, e la morte dei Bethsamiti che basta soltanto fare osservare la parodia l’usurpatore della divinità ha la sua arca dell’alleanza; ei vuole esservi rispettato come Jehovah nella sua: e nome Jehovah, punisce di morte il temerario che osa alzare gli occhi su di lui. Quel terribile santuario non era in Egitto la sola abitazione del serpente. In quel paese di primitiva idolatria, non si vedevano che serpenti adorati o familiari. I loro templi s’innalzavano in tutti i punti del territorio. Ivi, come a Babilonia si nutrivano con cura, si adoravano, e si consultavano. Gli egizi gli custodivano nelle loro case, gli guardavano con piacere, gli trattavano con deferenza e gli chiamavano a prender parte ai loro pasti. « In nessun luogo, dice Filarco, il serpente era stato adorato con tanto fervore. Nessun popolo mai ha uguagliato l’egizio nell’ospitalità data ai serpenti. » (Apud Aelian. lib. XVII, c. V). Per conseguenza il serpente entrava nell’idea o nella rappresentazione di ogni autorità divina ed umana. « Come segno di divinità, dice Diodoro siculo, le statue degli dei erano circondate da un serpente; lo scettro dei re, in segno di regia potestà; le berrette dei sacerdoti, in segno di potestà divina. » (lib . V) Le statue di Iside, particolarmente, erano coronate di una specie di serpenti di nome thermuthis, che si consideravano come sacri, ed ai quali rendevansi grandi onori. [Panth. egypt., di Champollion, lib. II, p. 4 — Vedi in questa opera, la rappresentazione degli dei egiziani.]. – Secondo gli egizi, questi serpenti erano immortali, servivano a discernere il bene dal male; si mostravano amici della gente dabbene, e non davano la morte che ai cattivi. Non eravi angolo del tempio, ove non vi fosse un piccolo santuario sotterraneo destinato a questi rettili, che venivano nutriti con del grasso di bove. [Aelian.,De natur. Animal. lib. X, c. xxxi ; e Diod. Sicul., ubi supra]. Di qui quelle parole così note di Clemente Alessandrino: « I templi egizii, i loro portici ed i loro vestiboli sono magnificamente costruiti; le corti sono circondate di colonne; marmi preziosi e brillanti di vari colori ne adornano le mura, di modo che tutto è confacente. I piccoli santuarii rifulgono per lucentezza d’oro e d’argento d’electron, pietre preziose dell’India e dell’Etiopia: tutti sono ornati di tende tessute d’oro. Ma se voi penetrate nel fondo del tempio e vi vien voglia di cercare la statua del nume al quale é consacrato, un pastoforo o qualche altro inserviente del tempio, si avanza con un’aria grave cantando un paean in lingua egizia, e solleva alquanto il velo come per mostrarvi il nume. Che cosa vi vedete voi? Un gatto, un coccodrillo, un serpente! Il dio degli Egizi comparisce…. è una bestia spaventevole che si rotola sopra un tappeto di porpora. » [Champollion, ibid.]. – Il dotto filosofo avrebbe potuto aggiungere: un caprone. Difatti satana aveva condotto l’umanità sino all’adorazione di questo immondo animale, sotto i nomi diversi di fauno, di satiro, di becco, di peloso, pilosi, come lo appella la Scrittura. « Il culto del capro, dice il dotto Jablonski, non era speciale alla città egiziana di Mendès; tutto l’Egitto lo osservava, e tutti gli adoratori avevano presso di sé il ritratto più o meno fedele al loro dio. Il suo domicilio principale lo aveva anche a Mendès, prefettura della quale egli era il dio tutelare. Il suo tempio vi era grande e splendido, e ivi soltanto era un becco vivo e sacro. Esso era posto alla pari degli otto grandi numi anteriori ai dodici altri, » Jablonski, Pantheon egiziano, Jib. II, c. VII] e onorato da pratiche che ci asterremo dal descrivere. Come Eliano ce lo insegna, fosse gatto, capro, o coccodrillo, il dio principale era sempre accompagnato da un corteggio di serpenti. L’Egitto era dunque appunto la terra del serpente. Esso regnava tanto sulla vita pubblica che sulla vita privata, con una potenza, della quale il Cristianesimo ci ha messo nella felice impossibilità di misurare l’estensione. Sarebb’egli superfluo l’attribuire i prestigi eccezionali, riferiti nella Scrittura, a quelle relazioni più consuete e più intime che in nessun altro paese, dei medium egiziani col terribile padre della menzogna? Poiché è certo che il paganesimo occidentale è venuto dal paganesimo orientale, non ci dovremo meravigliare se troviamo il culto solenne del serpente nella Grecia, nell’Italia ed anche presso i popoli del Nord. E qual culto, gran Dio! Nei baccanali aveva per iscopo di celebrare l’alleanza primitiva del serpente con la donna. Ascoltiamo Clemente d’Alessandria: « Nelle orge solenni in onore di Bacco, i sacerdoti che si direbbero punti da un estro furibondo, strappano carni palpitanti, e coronati di serpenti, invocano Èva con urla acutissime, Èva che prima aprì la porta all’errore. Ora, l’oggetto particolare dei culti bacchici, è un serpente consacrato da riti segreti. Perciò, se volete sapere proprio il significato della parola Èva, voi troverete che pronunziato con una forte aspirazione, Beva vuol dire serpente femmina. » [Cohortat. Ad Gentes, c. II]. – Questa alleanza di continuo ricordata, celebrata, figurata, compiuta nella iniziazione ai misteri di certi culti, era cantata dalla poesia, e raccontata dalla storia, che non ardiva rivocarla in dubbio, né in sé medesima, né nelle sue conseguenze. Siccome non v’è niente di nuovo sotto il sole, e che la religione di satana ha sempre lo stesso fine, si può affermare che è nel contrattarla, che le giovinette divenivano nell’antichità pagana, come oggi in Africa, sacerdotesse del serpente. [Arnob., lib. V; …Vedi Boettiger, Sabina t. I, p. 454; xx, 2, 15, 16; e num. xxv, 2; e Lamprid. in Adrian]. Qualunque si fossero queste infamie, indicate qui per ricordare al mondo l’indicibile degradazione a cui satana aveva condotto l’uinanità pagana; l’infinita riconoscenza che dobbiamo al Verbo redentore, e la profonda capienza della Chiesa nelle sue prescrizioni antidemoniache; la venerazione, di cui l’odioso rettile godeva tra i Greci, era tale che Alessandro si faceva gloria d’averlo avuto per padre. Infatti le sue medaglie lo rappresentano sotto la forma di un fanciullo che esce dalla gola di un serpente. [Camer., Medit. Mst., p. n, c. ix, p. 81. — Vedi intorno a questo fatto curiosi particolari in Plutarco, Vita Alexand.]. Nessuno animale ha ottenuto in Grecia gli onori divini, fuorché il serpente. In questa terra, pretesa cuna della civiltà, egli aveva un grande numero di templi. Gli Ateniesi conservavano sempre un serpente vivo, e lo riguardavano come il protettore della loro città: parodia di Jehovah, custode del suo popolo nell’arca dell’alleanza. Essi gli attribuivano la virtù di leggere nell’avvenire. Per questo essi ne nutrivano dei domestici, allo scopo di aver sempre a loro disposizione i profeti e le profezie. [Pausania, lib. II, p. 175, e Dizionario della Favola, art. Serpenti.]. Volendo Adriano continuare con magnificenza questo culto, cosi glorioso per la sapiente Atene, fece fabbricare in questa città un tempio splendidissimo d’oro e di marmo, la cui divinità fu un gran serpente portato dall’India. [Dione, in Adriano]. Abbiamo dunque avuto ragione di dirlo, né cesseremo di ripeterlo, che nei bei giorni della Grecia, ed altresì a tempo d’Adriano, la civiltà d’Atene, la metropoli dei lumi, almeno nei collegi, era inferiore alla civiltà di Haiti, dove si condanna a morte come ben tosto vedremo, gli adoratori del serpente. Secondo Plutarco, il culto del serpente era osservato nella Tracia, sino al delirio, dagli Edonesi. « Olimpia, dice egli, madre di Alessandro, emulando più ancora delle altre quelle invasioni di spirito divino, e portandosi con maniera più barbarica in quegli entusiasmi, traeva nelle sacre solennità grandi serpenti resi ammansiti, i quali spesse volte strisciando fuori dell’ellera ed i mistici canestri, e rivolgendosi intorno ai tirsi delle femmine ed alle ghirlande, sbigottivano gli uomini. » [Vita di Alessandro, traduzione del Pompei, t. III, p. 292]. Le loro grida erano la continua ripetizione di quelle parole : Evoe, sapoe, flues, altis. Presso gli Epiroti, l’orribile rettile godeva degli stessi onori e della stessa fiducia. Il suo santuario era un bosco sacro, circondato da muri. Una vergine era la sua sacerdotessa. Essa sola aveva accesso nel terribile recinto. Essa sola poteva portare da mangiare agli dei e interrogarli sull’avvenire. Secondo la tradizione del paese questi serpenti erano nati dal serpente Pitone, signore di Delfo. [V. Dizionario della Favola e secondo V opera ; Dio e gli dei, v. I, del Cavaliere Desmousseaux]. A Deio, Apollo era adorato sotto la forma di un drago che rendeva durante l’estate oracoli senza ambiguità. A Epidauro, il dio Esculapio era un serpente. Lo si credeva padre di una razza di serpenti sacri, la cui colonie epidauriche avevano cura di involare con esse un individuo che installavano nel nuovo loro tempio. [Aelìan.j lib. XI, c. II]. – Che sino dalla più remota antichità vi fosse stato a Delfo un mostruoso serpente tenuto per un dio, è ciò che affermano i primi abitanti del paese. Ancorché secondo la favola questo serpente fosse stato ucciso da Apollo, rimane pur sempre, che Delfo era divenuto il più celebre luogo fatidico dell’antico mondo. Sotto una forma o sotto un altra, l’antico serpente vi regnava da padrone, e di là su tutta la Grecia e sopra una gran parte dell’Occidente. Era tale la fiducia ch’egli ispirava, che le città greche ed anche i principi stranieri, mandavano a Delfo i loro più preziosi tesori, e gli ponevano in deposito sotto la protezione del dio rettile. Per un nuovo insulto a Colei che doveva un giorno schiacciargli il capo, a Delfo come in Epiro, a Lavinium e dapertutìo, satana voleva una vergine per sacerdotessa; e come la trattava! Essendo da prima giovine, dové più tardi, a causa della lubricità degli adoratori, essere di un età matura. Allorché il Nume voleva parlare, le foglie di un lauro piantato davanti al tempio si agitavano; lo stesso tempio tremava sin nelle fondamenta. Dopo aver la Pitia bevuto alla fonte di Castalia, condotta dai sacerdoti entrava nel tempio e si avanzava verso l’antro, che era rinchiuso nel tremendo santuario. Parecchi autori hanno scritto che quest’antro era sempre abitato da un serpente, e che nel principio, è lo stesso serpente che parlava. [Gran dizionario della Favola, art. Serpenti.]. L’orifizio sosteneva il famoso tripode, ch’era una macchina di rame composta di tre sbarre, sulla quale Pitia si poneva nel più indecente modo, a fine di ricevere il soffio profetico. [S. J. Chyrs., in Ep. I ad Cor.,homil. xxix, n. 1]. Tosto si spandeva qualcosa di misterioso nelle sue viscere, e il movimento fatidico cominciava. L’infelice figlia d’Èva non era più padrona di se medesima e dava tutti i segni d’essere invasa. I suoi capelli si rizzavano; la sua bocca schiumava, i suoi sguardi diventavano truci; un tremito violento s’impadroniva di tutto il suo corpo e si era obbligati a mantenerla per forza sul tripode. Ella faceva risuonare il tempio delle sue grida e delle sue urla. In mezzo a questa straordinaria agitazione essa proferiva gli oracoli, che alcuni copisti scrivevano sopra tavolette. Da questi furori diabolici, resultava spesso la morte della Pitia, la quale per questa ragione, aveva due compagne. La scena infernale che abbiamo descritta aveva luogo tutti i mesi. Essa ha durato dei secoli, è stata vista da milioni d’uomini, tra’ quali figura tutto ciò che l’antichità conosce di più grave e di più illustre. [Lucan. Pharsal,, lib. V ; Virgil., lib. VI : Gran diz. Della Favola, etc., etc. ; Stràb. lib. VIII]. Dietro questo fatto e mille altri dello stesso genere, compiti in tutte le parti del mondo, su qual fondamento porre in dubbio il successo favoloso ottenuto sotto il regno di Marc’Aurelio, operato dal Mago Alessandro di Paflagonia? Discepolo di Apollonio Tianeo, questo medium, percorse, come il suo maestro, differenti provincie dell’impero, mostrando un serpente addomesticato e che faceva mille giri divertenti. Ei lo dette per un dio, e un dio che rendeva oracoli. A questa nuova, si videro gli abitanti dell’Ionia, della Galazia, della Cilicia, degli stessi Romani; e persino Rutulio che comandava l’esercito, accorrere in folla all’oracolo vivente, al Pitone viaggiatore. I suoi responsi gli guadagnarono fede. In queste provincie, come nel rimanente della terra si prostrarono tutti dinanzi al dio serpente; gli offrirono olocausti e doni preziosi; gli innalzarono perfino statue d’argento. L’imperatore medesimo volle vedere il nume: Alessandro fu mandato alla corte dove fu ricevuto con grandi onori. [Luciano, in Pseudomate.]. Non solo i Greci tanto vantati per la loro filosofia, ma anche i Romani padroni del mondo, non poterono sfuggire alla dominazione dell’odioso rettile. Sin dall’origine essi hanno adorato il dio serpente, ed i loro omaggi non si sono smentiti. [Proper., ffleg. in Oynthia]. II loro padre Enea fondò presso Roma una villa per nome Lavinium, che può appellarsi l’ava di Roma. Poco distante da Lavinium vi era un bosco sacro, vasto ed oscuro, dove in una profonda caverna abitava un gran serpente. [In Lavinia, oppido Latinorum, quae quidem Roma voluti avia nominari posset…. Prope Lavinium igitur est lucus magnus et opacus. In luco autem latibulum est, ubi draco, etc. Aelìan., lib. XI, c. xvi]. Ancor qui erano giovinette, sacerdotesse di questo dio. Quando esse entravano per dargli, da mangiare, le si bendavano gli occhi; uno Spirito divino le conduceva dirittamente alla caverna. Se il serpente non mangiava le focacce, era una prova che la fanciulla che le aveva presentate aveva cessato d’esser vergine, e veniva spietatamente messa a morte. [Ibid.]. – Come se il culto perpetuo del serpente indigeno non avesse bastato, i Romani, in difficili circostanze, ricorrevano ad un serpente straniero reputato più potente. Còsi nel 401 essendo la loro città da tre anni di seguito desolata da una peste, la cui strage non riusciva ad arrestare, essi consultarono i vecchi libri sibillini, inspectis sìbjllinìs libris. Fu trovato che l’unico modo di far .cessare il flagello era di andare a cercare Esculapio, a Epidauro e di condurlo nella città. Per conseguenza venne allestita una galea ed una deputazione, la quale condotta da Quinto Ogulnio si recò ad Epidauro. Quando ebbero i deputati presentato la loro istanza, un gran serpente uscì dal tempio, si mise a passeggiare nei punti più frequentati della città con occhi dolci e con un passo calmo, in mezzo all’ammirazione religiosa di tutto il popolo. Lo storico Romano continua: « Spinto ben tosto dal desiderio di occupare il celebre santuario che era a lui riserbato, il nume affrettò il suo cammino e sali sulla galea romana. Egli scelse per sua dimora la stessa camera di Ogulnio, si avvolse in tanti cerchi e si abbandonò alle dolcezze di un profondo riposo. I Romani che l’avevano ricevuto con un rispetto misto a spavento, lo condussero a Roma. La galea avendo approdato sotto al Monte Palatino, il serpente si lanciò nel fiume che attraversò a nuoto, e venne a riposarsi nel tempio a lui preparato sull’isola del Tevere. Appena che il nume fu nel suo santuario la peste scomparve. [Valer, Maxim,, De Miracul., lib. I, c. vm , n° 2, ediz. Lemaìre, Parigi, 1832. — Le parole d’Aurelio Vittore non sono meno esplicite, et pestilentia mira celeritate sedata est]. Lattanzio conferma il racconto di Valerio Massimo, e ammette la scomparsa subitanea della peste attribuendo senza alcun dubbio all’influenza di un potente demonio, sotto la forma del serpente di Epidauro. [De Divin. Institi., lib. II, c. 17]. – Il primo popolo del mondo, la grande repubblica romana che manda una solenne ambasciata al serpente: quale eloquenza in questo sol fatto, e qual luce sinistra getta esso sull’antichità pagana! Anche all’epoca della storia romana, decorata nei collegi del nome del Secolo d’oro, il culto dell’odioso rettile non aveva perduto niente del suo splendore né della sua popolarità; tutto il contrario. Il serpente era dappertutto onorato nei templi del nume, nel palagio degli imperatori, nello spogliatoio delle matrone, nelle case dei semplici privati. Attia, madre di Augusto, essendo venuta a metà della notte a dormire nel tempio d’Apollo, secondo l’uso praticato nei templi dove si rendevano oracoli mediante sogni, fu tocca dal Nume sotto la forma di un serpente. Il suo corpo rimase segnato della figura indelebile di questo animale, in modo che ella non osò più mostrarsi nei pubblici bagni: Dietro questo fatto, Augusto si pretese figlio di Apollo, e volle che le sue medaglie perpetuassero la memoria di questa gloriosa discendenza.2 [Sveton., in Aug., c. XCIV. — Nel rovescio delle sue medaglie Augusto fece incidere Apollo con questa iscrizione: Cassar divi fitius., — Noi l’abbiamo visto coi nostri occhi.]. – Le vestali non avevano soltanto la custodia del fuoco sacro; erano esse specialmente incaricate di allevare un serpente sacro, venerato come il genio tutelare della città di Roma. Esse gli portavano il suo nutrimento tutti i giorni, e gli preparavano un gran banchetto ogni cinque anni. Queste vergini pagane, avevano altresì sotto la loro custodia un altro idolo, che il pudore non permette di nominare: idolo infame che si traeva dal tempio di Vesta i giorni di trionfo, per appenderlo al carro dei trionfatori. Di modo che il fine di satana era di condurre la povera umanità all’ultimo grado della crudeltà e della impudicizia. Ei l’aveva raggiunto, e poi ci vengono a parlare della bella antichità! [Paulin, adv. Pagan., v. 143; Doellinger, Paganesimo e giudaismo, Trad. fr. in-8°, t. i, p. 105 – Tertull, ad Uxor., lib. I, e. vi, p. 325, ediz. Pamel. in-fol;
id. de Monogam, sub. fin. – Plin. Hist. xxviii, c. vii, n. 4.— Vedi altresi Culto del fallo e del serpente, del dott. Boudin. in-8, Parigi, 1864]. – Eliogabalo non faceva nulla di nuovo, nulla che fosse di natura da sorprendere i Romani, ancor meno da urtarli, allorché egli fece portare a Roma dei serpenti egizi, a fine di adorarli come buoni genii. [Aegiptios dracunculus Romae habuit quos illi agathodæmenes appellant. Lamprid. in Heloogàb., p. I li, ediz. in-fol.]. – Tiberio aveva il suo serpente familiare che lo seguitava dappertutto, e ch’egli nutriva da sé medesimo con le sue proprie mani, manu sua. Mentre se ne stava ritirato a Capua, gli saltò in capo di rivedere Roma: non era distante che sole sette miglia da quella capitale, allorquando chiede del suo serpente per dargli da mangiare, quum eco consuetudine manu sua cibaturus. Ora il serpente era stato divorato dalle formiche, e l’oracolo consultato, avendo dichiarato questo accidente di cattivo augurio, l’imperatore prese il partito di ritornare immediatamente a Capua. [Sveton, in Tiber., c. 72]. – Nerone portava come talismano una pelle di serpente legata intorno al braccio. [Camerar., ubi supra]. Che più? « Parecchie medaglie di Nerone, dice Montfaucon, attestano che questo principe aveva preso il serpente per patrono, » [Àntic. spiegata, lib. I] e aggiungasi, per protettore. Così a Roma, sotto le mura della casa d’oro di Nerone, il viaggiatore legge ancora l’iscrizione che minaccia della collera del serpente, chiunque si permettesse di fare delle sozzure presso la reggia imperiale. [in Sveton., c. 72. id. in Neron., c. v.7 n. 6]. – Dietro l’esempio degl’imperatori, le signore romane avevano esse pure dei serpenti domestici. Ora se li passavano attorno al collo a guisa di collane, ora esse scherzavano con questi rettili, che durante il desinare gli montavano addosso e si introducevano nel loro seno. In questa familiarità col serpente, gli uomini galanti imitavano le donne.1 [Senec., De ira, xi, c. 31]. – Le provincie imitavano la capitale. A Pompei si vedono tuttora i santuari degli dei tutelari delle vie, chiamati Lares compitales. Gli affreschi rappresentano i sacrifici offerti a quelle divinità. Ora quasi dappertutto queste divinità sono due serpenti che ingoiano vivande confacenti. Babilonia e Pompei si rassomigliano. L’oriente e l’Occidente osservano lo stesso culto. Nella stessa città, sulle muraglie dei Pistrinæ, luoghi dove si manipola la pasta per fare il pane, è dipinto il sacrificio alla dea Fornax. La scena è coronata da due serpenti che rappresentano una cosi gran parte tra le divinità di Pompei. L’immagine della divinità favorita si rinviene persino negli ornamenti muliebri. Noi abbiamo contato un numero grandissimo di braccialetti d’oro in forma di serpenti, dei quali le signore di Pompei si ornavano le braccia ed i polsi. – Nelle Gallie, i Druidi portavano degli amuleti di pietra rappresentanti un serpente. Il culto dell’odioso rettile vi era talmente diffuso, che i primi missionari del Cristianesimo ebbero a combattere, come abbiamo visto, Draghi mostruosi, terribili divinità del paese. Ai fatti già citati aggiungiamo il seguente: Sant’Armentario arrivando nel Varo, fu obbligato a combattere un Drago. Il luogo del combattimento si chiama ancora il Drago, e lo stesso combattimento ha datò il suo nome alla città di Draguignan. Secondo le circostanze ed il genio dei popoli, il Padre della menzogna, sotto la forma preferita del serpente, si è manifestato come una divinità benefica o come un dio malefico. L’amore, o il timore hanno incatenato l’uomo ai suoi altari. Di qui quella giudiziosa osservazione del dotto Sig. De Mirville. « Il serpente! Tutta la terra lo incensa o lo lapida. » [Pneumatalog. 11, mem., t.II p. 431]. – I Lituani, i Samogizi ed altri popoli del Nord, non erano meno fedeli adoratori del serpente; lo chiamavano specialmente a santificare la loro mensa. In un canto delle loro capanne come nei templi dell’Egitto, erano mantenuti dei serpenti sacri. In certi giorni si facevano montare sulla tavola per mezzo di un panno bianco che scendeva sino alla loro tana. Assaggiavano tutte le pietanze, quindi rientravano nel loro buco. Così le vivande erano purificate; e i barbari le mangiavano senza paura. [Stuckins, Antiquit cenvivial, lib. II, c. xxxvi, p. 432, in-fol.]. Presso i Lituani particolarmente, il culto del serpente esisteva ancora nel quattordicesimo secolo. Nel 1387 il re di Polonia essendosi recato a Wilna, convocò un’assemblea pel dì delle ceneri. D’accordo con i vescovi che lo accompagnavano, si sforzò di persuadere i Lituani a riconoscere il vero Dio. Per mostrar loro che non era la verità che essi abbandonavano, fece spengere il fuoco perpetuo che si manteneva a Wilna, ed uccidere i serpenti che si custodivano nelle case e che si adoravano come tanti dei. I barbari vedendo che non avveniva alcun male a quelli che eseguivano gli ordini del principe, aprirono gli occhi alla luce e domandarono il battesimo. [Vedi anche Arnnal, di Filos. Crist., dicembre 1857, p. 242, e seguenti]. – Non spingeremo più oltre il nostro viaggio d’investigazione presso i popoli antichi. Notiamo soltanto, che il culto del serpente era cosi universale e così splendido nella bella antichità, che i templi avevano preso il nome di Draconie; il che significa che per designare un tempio, si diceva una dimora di serpenti. [Corn. a Lap., in Dan. xiv. 22.] – Perciò il culto del serpente vivo, del serpente in carne e in ossa, è stato uno dei più difficili a sradicare; ne daremo bentosto la prova. Difatti secondo il concetto di sant’Agostino, il demonio ama di preferenza la forma del serpente, perché essa gli ricorda la sua prima vittoria. [De Gen. ad Litter., lib. XI, n. 35, ediz. Gaume]. Che tutte le nazioni dell’antichità, niuna eccettuata, abbiano pagato al serpente il tributo delle loro adorazioni, è un fatto acquisito alla storia. Per quanto sia strano, non è però meno certo. Ora quando un culto di una cosi evidente identità, si osserva per un cosi gran numero di secoli, in tutte le parti del mondo conosciuto, sotto tutti i climi, presso le nazioni le più differenti di costumi e di civiltà, come non riconoscere che le condizioni di razza sono senza influenza sulla religione dei popoli? Come non riconoscere che è la religione dei popoli che genera la loro civiltà ed i loro costumi, invece d’essere prodotta da quest’ultimi; lo che non si teme di ripeterlo ogni giorno? In una parola, come mai non riconoscere la verità di questo assioma:
Dimmi ciò che tu credi, ed io ti dirò quello che tu fai!