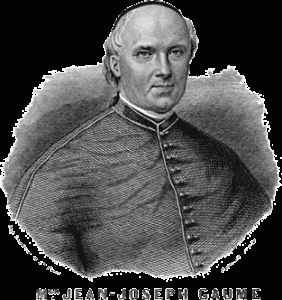LIBRO III.
La persona del Redentore (1)
[F. Pratt: La teologia di San Paolo – Parte SECONDA, S.E.I. Ed. – Torino, 1927 – impr.]
CAPO I.
Il Cristo preesistente.
1. – IL CRISTO PRIMA DEI SECOLI. – 2. PAOLO E IL CRISTO. — 3. PREESISTENZA ETERNA DEL CRISTO.
1. Gli storici moderni del dogma si mostrano talora sorpresi nell’intendere san Paolo, dopo la cristologia più semplice degli altri Apostoli, attribuire al Salvatore una preesistenza celeste prima della sua nascita terrena e persino una partecipazione alla creazione del mondo ». Il loro stupore può dipendere da una conoscenza imperfetta o da un apprezzamento inesatto della teologia dei primi Apostoli, ma il fatto stesso non resta meno sconcertante per chi vuole ridurre la grandezza del Cristo alle dimensioni umane. Ed è più sconcertante ancora, se si tiene conto di queste due cose: che san Paolo è stato il primo a fissare negli scritti la credenza cristiana, e che la sua cristologia non fu mai oggetto di una controversia. Questo fatto è innegabile ed è riconosciuto lealmente dai critici meno propensi a difendere le posizioni tradizionali: è questo appunto che rende tanto importante l’insegnamento di san Paolo intorno alla persona del Cristo. – La maniera con cui il fariseo convertito parla di Gesù di Nazaret, di quel novatore religioso morto poc’anzi sopra un patibolo, del quale ancora ieri egli si faceva un vanto e un dovere di distruggere l’opera e di scancellarne il nome, è un fenomeno strano che sembra contradire tutte le leggi della psicologia e tutte le analogie della storia. Paolo, carattere fiero, così cosciente della sua dignità, così sdegnoso degli idoli della carne e del sangue, è in estasi e in adorazione davanti al suo Maestro. Egli vuol essere il suo servo, il suo schiavo, anzi lo schiavo dei suoi fratelli, per amore di lui (Rom. I, 1). Egli non tollera che il Cristo sia messo alla pari con nessun essere creato: più alto che i cieli, più Tasto che l’universo, più potente che la morte, unico vincitore del peccato, unico mediatore della grazia, unico Redentore del genere umano, il Cristo ecclissa tutto col suo splendore, riempie tutto con la sua pienezza, è anteriore ai secoli (Col. I, 18-20; Ephes. I, 21-23). Perciò ogni ginocchio si deve piegare, davanti a Lui, in cielo, in terra e nell’inferno, perché i più perfetti spiriti celesti riconoscono in Lui il loro Capo, il loro Creatore, il loro Dio (Fil. II, 9-11; Col. I, 16-17; Rom. IX, 5Tit. II, 13). Questo è il quadro che l’Apostolo, al domani della passione, fa di Gesù ai testimoni della sua vita e della sua morte, ai suoi persecutori e ai suoi carnefici. – Che proporzioni gigantesche prende improvvisamente nella mente di Saulo l’immagine del Crocifisso! La trascendenza di questa immagine è tale, che non può più crescere: all’infinito non si può più aggiungere nulla. Tutti i nostri sforzi per seguirne lo sviluppo graduale sono vani: dal primo istante della sua conversione, per lui il Cristo è l’incomparabile, l’unico: nulla è superiore a Lui, nulla è uguale a Lui. E tutto questo non è a scapito della natura umana: Gesù Cristo non è un personaggio immaginario, ma è un essere reale, sempre vivo nella memoria dei suoi discepoli che ripetono le sue parole e si modellano sopra le sue azioni. Quando Saulo divenne Cristiano, erano trascorsi sei anni, o al massimo sette, dalla passione; quando inaugurò la sua predicazione pubblica, era trascorsa appena una decina d’anni; egli scrisse le sue prime lettere ventidue anni appena dopo quella data memoranda. Gesù Cristo, più vecchio di lui di qualche anno appena, era per lui, in tutta la forza del termine, un contemporaneo che avrebbe potuto incontrare nelle viuzze di Gerusalemme o sotto i portici del Tempio; era anche un suo compatriota, se è vero, come sostiene san Gerolamo, che la famiglia di Saulo era di origine galilea. E come mai egli è diventato il suo Dio? Né il tempo trascorso, né l’ambiente della Palestina, né le circostanze della morte di Gesù non favorivano un’apoteosi; e la serietà del monoteismo ebraico non si prestava affatto a quelle ridicole deificazioni che mettevano un Claudio o un Tiberio nel numero degli immortali, dedicando a loro templi, sacerdoti e sacrifici, uguagliandoli alle divinità dell’Olimpo che non erano in realtà né migliori né peggiori. Quando l’adulazione dei Romani degenerati, emula dell’adulazione orientale, decretò gli onori divini agl’Imperatori, i quali li accettarono prima con qualche ritegno e poi senza nessun pudore, gli Ebrei furono irreducibilmente refrattari a quell’empio culto. – L’adorazione di un uomo, fosse pure re o imperatore, era per loro l’abbominazione della desolazione; e bisognò pure cedere alla loro invincibile ripugnanza e dispensarli ufficialmente da un atto che ai loro occhi era più orribile che la morte. I Cristiani non si mostrarono meno intransigenti e molte volte sigillarono col loro sangue il rifiuto di dare ad un uomo i titoli e gli onori riservati a Dio. I pagani non capivano un bel nulla dei loro scrupoli, ma non riuscivano a trionfarne. Per i Cristiani più ancora che per gli Ebrei, il culto di Cesare fu sempre l’adorazione della Bestia, e il tempio degli Augusti il trono di satana. Quando san Paolo protesta che per noi vi è « un solo Dio, il Padre, e un solo Signore, Gesù Cristo », questa professione di fede risuona come il grido sdegnoso della coscienza cristiana contro la suprema aberrazione del politeismo morente. In quel tempo tutti i titoli divini, « Dio, Figlio di Dio, Dio da Dio, Signore o Signore Dio, Salvatore o Dio Salvatore », erano stati profanati dall’adulazione dei popoli e dall’incoscienza del paganesimo; ma Paolo, applicando questi titoli al Cristo preesistente, conserva a loro il valore che hanno nella Bibbia dove indicano Jehovah.
2 . La preesistenza del Figlio di Dio risulta evidentemente da quanto dovremo dire intorno alla sua natura divina, alle sue relazioni eterne in seno a Dio, al suo compito attivo nella creazione del mondo; ma essa si dimostra anche direttamente con tre serie di testimonianze. Ad un certo punto della durata del tempo, il Cristo « venne in questo mondo (I Tom. I, 15); apparve nella carne (I Tim. III, 16); si fece povero mentre era ricco, per arricchire noi con l)a sua povertà (II Cor. VIII, 9) ». Ora è chiaro che lo scambio delle ricchezze del cielo con la povertà della terra, suppone necessariamente un modo di esistenza anteriore all’incarnazione. I testi poi come questi: « Dio, avendo mandato il suo proprio Figlio nella somiglianza della carne del peccato e per il peccato, condannò il peccato nella carne (Rom. VIII, 3) », oppure anche: « Dio mandò suo Figlio, nato da una donna, messo sotto la Legge, per procurare a noi la filiazione adottiva (Gal. IV. 4) », non hanno nulla di comune con la frase biblica « Dio mandò a loro un giudice o un salvatore »; poiché se la missione del Figlio coincide con la sua origine terrestre, la sua esistenza deve assolutamente precedere, perché è la somiglianza della carne del peccato, ossia la natura umana, il termine della sua missione. – Il Cristo è il « primogenito di ogni creatura (Col. I, 15) ». È assolutamente impossibile che questa espressione voglia dire « primogenito tra le creature »; essa dunque significa « nato prima di ogni creatura »: e questo implica anzitutto che il Cristo non si deve mettere nella categoria degli esseri creati, e in secondo luogo, che possiede un modo di esistenza superiore e anteriore ad ogni essere creato. Affinché non rimanga nessun equivoco, Paolo si commenta da se stesso dicendo che il Cristo « è prima di tutte le cose »; e ne dà questa ragione, che « tutto fu creato per mezzo di Lui e per Lui (Col. I, 16) ». Siccome prima di operare bisogna essere, la conseguenza è evidente. Il Cristo non solamente esisteva, ma « sussisteva sotto forma di Dio (Fil. II, 6) ». La forma di Dio non si può né acquistare né perdere; essa non può essere soppiantata dalla forma di schiavo che aggiunse a se stessa nel tempo: dove si trova, si trova da tutta l’eternità. Perciò « Gesù Cristo era ieri, è oggi e sarà nei secoli (Ebr. XIII, 8) dei secoli. Come l’autore dell’Epistola agli Ebrei, san Paolo suole distinguere, nella vita del Cristo, tre stati o tre fasi: la preesistenza eterna del Figlio presso il Padre e quella che si potrebbe chiamare la sua preistoria, l’apparizione storica sopra la terra nella pienezza dei tempi, l’esaltazione gloriosa del Cristo risuscitato. È evidente che questi tre stati i quali si succedono senza cambiamento di soggetto, appartengono realmente alla stessa persona. L’ipotesi recente che attribuisce la preesistenza all’anima del Cristo, non ha bisogno di essere confutata: la preesistenza delle anime fu sempre antipatica al pensiero ebraico; non se ne trova nessuna traccia nel Nuovo Testamento; e perché mai san Paolo, in opposizione a tutti gli altri, farebbe al Cristo l’onore di una preesistenza la quale, in questo sistema, sarebbe comune a tutti gli uomini? Alcuni vogliono che l’Apostolo si sia ispirato da Filone, e che il suo Cristo non sia altro, in sostanza, che l’uomo tipo del filosofo alessandrino (Hingelfeld): ma dal momento che Paolo ignora il Platone ellenista, e in ogni caso non prende nulla da lui, dal momento che la sua teologia realista è agli antipodi dell’idealismo teosofico di Filone, questa nuova opinione manca totalmente di base e non regge alla critica. Altri critici ammettono che san Paolo abbia veramente insegnato la preesistenza reale del Cristo, e che è impossibile negarla senza partito preso e senza prevenzioni dommatiche; ma del suo Cristo preesistente si fanno la più strana idea. Il Cristo sarebbe preesistito non come Dio, ma come uomo: uomo vero che già possedeva un corpo luminoso, etereo, immateriale; uomo tipo, immagine divina ed esemplare divino, sul modello del quale saranno formati tutti gli altri; uomo celeste, venuto dal cielo e destinato a ritornare in cielo dopo una fase di esistenza terrestre; uomo spirituale, animato dallo spirito di Dio e che è spirito egli medesimo (Holtzman). Si assicura che san Paolo prende la sua teoria del Cristo preesistente dai sogni del giudaismo palestinese intorno all’esistenza del Messia; ma questa concezione rabbinica è troppo tardiva e poi non si può intendere se non di una preesistenza ideale. Ora i principali seguaci del sistema che stiamo esponendo, sono obbligati a riconoscere che il Cristo preesistente di san Paolo è davvero una realtà. Come mai non sarebbe un essere reale colui che crea e conserva il mondo, che è mandato da Dio, che cambia gli splendori del cielo con le umiliazioni della terra? Ma se Gesù Cristo era uomo prima di nascere, bisogna certamente metterlo nella categoria delle creature, poiché Dio solo è increato; e allora come può san Paolo affermare che ogni essere creato, senza alcuna eccezione, in cielo e in terra, è stato creato per mezzo di Lui e per Lui! Se Gesù Cristo era uomo prima di nascere, come si spiega che diventi uomo col nascere! E se Gesù nel risuscitare ritorna al suo stato di prima, a quello cioè che aveva prima di incarnarsi che cosa significa l a risurrezione! Ecco quanto gli autori di questa strana invenzione non hanno mai provato di spiegarci, ed è appunto quello che imprime al loro sistema, per quanto vogliano avvolgerlo nelle tenebre, il carattere dell’assurdo.
II. – GESÙ CRISTO SIGNORE.
1. NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO. — 2. SIGNORE, NOME PROPRIO DI DIO. — 3. PREGHIERE E DOSSOLOGIE IN ONORE DEL SIGNORE GESÙ.
1. Il compendio più breve della cristologia sta in questa formula: « Nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio (I Cor. I, 9)». Benché tutti gli elementi ne siano anteriori e risalgano alla predicazione apostolica, essa si trova così stereotipata soltanto in san Paolo il quale le dà un valore e una pienezza di significato della più alta importanza per la storia della teologia. – Nei Sinottici, la questione sta nel conoscere se Gesù è o non è il Cristo, cioè il Messia, il discendente e l’antitipo di Davide, l’attesa e la speranza d’Israele. Erode s’informa del luogo in cui deve nascere, Giovanni Battista lo mostra a dito, i demoniaci lo proclamano, Pietro lo confessa, Gesù stesso si rivendica altamente questo titolo che riassume la sua missione, i settari giudei glielo danno ironicamente (Matt. II, 4). Ma mentre i Sinottici ci fanno assistere, per così dire, a questo lavoro di riconoscimento graduale e conservano sempre il sentimento assai preciso del vincolo che unisce la qualità di Messia al compimento delle promesse, per san Paolo l’identificazione di Gesù col Cristo è un fatto acquisito e indiscutibile. Il Cristo ha visibilmente sconfitti tutti gli attacchi giudaici il cui ricordo è quasi scancellato: è il nome proprio del Salvatore e può, come nome proprio, fare a meno dell’articolo. Il Cristo muore per farci trionfare della morte, risuscita per incorporarci alla sua vita, regna glorioso per associarci alla sua gloria. La sua opera è sopramondana, e la scena in cui si consuma, è sopraterrena. Dall’unione dei cristiani col Cristo risulta un essere nuovo, il Cristo mistico, nel quale non vi è più distinzione tra Ebreo e Gentile, tra Greco e barbaro, tra schiavo e libero, perché tutti sono uno nel Cristo Gesù (Gal. III, 28) ». Quando si pensa che Paolo riflette certamente il pensiero cristiano del suo tempo, e che le sue Epistole precedettero la redazione dei Vangeli, non si può fare a meno di ammirare lo sforzo di ricostruzione storica al quale si dovettero sottoporre gli evangelisti per non proiettare sopra la vita e le parole di Gesù le idee e i sentimenti del loro ambiente.
2. È cosa nota che questa parola « Signore » è, nei Settanta, la traduzione abituale del nome ineffabile, del tetragramma sacro. Esso si poteva dare al Messia, perché era Re teocratico rappresentante di Jehovah, e anche perché era designato dalla profezia del Salmista: « E Signore ha detto al mio Signore (Ps. CIX, 1) ». Tuttavia gli evangelisti lo applicano a Gesù assai di rado. In san Marco e in san Matteo, il Signore è ordinariamente Dio stesso, come nell’Antico Testamento, e il titolo di « Signore » per lo più è soltanto una formola di cortesia, l’equivalente di « Maestro » o di « Rabbi ». All’avvicinarsi della passione, essi si allontanano alquanto dal loro riserbo (Marc. XI, 3). San Luca e san Giovanni incominciano più presto (Giov. IV, 1); tuttavia l’uno e l’altro sono assai in ritardo, in confronto con san Paolo, e tale ritardo, a nostro parere, si può spiegare con uno scrupolo di verità storica. Per san Paolo, fatta astrazione dalle citazioni dell’Antico Testamento, Gesù Cristo è regolarmente chiamato « il Signore ». È probabile che il linguaggio dell’Apostolo non presenti neppure un’eccezione (Cremer); in ogni caso, « Signore » è diventato il nome proprio del Cristo e può come tale, sopprimere l’articolo (Rom. XIV, 6I Cor. VII, 22). Ma vi è di più: nell’appropriarsi il nome di Jehovah, il Cristo ne riceve anche tutti gli attributi: Paolo si dice servitore del Cristo, come i profeti solevano chiamarsi servitori di Jehovah; nelle frasi che esprimono azioni divine, come la creazione, il conferimento della grazia, la santificazione, il giudizio, la retribuzione finale, il nome di Dio e del Signore si scambiano a caso, come porta il discorso, alla maniera con cui si scambiano i sinonimi; finalmente quello che la Scrittura racconta di Jehovah, Paolo lo intende, senza nessuna esitazione, come detto del suo Maestro (Am. III, 7; Ger. VII, 35; Dan. IX, 6, etc.). Jehovah era la « Pietra d’Israele » o semplicemente « la Pietra »; gli autori dell’Antico Testamento ci hanno abituati a questo linguaggio. Paolo lo conosce meglio di ogni altro, ma questo non gl’impedisce di affermare che la « Pietra era il Cristo » preesistente: Petra autem erat Christus (I Cor. X, 4). E poco dopo soggiunge: « Non tentiamo il Signore (o il Cristo), come alcuni lo tentarono e morirono del morso dei serpenti (I Cor. X, 9) ». O si legga «il Signore», o si legga «il Cristo», la variante ha poca importanza, perché i due termini, per san Paolo, sono sinonimi. – Gioele aveva detto, parlando di Jehovah: « Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo (Gioe. III, 5) ». Ma il Signore è il Cristo, e l’Apostolo può commentare il testo così: « Non vi è differenza tra il Giudeo e il Greco, poiché tutti hanno il medesimo Signore, liberale verso coloro che lo invocano; poiché (sta scritto): Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo (Rom. X, 13) ». La salvezza una volta annessa all’invocazione di Jehovah, è ora annessa all’invocazione del Cristo e, per provarlo, Paolo si fa forte della parola del profeta: logicamente ne segue che ai suoi occhi il Cristo è uno solo con Jehovah. Altrimenti non si può spiegare il discorso che egli rivolge agli anziani di Efeso: « Vigilate sopra voi stessi e sopra tutto il gregge di cui lo Spirito Santo vi ha costituiti custodi, per governare la Chiesa di Dio che Egli si acquistò col proprio sangue (Act. XX, 28) ». Questa espressione cominciò assai per tempo a scandalizzare certi teologi pusillanimi che le fecero subire diverse correzioni, una delle quali, che consiste nel sostituire il nome di « Signore » al nome di « Dio », finì con invadere la maggior parte dei manoscritti greci. I critici moderni per parte loro ricorrono alle più stravaganti ipotesi per non lasciar dire a Paolo, che « Dio si acquistò la Chiesa col suo proprio sangue ». Ma l’Apostolo non ha nessun bisogno della loro assistenza: il suo linguaggio, in questo passo, non è più straordinario che in cento altri passi; egli si limita, secondo il suo solito, a identificare Gesù Cristo con Dio, e gli applica un attributo che gli conviene soltanto secondo la natura umana. Ma la comunicazione degli idiomi, di cui egli fa l’uso più esteso lo autorizza a farlo. Bisognerà ancora stupire del valore che san Paolo dà alla formula: « il Cristo è Signore? ». Egli ne fa il pernio dell’ortodossia e il criterio dei carismi: « Nessuno che parli sotto (l’impulso del) lo Spirito di Dio dice: Gesù (sia) anatema! e nessuno può dire: Gesù (è) Signore, se non nello Spirito Santo (I Cor. XVI, 3) ». Egli la considera come il compendio più conciso del suo Vangelo: « Noi non predichiamo noi medesimi, ma il Cristo Gesù Signore (II Cor, IV, 5) ». Più ancora, egli la presenta come una professione di fede cristiana che racchiude in sostanza le condizioni della salvezza: « Se confessi con la tua bocca che Gesù è Signore e se credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato da morte, tu sarai salvo; poiché, dice la Scrittura, chiunque crederà in Lui non sarà confuso (Rom. X, 9) ». Isaia aveva infatti detto questo di Dio, e non del Cristo, ma per Paolo è la stessa cosa, non dobbiamo stancarci di ripeterlo, poiché il suo Cristo è Signore e Dio.
3. Se è così, dobbiamo aspettarci di vedere l’Apostolo mettere il Cristo sopra tutto ciò che non è Dio, in una sfera inaccessibile agli esseri creati, rivolgergli inni e preghiere come allo stesso Dio e applicare a lui le dossologie che la Scrittura riserva a Dio: e le nostre previsioni non sono punto deluse. L’Epistola ai Galati comincia con queste parole: « Paolo apostolo, non per autorità degli uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre (Gal. I, 1) ». Paolo nega assolutamente agli uomini ogni causalità, o remota o prossima del suo apostolato; egli non è il delegato né il mandatario degli uomini. – Quando dunque egli si dice apostolo esclusivamente per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, considera evidentemente il Cristo come un essere superiore all’uomo, o meglio come una persona la quale è più che uomo. Senza dubbio tra Dio e l’uomo vi sono gradi infiniti; ma se si riflette che Paolo non farebbe derivare la grazia — e una grazia come quella dell’apostolato — da un essere inferiore a Dio, e che comprende Gesù Cristo e Dio sotto una stessa particella causale, senza che si possa dire che egli stabilisce tra i due una subordinazione di autorità o di grado, poiché Gesù Cristo è anzi qui nominato per il primo, non si potrà opporre nulla agli interpreti i quali vedono in queste parole una prova della divinità del Figlio. – Per invalidare il loro ragionamento, bisogna essere sicuri in precedenza che Gesù Cristo non sia Dio, e che Paolo non lo abbia creduto tale; ma un simile pregiudizio rende impossibile qualunque sana esegesi. – La coscienza cristiana non separa il Cristo da Dio. Fin dalle origini, il Cristo è pregato, invocato, cantato e glorificato come Dio. Santo Stefano morente dice: « Signore Gesù, accogli lo spirito mio… Signore, non imputare a loro questo peccato (Act. VII, 59) ». L’ardente supplica che Gesù in croce rivolgeva a suo Padre, la rivolgono allo stesso Gesù i primi martiri: perché oramai « chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo (Rom. X, 13) »; e il Signore non è altri che il Cristo. I fedeli sono « coloro che invocano il nome del Signore »; questo è il loro titolo distintivo e caratteristico. Paolo scrive « alla chiesa che è in Corinto, ai (fedeli) santificati nel Cristo Gesù, santi per vocazione, come a quelli che invocano il nome di Nostro Signore Gesù Cristo, in qualunque luogo (I Cor. I, 2) ». Dopo la teoria, viene la pratica: l’Apostolo sentendo « nella sua carne uno stimolo, un angelo di satana », che lo schiaffeggia e che pare dover paralizzare il suo ministero, prega tre volte il Signore per esserne liberato; e il Signore gli dice: « Ti basta la mia grazia (II Cr. XII, 8-9) ». Egli prega, non Dio Padre, ma il Signore, perché sa benissimo che pregare il Signore è pregare lo stesso Dio; e il Signore, autore e distributore della grazia, gli promette il suo aiuto onnipotente. Nell’anno 112 della nostra èra, certi antichi Cristiani raccontavano a Plinio, che prima della loro apostasia solevano radunarsi per cantare inni al Cristo come a un Dio: Christo quasi Deo (Epist. ad Traian., 96). Non era affatto una novità: uno dei testimoni citati da Eusebio, afferma che l’usanza di comporre salmi e odi in cui il Verbo era celebrato come Dio, risale alle origini (Hist. Eccl.); e questa asserzione può essere verificata con l’espressa testimonianza di san Paolo: « Trattenetevi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e celebrando nel vostro cuore il Signore (Ephes. V, 19) » Gesù Cristo. Nel passo parallelo, « il Signore » è sostituito con « Dio (Col. III, 16) », e questo prova che i fedeli innalzavano le stesse lodi a Dio e al Cristo. Brevi frammenti di queste composizioni primitive, più notevoli per lo spirito religioso che per l’ispirazione poetica, sono assai probabilmente arrivati fino a noi. Tale sarebbe questa descrizione ritmica del « mistero della pietà »:
Egli si manifestò nella carne,
fu giustificato nello spirito,
apparve agli Angeli;
sarà predicato tra le nazioni,
fu creduto nel mondo,
fu rapito in gloria.
(I Tim. III, 16).
La dossologia è una specie di inno compendiato. Gli Ebrei la facevano seguire al solo nome di Dio, e anche l’Apostolo generalmente osserva tale pratica: « A Dio solo onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. ». Ma già san Paolo, san Giovanni, san Pietro, e anche l’Epistola agli Ebrei, quasi che si fossero data la parola d’ordine, vanno insensibilmente sostituendo il nome del Figlio a quello dei Padre: « Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà (facendomi entrare) nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen (II Tim. IV, 18) ». Infatti, siccome da Lui s i aspetta la grazia, è giusto che a Lui se ne dia l’onore e il ringraziamento: « Rendo grazie al Cristo Gesù Nostro Signore il quale mi ha fortificato, di avermi giudicato fedele con lo stabilirmi nel ministero ». – Però l’attribuzione delle dossologie al Cristo è eccezionale. Allorché il pensiero dell’Apostolo si fissa esclusivamente nella Persona di Gesù Cristo, egli può benissimo pregarlo, invocarlo, ringraziarlo, esaltarlo, come se fosse l‘unico autore dei beni soprannaturali; ma quando lo nomina unitamente a suo Padre, egli stabilisce tra loro due un ordine che non inverte mai. Allora egli ringrazia, implora e glorifica Dio per mezzo di Gesù Cristo o in Gesù Cristo; ed è più che naturale: « Il capo di ogni uomo è il Cristo, (come) il capo della donna è l’uomo; (ma) il capo del Cristo è Dio (I Cor. XI, 3) ». Qui vi è una gerarchia ben definita: Dio, il Cristo, l’uomo, la donna. Se si legge attentamente il contesto, si noterà anzitutto che si tratta del Cristo come capo della Chiesa, nell’economia della redenzione; in secondo luogo, che si tratta dei rapporti dell’uomo e della donna sotto l’aspetto cristiano e sotto l’aspetto sociale. Infatti la questione di cui si tratta, concerne il contegno delle donne nella Chiesa, contegno determinato dalla situazione delle donne nella Chiesa. Sotto l’aspetto individuale, la donna cristiana è immediatamente unita al Cristo redentore, precisamente come l’uomo, ma non è così sotto l’aspetto sociale. Qui vi è una gerarchia da osservare in teoria e da mantenere nella pratica. Come capo della Chiesa, il Cristo dipende immediatamente da Dio del quale è l’inviato e il mandatario; l’uomo dipende immediatamente dal Cristo e lo rappresenta nelle funzioni sacre della gerarchia ecclesiastica; la donna poi — o maritata o no — dipende immediatamente dall’uomo il quale solo ha parte nel governo della Chiesa. E questa subordinazione si deve tradurre esteriormente in atto, nelle assemblee religiose, col velo, simbolo di dipendenza, col quale la donna si coprirà la testa, come pure con l’interdizione che le è fatta, di profetizzare, di insegnare e di parlare in pubblico, davanti ai fedeli e ai loro pastori. – Dio è dunque il capo del Cristo mediatore, e appunto in tale rapporto Dio e il Cristo sono ordinariamente considerati quando sono nominati insieme nelle dossologie e nelle preghiere solenni. Paolo attende la grazia, la misericordia e gli altri beni spirituali simultaneamente dal Figlio e dal Padre e può indifferentemente domandarli al Padre o al Figlio; ma sembra che egli stesso abbia stabilita la regola abituale delle nostre preghiere, quando scriveva ai Colossesi: « Tutto quello che dite o fate, fatelo nel nome del Signore Gesù, ringraziando per mezzo di lui Dio Padre (Col. III, 17) »… Poiché « tutte le promesse di Dio sono diventate sì in lui », è ben giusto che noi rivolgiamo « per mezzo di lui l’Amen » delle nostre benedizioni (II Cor. I, 20). – Forse la cura di non intaccare menomamente, neppure in apparenza, il monoteismo ebraico, non è estranea a questa usanza introdotta dagli Apostoli e adottata in seguito dalla Chiesa, usanza che del resto, come si è veduto, non impedisce di pregare separatamente il Figlio, quando occorre, e di rivolgergli qualche volta le dossologie riservate a Dio solo.