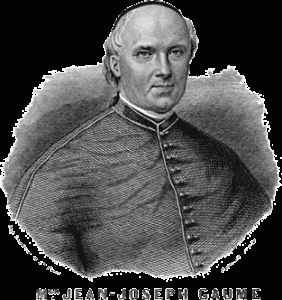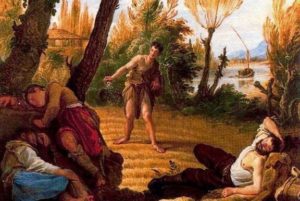CONOSCERE SAN PAOLO (26)
LIBRO PRIMO
Il paolinismo. (2)
CAPO I.
Definizione del paolinismo.
II. LA TEOLOGIA PAOLINA IN GERME.
1. IL CRISTO STA NEL CENTRO. — 2. NON PRECISAMENTE IL CRISTO MORENTE. — 3. MA IL CRISTO SALVATORE. — 4. COMPENDIO SINOTTICO.
[F. Pratt: La teologia di San Paolo – Parte SECONDA S. E. I. Ed. – Torino, 1927 – impr.]
1. Se per comprendere la Città di Dio di sant’Agostino o il Discorso sopra la storia universale di Bossuet, bisogna essere penetrati della tesi che questi due sommi ingegni svolgono con tanta magnificenza, non è meno necessario, per leggere con frutto san Paolo, esaminare attentamente i principi direttivi del suo pensiero. Nelle opere dell’ingegno, come nelle creazioni dell’arte o negli spettacoli della natura, vi è sempre un punto fuori del quale le proporzioni rimangono deformate, e le prospettive si presentano male. Questo punto centrale che irradia in tutte le direzioni, che imprime al tutto unità, coesione e armonia, e che non si può spostare senza turbare tutta l’economia dell’opera, è quello che sì chiama l’idea dominante. Pensatore di prim’ordine, dialettico forte, mente filosofica capace di coordinare insieme fatti disparati, di percepirne i rapporti nascosti, di unificarli con un lavoro di vigorosa sintesi, Paolo, dovette mettere nei suoi scritti un piccolo numero di idee dominanti, forse una sola, ed è certo che questa idea, una volta che sia conosciuta, sarà il filo conduttore della sua dottrina. Una prima esplorazione a volo d’uccello in questo campo immenso, è bastata a convincerci che il centro ne è il Cristo: tutto converge a questa parte; tutto parte di là e tutto riconduce là. il Cristo è il principio, il mezzo e il fine di tutto. Nell’ordine naturale, come nell’ordine soprannaturale, tutto è in Lui, tutto è per mezzo di Lui, tutto è per Lui. La più semplice operazione di aritmetica ci conferma in questa impressione. Lasciando da parte l’Epistola agli Ebrei, il nome del « Signore » cade dalla penna di Paolo circa duecentottanta volte; il nome di « Gesù » duecentoventi; il nome del « Cristo » quasi quattrocento volte. Se quasi a ogni linea delle sue lettere scrive uno dei nomi del Salvatore, è perché egli dirige tutto verso questo punto che è la mira dei suoi pensieri e delle sue adorazioni. Si apra a caso il libro delle sue Epistole, e l’occhio cadrà infallantemente sopra un’allusione alla natura o all’opera o alla mediazione dell’Uomo-Dio. Ogni tentativo di capirne un passo qualunque, facendo astrazione dalla persona di Gesù Cristo, cadrebbe certamente invano. È questo appunto che dimenticano i teologi i quali mettono come base della dottrina di Paolo o la nozione metafisica di Dio, o la tesi astratta della giustificazione mediante la fede, o il contrasto psicologico tra la carne e lo spirito. I primi sono ingannati da un’illusione ottica: essendo il pensiero ebraico profondamente religioso, l’idea di Dio riempie tutta la Bibbia; perciò per san Paolo, come per tutti i suoi compatrioti, Dio è la prima sorgente, la provvidenza universale, il fine ultimo di tutti gli esseri: non si fa nulla senza la sua iniziativa, non arriva nulla se non per mezzo di lui. Sotto questo aspetto, la teodicea di Paolo, poco differisce da quella d’Isaia, o di san Giovanni: essa è un’eredità della rivelazione antica e il patrimonio comune degli Israeliti. Ora non già nei punti di contatto, ma bensì nelle divergenze si deve cercare il pensiero intimo di un autore e l’idea madre di un’opera (Findlay). – Per un’altra ragione, non si può accettare come base della dottrina di san Paolo la giustificazione mediante la fede. Questa è una tesi ispirata dalla controversia e che deve la sua importanza alla polemica giudaizzante. Terminata la controversia, san Paolo sembra che se ne dimentichi o che non se ne occupi più: prova sicura, che non costituisce la base della sua teologia, almeno nella forma acuta che le venne impressa dalla lotta contro avversari irreconciliabili. Ecco la cosa che Lutero non capì, quando di questa tesi pretese di fare la quintessenza del vangelo e il palladio del protestantesimo. Il dualismo psicologico messo innanzi da certi scrittori razionalisti dei nostri giorni, sarà quello che ci darà la chiave della teologia di san Paolo? Impotenza dell’uomo in faccia al bene che ama, dominio del peccato che la Legge provoca invece di frenare, desiderio istintivo di una giustizia che deriva dalla sola fede e che le debolezze individuali non possano ostacolare, sentimento intimo che il Cristo basta a saziare tutte le aspirazioni dell’anima nostra: tali sarebbero gli articoli fondamentali di questo vangelo. In tal modo, si dice, la teologia di san Paolo è il frutto maturo della sua esperienza religiosa; egli non è debitore a nessuno, ma la deve soltanto a se stesso, oppure per parlare col suo linguaggio, allo spirito del Cristo; nel suo pensiero, così prima come dopo la conversione, vi è unità e continuità; tutto si spiega senza l’intervento incomodo del soprannaturale. Noi invece: abbiamo veduto che questo non spiega proprio nulla, né la conversione né tutto il resto. Sarebbe mai verosimile che Paolo riduca il suo vangelo a un’ipotesi filosofica proprio lui che per la sapienza umana sente soltanto compassione e sdegno? Si può ammettere che egli formuli la sua idea dominante in un passo unico il cui senso è controverso? (Rom. VII). No, non vi è né l’uomo né Dio al centro della teologia di san Paolo, ma vi è il Cristo. La sua dottrina non è un corollario della sua antropologia o della sua teodicea; essa ha come punto di convergenza il mediatore unico tra Dio e gli uomini.
2. Siccome la mediazione del Cristo altro non è, in altri termini, che la sua qualità di Redentore, e il Redentore tale non è se non per la sua croce, un gran numero di teologi, anche tra quelli che all’occasione difendono un altro sistema, vedono nel verbum crucis la pietra angolare del vangelo di Paolo: « Il fatto della morte di Gesù diventa così il centro di tutto il sistema paolino. Il Cristianesimo dell’Apostolo si riassume nella persona del Cristo; ma questa stessa persona non acquista tutta la sua importanza redentrice se non al momento della sua morte sopra la croce (Sabatier).,« L’idea è seducente, tanto più che le formali dichiarazioni di Paolo ci spingono su questa pista: « O Galati insensati, scrive egli a certi neofiti vacillanti, chi dunque ha potuto affascinare voi, quando davanti ai vostri occhi fu esposto il Cristo inchiodato alla croce? (Gal. III, 1) ». Egli aveva esposta, pubblicata dinanzi agli occhi dei Galati, l’immagine del Crocifisso; egli aveva loro fatto una pittura così viva e così straziante di Gesù in croce, che non poteva capire come mai avessero potuto staccarne lo sguardo; se essi lo tenevano fisso sopra quell’immagine insanguinata, l’incanto del fascinatore non avrebbe potuto nulla su loro. È certo che la predicazione della croce, aveva sempre, nelle sue prime istruzioni, un’importanza grande: « Io non volli sapere altro, in mezzo a voi, che Gesù Cristo, e Gesù Cristo crocifisso (I Cor. II, 2) ». Gesù Cristo è il tema generale della sua predicazione; Gesù Cristo crocifisso è l’argomento speciale. Se egli mette sempre come base il mistero della croce, non ci dà diritto di cercare in esso la sostanza del suo vangelo e l’idea generatrice della sua teologia? – Queste ragioni sono più speciose che solide. Affinché Gesù Cristo ci salvasse per mezzo della croce, bisognava che il dramma della redenzione si svolgesse in un certo punto dello spazio e del tempo, nel momento in cui gli Ebrei avevano perduto l’autonomia e il diritto della spada, sotto la dominazione romana che riservava ai popoli soggiogati quella pena infamante. Ora, benché nei disegni di Dio non vi sia nulla di fortuito, è forse verosimile che san Paolo leghi a una circostanza accidentale di luogo e di tempo la sua teoria capitale della salvezza degli uomini? L’Apostolo, si dice, non volle sapere altro che Gesù Cristo crocifisso. Questa infatti è una sua affermazione, ma egli vi mette due limitazioni. Una è contenuta nelle parole « in mezzo a voi » e dipende dalle condizioni speciali del suo apostolato in Corinto. Dopo l’insuccesso di Atene, aveva capito che bisognava presentare ai Greci cavillosi e frivoli il mistero della croce nel suo realismo sconcertante; forse, in un ambiente diverso, avrebbe adoperato un altro metodo. La seconda limitazione nasce dalla sua intenzione polemica: gli si fa il rimprovero di ignorare o di trascurare la sapienza, ed egli risponde che la sua sapienza, la sola che sia giovevole a loro e che essi siano in grado di comprendere, è la croce, oggetto di scandalo per gli Ebrei, oggetto di stoltezza per i Greci. Il paradosso sta nell’opporre la stoltezza della croce alla sapienza del secolo e nel dimostrare che Dio trionfa della sapienza con la stoltezza; ma l’Apostolo non ci dà il diritto di conchiudere anche che il verbum crucis porti in germe tutto il suo insegnamento. A dire il vero, la morte del Cristo considerata in se stessa, indipendentemente da ciò che le dà il suo significato e il suo valore, sarebbe senza effetto sopra la nostra salvezza: per se stessa, invece di essere lo strumento della redenzione, sarebbe il delitto supremo dell’umanità, il quale sembrerebbe dover esigere una nuova redenzione. Essa è meritoria per il Cristo e salutare per noi, solamente in quanto è, da parte del Figlio di Dio, un atto di riparazione e l’incoronamento di una vita di obbedienza. Per conferire alla morte di Gesù un valore redentore, è necessario includervi un elemento che la metta in relazione con Dio, con gli uomini e con lo stesso Salvatore: col Salvatore che l’offre, con Dio che l’accetta, e con gli uomini che ne godono i benefizi: soltanto a questa condizione essa è gradita a Dio e ce lo rende propizio. Un motivo più grave di non fermarci alla morte del Cristo per mettere in essa l’idea madre della teologia paolina, è che agli occhi di Paolo la morte del Cristo è inseparabile dalla sua risurrezione senza la quale, sotto l’aspetto soteriologico, essa è incompleta. Quando l’Apostolo riassumeva il suo vangelo ai neofiti di Corinto, diceva loro: « Vi ho trasmesso prima di tutto quello che io stesso ho ricevuto, che il Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu seppellito e che è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture (I Cor. XV, 3-4) ». – Questo è ciò che egli insegnava in Antiochia di Pisidia, in Atene e dovunque (Act. XIII, 29-30; XVII, 31; XXVI, 23, etc.). La morte del Cristo non andava mai disgiunta dalla risurrezione, perché l’una è il complemento e il corollario dell’altra. – Non soltanto la risurrezione gloriosa era dovuta al Salvatore a titolo di ricompensa, ma Dio doveva a se stesso la risurrezione del Figlio per sigillare la sua missione e per sanzionare la sua opera. La morte di Gesù, non essendo il pagamento di un debito personale, non ha in se stessa la sua finalità: « Dio dunque lo ha risuscitato, perché era impossibile che la morte lo trattenesse sotto il suo dominio (Act. II, 24) ». Perciò, non contento di affermare che il Cristo « è morto e risuscitato per noi », san Paolo non esita a scrivere queste parole il cui senso naturale, mette in subbuglio certi esegeti: « Fu dato a morte per i risuscitato per la nostra giustificazione (Rom. IV, 25) ». Dal che la risurrezione del Cristo fa parte integrante dell’opera redentrice.
3. Tuttavia l’idea complessa « Gesù morto e risuscitato per noi » non è ancora la formola che cerchiamo. Oltre al non essere abbastanza speciale di Paolo, essa esprime soltanto il lato oggettivo della nostra salvezza; ora l’Apostolo non separa mai i due aspetti della redenzione. Non occorre compulsare tutte le Epistole; basta osservare che se Gesù Cristo muore per noi, muore per farci morire misticamente, e che se risuscita per noi, risuscita per farci risuscitare moralmente con lui. Si unus prò omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt (II Cor. V, 15). È poi cosa affatto indifferente il presentare questa idea sotto forma di proposizione condizionale, col testo greco accettato e con la Volgata, oppure sotto la forma di entimema, con le edizioni critiche; poiché in un modo o nell’altro, la nostra morte mistica appare egualmente bene come la conseguenza necessaria della morte del Cristo. Vi è di più: « Se siamo morti col Cristo, noi crediamo che vivremo anche con lui (Rom. VI, 8) ». La nostra risurrezione è contenuta nella risurrezione stessa del Salvatore, come la nostra morte è racchiusa nella sua morte. – Si trova in san Paolo una lunga serie di parole nuove, la maggior parte delle quali non si possono tradurre in altra lingua se non con un barbarismo o con una perifrasi. L’Apostolo le ha create o rinnovate per dare un’espressione grafica all’ineffabile unione dei Cristiani col Cristo e nel Cristo. Tali sono: soffrire con Gesù Cristo, essere crocifissi con Lui morire con Lui, essere sepolti con Lui, risuscitare con Lui, vivere con Lui, essere vivificati con Lui, partecipare alla sua forma, partecipare alla sua gloria, sedere con Lui, regnare con Lui, essere associati alla sua forma, associati alla sua vita, coeredi. Vi si possono aggiungere compartecipe, concorporale, coedificato e alcune altre ancora che non esprimono direttamente l’unione dei Cristiani con il Cristo, ma indicano l’intima unione dei Cristiani tra loro nel Cristo. L’esame di questi curiosi vocaboli ci suggerisce tre osservazioni importanti:
— la nostra unione mistica col Cristo non si estende fino alla vita mortale Gesù; essa nasce soltanto nella passione, quando Gesù Cristo inaugura la sua opera redentrice; ma da quel momento essa è continua, e la comunicazione di idiomi tra i Cristiani e il Cristo è ormai completa. — Se poi risaliamo fino alla sorgente di questa unione di identità, vediamo che essa esiste di diritto e in potenza al momento in cui il Salvatore, operando in nome o a vantaggio dell’umanità colpevole, muore per noi e ci fa morire con Lui, ma che si effettua di fatto e in atto in ciascuno di noi, quando la fede e il Battesimo ci innestano sopra il Cristo morente e ci associano alla sua morte. — L’autore di tale unione è unicamente Dio stesso che, rivestendoci della forma e degli attributi del Figlio suo prediletto, ci riconosce come figli adottivi e ci tratta poi come coeredi di Gesù. Così noi ricadiamo in quello che vi è forse di più personale e di caratteristico nella teologia di san Paolo: voglio dire la formola In Christo Jesu, che abbraccia tutta la redenzione, dalla sua prima idea nell’intelligenza divina e dalla sua esecuzione potenziale al Calvario, fino alla sua realizzazione successiva in ciascuno di noi e alla sua consumazione finale nell’eternità. Dio ci ha eletti e predestinati nel Cristo; nel Cristo Egli riconciliava a sé il mondo; nel Cristo noi nasciamo alla grazia; nel Cristo noi vi cresciamo e vi perseveriamo; nel Cristo ancora noi saremo vivificati, risuscitati, glorificati. Ma non è questo precisamente l’oggetto del mistero che, come abbiamo veduto, è la pietra angolare del vangelo di Paolo? Tra la comunicazione di idiomi accennata poc’anzi, la formola In Christo Jesu e il contenuto del mistero regnano i rapporti più stretti e più costanti: non sono tanto tre verità distinte, quanto piuttosto tre aspetti particolari di una medesima verità, la redenzione per mezzo del Cristo e nel Cristo: il mistero la considera sotto l’aspetto di Dio che ne prende l’iniziativa e ne conserva il segreto; la comunicazione degli idiomi la considera sotto l’aspetto dell’uomo che se ne appropria i benefizi e ne raccoglie i frutti; la formola In Christo Jesu, la comprende nella persona stessa del Mediatore. In ogni modo, la teologia di Paolo è una soteriologia. Ma come potremo darle un’espressione abbastanza comprensiva da non omettere nulla di essenziale, e abbastanza breve da evitare ogni sovraccarico inutile? Forse la formola seguente, nonostante la sua imperfezione, sarebbe abbastanza esplicita, a condizione che sia ben precisato il valore dei termini: « Il Cristo Salvatore che associa ogni credente alla sua morte e alla sua vita ». Il Cristo Salvatore definisce la persona del Redentore; è il Messia, l’inviato, l’agente e il mandatario di Dio, il pontefice dell’umanità colpevole, il nuovo Adamo incaricato da Dio di riparare l’opera del primo. — Ogni credente specifica l’oggetto della redenzione, universale in potenza, senza distinzioni, senza esclusioni, senza privilegi; e nel tempo stesso indica la condizione essenziale della salvezza, la fede. — L’unione alla morte e alla vita del Cristo riassume il disegno della redenzione, concepito dal Padre da tutta l’eternità, eseguito nel corso dei secoli dal Figlio che, facendosi solidale con noi e unendoci a sé con un vincolo d’identità mistica, fa passare sopra di sé quello che è nostro, e sopra di noi quello che è suo.
4. Se siamo riusciti a fissare il vero centro della dottrina di san Paolo, sembra che ci dobbiamo mettere sul Calvario e di là come da un osservatorio elevato, contemplare anzitutto sotto tutti i suoi aspetti il mistero della nostra salvezza: la missione del Salvatore, l’efficacia della morte redentrice, gli effetti immediati della redenzione; poi gettare uno sguardo sopra gli avvenimenti che sono come il preludio del gran dramma, e un altro sguardo sopra la serie dei fatti che ne preparano lo svolgimento. Ma questo modo di procedere, per quanto sembri razionale, non è applicabile in pratica. L’opera della redenzione, condizionata dalla storia della caduta, non si spiega se non alla luce dei disegni divini e non si comprende se non in funzione della persona del Redentore. Bisogna dunque anzitutto esaminarne quella che si potrebbe chiamare la preistoria, cioè lo stato dell’umanità decaduta e i disegni di Dio sopra di lei, poi l’origine, le relazioni, la qualità di colui che assume l’incarico di salvare il mondo. Così pure le conseguenze della redenzione comprendono due ordini di benefizi disparati che non conviene mescolare insieme: voglio dire i canali stabiliti da Dio per versare sopra le anime gli effluvi del sangue redentore, e i frutti di salute che germogliano da questo succo divino. Perciò, fatta astrazione dalle suddivisioni che la natura dell’argomento impone o suggerisce, la teologia di san Paolo prende la seguente forma schematica:
I . Preistoria della redenzione.
1. L’umanità senza il Cristo.
2. L’iniziativa del Padre.
II. La persona del Redentore.
1. Il Cristo preesistente.
2. Relazioni del Cristo preesistente.
3. Gesù Cristo.
III. L’opera della redenzione.
1. La missione redentrice.
2. La morte redentrice.
3. Gli effetti immediati della redenzione.
IV. I canali della redenzione,
1. La fede e la giustificazione.
2. I sacramenti.
3. La Chiesa.
V. I Frutti della redenzione,
1. La vita cristiana.
2. I novissimi.
Invece di trovarsi al primo posto, come forse si aspettava, l’idea centrale occupa proprio il centro. Si sale gradatamente fino al fatto dell’insegnamento dottrinale per ridiscenderne poi il pendio. L’economia della redenzione si svolge così nel passato e nell’avvenire in un quadro cronologico le cui lontane prospettive non mancano affatto di armonia.
(Continua …)