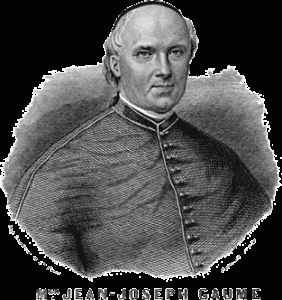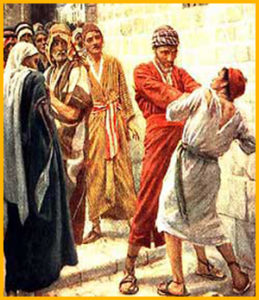GNOSI, TEOLOGIA DI Satana -32-
Gnosi ed UMANESIMO (1)
[Elaborato da: É. Couvert: La gnose contre la foi, Ed. de Chiré, 1989]
La gnosi è l’anima dell’Umanesimo, di tutto il Rinascimento [in realtà rinascimento del paganesimo e del culto solare di Mithra, con annesso becero ed assurdo eliocentrismo], che in nome di una pretesa e falsa libertà di pensiero e di coscienza, ha guidato la ribellione a Dio – pretendendo di averne causato addirittura la morte – ed al suo Cristo, ha stravolto, in unione con la gnosi islamica e giudaico-kabbalista, le fondamenta del Cristianesimo e della sua Chiesa, demolendone prima il potere temporale [1871] e poi, si fieri potest, quello spirituale [dal 26 ottobre del 1958]. La “Rivolta” ha interessato tutta la società, tutta la cultura, le arti, il pensiero, addirittura ha imposto un falso modello astronomico, fondato sul nulla, sull’immaginario di visionari allucinati, occultisti astrologi, alchimisti e veri e propri stregoni, definiti ancor oggi “scienziati”; coinvolte sono state naturalmente la letteratura, la filosofia, la teologia, virata dal sano e lucido tomismo, alle fantasie ofidiche della nuova teologia modernista. Il nostro É. Couvert, che non sapremo mai ringraziare abbastanza per la sua opera di “talpa-segugio” anti-gnostico, ha elaborato dei capitoli veramente straordinari per farci rivivere e comprendere l’ambiente in cui è rinata, nonché l’evoluzione storico-culturale della gnosi, vero cancro del Cristianesimo, e dell’intero pensiero umano. Possiamo ringraziarlo pregando per la sua conversione alla Chiesa Cattolica, quella vera, che non è la sinagoga satanica del “novus ordo”, fogna di tutte le eresie, infestata e disfatta dalla lebbra gnostica; possa finalmente comprendere – e chi meglio di lui – che Gesù Cristo non poteva ingannarci consentendo l’errore nella sua Chiesa o l’apostasia del suo “vero” Vicario, infallibile capo visibile della sua Sposa, senza macchia e senza rughe, Corpo mistico di Cristo, e parte del vero “PLEROMA”, [non la contraffazione luciferina], cioè la pienezza di Cristo, costituita dal Capo, l’uomo-Dio, e dalla Chiesa, membra del corpo, secondo la meravigliosa definizione di San Paolo ai Colossesi ed agli Efesini.
Introduzione
Fin dalle origini del Cristianesimo, abbiamo visto che gli gnostici si sono sforzati di penetrare nella giovane Chiesa per depositarvi il germe del loro culto satanico. Ma fu all’epoca un insuccesso clamoroso. A partire dal IV secolo, essi dovettero lavorare nell’ombra, e così la loro azione continuò discreta e nell’oscurità attraverso i secoli del Medio Evo. Qui e là, la loro dottrina satanica, appariva improvvisamente per ripiombare con altrettanta velocità nelle voragini dalle quali faceva capolino. Ad esempio: gli eretici Sabelliani, spiegavano Dio come una monade in espansione. Marcello, Vescovo di Ancyra, parlava di “dilatazione del divino” e del “logos” esteriorizzantesi da se stesso attraverso una energia attiva [emanazione!], benché rimanesse sempre Dio. Gli Ariani credevano che Gesù-Cristo e lo Spirito-Santo fossero delle emanazioni di Dio Padre [eoni!], che Gesù-Cristo fosse un uomo perfetto la cui anima fosse il “Logos”, in comunicazione diretta con Dio. – Più tardi, nel XII secolo, si vede apparire, senza apparenti legami con una gnosi precedente, un monaco calabrese, che pretendeva di aver intravisto, passeggiando al sole nel giardino del suo convento, un giovane uomo che gli tendeva una coppa dalla quale bevve alcuni sorsi. Joachim de Flore aveva gustato da un calice meraviglioso la “rivelazione dell’avvenire”, la visione del “Vangelo eterno”. Egli partì per la Terra santa, al ritorno si fermò in un monastero della Sicilia, alle falde all’Etna, ove ebbe un’estasi di tre giorni, simile ad un’agonia:« … io ero ai suoi piedi, racconta un suo discepolo: io scrivevo, e due altri erano con me. Egli dettava notte e giorno. Il suo volto era pallido come una foglia secca di un albero. » Egli annunciava la fine della legge del Cristo che doveva retrocedere, nell’anno 1260, e far luogo alla legge dello Spirito. La terza età, proclamava, sarà quella del Vangelo eterno, della legge dell’amore ed il tempo della libertà. La sua dottrina fu propagata dai francescani. E Jochim stesso non fu perseguitato. Dante, gnostico occultista, lo pone tra gli eletti e gli attribuisce il titolo di profeta. Egli ebbe discepoli in Germania, nel secolo XIV, i « Fratelli del libero Spirito», Maestro Eckart, Tauler, Suso. Nei fatti egli insegnava la più classica delle gnosi. La fine dell’umanità è un fondersi in Dio per mezzo dell’opera dello Spirito ed in questa unione, l’anima dell’uomo non è che Dio stesso! – Maestro Eckart continua l’insegnamento di Joachim de Flore. « L’anima, egli dice nei suoi sermoni, “Nisi granum frumenti”, sfugge alla sua natura, al suo essere alla sua vita e nasce nella divinità. È là che c’è il suo divenire. Essa diviene sì totalmente un solo essere al quale non resta altra distinzione che questa: «Esso resta Dio, ed essa resta anima. » Questa unione, « Einung », è nei fatti una fusione di due esseri in una sola divinità totale: è il ritorno all’ “unità primordiale” dei nostri gnostici. Il Papa Giovanni XXII, condannò in una bolla del 1329 questa tesi di maestro Eickart: « noi Ci metamorfosizziamo totalmente in Dio e ci convertiamo in Lui allo stesso modo che il pane, nel Sacramento, si cambia in Corpo di Cristo. Io sono così cambiato in Lui, perché Egli stesso mi fa essere suo. Unità, quindi, non similitudine. Con il Dio vivente è vero che non c’è alcuna distinzione. » Come questa, attraverso i secoli del Medio Evo, si può seguire una linea segreta di penetrazione, nel pensiero cristiano, di una gnosi che si nasconde sotto un linguaggio apparentemente cristiano. Ma se si vuole assistere veramente ad un ritorno in forze della gnosi nel pensiero cristiano, bisogna attendere il XV secolo, con la fioritura dell’Umanesimo nel Rinascimento. È allora che il pensiero gnostico va ad esercitare un’influenza decisiva su tutta la mentalità dell’élite coltivata nel XVI secolo, di tal sorta che dopo di allora, essa non ha mai cessato di avvelenare gli spiriti fino ad esplodere ai nostri giorni, malgrado gli sforzi energici della Chiesa per preservare la dottrina cristiana contro questa nuova invasione. Il Romanticismo degli ultimi secoli, ad esempio, non è stato che una riesumazione dell’Umanesimo gnostico. – Se si vuol definire con precisione l’Umanesimo del Rinascimento, occorre riconoscere che esso è stata il risultato di una penetrazione della gnosi cabalistica insegnata dai rabbini del XV secolo nella società cristiana del loro tempo.
LA KABBALA, FORMA GIUDAICA DELLA GNOSI.
Gli gnostici si sono sforzati, fin dai primi secoli, di penetrare nel giudaismo della diaspora in modo da indurre i rabbini, fedeli alla Rivelazione dell’Antico Testamento, a rinnegare il vero Dio, Yeowah. Essi hanno spiegato loro infatti, che Yeowah non era che un’entità demoniaca, che la legge di Mosè era stata da lui inventata per ridurre i Giudei alla schiavitù del Demiurgo, rinchiudendoli in una rete di istituzioni e principi arbitrari, manifestando la volontà determinata di un tiranno malvagio. Così essi hanno inondato la Siria e la Palestina di canti gnostici da loro composti. Vi si ritrova in essi tutto il principio dell’emanazione, le idee neoplatoniche, con uno stato di esaltazione e di entusiasmo grazie al quale si “volava nell’aria” sul “carro dell’anima”, e si compivano ogni sorta di miracoli, accompagnati da allucinazioni e da visioni. – Il risultato di questa penetrazione gnostica in Israele fu, nel corso del Medio Evo, l’apparizione della Kabbala, o “tradizione”. La sua forma definitiva si è espressa nel libro dello “Zohar”, cioè “Lo splendore”. Esso si presenta sotto la forma di un commentario del Pentateuco, insegnato da rabbi Simon Ben Jochai al suo circolo di pii uditori; la sua redazione attuale risale in gran parte a Moïse de Léon. Ne diamo un riassunto secondo Moïse Cordovero e Isaac Luria. – Ma è innanzitutto necessario sbarazzare lo Zohar di tutta una stravagante mitologia la cui lettura è veramente penosa per una intelligenza ordinaria e sana. I kabbalisti si sono ingegnati nell’avviluppare il loro insegnamento con un rivestimento fantasioso destinato in realtà a nascondere le loro vere intenzioni. In questo, per la verità, essi non hanno fatto che seguire l’esempio dei nostri primi gnostici. Era in effetti difficile far abbandonare ai rabbini il vero culto di Yeowah, e per questo bisognava fingere di seguire la Rivelazione dell’Antico Testamento, poi darne un commento rispettoso che doveva però lentamente pervenire ad invertirne completamento il vero senso. Si continuava a parlare del “Santo, il suo nome benedetto”, della “creazione”, ma queste parole si caricavano di un senso nuovo ed inaudito in precedenza in Israele, quello della gnosi, come già in precedenza esposto. Il “Gran Tutto”, il “Pleroma” dei nostri gnostici, si chiama, presso di loro l’« En-Sof », cioè il non-limitato”, il grande Essere immutabile, eterno, infinito, che racchiude in sé tutte le forme. Per spiegare l’apparizione del mondo visibile e la molteplicità degli esseri che popolano l’universo, i kabbalisti hanno ricorso come al solito, alla nozione di emanazione e contrazione. Il “gran Tutto” primitivo, esce dal “caos”, si contrae per lasciare un vuoto all’interno di sé, dal quale appaiono le forme determinate e multiple delle creature che sono il riflesso apparente dell’ « En-Sof ». In altri termini, il “gran Tutto” non è altro che la somma, la totalità delle cose finite. Per spiegare questo passaggio dall’uno al molteplice, dall’indeterminato alle forme concrete, gli gnostici avevano inventato delle potenze divine intermedie, gli Arconti, capaci di produrre gli esseri. Essi sono chiamati “Zephirot” dai kabbalisti. Il loro numero ed i loro attributi possono variare da una scrittore all’altro, ma il loro ruolo resta essenziale nella produzione delle cose finite distinte tra loro per le qualità, la gradazione, le determinazioni. – Una nozione fondamentale della kabbala è che essa rappresenta la maniera di presentare il panteismo più assoluto, è la corrispondenza di struttura tra i due mondi, quello dell’« En-Sof » ed il mondo visibile, oggetto della nostre percezioni: «Tutte le cose, ci dice lo Zohar, dipendono le une dalle altre e tutte sono collegate le une alle altre, affinché si sappia che: tutto è Uno, e tutto è l’Antico e niente è separato da Lui ». L’Antico, è il nome velato per designare la divinità originale, fonte di tutti gli esseri; lo Zohar precisa ancora: « Quando si afferma che le cose sono state create dal niente, non si vuole parlare del nulla propriamente detto, perché non può mai succedere che un essere venga da un non essere. Ma si intende con il nome di non-essere ciò che non si concepisce né dalla sua causa, né per essenza, ma è, in una parola, la causa delle cause, quello che noi chiamiamo il Non-Essere primitivo, perché è anteriore all’universo, e con questo noi intendiamo non sono gli oggetti materiali, ma anche la Saggezza sulla quale è fondato il mondo … Tutte le cose di cui questo mondo è composto, lo spirito, come il corpo, rientrano nel principio e nella radice dalla quale sono usciti. Esso è la l’inizio la fine di tutti i gradi della creazione, tutti i gradi sono marcati dal suo sigillo e non lo si può nominare se non come l’unità. Esso è l’Essere unico, malgrado le forme innumerevoli dalle quali è rivestito. » Tutto questo è perfettamente gnostico. Si riconoscono in queste considerazioni: – la filosofia di Spinoza, secondo la quale Dio è al tempo stesso causa e sostanza dell’Universo; – la filosofia di Hegel, per la quale il mondo apparente non è che la manifestazione di “Dio primordiale incosciente”; – la filosofia di tanti filosofi moderni che si son ingegnati nello sviluppare temi gnostici sotto le forme più disparate e stravaganti. – Lo Zohar studia anche l’uomo. Già Maimonide aveva distinto nell’uomo, altre al corpo ed all’anima, una intelligenza materiale, incaricata di animare il corpo, ed una intelligenza comunicata, emanazione dell’Anima universale del Mondo. Si tratta dunque di una costituzione tripartita dell’uomo, tale come si è sempre insegnato nella gnosi. Per il kabbalista, il corpo non è un rivestimento, ma il principio intermedio, cioè la Psiche dei nostri gnostici: è divisa in due anime, così da partecipare e della materia e dello spirito: questa è la nephesh, principio animale e sensitivo a contatto immediato con il corpo; la Ruach, invece, è la sede della vita morale ed il principio di animazione; “Neschama” resta l’anima spirituale, l’emanazione divina, l’intelligenza pura, lo pneuma degli gnostici. Tutte le anime preesistono nel mondo e cadono nei corpi in seguito ad una caduta; « Notate, spiega lo Zohar, che tutte le anime di questo mondo, che sono il frutto delle opere del Santo … sia esse benedetto, non formano prima della loro discesa sulla terra, che un’unità, poiché queste anime fanno parte tutte di un solo e medesimo mistero, e quando discendono giù in questo mondo, si separano in maschio e femmina; sono i maschi e le femmine che si uniscono. » Da qui, la trasmigrazione delle anime, insegnata già dagli gnostici nella metempsicosi. « Notate, dice sempre lo Zohar, che il Santo … esso sia benedetto, impianta le anime quaggiù; se esse prendono radici, è bene, altrimenti le strappa anche più volte e le trapianta fino a che mettano radici … le trasmigrazioni sono inflitte alle anime come punizione e variano secondo la colpevolezza … Ogni anima che si è resa colpevole durante il suo passaggio in questo mondo è, per punizione, obbligata a trasmigrare tante volte, quanto necessita perché essa raggiunga, con la sua perfezione, il sesto grado della regione dalla quale essa emana. » Si trova ancora nello Zohar la dottrina della Reminiscenza: « Anche prima della creazione, tutte le cose di questo mondo si trovavano presenti al pensiero divino, tutte le sue forme che gli sono proprie, così come tutte le anime umane, prima di scendere in questo mondo, esistevano davanti a Dio, nel cielo, nella forma che hanno conservato quaggiù e tutto ciò che apprendono sulla terra, esse lo conoscevano già prima di arrivarvi. » – Ecco come Adolphe Franck riassume la posizione dell’uomo, secondo lo Zohar: « L’uomo è allo stesso tempo il riepilogo ed il termine più elevato della creazione. Egli non è soltanto l’immagine del mondo, dell’universalità degli esseri, ivi compreso l’Essere assoluto, egli è anche e soprattutto l’immagine di Dio, considerato nell’insieme dei suoi attributi infiniti. Egli è la presenza divina sulla terra, è l’Adamo celeste che, uscendo dall’oscurità suprema e primitiva, ha prodotto questo Adamo terrestre … ». Rabbi Simon ben Jochaï spiega ai suoi discepoli che « la forma dell’uomo racchiude tutto ciò che è nel cielo e sulla terra, gli esseri superiori come gli esseri inferiori ». Non si poteva dir meglio che l’uomo è Dio stesso manifestato. Gli umanisti del Rinascimento non dimenticheranno affatto la lezione dei rabbini. Essi rappresenteranno l’uomo con gli arti divaricati, perfettamente descritto in un cerchio, nell’uovo primitivo dal quale sono stati estratti tutti gli esseri; i diari di Leonardo da Vinci e di Albert Dürer sono le proporzioni umane rappresentanti questa sovrapposizione della forma umana in una figura geometrica che vuol suggerire che l’uomo è la misura del mondo! – Come vediamo, la kabbala non è altro che la gnosi tradotta in ebraico. Il contenuto dottrinale è lo stesso, e gli si possono opporre gli stessi argomenti di buon senso che una ordinaria intelligenza non può mancare di trovare, se appena vuol prendersi la briga di riflettere un poco. Infine, il serpente ispiratore di tutta questa mitologia menzognera, non ha avuto remora né riguardo nel menzionare se stesso. Egli ha spiegato ai cabalisti che egli non è assolutamente il nemico del genere umano, bensì, al contrario, il suo protettore ed il suo padrino, che egli, poverino, è stato una vittima dell’ingiusta gelosia del Demiurgo, creatore della materia, che l’Arcangelo San Michele e le altre potenze celesti che lo avevano precipitato nell’abisso, erano dei veri demoni, mentre lucifero, belzebuth e astaroth erano l’innocenza e la luce stessa. Ecco che allora il regno di Michele e della sua milizia, deve ben presto finire, ed egli stesso sarà riabilitato e reintegrato nel cielo con la sua falange. Il nome del serpente velenoso è samael. Il giorno in cui ritroverà il suo nome e la sua natura di angelo, si ritaglierà la prima sillaba, che vuol dire “veleno” mentre la seconda è il termine comune designante tutti gli Angeli. Niente è cattivo, niente è maledetto: tutto ciò che si chiama il male, è in Dio stesso, l’altra faccia del bene. I mistici giudei del periodo talmudista, riflettendo sulla natura di Dio, avevano dichiarato che « Dio è il luogo in cui soggiorna l’universo »; essi avevano impiegato la parola “Ma kom” che vuol dire “piazza”, per designare Dio. Filone si esprimeva già così: « Dio è chiamato Ma kom (il luogo) perché racchiude l’Universo », nel suo trattato “De Somniis”. Come abbiano fatto dunque i rabbini, nel corso del Medio Evo, a riciclarsi aderendo in tutto alla kabbala? È cosa che sarà molto difficile da comprendere. In effetti questa nuova dottrina è la totale inversione dell’insegnamento della Bibbia, ed in particolare della Genesi. Ciò che è certo è che il giudaismo contemporaneo ha abbandonato il culto del vero Dio ed ha spinto questo abbandono alla sue estreme conseguenze. M. Th. Reinach, un’autorità in Israele, dichiara nella “Grande Enciclopedia”, che emergerà dal giudaismo « una religione superiore, conciliante la nozione della divinità, anima del mondo e sorgente del bene, con i dati della scienza, che la religione supera ma non saprebbe contraddire, accettando dal Cristianesimo il suo principio di fraternità universale già proclamata dai Profeti, ma correggendo il suo pessimismo che non vede salvezza che nell’altra vita, salvezza che scaturisce invece dal miglioramento infinito della specie umana: è questa la forma moderna della speranza messianica ».
GLI UMANISTI ALLA SCUOLA DEI RABBINI
È in Italia, nel corso del Medio Evo, che l’attività letteraria dei Giudei esercitò una influenza considerevole sul pensiero cristiano all’epoca in cui l’imperatore Federico II di Hohenstaufen aveva invitato il celebre Anatoli di Provenza a tradurre in ebraico gli scritti di Averroè, poi in latino le opere di Maimonide. Dal XIV secolo, gli scrittori giudei si avvicinarono ai principali rappresentanti della cultura italiana. Guido Romano studia la filosofia scolastica e scrive sul soggetto, dei trattati in ebraico. Suo cugino Manoello [Manuel Romano o Manoello Giudeo], divenne amico intimo di Dante, scrisse una sorta di Divina Commedia in lingua ebraica, nella quale fa l’elogio del suo amico e deplora la morte del grande (?!) poeta fiorentino in un sonetto in italiano. Dante stesso, come ben sappiamo, ha preso come modello della sua Divina Commedia, ricopiandolo in gran parte, il “Libro del viaggio notturno” del mistico arabo Ibn el Arabi, scritto ottanta anni prima. Questo trattato descrive in effetti una traversata dei tre mondi dell’aldilà: l’inferno, il purgatorio, il paradiso, con gli stessi incontri e le medesime peripezie e riportando molti personaggi simili. Ora, Ibn el Arabi era affiliato alla setta mistica degli “Assassini”, ed il suo libro era stato tradotto in ebraico. È così che da questo ambiente culturale, Dante ha tratto il suo odio per il Papato. Egli mette nell’Inferno nella “bolgia” dei simoniaci, i Papi Nicola III, Clemente V, Bonifacio VIII, con i corpi conficcati in buche, testa all’ingiù, piedi all’aria. Cotti al fuoco! Essi avevano invertito l’ordine stabilito da Dio, era giusto che fossero invertiti a loro volta; essi avevano calpestato la santa fiamma dello spirito: la Santa Fiamma brucia in compenso i loro piedi. La Chiesa subisce un affronto cruento, ricevendo uno schiaffo più violento di quello del Nogaret sul volto di Bonifacio VIII. Essa ne resterà per lungo tempo abbattuta. Gli umanisti del Rinascimento, non fecero altro che sviluppare questo odio satanico contro Roma, e Lutero non avrà difficoltà ad ammassare tutta questa spazzatura per gettarla in faccia al Papato. Elia Del Medigo insegna pubblicamente a Padova e Firenze; egli viene anche scelto un giorno, dal senato di Venezia, per arbitrare un grande incontro filosofico. Per costituirsi professori e maestri del pensiero religioso, gli scrittori giudei cominciano a produrre edizioni della loro bibbia ebraica, poi delle grammatiche e dei dizionari ebraici: il primo tipografo di Mantova è un medico giudeo che lavora con una donna. Un altro edita a Reggio Calabria. Ecco ben presto i nostri umanisti inquieti: la Chiesa non possedeva dunque la vera Bibbia. Le Pogge si chiede secondo quali principi San Girolamo avesse tradotto la Vulgata. Bruni gli risponde che leggere la Bibbia nell’originale, è mostrare una diffidenza ingiusta rispetto all’opera intrapresa da san Girolamo. Nel 1482, i Giudei furono cacciati dalla Sicilia e si rifugiarono a Firenze. È là che essi formano Pico della Mirandola (1463-1494): sotto la direzione di Elia Del Médigo e di Jonachan Alemanno, a mezza voce e porte chiuse, coi vetri oscurati, nella sua camera di Firenze, Pico studia la kabbala nelle scritture misteriose portate dall’Oriente, per passare poi ad elementi di arabo e di caldeo. Egli si approfondisce nello studio dei numeri. Pretende di ritrovare nella kabbala l’incarnazione del Verbo, la divinità del Messia, la Gerusalemme celeste. Gesù vi appare, egli crede, come colui che unisce tutte le cose nel Padre, per il quale tutto è fatto e tutto diviene, e tutto sabbatizza. Gesù è rivelato in ogni tempo come il Pallas di Orfeo, lo spirito paterno di Zoroastro, il Figlio di Dio di Mercurio, la Saggezza di Pitagora, la sfera intelligibile di Parmenide, il Verbo di Platone. Presso di lui tutto procede per via di simboli, allegorie, immagini. Ogni rivelazione è esoterica, ermetica. Gesù non ha scritto, ma ha rivelato i suoi misteri ai suoi discepoli, come insegna Origene [passato già ai Manichei], e secondo Dionigi l’Aeropagita, questi ultimi devono impegnarsi formalmente a non confidare nulla attraverso la scrittura, ma a trasmettere tutto bocca a bocca. – In Germania altri rabbini formano e plasmano Reuchlin (1455-1522). Nel 1492, nel momento in cui i rabbini di Toledo e di Cordova, cacciati dalla Spagna, camminavano verso la Germania, un Giudeo, medico dell’imperatore Massimiliano, fece dono a Reuchlin di un manoscritto prezioso della Bibbia. Nel 1494, Reuchlin pubblica il suo libro “De Verbo mirifico”, il cui senso era: “solo i Giudei hanno conosciuto Dio”. Nel 1498, tre mesi dopo il supplizio di Savonarola, egli visita Firenze, raccoglie l’anima del martire tra i visionari che lo piangono, torna ai suoi studi e pubblica nel 1506 i suoi “Rudimenta hebraica”, e nel 1512 il suo “Lexicon Hebraicum”. La dottrina centrale della kabbala, egli dice, ha per oggetto il Messia, essa trae la sua origine immediatamente dall’illuminazione divina. Grazie a questa luce, l’uomo diviene capace di penetrare il contenuto della dottrina, interpretando simbolicamente le lettere, le parole, le frasi della Scrittura. Egli è inoltre lo zio del celebre compagno di Lutero, Melantone. In Francia il neo-platonismo circola nelle opere di Lefebvre d’Etaples. Gli scritti dello pseudo-Dionigi esercitano molte attrattive sugli umanisti che li credono autentici. Nel 1521, in una “Raccolta di allegorie e sentenze morali estratte dai due Testamenti”, noi vediamo apparire delle formule ben conosciute sull’illuminazione dell’intelligenza e la “purgazione dei sentimenti”. – La penetrazione platonica è manifesta in un erudito ebraizzante, Charadame de Seez. Sotto il titolo di “Alfabeto ebraico”, egli pubblica nel 1529, un piccolo trattato di mistica dionisiaca. Egli vede nell’ebraico, lingua sacra, tutto un simbolismo. Questa lingua è stata, egli dice, insegnata direttamente da Dio; essa è dunque eminentemente divina. Le parole hanno un senso celato. Nel triplo nome di Gerusalemme gli apparirà, ad esempio, quello della Trinità. Egli cerca nelle lettere, nella loro forma, nella loro consonanza, nella loro armonia, nel loro numero, tutto un senso nuovo. L’uno figura essere di Dio, imperituro e semplice, l’altro, il Cristo, questi gli elementi del mondo materiale o le forme multiple della creazione, queste altre l’uomo, la sua intelligenza, il suo corpo. L’alfabeto ebraico racchiude così tutta una teologia e questo non è altra cosa che la speculazione neo-platonica di Hermète Trismegisto. La gerarchia del mondo, l’armonia degli esseri “non soltanto nelle cose che sono visibili, ma anche nelle cose umane che l’occhio non percepisce.” Questo ritorno al platonismo è l’opera degli ebraizzanti. Noi potremmo continuare così la lunga lista degli scrittori e delle opere destinate a diffondere il pensiero giudaico negli ambiente intellettuali del Rinascimento, ma la lista sarebbe fastidiosa ed inutile.
UNA SETTA DI INIZIATI
Nel XV secolo gli umanisti, così formati dalla kabbala giudaica ed impregnati di neo-platonismo, hanno coperto l’Europa occidentale, salva la Spagna dalla quale i Giudei erano stati espulsi, di una rete densa di relazioni e di attive complicità. Essi hanno fatto circolare, prima sotto traccia, e poi sempre più apertamente, una moltitudine di opere di violenta polemica anticristiana, opere nelle quali viene insultato e disprezzato il Papato, si biasimano gli ordini religiosi con un odio feroce contro tutto ciò che potrebbe riferirsi all’ascesi, alla rinunzia, alla povertà volontaria … Legati tra di loro da un segreto comune, gli umanisti praticano un metodo meraviglioso ed efficace per darsi una grande autorità intellettuale sull’élite coltivata del loro tempo, schivando scrupolosamente tutti i rischi connessi al loro accanito combattimento. Essi cominciano con l’assicurarsi la protezione del potente del giorno, un cardinale, un vescovo, un principe, un re, lo stesso imperatore, finanche il Papa. Essi li lusingano di volta in volta senza vergogna, servono indifferentemente l’uno o l’altro. Fidelfo si mette a servizio dei Visconti, poi della Repubblica ambrosiana, poi degli Sforza. Fontana serve indifferentemente gli Aragonesi ed i francesi che erano venuti a cacciarli da Napoli. Appena un personaggio emerge, essi accorrono, si rendono disponibili, lusingano, “scodinzolano e leccano”. – Redigono all’inizio dei loro scritti delle grandi dichiarazioni di ortodossia onde sfuggire ai fulmini dei tribunali dell’Inquisizione o del Santo Officio. Ad esempio, Marsilio Ficino scrive al principio delle sue opere: « In tutte le cose che sono state trattate da me qui o altrove, io non voglio proporre nulla che non sia stato approvato dalla Chiesa ». (« Tantum adsertum esse volo, quantum ad Ecclesia comprobatur »). Una volta assicurati i loro “deretani”, gli umanisti sono di un’audacia incredibile; essi ingiuriano i loro avversari, si prendono gioco dei tribunali ecclesiastici, pubblicano satire incendiarie, ingaggiano violente polemiche, sversano tonnellate di spazzatura sulla Chiesa, soprattutto sugli ordini mendicanti, in tutta impunità. Se talvolta un tribunale ecclesiastico si inquieta e comincia un processo per diffamazione, è ben presto fermato nelle procedure dal potente protettore di turno che interviene discretamente. – Si riporta ad esempio, la storia di Lorenzo Valla: nato a Roma nel 1415, studia la storia, dichiara che la famosa donazione dell’imperatore Costantino alla Santa-Sede è un falso. Allora insulta il Papa, afferma che una cortigiana è più utile allo società di un religioso, pretende di non aver mai incontrato un Papa uomo onesto ed aggiunge una moltitudine di altre “gentilezze” di tal sorta. Deve egli darsi alla fuga e rifugiarsi presso Alfonso il Magnanimo, re di Napoli e protettore degli uomini di preteso talento (cioè degli umanisti), nel 1445. Ma Valla è anche un violento ed un litigioso; egli maneggia meglio la spada che la penna, e la polizia napoletana comincia ad interessarsi di lui e minaccia una tempesta, avendo egli scritto delle cose folli sulla Trinità e sul libero arbitrio. Viene così condannato ad essere bruciato vivo dall’Inquisizione. Ma il re Alfonso interviene, e Valla viene rilasciato per essere frustato nel chiostro di San Giacomo. Egli torna in seguito a Roma ove ha la fortuna di trovare il Papa Niccolò V. il quale gli accorda una pensione; diviene poi canonico, curiale e professore vantato e celebre. – Simile avventura, ugual copione, si legge nella storia dell’Accademia di Roma ove vediamo comparire una vera società segreta. – Un giorno, il Papa Paolo II (1464-1471) destituì dal collegio degli abbreviatori della cancelleria romana, diversi umanisti e li rimpiazzò con altri più sicuri da un punto di vista dottrinale. Nel corso di venti mesi, essi sedettero alla porte del palazzo pontificale senza riuscire a farsi ricevere. Uno di essi, Platina, scrisse allora al Papa minacciandolo di andare a visitare i re ed i principi per invitarli a convocare un Concilio davanti al quale Paolo II avrebbe dovuto poi discolparsi della condotta tenuta nei loro confronti. Questa insolenza lo fede condurre al Castel Sant’Angelo; il resto della truppa degli umanisti, si riunì presso uno di essi, Pomponio Leto. Così nacque l’Accademia romana di cui lo storico Grecorovius ci dice che essa « funzionava come una loggia di classici franco-massoni ». Per evitare di essere perseguiti, i membri di questa accademia si riuniscono in catacombe. Essi celebrano il Natale come anniversario della fondazione di Roma; il loro “papa” è Pomponio Leto, « questo oracolo delle buone lettere, ci dice Antonio di Verona, il capo singolare delle muse, il sovrano pontefice » (maximus pontifex); Platina è chiamato il “pater amatissimus”. Quest’ultimo, Callimacus, Luca Toloza ed i loro amici che « si sono appassionati alla storia di Roma, l’hanno apprezzata, e perché Roma ritorni al suo primitivo stato, hanno deliberato di sottrarre questa città all’assoggettamenti ai preti ». Papa Paolo II si inquieta e verso gli ultimi giorni del febbraio del 1468, la polizia pontificia arresta i membri dell’Accademia con l’accusa di lesa maestà pontificale e cospirazione: essi avevano progettato semplicemente di assassinare Paolo II e proclamare la repubblica. Pomponio Leto fugge a Venezia, ma ripreso viene imprigionato con gli altri nel Castel Sant’Angelo. – Il Papa successivo, Sisto IV, purtroppo, si incarica di mettere in libertà i prigionieri dalla loro prigione. Platina viene nominato addirittura bibliotecario del Vaticano, Pomponio viene ristabilito alla Sapienza. Le riunione dell’Accademia possono quindi riprendere. E qui si riprende a sacrificare a San Vittore, a San Fortunato, a San Genesio: queste sono dei nomi di “copertura” della Fortuna, della Vittoria, del “Genetliaco” della città eterna. Nel 1483 l’imperatore Federico accorda all’Accademia romana, che è definitivamente recuperata, il diritto di creare dei dottori e di incoronare poeti. Il cerchio è chiuso; i sovversivi sono padroni del terreno nella stessa Roma, qui al centro della Cristianità. – Altra società segreta … nel 1545, Sozzini, o Soccino, o Socino, nato a Siena nel 1525, fonda a Vicenza una società segreta per la distruzione del Cristianesimo che vuole rimpiazzare con il “puro razionalismo”. Nel 1546, egli organizza una conferenza a Vicenza ove arrivano delegati da tutta Europa, uniti tra loro dall’odio per tutto il Cristianesimo. Nel corso di questa conferenza si conviene come mezzo per distruggere la Religione di Gesù-Cristo, il formare una società segreta. L’apostata Ochino, vecchio generale dell’ordine dei Cappuccini, è anch’egli presente a questo incontro come uno dei più virulenti. Papa Paolo III, informato di tale conferenza di Vicenza, indirizza una lettera alla Repubblica di Venezia per segnalare questo pericoloso focolaio di corruzione. Si arresta Giulio Trevisan e Francesco de Lugo, che venono giustiziati. Gli altri, tra cui Ochino e Lelio Sozzini, riescono a fuggire. Essi divengono in Europa i propagatori di una nuova dottrina che pretende di ricostruire sulle rovine della Chiesa un tempio che avrebbe accettato tutte le credenze, dal libero pensiero fino al culto di lucifero. Ecco gli inizi della setta massonica e del blasfemo ecumenismo. Alla morte di Lelio, suo figlio Fausto Sozzini (1539-1604) fu suo zelante continuatore. Adriano Lemmi, antico Maestro del Grand’Oriente di Italia, ha presentato, durante la sua elezione, il 29 settembre 1893, Lelio Sozzini come il vero padre della franco-massoneria. – La complicità delle grandi autorità politiche e religiose è considerevole in questa diffusione delle sette anticristiane nel corso del Rinascimento. Re, imperatori, cardinali, finanche Papi, si fanno efficaci e zelanti protettori di coloro che preparavano la loro caduta … incredibile e colpevole accecamento! – Un giorno che Erasmo, sconvolto davanti alle conseguenze violente di una riforma protestante che egli aveva singolarmente contribuito a fomentare, scriveva della sua sconfitta al suo amico, il principe Alberto di Carpi; costui gli risponde sottolineando per bene le vere responsabilità: « I principi ecclesiastici ed i laici, egli scrive, raccolgono ora i frutti della semenza che hanno sparso a profusione, o di cui essi tutti hanno almeno favorito la crescita. Sono i poeti che hanno contribuito più ad eccitare in Germania la rivola contro la Chiesa e la società. Sono essi che hanno incoraggiato tutte queste violazioni del diritto di cui noi siamo tutti i giorni testimoni. Ma chi dunque ha sostenuto questi uomini? Sono i dignitari ecclesiastici, finanche quelli di rango più elevato. Essi hanno intrattenuto alle loro corti voluttuose queste persone dalle tendenze semipagane, che gettano il disprezzo su tutto ciò che sia rimasto caro al popolo e non hanno altro scopo che di ribaltare tutto ciò che esiste. » Questa lettera è estratta dai “Lucubrationes” nelle quali Erasmo, deluso dai risultati della riforma luterana, aveva raccolto i documenti nell’ultima parte della sua vita.
[1. Continua …]