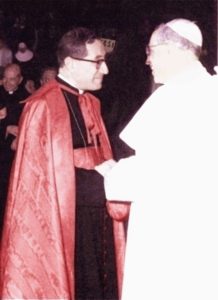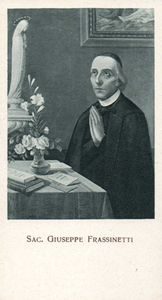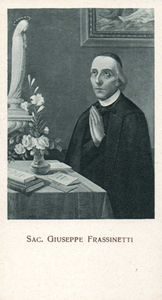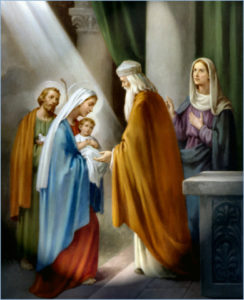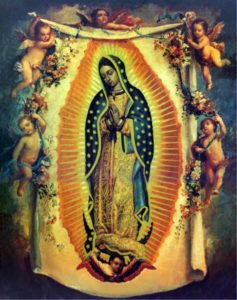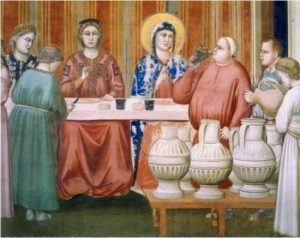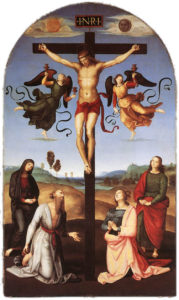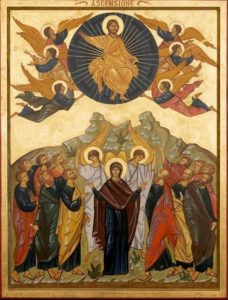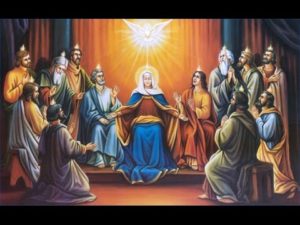[D. Gaspare Gilli: PICCOLO MESE DI MAGGIO AD USO DEL POPOLO; Tip. Dell’Imm. Concezione ed. – 1864]
I. GIORNO
Maria prima della creazione.
Da tutta l’eternità il Signore ha decretato il mistero dell’Incarnazione di suo Figlio e preparato i mezzi che servir dovevano ad attuare quest’atto d’infinito amore. Quindi da tutta l’eternità eziandio egli conobbe Maria, la elesse fra tutte le donne, l’amò con amore di singolare preferenza, la fece sua sposa. Laonde possiamo dire che, nella mente di Dio, Maria già esisteva nel cielo, prima di tutti i tempi, accanto a Gesù, Pontefice eterno, e che già stava preparato in salute del mondo questo capolavoro della divina misericordia. Il mondo aveva ancora da imparare a riporre in Maria tutta la sua speranza, e già destinata era Maria a riparare ad ogni futura disgrazia del mondo. Ecco il perché noi siamo sì cari al suo cuore; ecco il perché non cesserà mai la Santa Chiesa d’invocarla: Salute degli infermi, Rifugio dei colpevoli, Aiuto dei cristiani, Consolatrice degli afflitti e via dicendo; perché dal nostro infortunio appunto nacque la sua gloria. – Io ancora fui da tutta l’eternità presente al pensiero di Dio, e da Lui infinitamente amato. Da tutta l’eternità mi preparò i benefici e le grazie che adesso con tanta liberalità mi largisce. Alla mia salute si riferisce tutto il piano dell’Incarnazione e della Redenzione. L’amor di Dio verso di me, fu in certa guisa, più disinteressato di quello che ebbe per Maria, perché fui da Esso amato malgrado la schifosa lebbra del peccato di che già vedevami contaminato, mal grado la previsione dell’abuso che avrei fatto delle sue grazie, malgrado la mia sconoscenza, e la mia malizia. E non mi risolverò ancora di porre un termine al corso, oimè! Già troppo protratto delle mie ingratitudini e delle infedeltà mie?..
ESEMPIO.
La Spagna si distinse mai sempre per la sua venerazione verso la Madre di Dio; già ne celebrava le feste priaché fossero venute a notizia di altri popoli eziandio cattolici; si distinse ancora per la moltitudine e la magnificenza dei santuari, degli oratorii a lei dedicati; per il gran numero dei Santi devoti di Maria, e degli ordini religiosi istituiti a di Lei gloria. Presentemente ancora distinguesi la Spagna pel suo culto alle statue ed alle immagini della SS. Vergine; si trovano rinomatissimi santuarii a Madrid, Saragozza, Toledo, Siviglia, Gruadalupa, Valenza, Barcellona, Agreda, ed in quasi tutte le città e villaggi le confraternite del Rosario e dello Scapolare. Passo sotto silenzio il suo culto verso l’immacolata Concezione, poiché ne parlai in altra operetta – Il mese dell’Immacolata Concezione – Dirò solamente che nel 1859, dichiarata la guerra all’impero del Marocco, la regina Isabella II fe’ preparare per l’armata belligerante uno speciale vessillo, sul quale era dipinta l’immagine di Maria concepita senza peccato. E le rapide e decisive vittorie riportate dagli Spagnoli in quella sì malagevole guerra, ben provarono che non indarno si venera Maria, e nel suo patrocinio si confida.
Orazione.
O Vergine tutta piena di dolcezza, di bontà, di clemenza, la quale non foste arricchita dal Signore di tanta potenza e bontà, se non perché vi faceste per tutti i secoli la consolatrice degli afflitti, il sostegno dei deboli, il rifugio de’ poveri peccatori, deh! pregate per me adesso, e nell’ora della mia morte. Così sia.
OSSEQUIO.
Portate sul cuore l’immagine di Maria; e premendola con affetto al seno, ditele spesso: Questo cuore, o Maria, voglio che sia tutto vostro.
GIACULATORIA.
Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
Lasciate, o Vergine,
Che anch’io vi onori:
Voi siete l’unica
Gioia de’ cuori.
-343-
O Domina mea, sancta Maria, me in tuam
benedictam fidem ac singularem custodiam et
in sinum misericordiae tuae, hodie et quotidie
et in hora exitus mei animam meam et corpus
meum tibi commendo: omnem spem et consolationem
meam, omnes angustias et miserias meas,
vitam et finem vitae meae tibi committo, ut per
tuam sanctissimam intercessionem et per tua
merita, omnia mea dirigantur et disponantur
opera secundum tuam tuique Filii voluntatem.
Amen (S. Aloisius Gonzaga).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, quotidiana orationis recitatione in integrum mensem producta (S. C. Indulg., 15 mart. 1890; S. Pæn. Ap., 28 mari. 1933).

II. GIORNO.
Concezione di Maria.
Non v’ha dubbio che l’anima di Maria non sia stata fregiata dal Signore di tutti i doni della natura; ma non v’ha dubbio neanco che il più prezioso di questi doni, quello senza cui un nulla sono tutti gli altri, si è il dono della santità. Maria fu concepita senza peccato, è dogma di fede, la fede de’ figli suoi. Tutti i discendenti di Adamo sono redenti, purificati pei meriti del Redentore; Maria sola è preservata: ricevono gli altri una grazia di purgazione, di riparazione; riceve Maria una grazia di preservazione, di conservazione. Quindi fin dalla sua concezione Ella è dotata del perfetto uso di ragione, e di tutte le grazie che sono ad un tempo il principio, le compagne, gli effetti d’una più che angelica innocenza. Quindi ancora il suo cuor puro, la sua anima innocente, il suo spirito ripieno di sapienza e d’intelligenza, fin da quel punto elevaronsi naturalmente e senza sforzo verso il cielo: fin da quel punto Maria conobbe, adorò, amò il Signore con maggior ardore dei serafini: fin da quel punto Maria poté dire: II mio amore è il mio peso. – Ed io, figlio del peccato, caduto nel fango al primo mio passo nella vita, col marchio dell’anatema del padre mio in fronte, contaminato dalla colpa della mia madre, schiavo d’un padrone infame e crudele, non ho, non sento propensione, attrazione che pel male! verso il male si diressero le prime mie inclinazioni; non cerco se non il male; non respiro, non conosco, non opero che il male! Io posso a tutta ragione esclamare: Il mio peso, il movimento del mio cuore è un principio di male…. Ed ardisco camminare con la testa alta; ardisco nutrire pensieri di vanità, di superbia, io schifoso verme di terra, io disprezzabile composto di lordura e di peccato!
ESEMPIO.
L’Algeria, celebre contrada del nord dell’Africa, ove la religione cristiana fiorì con tanta gloria, ai tempi specialmente di S. Agostino, vescovo d’Ippona, restò sepolta per molti secoli nelle tenebre del maomettismo. Gli Algerini tuttavolta conservarono l’idea di un Dio solo, e del culto della Madre del Messia. Ma dal 1839, epoca in cui fu creato il primo loro vescovo Monsignor Dupuch, la religione cristiana risorse a vita novella. Un misto di stupore e di edificazione s’impadronisce del cuore nell’osservare questi Arabi teneramente commossi alla vista delle immagini di Maria. Quando nelle solennità, la processione percorre la città, essi piegano il ginocchio dinanzi allo stendardo della Vergine Immacolata, e nelle infermità de’ loro figliuoli, corrono innanzi tutto ad offrirli a questa tenera Madre, perché credono che là è la salute degli infermi.
Orazione.
Balzò di gioia il cuor mio, o Vergine innocentissima, in udendo la voce del successore di Pietro annoverare tra i dogma di fede l’Immacolata vostra Concezione. Io lo credo questo dogma, e vorrei mi fosse dato soscriverlo col mio sangue, e morire ripetendo col cuore pieno di amore: O Maria concepita senza peccato pregate per me che a voi ricorro. Così sia.
OSSEQUIO.
Fate una visita ad un’immagine di Maria, e raccomandate caldamente alla sua intercessione l’anima vostra.
GIACULATORIA.
Salva, me, Domina, salva me.
Un dono voglio
Da voi, Maria;
Salvate, pregovi,
Quest’alma mia.
# # #
Ave Maria, etc.
O Domina mea! 0 Mater mea! Tibi me totum
offero, atque, ut me tibi probem devotum, consecro
tibi oculos meos, aures meas, os meum,
cor meum, piane me totum. Quoniam itaque
tuus sum, o bona Mater, serva me, defende me
ut rem ac possessionem tuam.
[Indulgentia quingentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodooblationis actus quo tidie per integrum mensem pie iterates fuerit (S. C . Indulg., 5 aug. 1851; S. Pæn. Ap.,
21 nov. 1936).

III. GIORNO.
Nascita di Maria.
Maria nasce nell’oscurità e nel silenzio; viene al mondo, come la grazia, senza strepito, senza splendore. Deposta in povera culla, la sua nascita non è festeggiata che dai suoi genitori e da qualche congiunto. Che se ignari della loro fortuna, insensibili dìmostraronsi gli uomini, chi può ridire qual fu il primo sguardo di amorosa compiacenza abbassato dall’augusta Trinità sopra questa benedetta fanciulla? Sì, la mano dell’Onnipotente si stese con ineffabile tenerezza sopra Maria, la quale, fin da quel primo istante, già faceva ascendere al trono di Lui l’ossequio delle più pure e più fervide adorazioni. Rischiarata da lume celeste, Maria già ravvisa la vita che per Lei comincia, sotto il suo vero punto di vista; un viaggio più o meno lungo che mette all’eternità; un tempo di prova; un campo ove pochi giorni sono concessi all’uomo per seminar nel tempo quello che desia raccogliere nell’eternità: quindi si getta con perfetto abbandono tra le braccia del Signore, domandandogli una sol cosa, amarlo, amarlo sempre con novello ardore; ed intrepida s’avvia per la strada che se le apre dinanzi, e che dovrà innaffiare di tante lacrime. – Ad esempio di Maria abbiamo noi considerata la vita al lume della fede? Oimè! I primi nostri anni furono di dissipazione, e di oblio del Signore. Ben lungi dal ravvisare la vita come un tempo di prova, destinato alla conquista del cielo, l’abbiamo tenuto qual lungo giorno di festa che tutto scorrere doveva tra i piaceri. Poi, allor che l’età dell’esperienza sottentrò alle illusioni della giovinezza, invece di considerarci quali viaggiatori sviati, e piangere nell’amarezza del cuore il lungo tratto di vita percorso senza Dio, ci siamo ingolfati negli interessi del tempo senza por mente a quelli dell’eternità, senza por mente che ben tosto verrà la morte a gettarci poveri e nudi d’ogni merito ai piedi del tribunale del Giudice eterno! E adesso che cosa risolviamo?….
ESEMPIO.
Fin dal II, secolo della Chiesa, con la propagazione del Vangelo si propagò in Germania, vastissima contrada posta nel centro dell’Europa, il culto di Maria; e già le di lei feste solennizzavansi con grande magnificenza ai tempi di Carlo Magno. Tutti gli imperatori, pochissimi eccettuati, fino al regnante Francesco Giuseppe, si professarono devoti di Maria. S. Stefano la proclamò signora dell’Ungheria; Ottone I pose la Baviera sotto la di Lei protezione; Federico il Vittorioso la Sassonia; Massimiliano II la Boemia; Ferdinando III tutta l’Austria; ed un gran numero di regine assunsero l’augusto nome di Maria. Fra tutti i sovrani però, quelli d’Austria dimostraronsi i più zelanti per la gloria dell’Immacolata Concezione; fin dal 1725 ottennero dalla s. Sede il privilegio al loro clero di recitarne l’ufficio in tutti i sabati, ed in mezzo alle molte statue di bronzo dei suoi imperatori, Vienna lascia vedere sulla piazza principale, la statua della Vergine innalzata da Ferdinando III nel 1629, sul cui piedestallo leggesi: Alla Vergine Madre di Dio concepita senza peccato. Le strade della Boemia, Sassonia, Ungheria, ecc., sono seminate di statue e d’immagini di Maria; numerose le cattedrali a Lei dedicate.
Orazione.
Prostrato ai piedi della vostra culla, o celeste bambina, vi offro l’omaggio della mia adorazione e dell’amor mio; ma deh! voi permettetemi che, da questo istante, unisca la mia vita alla vostra, onde renderla gradita al vostro divin Figlio, e copra la mia nudità col dovizioso tesoro dei vostri incomparabili meriti. Così sia.
OSSEQUIO.
Se avete qualche peccato mortale, andate subito a confessarvene, oppure detestate quelli che commetteste per lo addietro.
GIACULATORIA.
Solve vìncla reis, Profer lumen cæcis.
Il pie’ scioglietemi
Da lacci rei;
E luce fatevi
Degli occhi miei.
348
Concede nos famulos tuos, quæsumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitategaudere; et, gloriosa beatæ Mariæ semper Virginis
intercessione, a præsenti liberari tristitia et æterna perfrui lætitia.
Per Christum Doninum
nostrum. Amen (ex Miss. Rom.).
Indulgentia trìum annorum.
Indulgentia plenaria suetis conditionibus, oratione quotidie
per integrum mensem devote repetita (S. Paen. Ap.,
i8 mart. 1935).

IV. GIORNO.
Infanzia di Maria.
E il fanciullo cresceva in sapienza, in età, in grazia dinanzi a Dio, e dinanzi agli uomini. Tale fu il Figlio: tale per conseguenza esser dovette la Madre, ricevendo ognora, ed ognora più rendendosi fedele nel corrispondere alla grazia ricevuta. Il corpo di Lei prendeva lente proporzioni, ed in ragione dell’età; la di Lei anima però batteva a passi di gigante la strada della perfezione. Ma qual perfezione non chiedeva da Maria l’eccelso ministero che doveva poi un giorno esserle affidato? E Maria, fedele, obbediente agli impulsi della grazia, docile alla voce del Dio che la custodiva e governava, non pose mai il menomo ostacolo, non mai arrestò il corso della grazia nel proprio cuore; laonde per un progressivo accrescimento di celeste soccorso, pervenne a sì fatto apice di virtù, di meriti e di grazie che vincerà sempre ogni nostro concetto, come ogni nostra espressione. – Ed a me quando mai mancò la grazia, e quando mai le ho io corrisposto? Ah! sì preziosa è la grazia che un’anima, la quale siane in possesso, può ad ogni istante alzare al cielo uno sguardo di speranza, d’amore, e dire a se medesima: Là è la mia patria, là io sono amata, attesa, desiderata: là ho un Padre il cui amore veglia sopra di me, la cui orecchia sta sempre aperta alle mie preghiere, il cui cuore s’intenerisce ad ogni mio sospiro; là infine ho un possente mediatore il quale perora la mia causa presso il Padre suo; una Madre e dei fratelli che mi tendono la mano onde ajutarmi a raggiungere il trono che mi sta presso di loro preparato. Eppure! io che sono sì sensibile agli avversi colpi di fortuna; io che sono inconsolabile nella perdita della sanità, de’ parenti, ho fatto lagrimevole getto d’un bene così prezioso qual è la grazia, e poi non solo non trovo una lacrima a spargere per una perdita sì grande, ma vivo gli anni interi senza darmi pensiero di riacquistarla! O Maria, o Madre mia, pietà, soccorso!
ESEMPIO.
L’Anatolia, la Siria, la Palestina, le quali stavano tanto a cuore agli Apostoli, fin dalla culla del Cristianesimo, e distinguevansi per la loro fede e per la loro divozione verso l’immacolato Cuore della Vergine tutta santa, presentano pur anco oggi giorno non pochi esempi di fedeltà alla vera religione e di pietà verso Maria. Nicomedia, Nicea, Smirne, Efeso, Antiochia, Neocesarea, Damasco, Tiro, Palmira, ecc., ricche di religiose rimembranze, queste celebri città conservano ancora molte immagini, statue, reliquie della Madre di Dio, e rispettosi gli abitanti inchinansi tuttora dinanzi ai venerabili avanzi degli antichi santuari, ove cantavansi altre volte le di Lei grandezze, ed i prodigi da Dio operati in virtù delle di Lei orazioni. Così le antiche città della Palestina: Nazaret. Betlemme, Gerusalemme, Ioppe, Edessa ecc., nomi sì cari al cuore cristiano, e sono e saranno mai sempre l’oggetto d’incessanti pellegrinaggi.
Orazione.
O Madre della grazia, sovvengavi che io sono la debolezza, la fragilità in persona; vegliate voi medesima alla custodia del prezioso tesoro che mi fu dal Signore confidato; proteggetemi, difendetemi, copritemi col manto della vostra materna protezione fino all’estremo mio respiro. Così sia.
OSSEQUIO.
Fate un atto di mortificazione della gola in penitenza delle soddisfazioni illecite date al vostro corpo.
GIACULATORIA.
Munda cor et corpus meum, Sancta Maria.
Questa mia carne
Questo mio cuore
Purgate al fuoco
Del vostro amore.
347
Adiuvet nos, quæsumus Domine, gloriosæ
tuæ Genitricis semperque Virginis Mariae intercessio
veneranda: ut quos perpetuis cumulavit
beneficiis, a cunctis periculis absolutos,
sua faciat pietate concordes: Qui vivis et regnas
in sæcula sæculorum. Amen (ex Miss. Rom.).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodoquotidiana orationis recitatio i n integrum mensem produhierit
(S. Pæn. Ap., 6 febr. 1934):

V. GIORNO.
Presentazione di Maria al tempio.
Maria conta appena tre anni di vita, e già la vediamo condotta al tempio da’ suoi pii genitori; vanno essi a trapiantare a pie degli altari del Dio vivente questo giglio abbagliante di purezza e d’innocenza, onde cresca e si spanda all’incontaminata ombra del santuario. Per riguardo a Maria, si è il suo cuore che la guida al tempio; il suo cuore tutto ardente d’amore non è penetrato che da un pensiero, da un desiderio: essere tutto del Signore senza interruzione di tempo, senza divisione d’affetti. Il mondo non conteneva pericolo di sorta per la Vergine Immacolata, e vi avrebbe potuto vivere pura e senza macchia; è vero: Maria tuttavolta vivere doveva vicino a Dio. Fanciulla, il suo posto è il santuario; madre presso la culla del Figlio; poi un giorno presso la croce di Lui; più tardi alla destra di Lui ne’ cieli. – Voleva il Signor che la vita di Maria offrisse un modello a tutte le persone del suo sesso, quale che fosse la posizione in cui sarebbersi trovate; laonde cominciò a darla perfetto esemplare a quelle che avrebbero un giorno eletto la miglior parte, e rinunziato a tutto per non possedere che Lui solo. – Quanto differente è la nostra condotta! Non che imitar Maria nell’offrire a Dio le primizie della nostra vita, crediamo di far gran cosa nel conservargliene i miserabili avanzi. E nulladimeno abbiamo appreso fin dalla nostra infanzia che fummo creati all’unico fine di amare e servire il Signore, e per tal via conseguire la vita eterna. Non sono tutti chiamati come Maria a rinunziare ad ogni terreno affetto o legame, onde consacrarsi a Dio in un chiostro; ma nessuno tuttavia è dispensato dal dovere di tendere alla perfezione propria del suo stato o della sua condizione. L’essenziale, su che trovasi, generalmente parlando, fondata l’eterna nostra salute, si è di corrispondere ai disegni di Dio, vedere di conoscere la propria vocazione, e poi generosamente seguire la divina chiamata.
ESEMPIO.
La Religione Cattolica, abbracciata dalla Svizzera fin dai primi tempi del Cristianesimo, vigorì in tutta la sua purezza fino al secolo XVI, in cui Lutero, Zwinglio e Calvino vi seminarono l’eresia. Presentemente sono misti insieme eretici e cattolici, ed i templi dedicati a Maria, dei quali non pochi sono venerabili per la loro antichità, trovansi seminati, come porti di salute, in mezzo alle popolazioni sedenti nelle tenebre dell’errore. A Unterwald, ove il pellegrino non iscorge sotto a’ suoi piedi se non ispaventevoli precipizi, e sopra il suo capo enormi massi di pietra quasi lanciati in alto, avvi un santuario adorno di graziosi dipinti, rappresentanti gli attributi della SS. Vergine, nel quale si venera da parecchi secoli una celebre statua chiamata Nostra Signora del Passeggero. Qui vengono i Calvinisti medesimi nelle loro afflizioni ad implorare la misericordia di Maria. A Einsiedeln il santuario di Nostra Signora la miracolosa, è sempre affollatissimo di pellegrini d’ogni regione; nel 1859 vi si recò con tutta la sua famiglia Carlo Antonio, principe regnante di Hohenzollern-Sigmaringen. All’abbadia del medesimo villaggio, in una sotterranea cappella, incavata nel vivo masso, si onora l’antica e graziosa immagine della beata Vergine, chiamata Nostra Signora della Pietra, meglio nota però sotto il titolo di Nostra Signora degli Eremiti, rinomatissima per sorprendenti prodigi. – A questo santuario pellegrinarono nel 1858 l’arciduca Luigi d’Austria, fratello dell’attuale imperatore Francesco Giuseppe; e nel 1859 un grandissimo numero di ufficiali francesi ed austriaci. In Ginevra finalmente, metropoli del Calvinismo, Monsig. Marilley vescovo di Losanna, accompagnato da tre altri vescovi e da più di 150 sacerdoti, consacrò una magnifica chiesa dedicata all’Immacolata Concezione.
Orazione.
O Vergine immacolata, la quale con fedeltà sì perfetta corrispondeste ai disegni di Dio, insegnate alla povera anima mia la strada che batter dee per non perdersi; e poi, quale che ella siasi, impetratemi quello spirito di generosità che fa coraggiosamente superare ogni ostacolo, e trovare tutta la sua felicità nell’ adempimento della volontà divina. Così sia.
OSSEQUIO.
Eccitate qualche orazione in onore di Maria.
GIACULATORIA.
Vitam prcesta puram, iter para tutum.
O Madre datemi
Un alma pura:
Del ciel mostratemi
La via sicura.
349
Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes,
refove flebiles, ora prò populo, interveni
prò clero, intercede prò devoto femineo sexu:
sentiant omnes tuum iuvamen, quicumque celebrante
tuam sanctam commemorationem
(ex Breviario Rom.).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummododevota orationis recitatio, quotidie peracta, in integrum
mensem producta fuerit (S. Pænit. Ap., 29 maii 1936).

VI. GIORNO
Dimora di Maria nel tempio.
Nascosta nella solitudine del tempio, Maria non ha che un desiderio: glorificare il Signore e ad ogni respiro di sua vita dargli un novello attestato dell’amor suo. Ma per giungere a questo fine non ignora ella non esser d’uopo di fare strepitose azioni, le quali risveglino l’ammirazione degli uomini, severamente eseguire la volontà divina, né esser altra questa volontà divina se non il perfetto adempimento dei doveri annessi allo stato in che ella ci ha posto. Quali sono i doveri dello stato di Maria? Quelli di tutti i fanciulli in generale, e specialmente delle giovani figlie; la preghiera, il lavoro, l’obbedienza, la carità. — Più infiammata d’amore che i serafini l’anima di Maria elevavasi a Dio con prodigiosa rapidità ed agevolezza. — Dall’orazione passava al lavoro; ma la sua intima ed abituale unione con Dio volgeva in una incessante preghiera ogni suo lavoro, ogni sua azione. — Posta sotto l’ubbidienza, un desiderio di chi la guidava, equivaleva per Lei ad un comando; e faceva consistere la propria felicità nel prevenirne eziandio gli ordini ed i desideri, — Educata nel tempio in compagnia di altre fanciulle, Maria copriva col velo di carità le loro imperfezioni, ed alla loro invidia non opponeva che dolcezza ed invitta pazienza. La santità che Dio da noi richiede, consiste nell’adempire esattamente i doveri del nostro stato; ed adempirli con l’unico intento di piacere al Signore e fare la volontà sua. Fuori di qui, non vi ha, non dirò perfezione, ma neanco salute. Sì, intendiamola bene, negligentare i propri doveri sotto pretesto di occuparsi in opere più perfette, la è grossolana illusione; e le opere che noi anteponiamo ai propri doveri, per quantunque sante esser possano in se medesime, non che tornar gradite al Signore, ci costituiscono colpevoli e degni di punizione al divin suo tribunale.
ESEMPIO.
La Russia, impero sì vasto al presente, era ancora un deserto nel iv secolo. S. Ignazio di Costantinopoli vi mandò missionari nell’870. Nel 950 fu solennemente battezzata la principessa Olga col nome di Elena, e tosto per ogni dove edificaronsi templi all’augusta Madre del Salvator del mondo. Valdimiro I nel 992 nella città da lui edificata, ed alla quale impose il proprio nome, eresse un sontuoso tempio, in cui collocò un’immagine di Maria, inviatagli da Nicolao patriarca di Costantinopoli, divenuta poi rinomatissima pei prodigi che operava. Si è alla vista di quest’immagine che Pietro il Grande pose fine alla strage degli Strelitz nel 1698. Separandosi con la scisma dalla Chiesa romana i Russi non abbandonarono già il culto di Maria. Dedicata all’Assunzione di Maria è la più bella chiesa di Mosca, la cattedrale; se ne porta processionalmente l’immagine sotto un magnifico baldacchino, ed eziandio nella casa degli infermi a loro consolazione e sollievo. Ad una porta del Kremlin è sovrapposta una prodigiosa immagine della B. Vergine guardata da due sentinelle a capo scoperto. Dinanzi a questa profondamente inchinossi Napoleone I nel 1812. – Fino alla superstizione spingono il culto di Maria i Russi. Si è per tale motivo che Mosca è considerata come una città santa, ed in essa fannosi incoronare gli imperatori.
Orazione.
O Maria, perfetto esemplare di tutte le età, di tutte le posizioni in cui possono trovarsi le persone del vostro sesso, ottenetemi la grazia che, a vostro esempio, io doni un principio di vita a tutte le mie azioni per mezzo di un’intima ed abituale unione con Dio, onde possa, all’uscir dal tempo, ricevere nell’eternità il guiderdone promesso a chi è fedele nelle piccole cose. Così sia.
OSSEQUIO.
Nelle tentazioni prendete in mano la corona e baciatela. Disgustar Maria mentre baciate il suo rosario, nol farete per fermo.
GIACULATORIA.
A Peccato mortali lìbera me, Domina.
Lungi tenete
Da questo seno
Dell’atra colpa
Il rio veleno.
351
O Mater pietatis et misericordiæ, beatissima
Virgo Maria, ego miser et indignus peccator ad
te coniugio toto corde et affectu; et precor pietatem
tuam ut, sicut dulcissimo Filio tuo in
Cruce pendenti adstitisti, ita et mihi misero
peccatori et fidelibus omnibus sacrosanctum Filii
tui Corpus sumentibus clementer adsistere
digneris, ut tua gratia adiuti, digne ac fructuose
illud sumere valeamus. Per eumdem Christum
Dominum nostrum. Amen.
Fidelibus supra relatam o rationem ante Communionem recitantibus conceditur: Indulgentia trium annorum; Indulgentia plenaria, si quotidie per integrum mensemidem præstiterint et præterea sacramentalem confessionem, alicuius ecclesiæ vel publici oratorii visitationem
et ad mentem Summi Pontificis preces addiderint (S. Pænit.
Ap., 25 maii 1941)

VII. GIORNO.
Voto di Verginità.
Separata ed ignorata dal mondo cresceva Maria in età, in santità, in grazia all’ombra del santuario. Sempre volta dalla parte del cielo, la sua anima pura ed immacolata consumavasi già tra i casti ardori del divino amore, né altra felicità conosceva od altra gloria che la felicità e la gloria d’essere tutta di Dio. Una bocca divina non ancora aveva proclamato l’eccellenza della purità, e Maria già l’ha indovinata col suo cuore, il quale comprende ed ama tutto che è puro e santo. Gelosa quindi di riserbare per Dio solo tutti gli affetti del suo cuore, a Lui si consacra col voto di verginità. Quest’atto eroico, divenuto in seguito l’irresistibile calamita delle anime generose presuppone una prodigiosa virtù, in Maria. Difatto viva più che mai era in que’ giorni tra la nazione l’attesa del Messia; non ignoravasi che nascer doveva dalla prosapia di David; Maria erane un rampollo: qual donna avrebbe rinunziato alla seducente speranza di divenire madre dell’Aspettato dalle genti?… Maria fu più che donna; con questo voto si rese superiore agli Angeli stessi. O Vergine Immacolata! non sarà sterile tanta virtù; a te, a te sola sta riserbata la gloria che fuggi; diverrai madre del Figlio di Dio. Beate le anime dal cuor puro, esse vedranno Dio. Vedranno Dio per l’affettuosa conoscenza che egli loro comunica delle sue grandezze, delle infinite sue perfezioni, delle sue misericordie, dell’amor suo: vedranno Dio per l’attitudine ad abbracciare tutto che a Lui si riferisce, per la facilità a comprendere i misteriosi rapporti che esistono tra il Creatore e la povera creatura. Si Dio rivelasi al cuor puro, gli si manifesta, lo tratta con la dolce ed intima famigliarità di amico ad amico. Ma non obliamo che questo fiore del cielo non agevolmente si acclimata sulla nostra terra: onde conservisi, è d’uopo circondarlo di precauzioni, di sollecitudini assidue; che estrema è la sua delicatezza, e ben poca cosa è sufficiente a cagionargli la morte.
ESEMPIO.
Il Portogallo non ha solamente comune con la Spagna il territorio, ma i costumi eziandio e gli affetti religiosi, il rispetto e la divozione verso l’Immacolato Cuore di Maria. Sì profonde radici aveva piantato la religione cristiana fra questo popolo che, per molti secoli fu l’unica religione permessa: ragione per cui il sommo Pontefice Benedetto XIV concesse ai re di Portogallo l’ereditario titolo di Fedelissimo. – La divozione alla beata Vergine vigorisce tuttora, sebbene la fede abbia rimesso non poco di sua vivezza, e rari sono i Portoghesi i quali non portino lo scapolare di Maria, od una qualsiasi di Lei immagine, purché tuttavolta abbia toccato alcuna di quelle che sono riputate prodigiose. Onorasi a Cieca un’immagine denominata la B. Vergine degli sgozzati, perché, dicesi, molte persone strangolate nella guerra di Alfonso II nel 1253, portate dinanzi a quest’immagine, istantaneamente risuscitarono. – Un’altra è venerata a Villa-Viciosa, sotto il titolo di Nostra Signora della Stella; ed una terza presso Lisbona da parecchi secoli rinomatissima, appellata Nostra Signora dei lumi, presentemente visitata da innumerevoli pellegrini portoghesi e spagnoli.
Orazione.
O Vergine Immacolata, chiamata con tanta ragione da santa Chiesa, Madre senza macchia, giglio splendido di purezza e d’innocenza, pregate per me sì fragile, sì contaminato da innumerevoli colpe. Sovvengavi che vostro figlio io sono; deh! accorrete in mio soccorso nell’ora della tentazione, e della mia morte. Così sia.
OSSEQUIO.
Prostratevi dinanzi ad un immagine di Maria e pregatela a tener lontano da voi i divini castighi.
GIACULATORIA
Mater Dei, ora pro me.
Voi che di Dio
La Madre siete
Potenti suppliche
Per me porgete.
339
Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse
auditum a sæculo, quemquam ad tua recurrentem
praæsidia, tua implorantem auxilia, tua petentem
suffragia esse derelictum. Ego tali animatus
confidentia ad te, Virgo Virginum, Mater,
curro; ad te venio; coram te gemens peccator
assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere,
sed audi propitia et exaudi. Amen.
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, quotidianaorationis recitatione i n integrum mensem producta (S. C.
Indulg., 11 dec. 1846; S. Pæn. Ap., 8 sept. 1935).

VIII. GIORNO.
Annunciazione.
Da qualche tempo Maria, per obbedire ai ministri di Dio, era uscita dal santuario, ed unitasi in matrimonio con l’artigiano Giuseppe. Ma questo sposo, puro e vergine anch’esso, non doveva essere che il custode, il protettore della verginità di Maria. Intanto suona l’ora della nostra redenzione; l’arcangelo Gabriele, ad un cenno dell’Eterno, scende dal cielo, viene a gettarsi ai piedi di Maria, e le dice: Io vi saluto, o piena di grazia; il Signore è con voi. Queste sublimi parole: Piena di grazia, atterriscono l’umiltà di Maria: ah! se Ella inquietasi per un sì rispettoso saluto, qual effetto produrrà in lei la parola del celeste messaggero con cui le domanda il consenso di divenir madre del suo Dio?- Son vergine, risponde la timida fanciulla, e vergine io vo’ rimanere. Ma al sentire che il prodigio dell’amore e della misericordia di Dio sarà in Lei l’opera dello Spirito Creatore, abbassa il capo ed esclama: Io sono l’ancella, del Signore, in me si compisca la di Lui volontà. Sì, niente meno richìedevasi che un abisso di umiltà e di delicatezza per contenere l’abisso dell’amore e dell’annientamento di quell’immensa maestà che non può essere contenuta da cosa alcuna. – Perché mai siamo noi sempre umili unicamente in parole, ed in pratica non mai! Ah! si è perché non conosciamo noi medesimi; che anzi paventiamo lo studio del nostro cuore, perché questo studio,- persuadendoci della nostra debolezza, della grandezza della nostra miseria, c’insegnerebbe ad un tempo l’umiltà; essendo impossibile conoscerci quali siamo in realtà, e conservare qualche stima per noi medesimi. – Oimè! noi siamo un nulla; abbandonati alle proprie nostre miserie, siamo impotenti a tutto; sprovvisti della grazia siamo inabili ad ogni bene, abilissimi ad offender Dio con i più deplorabili disordini, e nulla possediamo che non sia un dono della liberalità del Signore. Laonde chi non è umile commette un furto a Dio, e la più schifosa delle ingiustizie.
ESEMPIO.
La Russia divide presentemente con la Turchia il possesso dell’Armenia, vasta contrada dell’Asia occidentale che abbracciò il culto di Maria col Vangelo fin dal primo secolo della Chiesa. Nella città di Van, la più antica di tutta l’Armenia, si ravvisano ancora i venerabili avanzi d’ un celebre santuario di Maria, erettovi, dicesi, dall’apostolo s. Bartolomeo, quando vi predicò il Dio crocifìsso per la salvezza degli uomini. C’insegna una costante tradizione che veneravasi fin d’allora una prodigiosa immagine della Madre di Dio, affidata dallo stesso Apostolo alle sollecite cure di sante donne. Trovasi nell’Armenia un buon numero di antiche chiese, parecchie delle quali dedicate a Maria, che partironsi tra di loro i Greci uniti, i Greci scismatici ed i Musulmani. Generalmente parlando, fassi ognor più ardente adesso la divozione degli Armeni all’immacolato Cuore di Maria.
Orazione.
O Maria, Vergine purissima, la quale foste la più elevata delle creature, appunto perché foste la più umile, volgete uno sguardo di misericordia sopra di me così pieno di amor proprio, e fate che modellando il mio cuore sul vostro, il quale è parlante immagine di quello di Gesù, possa un giorno conseguir la mercede promessa ai dolci ed umili di cuore. Così sia.
OSSEQUIO
Baciate tre volte la terra, ripetendo a voi medesimo queste parole: Quid superbis terra, et cinis?
GIACULATORIA.
Tu nos ab hoste protege, et mortis hora suscipe.
Nell’ultima ora
Della mia vita
Imploro, o Madre,
La vostra aita.
293
Dignare me laudare te, Virgo sacrata;
Da mihi virtutem contra hostes tuos.
(ex Brev. Rom.).
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suet is conditionibus, si quotidianainvocationis recitat io in integrum mensem producta fuerit.
(S. C. Indulg., 5 apr. 1786; S. Paen. Ap., 28 mari. 1933).

IX. GIORNO.
La Maternità divina.
Erudita nelle sacre scritture, non ignorava Maria quanto caro le sarebbe costato il titolo di Madre di Dio; e che il suo Figlio avrebbe dovuto comprare a prezzo di sangue il nome di Salvatore, e quindi Ella parimenti pagare con lacrime, e lacrime ben amare il nome di Madre. Che farà Maria dinanzi a sì dolorosa prospettiva? Rassicuriamoci: il Signore ha parlato, e l’umile Vergine non sa che obbedire. Si è quindi col sentimento di profonda umiltà, e perfetta sommissione a ciò che tutto chiederà il Signore da Lei e dal suo divin Figlio, che esclama: Io sono l’ancella del Signore, in me si compisca la volontà di Lui. Chiniamo il capo dinanzi a queste parole le quali ci dipingono al naturale il Cuore della nostra Madre del cielo, l’abisso della sua umiltà, l’estensione della sua rassegnazione. Io sono l’ancella di Dio; qui accetta per sé la gloria della maternità divina, e poi più tardi accetterà per sé, per suo figlio le miserie di Betlemme, l’oscurità d’una vita laboriosa, e più tardi ancora gli strazi del Calvario. Ottenuto questo consenso da Maria, il Signore fecondò il seno verginale di Lei con l’onnipotente sua virtù, ed essa divenne vera Madre del Figlio di Dio. Non invidiamo a tanta fortuna di Maria; che per mezzo della comunione siamo noi eziandio chiamati a dividerla con Lei. La comunione ci unisce non solamente alla divinità ma all’umanità ancora dell’adorabile Salvatore; a quel sangue prezioso che pagò sul Golgota il riscatto dell’anima nostra; a quel sacro Cuore che dimostrossi così misericordioso, così sensibile alle nostre miserie. Tale unione con chi mai la contrae Iddio per mezzo della comunione? Con l’uomo: con l’uomo, essere d’un giorno, chiamato dal nulla alla vita dalla di Lui potenza; essere mortale che oggi esiste e domani non è più contato nel novero dei viventi. Approssimiamoci pertanto alla mensa degli Angeli con fede viva, con umiltà profonda, con ardente carità, con purezza di coscienza ed allora diverrà per noi il preludio dell’eterna nostra comunione nel cielo.
ESEMPIO.
Il regno d’ Inghilterra fu convertito al Vangelo nel 590 da s. Agostino, consacrato in seguito primo arcivescovo di Cantorbery. In brevissimo tempo elevaronsi per ogni dove sontuosissime chiese dedicate a D. O. M. sotto l’invocazione di Maria, e non piccol numero di monasteri e di abbadie in di Lei onore, tra cui primeggiano quelle di Glastembury, di Abingdon, di Ramsy, di York, di Westminster. Sorse eziandio un gran numero di cattedrali consacrate alla Regina degli Angeli; per la costruzione di quella di Salisbury impiegaronsi 39 anni, e ne conta poche pari in magnificenza. Una passione, oimè! non frenata nei suoi inizi, bastò a svellere dal corpo della Chiesa questo regno, chiamato per antonomasia, la terra dei Santi; la cupidigia distrusse i monasteri, l’empietà chiuse i templi, e la barbarie trucidò vescovi, sacerdoti, monaci, vergini… Siffatte conseguenze seco si trasse la brutta passione! Povera Inghilterra! In tuo favore non altro abbiamo che lacrime e voti; ma in tuo prò congiungono le loro preghiere alle nostre ed a quelle di Maria, gli Agostini, gli Anselmi, i Tommasi, gli Edoardi, gli Edmondi, e ben già se ne ravvisano i salutari effetti. Noi vediamo quel governo farsi di giorno in giorno meno ostile al cattolicismo: già si contano 926 chiese cattoliche; un cardinale creato nel 1840, 18 tra arcivescovi e vescovi, 1217 sacerdoti esercitano liberamente le loro funzioni. Un gran numero di scuole, di seminarii, di ospizi, di ospedali, la più parte affidati alla tutela di Maria, danno le più care speranze di un prossimo ritorno al seno di santa Chiesa di tutto il regno.
Orazione.
O Maria, primo tabernacolo del Verbo fatto carne, la quale riceveste con tanto amore nel santo vostro seno questo Dio annichilato, ottenetemi le disposizioni necessarie, onde fervorose sempre e meritorie siano le mie comunioni in vita, e sopra ogni altra fervorosa e santa quella che precederà la mia morte. Così sia.
OSSEQUIO.
Nel mettervi a letto figuratevi d’essere al divin tribunale, ed ascoltate ciò che vi dice la coscienza.
GIACULATORIA.
In Die judicìi libera me, Domina.
Nel giorno estremo
Giorno di pianto,
Madre copritemi
Col vostro manto.
-295-
Virgo ante partum, ora prò nobis.
Ave Maria.
Virgo in partu, ora prò nobis.
Ave Maria.
Virgo post partum, ora prò nobis.
Ave Maria.
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, invocationibus quotidie per integrum mensem iteratis (S. C . Indulg.,
20 maii 1893; S. Pæn. Ap., 12 oct. 1934).

X. GIORNO.
Visitazione.
Il bambino che vive nelle castissime viscere di Maria venne a portare sulla terra il sacro fuoco della carità; il suo cuore ne è la sorgente, e già lo accese nel cuore di sua Madre. Al contatto del cuore di Gesù, il cuor di Maria diviene fornace divampante di amore e di carità: questo fuoco è attivissimo epperciò la stimola, la spinge a comunicarlo ad altri cuori. Quindi alla primiera notizia che la situazione d’Elisabetta domanda le sue cure, Maria esce dalla cara sua solitudine di Nazaret, s’avvia verso le montagne della Giudea, e va a costituirsi ancella di colei alla quale ella medesima è immensamente superiore. Ma lo spirito di Maria non conosce quelle idee di preminenza, di dignità, d’autorità, e va dicendo, di che il mondo si pasce con tanta sicurezza; eh! no: più la è grande, e più è umile; né altro ravvisa in Elisabetta che una sua parente la cui avanzata età e gravidanza merita le sue attenzioni. — La carità comunica i tesori del cielo: ovunque passa, Maria semina benedizioni: alle sue parole Giovanni è santificato, Elisabetta profetizza, la casa del Levita esulta di gioia, e Maria prende parte sincera alla felicità di che è cagione. Per poco che si esaminino le parole dell’adorabile Salvatore intorno alla virtù della carità, di leggieri si scorge che questa virtù la vince sopra ogni altra agli occhi di Lui, ed è come la respirazione, la vita del suo divin cuore tutto ardente d’amore verso Dio, e degli uomini. E qual amore? ah! Betlemme, il Calvario, il tabernacolo altamente ci predicano che sì fatto amore non si contentò di parole: operò, sofferse, sacrificossi in pro nostro. Laonde non illudiamo noi medesimi; la carità che Dio esige da noi verso il prossimo esser dee una carità non teorica ma pratica, perciò disse; Tutto che FARETE al minimo dei vostri fratelli, lo considererò come fatto a me stesso.
ESEMPIO.
Fin dal IV secolo noi vediamo s. Adalberto vescovo di Gnesne, comporre inni a Maria per l’armata polacca, la quale combatteva ne’ paesi ancora infedeli della Pomerania e della Prussia. Uno di questi, le cui iniziali erano: Boga Botsica (Madre di Dio), fu per molti secoli il loro cantico guerriero. I Poloni ascrissero mai sempre a loro precipuo onore l’essere detti i figli della Chiesa Cattolica Romana, ed i servi fedelissimi della Madre di Dio, da essi chiamata la Regina del cielo e della Polonia, od eziandio semplicemente la Regina della Polonia. Ad avere un’idea caratteristica della venerazione che questo sventuratissimo regno sentiva per Maria, parmi sufficiente questo fatto. Per legge di stato era formalmente vietato l’imporre a chi che sia il nome di Maria, onde col rendersene familiare il nome, non si venisse a scemar di rispetto verso di Lei; e questa proibizione fu spinta a tal segno che Ladislao IV, impalmandosi a Maria Luigia di Nevers, nel contratto nuziale appose la clausola che la novella regina abbandonerebbe il nome di Maria, perché forse non l’avrebbero i polacchi tollerato. Indarno tentarono per lo addietro la riforma ed il sinodo russo di schiantare questo culto da quella infelice nazione; ma pur troppo! da tre anni sì feroce è la persecuzione mossale dai luogotenenti dello Czar Alessandro, sotto politici pretesti, che quasi quasi presentemente (1867) non rimane più vestigia né di polacchi, né di culto cattolico. Il cielo solo può ancora rimediare a tanto sterminio; preghiamo e speriamo!
Orazione.
O Maria, consolatrice degli afflitti, ispirate al mio cuore un grammo di quella carità che rese l’immacolato vostro Cuore così sensibile alle nostre miserie. Deh! fate che a vostro esempio, io sia pieno di misericordia, d’indulgenza, di compassione pe’ miei fratelli, e specialmente per quelli che mi offendono, o da cui ricevo qualche torto, onde conseguir possa il premio promesso alla carità. Così sia.
OSSEQUIO.
Stando in Chiesa, dite: Se io dovessi star qui in ginocchio per tutta l’eternità, oh! che disperazione. E nell’inferno! e nell’inferno!
GIACULATORIA.
A pœnis inferni libera me, Domina.
Dal cupo, orribile
Eterno esilio
Madre salvatemi
Son vostro figlio.

XI. GIORNO.
Il Magnificat.
Continuiamo ad ammirare i prodigi di che è feconda la visita di Maria ad Elisabetta. — La Vergine immacolata ascolta le lodi che le sono prodigate dalla cugina ad ispirazione di Dio; non le rifiuta queste lodi, che la vera umiltà come ama la verità così odia e detesta la menzogna. Ma il suo cuor verginale, non che ripiegarsi sopra se medesimo onde compiacersi od invanirsi della propria eccellenza, non pone mente se non ai benefizi del Signore, e trovasi talmente ricolmo da sentimenti di gratitudine e d’amore verso di Lui che, impotente a contenerli dentro se medesimo, simile a vaso troppo pieno, apresi un’uscita, e lega ai secoli avvenire il più soave cantico che vanti la novella alleanza, qual perenne monumento della sua umiltà, riconoscenza ed amore. — L’anima mia glorifica il Signore, ed il mio spirito è rapito di gioia in Dio mio Salvatore, perché guardò l’umiltà della sua ancella; ed ecco che tutte le generazioni mi diranno beata ecc. – E questo inno di paradiso è cantato da Maria a nome di tutti i beneficati dal Signore, di tutti i redenti del Calvario. Ad esempio di Maria, siamo noi riconoscenti ai benefici di Dio? La ricordanza della liberalità di questo Dio, il quale è per noi il Padre più tenero ed il benefattore più generoso, accende per avventura ne’ nostri cuori un profondo sentimento di gratitudine e d’amore? Oimè! l’abitudine di ricevere i benefici dal nostro Dio ci rese insensibili, e ce ne serviamo senza neanco benedire alla mano che sopra di noi li sparge; non ne conosciamo il prezzo se non allorché ne siamo privi; e le nostre labbra che apronsi così spesse fiate onde implorare novelli favori, ignorano poi la via d’aprirsi allorché è d’uopo renderne grazie a Colui dal quale scende ogni dono perfetto. Oh! Perché mai non arrossiamo di comparir ingrati verso Dio, noi i quali arrossiamo di comparir ingrati verso gli uomini?
ESEMPIO.
Sebbene fin dal II secolo, e poi nuovamente nel VI fosse predicato il Vangelo nella Baviera da s. Roberto, possiam dire tuttavolta che la Religione Cattolica, col culto della Madre di Dio, non divenne la religione dominante che nel 755, in cui s. Bonifazio vescovo di Metz e di Magonza fondò l’arcivescovado di Eichstadt. Ottone I pose tutti i suoi stati sotto il patrocinio di Maria. Alla metà del secolo XVIII noveravansi nella Baviera 315 case religiose, tutte dedicate al culto della B. Vergine, e la più parte occupate nell’educazione della gioventù. Ad Alten-Oelting è venerata una prodigiosa statua, celebre per innumerevoli pellegrinaggi che vi si fanno. Frequentatissima da ogni ceto di persone è l’immagine della B. Vergine al monastero della Visitazione in Oggersheim. La festa della Natività solennizzata nella chiesa della santa Casa di Loreto, vi radunò nel 1845, oltre a dodici mila fedeli, di cui otto mila accostaronsi ai Sacramenti, A Munich, in una cappella attigua al convento de’ Cappuccini, si scorge la più gran venerazione a Maria V. Addolorata. La cattedrale di Passau, dedicata alla Annunziazione di Maria, vi trae ogni anno un considerevole numero di pellegrini, e Maria Annunziata li rinvia consolati, paghi nei loro voti.
Orazione.
O Maria, perfetto modello di gratitudine, non permettete che la sconoscenza agghiacci il mio cuore; ma prestatemi il vostro per benedire al Signore di tutti i beni spirituali e temporali a me prodigati, onde la mia vita divenga un continuo ringraziamento, e quest’inno di benedizione, di laude cominciato nel tempo, possa continuarlo perennemente nell’eternità. Così sia.
OSSEQUIO.
Risolvetevi ad una pratica di divozione a Maria da farsi ogni giorno affinché vi liberi dall’inferno.
GIACULATORIA.
Gratias tibi, Virgo, quia non ardeo.
Se tra le eterne
Fiamme non sono,
Vergine eccelsa
Fu vostro dono.
320
Magnificat anima mea Dominum: Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce
enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum
nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies
timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente
cordis sui.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles inanes. Esurientes implevit bonis: et dìvites dimisit inanes.
Suscepit Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiæ
suæ. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham
et semini eius in sæcula.
(Luc., I , 46).
Indulgentia trium annorum.
Indulgentia quinque annorum, si canticum in festo Visitationis B. M. V. vel quolibet anni sabbato recitatum fuerit.
Indulgentia plenaria suetis conditionibus, cantico quotidie
per integrum mensem pie recitato (S. C. Indulg.
20 sept. 1879 et 22 febr. 1888; S. Pæn. Ap., 18 febr.
1936 et 12 apr. 1940).

XII. GIORNO.
Ritorno di Maria in Nazaret.
Come tutti gli sventurati figli di Adamo, e più di tutti Maria doveva essere provata al crogiuolo della tribolazione; conciossiachè predestinata dal Signore ad immensa gloria esser doveva predestinata eziandio ad immensi dolori. Non ci rivela l’Evangelo se Maria fosse ancora presso la cognata al tempo della nascita del santo precursore; certa cosa è tuttavolta che fu mai sempre guidata dal Santo Spirito in ogni sua operazione. Rientrata nell’oscurità di Nazaret, per le necessarie domestiche relazioni s’avvede il casto suo sposo della gravidanza di lei. Quale sconforto per Giuseppe! Che pensa? a che si risolve? Reputeralla colpevole? Oh! no; troppo santa è Maria, e troppa venerazione ispira…. eppure non si può ignorare che Ella è divenuta madre. — Sospende adunque ogni giudizio, ed appigliasi al partito di celatamente allontanarsi da lei; preferendo in sì fatta guisa esporsi al biasimo ed al disprezzo che ne saranno la conseguenza, piuttostochè diffamare la Vergine Immacolata con l’accusarla d’infedeltà al cospetto di tutta la nazione. Maria legge sul volto dello sposo tanta tristezza: con una sola parola potrebbe ridonargli la pace; ma questa parola formerebbe la sua gloria, e l’umile Maria non la pronunzia. – Se il silenzio di Maria è il modello delle anime bersagliate dai falsi giudizi e dalla calunnia, la moderazione di Giuseppe in sì delicato frangente è la condanna delle anime corrive nei giudizi temerari. Non giudicate, e non sarete giudicati: chi pronunziò questo comando e questa promessa si è quel Giudice sovrano ed infinitamente giusto cui avremo un giorno a rendere ragione dal più grave delitto al più intimo palpito del cuore. E noi non ignoriamo neanco che il Vangelo è l’unico codice che verrà da Lui consultato onde profferire inappellabile sentenza; e che allora la misericordia cederà il luogo alla giustizia. Or bene; fu per avventura così santa la nostra vita che nulla ci resti a temere da un giudizio il cui pensiero incuteva terrore ai più gran santi?…
ESEMPIO.
La Lapponia dividesi in russa e svedese. Cristiani sono i Lapponi, ma la lor religione trovasi in generale, sfigurata da assurdissime superstizioni. Le sole religiose idee rette da essi conservate, riguardano il mistero dell’Incarnazione, ed il culto della Santa Vergine, epperciò professano un esemplare rispetto alla croce di Gesù ed alle immagini di Maria. Incerta è l’epoca della loro conversione al cristianesimo. I più accreditati autori la fissano circa l’842, tempo in cui l’apostolo del Settentrione, s. Anscario, evangelizzò la Lapponia, l’Islanda e la Groenlandia. – Un celebre tempio dedicato a Maria, fu eretto nel 1030 a Wardenhuns.
Orazione.
Oimè! colpevole e pieno di miserie, o tenera Madre mia, giudico i miei fratelli con una severità che dovrei riservare per me solo, e riservo per me un’indulgenza che dovrei unicamente usare verso i miei fratelli. Deh! Insegnatemi a conoscere me stesso affinché vivendo nell’umiltà, eserciti la sincera carità. Così sia.
OSSEQUIO.
Fate una visita a Maria onde per voi ringrazi il divin Figlio dei benefici che vi ha fatto, e vi perdoni l’ingratitudine vostra.
GIACULATORIA.
Vita, dulcedo, spes nostra, salve.
Vita dolcissima,
Speranza mia
Salve purissima
Vergin Maria.
-276-
Christe, qui Mariæ et Ioseph
subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus
consecrasti: fac nos, utriusque ausilio,
Familiae sanctae tuæ exemplis instrui et consortium
consequi sempiternum: Qui vivis et
regnas in sæcula sæculorum. Amen (ex Missali Rom.).
Indulgentia quinque annorum.
Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo
orationis recitatio, quotidie devote peracta, in integrum
mens’em producta fuerit (S. Pæn. Ap., 3 sept. 1936).

XIII. GIORNO.
Viaggio a Betlemme.
Era scritto che il Messia doveva nascere a Betlemme. Nascosta nell’umile sua dimora Maria attendeva con profonda pace quel giorno benedetto tanto sospirato dai patriarchi e dai profeti, quando sente da Giuseppe essere necessario recarsi seco lui a Betlemme pel censimento prescritto dall’imperatore romano, essendo ambedue della famiglia di David. In tal guisa il Signore fa servire all’esecuzione de’ disegni suoi la politica ed i capricci degli uomini. Ecco Maria portata da umile cavalcatura, guidata dal santo suo sposo, dirigersi alla volta della città reale. Arrivata alle porte di Betlemme, fa sosta la povera carovana, e Giuseppe s’inoltra a cercar un asilo; ma tutti gli alberghi sono ingombri d’illustri viaggiatori, di doviziose famiglie…, non v’ha ricetto pel povero artigiano. Ei ritorna a Maria e le annunzia l’amaro disinganno; e Maria abbassa il capo e adorando la volontà di Dio, risponde: Fiat. – Una donna commossa a tal vista, loro addita una grotta deserta non lungi dalla città in mezzo alla campagna. O Figlia di David, o Madre dell’Altissimo, ecco la vostra reggia! Vi entra Maria, e volgendo intorno intorno lo sguardo sopra le umide e povere pareti, ripete una seconda volta Fiat. – La povertà preparò la culla al Dio fatto carne, lo accolse al suo ingresso nel mondo, lo seguì sulla terra d’esilio, con Lui fe’ ritorno dall’Egitto in Nazaret, ormeggiò tutti i suoi passi nella privata e pubblica sua vita; Ella ancora lo accompagnò al Calvario, seco Lui ascese il sanguinoso trono della croce; Ella infine gli preparò l’ultimo suo letto. Dopo sì fatti esempi oh! come consolanti, come belle sulle labbra dell’Uomo-Dio risuonano quelle parole che beatificano la povertà, e la fanno sedere sul trono della felicità e della gloria: Beati i poveri di spirito, ché ad essi appartiene il regno de’ cieli. Tutti i santi ottimamente compresero la morale del divino Maestro, e ne fecero lo studio e la pratica di tutta la loro vita; e noi l’abbiamo in orrore, e diciamo col fatto: Beati i ricchi, e pretendiamo salvarci!..
ESEMPIO.
Il culto a Maria venne introdotto in Italia col Vangelo fin dal primo secolo della Chiesa, e rapidissima ne fu la propagazione, malgrado le persecuzioni degli imperatori pagani, e le irruzioni de’ barbari, nemici non meno accaniti della Cattolica Religione, e sempre puro si mantenne come s’addice alla contrada, nel cui centro ha sede il Vicario dell’Uomo-Dio. Impossibile riesce il far menzione dei mille luoghi ove si venerano prodigiose immagini di Maria. Roma sola conta oltre a cinquanta chiese a lei dedicate, e quattordici Napoli. Se questa adesso sì sventurata nazione, può andar superba per l’amore di preferenza dimostratole dal Signore nel costituirla il centro della cattolicità, non può forse andar parimente superba per l’amore di preferenza dimostratole da Maria che in essa volle prodigiosamente trasferita la casa di Nazaret, santificata dalla sua presenza, e da quella del Salvator del mondo? – Onorasi a Torino la B. Vergine della Consolata, a Pisa la Madonna della Spina, a Firenze la Madonna del Popolo, a Mantova la Madonna delle Grazie, a Capotena quella del Rosario, a Carlo-Forte quella della Concezione, a Spoleto quella del Carmine, senza parlare di quasi innumerevoli santuari posti sulla vetta o tra le gole delle più dirupate montagne. Il Tirolo, la Stiria, hanno le case e le vie adorne tutte dell’immagine di Maria.
Orazione.
O Maria, la quale foste veramente povera di spirito e di cuore, ottenetemi stima ed amore alla povertà; fate che, a vostro esempio, io cerchi innanzi tutto il regno di Dio e la sua giustizia, convinto che si avvererà in tal guisa la promessa del vostro divin Figlio, e che tutto il resto mi sarà donato per soprassello. Così sia.
OSSEQUIO.
Ovunque vi troviate, esercitate una particolare modestia in riparazione degli scandali dati al vostro prossimo.
GIACULATORIA.
A delictis meìs munda me, et ab alienis parce servo tuo.
Vorrei perdono
De’ falli miei
De’ falli altrui
Perdon vorrei.
308
Recordare, Virgo Mater Dei, dum steteris in
conspectu Domini, ut loquaris prò nobis bona,
et ut avertat indignationem suam a nobis (ex
Missali Rom.).
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, si quotidie perintegrum mensem invocatio pie recitata fuerit (S. Pæn.
Ap., 22 nov. 1934).

XIV. GIORNO.
Maria al presepio.
Entrata nell’umile tugurio obliò ben tosto la Vergine Immacolata e le fatiche del viaggio e la durezza dei betleemiti, e la terra e tutte le cose della terra, per non occuparsi che del Dio il quale faceale presentire imminente il suo ingresso nel mondo per mezzo d’estasi d’amore sconosciute ai serafini stessi. Ed è frammezzo a quest’estasi di paradiso, che il Dio Bambino uscì dal seno verginale di Maria senza danno alcuno all’integrità di Lei, come il raggio del sole attraversa limpido cristallo senza alterarne benché menomamente la purezza. Il primo vagito dell’adorabile bambino fe’ rientrare in se medesima la Vergine Madre: tremante d’emozione e di gioia contemplò Maria con religioso spavento per qualche istante il Verbo fatto carne: poi prendendolo tra le braccia, lo serrò contro il cuore, lo bagnò di lacrime, adorollo come suo Dio, baciollo come suo figlio. – Oh! chi ci dirà i sentimenti del cuor di Maria in quell’ora avventurata, allorché l’amor di Dio e l’amor materno formarono nel suo cuore un solo amore, e l’inondarono di castissime voluttà? Chi varrà a dipingerci i trasporti d’amore che fece nascere nel cuor di Maria la prima occhiata di Gesù, il primo vagito di Gesù, la prima lacrima di Gesù? Ah! non è dato alla debolezza nostra lo scandagliare questo abisso. Contemplare, adorare Gesù tra le braccia della Vergine-Madre, quale ventura! Ma non possiamo forse visitare Gesù, adorarlo in annichilamenti più profondi ancora, gli annichilamenti dell’Eucaristia? È forse meno amabile nel tabernacolo che nel presepio? meno prodigo di sue grazie? – Il tabernacolo! ah! ecco il centro della luce ove illuminaronsi le intelligenze più prodigiose; la fornace ove si accesero i cuori i più ardenti, la scuola ove si apprese la virtù dei sacrifici i più eroici, la sorgente di acqua viva a cui si attinsero le consolazioni più pure. Eppure per quanti cristiani il Dio del tabernacolo, come il Dio del presepio, è un Dio straniero, un Dio sconosciuto! Ci troviamo noi forse nel novero di questi sconoscenti ed infelici cristiani?….
ESEMPIO.
Antico quanto il Cristianesimo, è nella Corsica il culto della SS. Tergine; vi predicarono l’Apostolo s. Paolo ed i discepoli di san Pietro. La più parte delle cattedrali di quest’isola ricordano un mistero della vita di Maria; l’Assunzione quella di Nebbio, edificata nel VII secolo, e quella di Mariana; l’Annunziazione quella di Corte, e tutti gli altri misteri le numerosissime cappelle di che trovansi seminati i dintorni di Bastia, la cui cattedrale si appella Maria- la- Santa. Fioriscono le associazioni del Rosario, dell’Annunziazione, della Natività, ecc.; quasi tutte le feste di Maria vi sono celebrate coll’ottava. Il più celebre degli oratori è quello di Lavasina sulla spiaggia marittima: malgrado la corruzione de’ nostri giorni, da tutti i punti d’Italia vi accorrono devoti i pellegrini d’ogni età e condizione tra li 8-16 settembre a sciogliere i voti fatti nel corso dell’anno. Nel 1730 (30 gennaio) in generale adunanza riuniti i Corsi elessero Maria per loro sovrana, ed ordinarono che, sull’esergo delle monete corse, venisse inciso: Monstra te esse matrem.
Orazione.
O Maria! la quale foste il sacro altare su cui riposò le tante volte il Verbo incarnato; deh! fate che io trovi le mie delizie nel tenermi ai suoi piedi nel sacramento dell’amor suo, onde, dopo averlo senza interruzione corteggiato nel tempo, venga annoverato tra i suoi adoratori ancora nel gran giorno dell’eternità. Così sia.
OSSEQUIO.
In qualsivoglia luogo v’incontriate in un’immagine di Maria, salutatela col recitare l’Ave Maria, vincendo ogni rispetto umano.
GIACULATORIA.
Sancta Maria, Mater Dei, ora prò nóbis peccatoribus.
Per tutti ì rei,
Pregate Iddio:
Son reo pur troppo,
O Madre anch’io.
311
Benedicta es Tu, Virgo Maria, a Domino Deo
excelso, præ omnibus mulieribus super terram
(ex Missali Rom.).
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, prece iaculatoria quotidie per i ntegrum mensem pie repetita (S. Pænit. Ap., 20 maii 1936).

XV. GIORNO.
Purificazione.
Nella stessa guisa che il sole vibrando i suoi raggi sui fiori non fa che renderne più splendido il colore, più soave l’olezzo, così la nascita di Gesù lungi dal nuocere alla purezza della Vergine-Madre, accresciuta aveala ed adorna di novello fulgore. Laonde per lei non vigorisce la legge della purificazione, né pel suo figlio concepito per opera dello Spirito Santo, figlio unico dell’eterno Padre, è vero: ma, e come potrà non sottomettersi a questa legge, Maria, la quale vide il Figlio di Dio sottomettersi alla legge promulgata pei peccatori, la legge della circoncisione? Dolorosissimo oltre ogni dire fu per la povera Madre questo sacrifizio: non già perché rapisse a Lei dinanzi agli uomini la sua più bella qualità, quella di Vergine incontaminata, figuratevi! Maria non cercava che di nascondere la propria gloria: ma in qual modo velare la gloria di quel desso che Ella così ardentemente bramava di vedere adorato, conosciuto, glorificato da tutte le creature? Presentare al suo popolo come un ordinario bambino l’aspettato della nazione, il promesso dai profeti, il Dio che scendeva a vivere con l’uomo, salvarlo, riaprirgli il cielo? Vani discorsi! Maria allora soltanto si stima avventurata che le è dato glorificare la Maestà sovrana con l’umile ubbidienza alle sue leggi. – Quest’ammirabile ubbidienza di Maria come altamente condanna le continue nostre infrazioni delle leggi di Chiesa santa, ed i mendicati pretesti onde esimerci dall’osservarla! Oh! guai a quei figli ingrati i quali ribellansi alla loro Madre, la deprezzano, contristano il cuore di lei, l’oltraggiano; perché, vano l’illudersi! non è la Chiesa solamente che essi offendono, sebbene Dio stesso. Non limitiamoci tuttavolta ad amarla e rispettarla, con l’umile sommissione alle sue leggi, ma facciamola amare e rispettare dagli altri ancora col prenderne la difesa contro i suoi nemici: Non curiamo i loro sarcasmi; che anzi andiamone superbi; che i sarcasmi e gli insulti tollerati per la nostra fede, diverranno un giorno i nostri titoli di gloria dinanzi a Dio.
ESEMPIO.
Come la Lapponia, così tutte le altre regioni del Nord furono evangelizzate dall’apostolo del settentrione, S. Anscario. Sventuratamente, per mancanza di cristiana istruzione, il culto di Gesù e di Maria trovossi adulterato ben presto da innumerevoli superstizioni. Nel XVI secolo i Danesi, i Norvegesi e gli Svedesi abbracciarono gli errori di Lutero e di Calvino. Una parte ciò non ostante non disprezzabile professa ancora la Religione Romana, e nutre fervida divozione a Maria. Le preghiere che, mercé gli scritti dello svedese P. Stub barnabita, da ogni parte del mondo cattolico salgono a Dio in pro di queste settentrionali regioni, già cominciano a produrre sensibile effetto. In Isvezia con la religione rialzasi visibilmente il culto di Maria. Monsig. Studach vicario apostolico a Stockolm, consacrò (16 settembre 1837) una chiesa a Dio sotto l’invocazione di Maria; e due anni dopo, nella chiesa di s. Eugenia, eresse canonicamente la compagnia dell’immacolato Cuore di Maria. Confidiamo che si degnerà il Signore di esaudire pienamente le nostre preghiere.
Orazione.
O Maria che mi deste un sì prodigioso esempio di ubbidienza alle leggi di Dio e della Chiesa, ottenetemi quella perfetta sommissione che ha sua sorgente nell’amor di Dio. Vegliate eziandio sull’amatissimo pontefice Pio IX, consolatelo, tergete le sue lacrime col ricondurre ai suoi piedi tante anime infelici che l’abbeverano di amarezza, ed infliggono sul paterno suo cuore dolorosissime ferite. Così sia.
OSSEQUIO.
Se tra i vostri libri, o scritti, od immagini possedete alcun che di meno decente, consegnatelo tosto alle fiamme ad onor di Maria.
GIACULATORIA.
Janua cœli, ora prò nobis.
Per queste a voi
Alme fedeli,
Pregate, o lucida
Porta de’ cieli.
312
Regina mundi dignissima, Maria Virgo perpetua,
intercede prò nostra pace et salute, quæ
genuisti Christum Dominum Salvatorem omnium
(ex Missali Rom.).
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodoquotidie per integrum mensem invocatio devote iterata fuerit (S. Pæn. Ap., 10 oct. 1936).
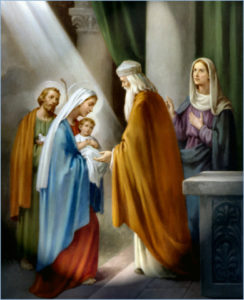
XVI. GIORNO.
Vaticinio di Simeone:
Non solamente per osservare la legge della purificazione venne la Vergine-Madre al tempio, ma eziandio onde deporre sull’altare del Signore l’innocente Vittima delle prevaricazioni di tutti i discendenti del primo fra i colpevoli. In questo mentre, eccoti il vecchio Simeone, guidato dal Santo Spirito al tempio, approssimarsi a Maria, tendere le braccia al divin bambino, adorarlo profondamente, e poi, premendolo amorosamente al cuore, esclamare « I miei occhi videro la salute, or muoio in pace. » Vestendo quindi mestissimo aspetto volge fatidica parola a Maria « Ecco che è posto in ruina ed in risurrezione di molti in Israello; e come segno di contradizione; ed una spada trapasserà l’anima tua » Ben comprese la povera Madre tutto il senso di quelle parole: comprese che il suo Gesù sarebbe quella spada, vale a dire che i suoi dolori formerebbero una piaga sì fatta nel materno suo cuore che, apertavi in quell’istante medesimo, doveva ad ogni giorno, ad ogni ora del giorno, farsi più crudele, più profonda, più lacerante, né più rimarginarsi che sulla soglia del cielo. E tutta volta nella veemenza dell’afflizione, non sa Maria che adorare la volontà del Signore, e pienamente abbandonarsi agli imperscrutabili suoi disegni. Rendiamoci capaci di questa importantissima verità; cioè che il Signore non domanda da noi strepitose azioni, ma la perfetta sommissione della nostra volontà alla sua. Ecco il più gran segno d’amore che sia in nostra mano di dargli, non meno che la più sicura, la più agevole via onde giungere alla più alta perfezione. Facendo la volontà nostra noi bene spesso ci diamo a credere di gradire a Dio, e non soddisfiamo che il nostro amor proprio: laddove sottomettendo la nostra volontà a quella di Dio, per quanto penosa la esser ci sembri, certa cosa è tuttavia che noi soffriamo ma Dio è contento; ed a misura che perfetta è la nostra sommissione, più abbondante farassi la pace nel nostro cuore, e più copiosi saranno i meriti che ci acquisteremo pel cielo.
ESEMPIO.
L’Olanda, regno dopo il 1814, ebbe i suoi apostoli fino dal II secolo: sant’Egisto e san Materno con la fede propagarono il culto di Maria nella Frisia: san Siagrio e san Superiore fra i Batavi. In breve tempo, mercé lo zelo di questi santi, a Tourges, Haarlem, Maestricht, Loeuwarden, Groeninga, Arnhem, ecc. elevaronsi magnifici santuari, ove inneggiavasi a Dio ed alla perfezione dell’immacolato Cuor di Maria. S. Willibrord, primo vescovo di Utrecht, vi edificò una chiesa all’augusta Madre di Dio, mentre altrettanto facevano nella Frisia, s. Bonifazio, e nella Campignia s. Lamberto. Gli errori di Lutero e Calvino penetrarono nell’Olanda nel 1566, e vi fecero pur troppo, orribili guasti; presentemente tutto dà a sperare un non lontano ritorno in grembo alla Chiesa Cattolica. Qualche anno fa, venne ridonato ai cattolici l’antico tempio di Maria, il quale era stato ridotto ad arsenale. Nuovo passo che dà nella divozione verso la B. Vergine, questa contrada.
Orazione.
O Maria, perfetto esemplare di sommissione alla volontà divina, fate che in mezzo alle mie afflizioni, io non dimentichi mai che il Signore non vuole se non quello che è proficuo all’anima mia; e che la mano con cui mi flagella, è mano di amorosissimo padre. Frenate le mie mormorazioni, ed insegnatemi a benedire a quel Desso la cui volontà è sempre piena per me di sapienza, di misericordia, d’amore. Così sia.
OSSEQUIO.
Se mai vi siete raffreddato nella divozione a Maria, fate di riprendere tosto il primiero fervore.
GIACULATORIA.
Et tràhe me, post te, Santa Mater.
Siatemi fulgida
Propizia stella,
Con voi traetemi
Vergine bella.
314
Ora prò nobis, sancta Dei Genitrix, ut digni
efficiamur promissionibus Christi (ex Brev. Rom.).
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria, su etis conditionibus, quotidiana invocationis recitatione per integrum mensem producta (S. Pæn. Ap., 15 dec. 1940).

XVII. GIORNO.
Fuga in Egitto.
Il vaticinio di Simeone non tardò ad avere il suo principio, l’angelo del Signore comparisce a Giuseppe nel sonno e « su, gli dice, alzati, prendi il fanciullo e la madre di Lui, fuggi in Egitto, che Erode cerca a morte il bambino. » Oh! chi non si sente commosso da tenera compassione nel contemplare la Vergine-Madre tremante per la vita del suo divin Figlio, toglierlo dalla culla, stringerselo amorosamente al seno, e, senza permettersi un sol lamento, avviarsi tra le tenebre della notte, senz’altra guida e compagnia che il suo sposo Giuseppe, verso la terra d’esilio? Che non dovette soffrire per anco quest’augusta Trinità della terra, nell’attraversare l’immenso deserto che separa l’Egitto dalla Palestina, senz’altra risorsa per sì lungo cammino che la fiducia in Dio? E poi, giunti i santi esiliati al termine del loro viaggio, non giunsero tuttavolta al termine delle loro pene. In Egitto più ancora che a Betlemme ed a Nazaret, la povertà con tutte le sue privazioni ed umiliazioni, stette indivisa compagna ai loro fianchi. Ma tutte queste prove, tutti questi dolori erano da Dio voluti, e l’umile Vergine, sempre uguale a se stessa, li sopporta in silenzio, con inalterabile pazienza, con perfetta rassegnazione. – Se il Signore volle che Maria prendesse sì gran parte ai dolori umani, non è forse per rendere noi persuasi che la croce è il vero sigillo de’ predestinati? E dall’ora in cui l’Uomo-Dio, barcollante sotto l’enorme peso della croce, guadagnò la vetta del Golgotha, e confitto consumò il sanguinoso suo sacrificio, questa croce sì è fatta non la speranza soltanto de’ discepoli suoi, sivveramente l’eredità loro. Qui non v’ha eccezione: come la morte, così la croce, raggiunge tutte le classi della società, il dovizioso ed il mendico, il vecchio ed il giovane, a tutti Gesù distribuisce alcuna delle spine del doloroso suo diadema, ed a tutti fa sentire: « Colui che vuol essere mio discepolo, rinunzi a se medesimo, tolgasi la sua croce sulle spalle, e mi segua. »
ESEMPIO.
La Grecia, celebre contrada meridionale dell’Europa, fu per la massima parte evangelizzata dall’apostolo s. Paolo, e fervido ognora si mantenne il culto di Maria. Non vi ha forse altro paese così fecondo in ritrovati onde alimentare questo culto; Maria è invocata sotto differenti titoli: vien chiamata Nostra Signora delle Grazie, dei Dolori, della Misericordia, dell’Immenso. Consolatrice, Stella del mattino, Nostra Signora la Vergine-Madre, Nostra Signora Madre di Dio, ecc. ; è rappresentata sotto graziosissimi simboli: di regina in atto di proteggere il suo popolo, di ricca dama in atto di largire copiose limosine, o di medicar infermi, soccorrere afflitti, ricoverare mendici, come stella che rischiara la tenebria del mare ai naviganti: come vascello immobile al rompere delle tempeste: come incrollabile fortezza contro nemici assalti; come porta che mette in cielo, ecc. – La si nomina Panagia, la tutta-Santa, Evangelistria, apportatrice di fauste novelle, Nicopeia, trionfatrice, Phaneromena, rivelatrice di cose salutari, Hodegetria, guida conduttrice, Achatista, preservatrice, ecc. Atene, Megara, Vonitza, Gordiani, ecc.; le isole di Tino, di Delos, di Santorini, vantano superbi santuari di Maria, ne’ quali i Greci scismatici, confusi coi cattolici, implorano il soccorso della Vergine-Madre, ne celebrano i prodigi, e vi cantano inni di grazie.
Orazione.
O Maria, chiamata a sì giusto titolo Madre del dolore, e che conosceste tutte le amarezze della vita, ottenetemi la grazia di accettare ognora in spirito di penitenza le croci cui piacerà al Signore di addossarmi, e di santificarle per mezzo della pazienza e della rassegnazione, onde tutte rivolgansi in meriti dinanzi a Dio, e mi ottengano il premio promesso ai tribolati. Cosi sia.
OSSEQUIO.
Recitate la corona ad onore di Maria, e, se vi è possibile, invitate altri a tenervi compagnia.
GIACULATORIA.
Mater amabilis, ora prò nobis.
O Luce amabile
Degli occhi nostri
Porgete suppliche
Pei figli vostri.
315
Sancta Maria, Dei Genitrix Virgo, intercede prò me.
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria, suetis conditionibus, dummodoquotidie per integrum mensem invocatio devote iterata fuerit (S. Pæn. Ap., 25 febr. 1941).

XVIII. GIORNO.
Amor di Maria verso Gesù.
Onde spiegare qual sia stato l’amor di Maria verso il suo divin Figlio, sarebbe necessaria non la lingua di un Angelo solamente ma il di Lei cuore: basta dire che quest’amore fu una derivazione dell’amor di Dio pel suo Verbo nel cuor di Maria; cuore creato da Lui appositamente per amare Gesù, ed amarlo senza divisione d’affetti. Quest’amore comunicato a torrenti nel cuor della Vergine-Madre dal Santo Spirito nel momento che discese onde fecondare le castissime viscere di Lei, andava ognora più divampando ad ogni sguardo, ad ogni parola, ad ogni carezza che da Gesù riceveva. Arroge che Maria poteva tranquillamente concentrare nel suo Figlio tutta la tenerezza dell’anima sua, tutti gli affetti del suo cuore, perché, in amando il più bello ed il più amabile de’ figli degli uomini, amava il suo Dio. Né sterile già ed ozioso dimorava tanto amore nel cuore di Maria, figuratevi! ei manifestavasi nelle sollecitudini, nella vigilanza con che provvedeva a tutti i bisogni di Lui, e risparmiavagli tutti i patimenti possibili: e queste cure prodigate da Maria verso Gesù con religiosa premura, con profonda umiltà, con illimitata tenerezza divenivano per quell’immacolato cuore gioie ognor novelle, ed alimento ognor novello a più acceso amore. – Nel meditare sull’amor di Maria verso Gesù, la confusione ed il rossore s’impadroniscono come naturalmente dell’anima nostra; vediamo tuttavolta che non nasca in noi scoraggiamento di sorta, sebbene un vivo desiderio di emularlo, quanto sia possibile alla fralezza nostra. Oh! Come passarcela senza Gesù il quale è l’unico nostro padre, fratello, amico, benefattore, tesoro? E se non possiamo far senza di Lui nel corso di nostra vita, che dire del momento di nostra morte? Chi di noi vuol morire senza Gesù, senza appoggiarsi sul cuore di Lui, senza gettar l’àncora delle proprie speranze sulla di Lui bontà infinita? E poi; allorché cangerà la sua qualità di Salvatore in quella di giudice nostro, come non ci riputeremo avventurati d’averlo amato in vita!….
ESEMPIO.
Il regno di Francia, da pochi anni impero, da XIV secoli per lo meno, a nessun altro cattolico paese della terra va secondo nel culto all’immacolato Cuor di Maria. S. Clotilde invocò il patrocinio di Maria, e Clodoveo, riportata una compiuta vittoria sui Germani a Tolbiac nell’anno 496, mantenne la sua promessa, ricevette il battesimo, e divenne zelantissimo dell’onor di Maria. Non è possibile nei stretti limiti di un esempio, diffondermi come sembra richiedere il soggetto; tuttavolta, a dare una sufficiente nozione, basta l’accennare che la Francia nelle sue ottanta diocesi, addita con santa alterigia, quaranta cattedrali che portano il nome dell’augusta Madre di Dio, e cinquanta mila oratorii, ove Maria dimostrasi la consolatrice degli afflitti. I suoi Sovrani da Clodoveo al regnante imperatore, moltissimi dei quali riposero tutta la loro gloria nel dimostrarsi degni del titolo di re Cristianissimi, precedettero con l’esempio i loro sudditi nella devozione e nell’amor di Maria. Questa terra di Maria difese con zelo e perseveranza l’onore dell’Immacolata Concezione: primiera dopo Roma, adottò la divozione del mese di maggio; diede il primo slancio a quella dei sacri Cuori di Gesù e di Maria, e conta migliaia di associazioni in di Lei onore. — O figlia primogenita della Chiesa, tergi, è tempo, le lunghe lagrime dell’amatissimo Pontefice, l’immortale Pio IX! Il Signore in tua mano ha posto i mezzi…. paventa che non ti stimi più degna di tanto onore, e scelga un’altra nazione per frangere le molte catene da che è cinta l’Immacolata sua sposa, e far cessare gli assalti con che tentano stoltamente di abbatterla gli arditi nemici suoi, nemici dell’altare come del trono!
Orazione.
O Maria, madre del bell’amore, insegnate alla povera anima mia la scienza del divino amore: insegnatemi ad amar Gesù con le opere, e non unicamente con le parole, ad amarlo costantemente tra le consolazioni come tra le croci, nella sanità come nelle malattie, onde l’estremo mio respiro sia ancora un atto d’amore per Lui, e di fiducia nella sua misericordia. Così sia.
OSSEQUIO.
Prima d’ogni azione ed in specie tra le tentazioni ripetete tra voi medesimo: Dio mi vede!
GIACULATORIA.
Illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
A noi volgete
O Madre, quelle
Vostre pietose
Tenere stelle
321
Ave maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix cœli porta.
Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace
Mutans Hevæ nomen.
Solve vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces
Qui prò nobis natus
Tulit esse tuus.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos
Mites fac et castos.
Vitam præsta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Iesum
Semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.
(ex Brev. Rom.).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo pia hymni recitatio, quotidie peracta, in integrum mensem
producta fuerit (S. C. Indulg., 27 ian. 1888; S. Pæn.27 mart. 1935).

XIX. GIORNO
Vita nascosta.
La vita di Maria in Nazaret, dopo il ritorno dall’Egitto, nulla, in apparenza, aveva di straordinario. Non scorgevasi in Lei che un’umile e povera donna, modesta, calma, silenziosa, onninamente occupata nelle sue domestiche faccende, ne’ lavori adatti alla sua posizione; che non cercava di comparire, di trarre sopra di sé gli sguardi altrui, fedele all’adempimento di tutti i doveri di religione, nulla nulla singolarizzandosi negli esercizi di pietà, né facendo, a giudizio dell’occhio, se non tutto che faceva quale che si fosse altra pia e fervente israelita. Tuttavolta sotto queste apparenze così umili e così comuni quali tesori di santità e di grazia non erano nascosti! Il disse lo Spirito Santo: « La bellezza della figlia di Sion è tutta interiore; » e questa bellezza celeste, involata ad ogni sguardo, splendeva in tutto il suo fulgore agli occhi del Signore. Sì, la vita di Maria era una vita nascosta, oscura; le opere di Lei piccole in apparenza, e di niuna importanza, ma grandi in realtà erano e del massimo pregio, perché nobilitate tutte, ed in ogni loro parte, dalla purezza d’intenzione, e divinizzate per mezzo dell’incessante unione che Ella facevane con tutte le azioni del suo divin Figlio. – La vita di Maria in Nazaret deve risvegliare in noi non l’ammirazione soltanto, ma un grande ardore di vivere, a suo esempio, in continua unione con Gesù. A tal fine meditiamone senza posa la vita; seguiamolo passo passo dalla nascita alla morte: vediamo segnatamente di penetrarci del suo spirito, modellare sopra i suoi i sentimenti nostri; amiamo ciò che Egli ha amato, disprezziamo ciò che Egli ha disprezzato, desideriamo ciò che Egli ha desiderato. Teniamo costantemente fissi gli occhi sopra questo divino esemplare onde rendere perfettamente uniformi i nostri ai suoi pensieri, la nostra alla sua volontà, le nostre alle sue opere; che egli solo è la via che dobbiamo seguire, la verità che dobbiamo credere ed amare, la vita di cui dobbiamo vivere nel tempo e nell’ eternità.
ESEMPIO.
L’Egitto, evangelizzato fin dal primo secolo della Chiesa, e divenuto meritamente celebre per i suoi deserti popolati dai padri degli anacoreti, non offre più oggigiorno che amare memorie dell’antica sua fama. Paolo, Antonio, Pacomio, Macario, e cento e cento altri furono l’edificazione dell’alta Tebaide per la santità, per l’austerità, per l’operosità della loro vita, e per il loro amore verso Maria. Origene fe’ illustre la bassa Tebaide, per la scuola da lui diretta, e per la difesa del culto di Maria, sostenuta contro Berillo. Credesi che la dimora della santa Famiglia in Egitto sia stata tra Alessandria ed il Vecchio-Cairo. Alessandria fu una delle culle del Cristianesimo e del culto dell’augusta Madre di Dio. Gli Atanasii, gli Alessandri, i Clementi, spiegarono il loro ingegno ed il loro zelo onde far conoscere ed amare Colei, alla quale era dedicata la chiesa metropolitana. Presso l’altar maggiore, nel santuario di Alessandria, si venerò per lungo tempo un antico quadro della Madre di Dio, in atto di occuparsi delle domestiche faccende in Nazaret; e sul limitare della chiesa un’altra immagine rinomata per sorprendenti prodigi. Il vicariato apostolico di Alessandria novera quindici mila cattolici romani devoti di Maria, e l’Egitto buon numero di Copti e di Greci; non pochi Musulmani ancora, specialmente gli Albanesi, piegano il capo, in passando dinanzi all’immagine di Maria, e nei loro solenni giuramenti invocano il di Lei nome più che quello del loro profeta Maometto.
Orazione.
O tenera Madre mia, io voglio, a vostro esempio, pensare collo spirito di Gesù, operare con le mani di Gesù, amare col cuore di Gesù, pregare, soffrire in unione con Gesù, e morire ancora unendo l’estremo mio respiro all’estremo respiro di Gesù, e la mia morte alla consumazione del suo sacrificio. Da Voi imploro, da Voi spero tal grazia. Così sia.
OSSEQUIO.
Baciate tre volte l’immagine di Maria dicendole: Voglio piuttosto servire a Voi, tenera Madre mia, che al demonio.
GIACULATORIA.
O Domina servus tuus sum ego;
Son vostro schiavo
Caro mio Bene:
Oh! fortunate
Dolci catene.
322
O gloriosa Virginum,
Sublimis inter sidera,
Qui te creavit, parvulum
Lactente nutris ubere.
Quod Heva tristis abstulit,
Tu reddis almo genuine:
Intrent ut astra flebiles,
Caeli recludis cardines.
Tu regis alti ianua,
Et aula lucis fulgida:
Vitam datam per Virginem
Gentes redemptae plaudite.
Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre et almo Spiritu,
In sempiterna saecula. Amen.
(ex Brev. Rom.).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, si quotidieper integrum mensem hymnus pia mente iteratus fueri:
(S. Pæn. Ap., 22 nov. 1934).
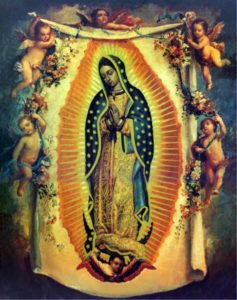
XX. GIORNO.
La vedovanza.
Il momento dei gran dolori approssimavasi per la Vergine-Madre, e ad una vita di tranquilla felicità passata con Gesù e Giuseppe, stava per succedere una vita di sacrifici, d’isolamento, di strazianti inquietudini, di profondi dolori. Separandola dal casto suo sposo, volle il Signore far presentire alla Vergine Santa quell’altra separazione la quale le aprirebbe nel cuore tale ferita che non più si sarebbe rimarginata se non alla porta del cielo. Onusto di virtù e di meriti più che di anni, l’augusto capo della santa famiglia vide senza tema appressarsi l’istante che riunirlo doveva ai padri suoi. La sua vita, le sue forze eransi consumate in prò di Gesù e di Maria; ed ei troppo bene conosceva il cuore di quel Desso che osava chiamar figlio suo, per non sentirsi, in quei momenti estremi, ripieno della più intima confidenza, della più dolce tranquillità. E come no, s’ei moriva tra le braccia dell’Autor della vita, la testa appoggiata sopra il cuore di Lui? Preparata ad ogni sacrificio adorò Maria in umile silenzio la mano che sopra di Lei aggravavasi, e versò amare, ma rassegnate lacrime sopra la morte dell’amico e compagno delle sue gioie come dei suoi dolori, del suo esilio come delle sue fatiche e dal quale videsi mai sempre rispettata, custodita. – Ah! noi tutti conosciamo per esperienza propria i dolori che produce la morte d’un essere teneramente amato. In queste amare circostanze, non chiede il Signore che siamo insensibili a sì fatti sacrifizii; neanco le nostre lacrime ei condanna: solo ci vuole rassegnati alla volontà sua; vuole che dinanzi a Lui conserviamo la memoria delle persone che ci erano care, e che le nostre lacrime, congiunte alle nostre umili ed ardenti orazioni, divengano il prezzo del riscatto che gli offriamo onde soddisfare alla sua giustizia, ed aprir loro le porte del cielo. Agevole non meno che efficace si è questo mezzo. Il nostro amore segua pertanto le anime dei nostri morti tra le mani della divina giustizia, ed in tal guisa loro comprovi che non indarno affidaronsi alla costanza del nostro affetto.
ESEMPIO.
Il regno del Belgio, giovane se contansi gli anni suoi, e piccolo se il numero degli abitanti, vecchio tuttavolta e grande comparisce, se si pon mente agli anni consacrati nel servizio di Dio e nel culto dell’augusta Madre di Gesù; credesi evangelizzato, nel primo secolo della Chiesa. Fra le sue 2530 città e borgate, il Belgio ne conta un numero non piccolo le quali portano il nome di Maria; sia a mo’ d’esempio: Audhenove-Santa-Maria, Leerne-Santa-Maria, Mariabourge, Mariakerke, Marietta, Santa Maria Hoorebeke, ecc. Possiede venti mila altari dedicati a Maria, e rarissime sono le famiglie, ove la di Lei immagine non sia collocata d’accanto al crocefisso. Innumerevoli sono i santuari rinomati per grazie ottenute, e per affluenza di pellegrini da ogni angolo d’Europa, i conventi, gli ospedali, i ricoveri che portano il nome di Maria. Un gran segno della divozione del Belgio all’immacolato Cuor di Maria si ravvisa nella costante celebrazione delle di Lei feste, come se di precetto, sebbene abrogate dal concordato del 1801. Un altro segno si è il non trovarsi città o borgo, il quale non abbia un’associazione, una compagnia eretta in onore della B. Vergine. Il Belgio finalmente fu posto sotto la protezione di Maria dal card. Arcivescovo di Malines, nell’incoronamento dell’Immagine di Nostra Signora della Misericordia a Bruxelles (25 maggio 1843) cui presero parte, e vi vennero consacrati il re con tutta la real famiglia. Medaglie battute in quella circostanza in argento dorato, in argento ed in bronzo, ricorderanno alle venture generazioni la devozione del Belgio all’Immacolato Cuor di Maria.
Orazione.
O Maria, dolce stella che brillate sull’oceano di fuoco, ove la divina giustizia monda le anime dei trapassati, abbiatene pietà: perorate voi la loro causa presso il vostro divin Figlio; presentate alla sua giustizia, in loro redenzione, qualcuna delle lacrime che versaste ai piè della croce: lascerassi Gesù intenerire, aprirà loro il cielo, ed esse eternamente benediranno al Figlio ed alla Madre. Così sia.
OSSEQUIO.
Se siete in peccato mortale, confessatevene subito: se in grazia vincete l’ostacolo che in voi ravvisate a darvi del tutto a Dio.
GIACULATORIA
Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia.
A voi, Giuseppe,
Gesù, Maria
Dono il mio cuore
E l’alma mia.
-323-
Alma Redemptoris Mater, quæ pervia caeli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti.
Surgere, qui curat, populo: tu quae genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.
(ex Brev. Rom.).
Indulgentia quinque annorum.
Indulgentia plenaria, suetis conditionibus, dummodo
quotidiana antiphonæ recitatio per integrum mensem producta
fuerit (S. Pæn. Ap., 15 febr. 1941)
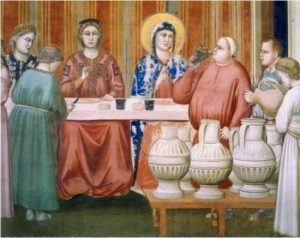
XXI GIORNO.
Le nozze di Cuna.
Era giunto il Giorno in cui il Figlio di Maria doveva presentarsi ad Israello qual Messia da tanti secoli aspettato, e provare la divinità della sua missione con il far servire l’onnipotenza sua a sollievo di tutte infermità umane. Ma volle inaugurare la sua vita pubblica con un atto di deferenza alla propria Madre, onde additare al mondo intero il canale per cui gli sarebbero discese tutte le sue grazie dal cielo. Invitati Gesù e Maria ad una festa nuziale in Cana di Galilea, a mezzo il festino avvedesi Maria che non v’ha più vino; commossa per il rossore che provato ne avrebbero i giovani sposi, volgesi fidente al suo Figlio e lo prega: « Non hanno più vino » Sicura poi d’essere esaudita dice ai servi: « Eseguite quanto Ei diravvi. » E la confidenza della Vergine-Madre non fu delusa. Ordina il Salvatore che vengano riempite d’acqua sei idrie poste per la purificazione dei convitati; quindi soggiunge ai servi: « Prendetela desso, e portatela al maestro di casa » il quale stupefatto conobbe cangiata l’acqua in vino per l’onnipotente volontà del Figlio di Maria. Il Vangelo termina la narrazione di questo prodigio dicendo: « Tutti i convitati, testimoni di questo primo miracolo di Gesù, ammirarono la sua potenza e bontà, ed i suoi discepoli in Lui credettero. » – Come i discepoli noi crediamo nella divinità di Gesù, ma confidiamo noi parimenti come Maria nella bontà del suo sacro Cuore? Oimè! quanto pochi conoscono questa misericordia infinita del cuor di Gesù. Quante anime vivono preda di continue inquietudini perché non sanno aprir il loro cuore alla confidenza! Temiamo di dispiacere a Gesù, ma temiamo eziandio di non amarlo; non abbiamo paura di Lui, per amor del cielo! siano pure gravi, innumerevoli le nostre colpe, in Lui speriamo; a Lui andiamo con illimitata fiducia, chiediamogli perdono, gettiamoci tra le sue braccia; esse sempre stanno aperte per riceverci; che dico? ci offre il suo cuore in rifugio ed asilo della fralezza nostra, ed in quell’amorosissimo cuore non vi regna che la sua misericordia.
ESEMPIO.
Non parrà strano che tra le dense tenebre del gentilesimo, si ravvisino altari eretti in onore della Madre di Dio, se si pon mente che il Signore non solo per mezzo dei voti de’ patriarchi e dei vaticinii de’ profeti, ma eziandio per mezzo delle sibille la volle manifesta agli etnici stessi. — I Druidi sacerdoti de’ Galli 1840 anni circa prima della nascita del Salvatore, scavarono una profondissima e spaziosa fossa, e vi eressero un altare ALLA VERGINE CHE PARTORIREBBE, presso Chartres, luogo ove tenevano le loro adunanze. Questo altare, elevato sopra terra, venne poi dai Cristiani convertito in Chiesa cattedrale. — Gli Argonauti avendo costrutto 1200 anni prima di Gesù Cristo, in Cizico un sontuoso tempio, e consultato l’oracolo di Pizio, cui consacrare il dovessero, ebbero in risposta: A MARIA, GENITRICE DEL VERBO ETERNO. — Giasone, re degli Argonauti, avendo anch’esso costrutto un tempio nella rócca di Atene, e consultato l’oracolo di Delfo, a chi, in avvenire, verrebbe dedicato, ebbe questo responso: Io vedo tre: un Dio solo regnante sopra gli dei, il cui Verbo immortale, concepito da una Vergine, attraversando la terra, condurrà tutti in dono al Padre. MARIA È IL NOME DI COLEI CHE SARÀ QUI ONORATA. — Finalmente nessuno ignora che gli Egizii adoravano una Vergine col Figlio in grembo, istruiti sopra questo mistero dal profeta Geremia, condotto in Egitto da quei Giudei, i quali colà cercarono scampo contro il furore dell’esercito caldeo e, dimoratovi per quattro anni, profetò ed operò prodigi alla corte di Faraone.
Orazione.
Sì, nella bontà del vostro divin Figlio, o Maria. Madre della santa speranza, voglio riporre tutta la mia fiducia; ed affinché perfetta sia questa mia fiducia, si è sulla tenerezza del materno vostro cuore che appoggiar la voglio. Nelle vostre mani adunque, o tenera Madre mia, malgrado l’indegnità mia, io pongo i miei più cari interessi, gli interessi dell’eternità. Così sia.
OSSEQUIO.
Esaminatevi sulle vostre confessioni, e proponete di correggerne i difetti.
GIACULATORIA.
Mater divinæ gratiæ, ora prò nobis.
Per noi pregate
O fonte immensa
Di quelle grazie
Che Dio dispensa.
324
Ave, Regina cælorum,
Ave, Domina Angelorum;
Salve, radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et prò nobis Christum exora.
(ex Brev. Rom.).
Indulgentia quinque annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, antiphona quotidieper integrum mensem repetita (S. Pæn. Ap., 15 febr. 1941).

XXII. GIORNO
Maria a piè della Croce.
Il giorno dei gran dolori era finalmente sorto per la tenera nostra Madre. Già il Figlio della Vergine Immacolata ha sofferto il crudele ed ignominioso supplizio della flagellazione; già il Re dei secoli eterni è stato coperto della porpora reale dell’adorabile suo sangue ed incoronato di spinoso diadema; e già pallido, sanguinoso, sfigurato ha raggiunta la vetta del Golgota! Non sì tosto vede elevata la croce su cui sta confitta la Vittima dell’uman genere, questa Madre incomparabile, la quale rimaneasene nascosta nei giorni della gloria di Gesù, apresi il passo in mezzo alla moltitudine che ondeggia sulla santa montagna, e calma, maestosa viene a porsi a piè della croce. Nessuna debolezza della natura scorgesi in questa desolatissima tra le madri, sebbene tutto sia immenso in Lei il dolore come l’amore. Gesù sulla croce, Maria ai piedi… qual meraviglia? Qui e non altrove è il suo posto in questo solenne momento: sta in piedi, è vero; ma quest’attitudine è l’unica che le si addice; che là non è solamente Madre, ma sacerdote eziandio con Gesù: ebbene il sacrificatore deve stare presso l’altare del sacrificio nella posizione in cui vediamo immobile la Regina dei martiri. – Quante volte abbiamo invidiato la sorte di Maria e delle altre pie donne d’aver potuto assistere al sacrificio dell’adorabile nostro Salvatore? Ma ci è pur dato accompagnare Gesù sopra un altro Calvario, ove ogni giorno ancora in nostro prò s’immola, il santo Sacrificio della Messa. – Qui troviamo lo stesso sacerdote, la stessa vittima, lo stesso sangue, e nel cuore della Vittima, lo stesso amore per noi, la stessa brama di salvarci. Guardiamo l’altare, e comprenderemo allora la longanimità della divina giustizia a fronte dell’oceano d’iniquità che inonda la terra: si è pel grido d’amore che di qui al cielo s’innalza incessantemente: « Padre, perdonate loro perché non sanno ciò che fanno. » E noi facciamo sì poco caso dell’assistere o no ad una Messa!… Sventurati!
ESEMPIO.
Intorno alle chiese erette in onor di Maria dagli Apostoli, quando era ancor in vita, vedi ciò che abbiamo detto nella considerazione del secondo giorno. — Dopo la erezione in tempio della santa Casa di Loreto, la prima basilica in onor di Maria venne edificata da uno de’ Magi in Crangavore nell’India orientale. Una seconda ne vediamo edificata, tre anni dopo il parto della Vergine-Madre in Calcutta. Sorgeva essa, come attestò Vasco Gama al re di Portogallo aver egli stesso veduto, allorché nel 1498 approdò a questa rinomata città dell’India, nel mezzo di un gran tempio di forma rotonda; vi si ascendeva per una gradinata di bronzo, ed ai soli sacerdoti non era vietato l’ingresso, ma essi ancora, appena entrati, dovevano innanzi tutto prostrarsi a terra, e con le braccia tese esclamare: Maria Maria! — Divulgatasi appena l’Assunzione di Maria al cielo, i Cristiani eressero incontanente in di Lei onore un oratorio sul monte Carmelo. — Un altro edificato da s. Marta in Marsiglia, venne consacrato da s. Massimino, uno de’ settanta discepoli del Redentore. — Così ancora un tempio sontuosissimo le dedicò Candace regina degli Etiopi, il cui eunuco era stato battezzato dal diacono s. Filippo. — Finalmente s. Materno, discepolo di s. Pietro, e apostolo della Germania, le innalzò una magnifica basilica in Tongres, paese di Liegi.
Orazione.
Oh! la più desolata della madri, ottenetemi la grazia di non assistere giammai all’adorabile Sacrificio dei nostri altari, senza prender parte ai sentimenti di dolore e d’amore che Voi provaste sul Golgota; senz’essere penetrato di sovrano orrore contro il peccato, di profonda riconoscenza verso il vostro divin Figlio; e specialmente poi di assistervi con vero spirito d’immolazione e di sacrifizio. Cosi sia.
OSSEQUIO.
Assistete ad una Messa in ispirito d’unione con Maria a piè della croce.
GIACULATORIA.
Ave, verum corpus natum ex Maria Virgine.
Salve, santissimo
Corpo divino,
Di pura Vergine
Nato bambino.
414
Oratio
O Maria, Vergine potente, Tu grande ed illustre
presidio della Chiesa; Tu aiuto meraviglioso
dei C pristiani; Tu terribile come esercito
ordinato a battaglia; Tu, che da sola hai distrutto
ogni eresia in tutto il mondo, nelle nostre
angustie, nelle nostre lotte, nelle nostre
strettezze difendici dal nemico e, nell’ora della
morte, accogli l’anima nostra in paradiso. Così
sia (S. Giovanni Bosco).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodoquotidie per integrum mensem oratio devote repetita fuerit
(S. Pæn. Ap., 20 febr. 1923 et 29 iul. 1933).
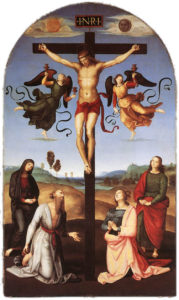
XXIII. GIORNO.
L’Adozione.
Il gran dramma della passione toccava il suo termine: Maria aveane seguito tutte le fasi, visto tutte le sanguinose scene coi proprii occhi; oimè! per comprendere l’immensità del dolore di quell’anima immacolata, d’uopo sarebbe amare Gesù come Ella lo amava, e conoscere come Ella conosceva il prezzo del sangue in nostro prò versato. Già per ben due volte l’augusta Vittima rotto aveva il misterioso suo silenzio; « Padre perdonate loro » e: « Oggi meco sarai in paradiso, » ed intanto pareva obliasse la desolata sua Madre. Ad un tratto i moribondi suoi occhi s’abbassano sopra di Lei: se ne avvede Maria, e alzandosi sulla punta de’ piedi, mani ed occhi rivolti al divin giustiziato, sta come immobilmente sospesa dalle labbra di Lui… povera madre! ha tanto bisogno d’una parola di conforto!… Ascoltiamo: « Donna, ecco il tuo figlio » accennando a Giovanni; ed a Giovanni: « Ecco la madre tua » accennando a Maria. In mezzo agli strazii del suo dolore, sempre grande, generosa sempre la Regina de martiri innalzasi all’altezza delle viste di suo Figlio, ne comprende il pensiero: entrando subito ne’ sentimenti di Lui, dilata le viscere della sua carità; ed aprendo il suo cuore a tutti i redenti del Calvario, adotta a piè della croce, nel silenzio e nell’estasi del dolore, tutta la grande famiglia umana. – Queste parole di Gesù produssero in Maria il loro effetto, aprirono, vo’ dire, nel cuore di Lei profonde ed inesauribili sorgenti d’amore materno, di sacrificio, di tenerezza. E ben cel sappiamo noi tutti sventurati figli di un padre prevaricatore. Amiamo adunque la nostra Madre celeste; ripaghiamo con figliale confidenza e gratitudine l’amore di Lei; nelle nostre pene, nei nostri pericoli, nelle nostre debolezze ricorriamo a Lei, appoggiamoci sul di Lei cuore, rimettiamo nelle di Lei mani tutti i nostri interessi personali, riposiamoci in tutto sopra di Lei come tranquillo riposa il fanciullo tra le braccia della madre, abbandonandole la cura di tutto che ci riguarda, né più pensiamo che ad esemplare le virtù di Lei, e renderci degni della di Lei tenerezza.
ESEMPIO.
L’esempio degli Apostoli nell’edificare oratori: in onore dell’augusta Madre di Dio, fu ben tosto con sommo ardore seguito dai Cristiani di ogni nazione, in guisa che volerli presentemente numerare sarebbe forse poco men malagevole impresa che il voler numerare le stelle. Siccome un lieve saggio ne abbiamo avuto nelle prime sei considerazioni e in tutti gli esempi finora addotti, mi limiterò a dar qualche cenno in generale. — Appena ebbe l’imperator Costantino abbracciato il Cristianesimo, ed unitamente alla sua madre s. Elena, dato più luminosi esempi di fervido zelo in prò della religione e del culto di Maria, questo culto non vide più limite alcuno: i grandi vi profusero le immense loro ricchezze; all’augusta Madre del Salvatore del mondo dedicaronsi templi i quali per la loro sontuosità divennero la meraviglia dell’universo; le più preziose gemme perdevano tutto il loro pregio trattandosi di offrirle a Maria. Ed il popolo che non possedeva ricchezze, le rese un culto più intimo e più commovente ancora; sulle colline, in mezzo ai campi, tra le gole e sulla vetta dei monti vidersi qui e colà sorgere umili altari a Maria, coperti da prima di reticelle, di edera o di pampini, divenuti in seguito per la più parte celeberrimi santuari. Ed ora non si trova città protetta dalla croce della redenzione che non vanti una chiesa, od un altare almeno dedicato a Maria.
Orazione.
Ricordatevi, o Vergine santa, che noi siamo i figli del vostro dolore, e che diveniste la Madre nostra tra le agonie e gli strazi del Calvario. Ah! non obliate che dal vostro divin Figlio stesso noi fummo alla vostra misericordia ed al vostro amor confidati, tenera Madre nostra. Stendete adunque sopra di noi, la materna vostra mano, ed accordateci la vostra protezione adesso e nell’ora di nostra morte. Così sia.
OSSEQUIO.
Dite spesso tra il giorno: — Cristo crocefisso, ed io tra le delizie!
GIACULATORIA.
Sancta Mater, Istud agas, Crucifixi fige plagas cordi meo valide.
Madre stampatemi
Sin dentro il cuore
Le piaghe amabili
Del mio Signore.
-438-
Oratio
Omnipotens et misericors Deus, qui in beata
semper Virgine Maria peccatorum refugium et
auxilium collocasti, concede, ut, ipsa protegente,
a culpis omnibus absoluti, misericordiae
tuae effectum felicem consequamur. Per Christian
Dominimi nostrum. Amen (ex Missali Rom.).
– Indulgentiam : trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodoquotidie per integrum mensem oratio devote recitata fuerit
(S. Pæn. Ap., 20 iul. 1934).

XXIV. GIORNO.
Il Sepolcro.
Il gran sacrifizio era consumato! Maria aveva contato gli estremi sospiri, gli estremi battiti del cuore di Gesù; aveva visto la morte chiudergli gli occhi, ed il sacro capo di Lui cadere sul petto senza vita… Maria non aveva più figlio! Ma non era sufficiente per questa desolatissima tra le madri l’aver visto morire il suo Gesù: oh! come crudele esser dovette all’anima sua la ferita fatta dalla lancia all’esanime cuore del suo Figlio. Intanto ogni ora, ogni momento del gran giorno della redenzione portava novelli dolori al cuore della Regina dei martiri: pochi istanti appresso Ella assistette alla deposizione della croce operata da Nicodemo, Giuseppe d’Arimatea ed altri, ricevette tra le sue braccia il corpo inanimato di suo Figlio, e poté ravvisare tutto lo sterminio che la barbarie degli uomini aveanvi portato. Qual contrasto tra la Vergine-Madre di Betlemme, e la Vergine-Madre del Calvario! E che dirò del suo dolore allorché accompagnato quell’adorabile corpo alla sepoltura, e deposto nella tomba, vide l’enorme pietra che chiudeane l’ingresso, frapporre come una barriera fra lei e l’unico oggetto dell’amor suo? Comprese Maria esser questo il compimento del suo sacrificio, e rassegnata al divino volere, esclamò: Fiat, e rifece silenziosa la strada di Gerusalemme. – Non tutte le anime sono chiamate da Dio a sopportare così terribili prove; a ciascun di noi tuttavolta il Signore chiede nel corso della vita sacrifizi proporzionati alle nostre forze, ed alla misura delle grazie ricevute. Ebbene; se, onde venir in aiuto al lavorio della grazia nelle anime nostre, ci colpisce il Signore ne’ più sensibili affetti, se frange Egli stesso i legami che noi non avremmo il coraggio di rompere, adoriamo la sua misericordia in mezzo alle lacrime nostre; e senza lai, senza mormorazioni, sfrondiamo con Maria a piè della croce del nostro Salvatore l’ultimo fiore delle nostre gioie di quaggiù; e poi, abbracciandoci a questa croce, ed attaccandovici con tutte le nostre forze, esclamiamo col Serafino d’Assisi: Mio Dio, mio tutto.
ESEMPIO.
Sei sono le Immagini di Maria dipinte dall’Evangelista s. Luca, che si conservano in Roma. La prima si venera in S. Maria Maggiore. Nel 590 portata processionalmente per le contrade di Roma quest’immagine, fece tosto cessare una fierissima pestilenza. Dalla chiesa di s. Maria Transtevere fu trasferita a S. Maria Maggiore da s. Domenico sulle proprie spalle, e deposta nella cappella Sistina; Paolo V, a destra della basilica, di rincontro al sacro Presepio, costrusse una sontuosissima cappella, in cui è ancora presentemente venerata. La seconda in S. Maria di Ara-Cœli. La terza in S. Maria di Via Lata; quest’immagine è dipinta con un anello nel dito. La quarta in S. Maria del Popolo ivi processionalmente trasferita dal luogo chiamato Sancta- Sanctorum, dal sommo Pontefice Gregorio IX nel 1227. La quinta in S. Maria Nuova, portata da Troia; sotto il pontificato di Onorio Iii, questo dipinto si rinvenne intatto dopo l’incendio della chiesa. La sesta in S. Maria al Campo Marzio portatavi di Grecia dalle monache di s. Benedetto prima del 600; anche questa conservossi illesa, e stette prodigiosamente sospesa in aria dopo l’incendio della trave, cui era raccomandata. – La settima si venera in Costantinopoli nel tempio eretto dall’imperatrice Pulcheria, e dedicato Alla Madre di Dio Odigitria; dicesi dipinta da s. Luca, vivente ed annuente la B. V. Quivi ancora nella basilica di s. Sofia si conserva l’ottava; involata dai Veneziani, fu da essi restituita per autorità del sommo Pontefice Innocenzo III. La nona in Napoli nella chiesa di S. Maria Maggiore.
Orazione.
O desolata Vergine, cui il Signore ha misurato la grandezza delle vostre prove alla generosità e coraggio del vostro cuore di santa e di madre, deh! accorrete in mio soccorso; fatevi, non solamente il mio sostegno, la mia consolatrice, ma il mio esemplare ancora, ed ottenetemi la grazia d’un perfetto distacco, e d’una perfetta rassegnazione a tutte le volontà del Signore. Così sia.
OSSEQUIO.
Se foste moribondo, qual cosa vi darebbe maggior rimorso? Rimediatevi subito, implorando l’aiuto di Maria.
GIACULATORIA.
Doce me, Domina, facere voluntatem tuam.
Voi del mio cuore
L’arbitra siete,
Deh! dunque ditemi
Quel che volete.
INVOCATIONES
386
Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza mia.
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, si quotidiana invocationis recitatio in integrum mensem producta fuerit
(S. C. Indulg., 30 sept. 1852).

XXV. GIORNO.
La Risurrezione.
Spuntò finalmente il giorno fatto dal Signore: la sua luminosa aurora ha dissipato le sanguinose ombre del Calvario, e riempito di gioia l’Immacolato Cuore della nostra divina Madre. Non dice il Vangelo che Maria sia stata favorita della prima visita di Gesù risuscitato, ma non la nega neanco. E non gliene andava forse debitore il suo divin Figlio? Se tal favore fu concesso a Maddalena in grazia del suo illimitato e costante amore per Gesù, possiamo farci capaci che abbiane privata Maria, il cui amore superò quello di Maddalena più che piccola fiammella non è superata dallo splendor del sole? Cosi c’insegna una pia ed antica tradizione. Ah! Sarebbe d’uopo inventare nuove espressioni per nominare la gioia della povera Madre in quell’istante in cui poté stringere al seno il suo Figlio risorto, sentire quel sacro Cuore ferito dalla lancia, palpitar nuovamente contro il suo, ed udir chiamarsi ancora col dolcissimo nome di Madre. No, no, io non so se il cielo con tutte le sue magnificenze, e le sue delizie possegga gioie più dolci, più intime, più sensibili per la nostra divina Madre di quella gioia in che dovette sentirsi come naufraga in quell’avventurato istante. – Impariamo da Maria a santificare le nostre gioie non altrimenti che i nostri dolori, riferendo tutto a Dio. Consolazioni o pene, gioie od amarezze, tutto, nei disegni del Signore giovar deve al perfezionamento dell’anima nostra, alla nostra salute. Qui eziandio convergere debbono tutti i nostri sforzi, dirigersi tutte le nostre aspirazioni, limitarsi tutta la nostra ambizione. Sì, ciascun di noi adoprar deve sante industrie per accrescere mai sempre il tesoro dei meriti suoi, rivolgendo tutte le peripezie della vita a sua emendazione, a suo spirituale progresso, né perdere di vista giammai la gran parola dell’adorabile Salvatore: Siate perfetti come perfetto è il vostro Padre del cielo.
ESEMPIO.
La decima delle immagini di Maria dipinte da S. Luca, si venera sul monte della Guardia, a tre miglia circa da Bologna nella chiesa dedicata al medesimo evangelista s. Luca, scelta, se prestiamo fede ad un’antichissima leggenda riprodotta dal Sigonio, da Maria stessa. Ogni anno questa prodigiosissima effigie, viene con solennissima pompa trasferita, nella seconda feria delle rogazioni, in Bologna, «processionalmente portata per le precipue vie della città. L’undecima vedesi presso il borgo di Cestochovia distante 18 leghe da Cracovia. A questo santuario, uno dei più ricchi del mondo per magnificenza e preziosità di arredi, accorrono a torme pellegrinando i cristiani non solo dalla Polonia, ma eziandio da tutta la Slesia, dalla Moravia e dalla Pomerania; tanti sono i prodigi che vi si operano, le grazie che si ottengono. – Il dipinto rappresenta Maria col bambino Gesù in grembo, vestito alla greca; porta due cicatrici sul volto, inflitte, dicesi, dagli eretici Ussiti, cancellar le quali non fu ancor possibile all’industria dell’uomo, sebbene ne abbiano fatto la prova i più esperti pittori. Le tre ultime si trovano nell’isola di Malta; il celeberrimo spositore della s. Scrittura, Cornelio a Lapide, narra che furono dipinte da S. Luca, allorché avernò per tre mesi in quell’isola, compagno di viaggi dell’apostolo s. Paolo.
ORAZIONE
O Maria la quale non faceste mai sosta per il sentiero della perfezione, e vi giungeste alla più sublime altezza, abbiate compassione della fralezza, della miseria d’un vostro figlio. Estrema è la mia codardia, ai vostri piedi il confesso. Deh! ottenetemi, vi scongiuro, possenti grazie che trionfino sulla mia fralezza ed accidia, affinché sostenuto dalla materna vostra protezione, cominci una vita di fervore, d’amore, di sacrifici. Così sia.
OSSEQUIO.
Usate particolar modestia in chiesa, tenendo bassi gli occhi in tempo della santa Messa.
GIACULATORIA.
Munda me ab omni iniquitate mea, Sancta Dei Genitrix.
D’ogni mondatemi
Macchia più lieve;
Fatemi candido
Come la neve.
370
Immaculata Mater Dei, Regina cœlorum, Mater
misericordiae, advocata et refugium peccatorum,
ecce ego illuminatus et incitatus gratiis,
a te materna benevolentia large mihi impetratis
ex thesauro divino, statuo nunc et semper dare
in manus tuas cor meum Iesu consecrandum.
Tibi igitur, beatissima Virgo, coram novem
choris Angelorum cunctisque Sanctis illud trado,
Tu autem, meo nomine, Iesu id consecra;
et ex fiducia filiali, quam profiteor, certum mihi
est te nunc et semper quantum poteris esse facturam,
ut cor meum iugiter totum sit Iesu,
imitans perfectissime Sanctos, praesertim sanctum
Ioseph, Sponsum tuum purissimum. Amen
(S. Vincentius Pallotti).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, si quotidieper integrum menseni oratio devote recitata fuerit (S. Paenit.
Ap., 27 iulii 1920 et 12 sept. 1936).
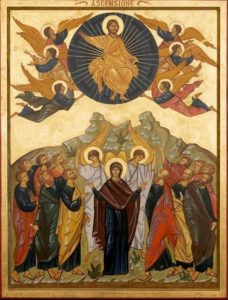
XXVI. GIORNO.
L’Ascensione.
Terminata era la missione dell’Uomo-Dio sulla terra; gettate le fondamenta della sua Chiesa, istituiti i sacramenti, ammaestrati gli Apostoli, non più rimaneva all’adorabile Salvatore che dare ai beneamati del suo cuore un’ultima benedizione, pegno di quell’eterna benedizione che accorderebbe loro ben presto in cielo. Non v’ha dubbio che con gli Apostoli e gran numero di discepoli non siasi trovata Maria sul monte degli olivi in quella commovente circostanza. Appena colà radunati, ecco Gesù comparire in mezzo al suo piccolo gregge, e dopo aver loro dato un ammonimento ancora, e la benedizione, i suoi piedi abbandonano la terra, ed Egli s’innalza maestosamente verso il cielo. Se, come insegna antica tradizione, il Salvatore concesse alla Madre di poter essere testimonio del suo trionfante ingresso nel cielo, chi varrà a descrivere il rapimento, l’estasi di felicità in che l’avrà piombata la vista del corpo glorificato del suo Gesù sedente alla destra del Padre? Ah! quinc’innanzi la vita di quest’anima immacolata non sarà più che un ardente aspirazione verso il cielo, un’accesa brama di veder finire il suo esilio, sopportando tuttavolta gli inenarrabili dolori di sì fatta lontananza con perfetta e paziente rassegnazione alla volontà del Signore. – Desideriamo noi il cielo come la nostra divina Madre! Il cielo! Ah! Egli è pure la dimora del nostro Padre, l’eredità nostra, la nostra patria, il luogo ove tergerannosi per sempre le lacrime nostre. Coraggio adunque: ogni giorno di quaggiù è un passo che a Dio ci avvicina. Che cosa importano le fatiche del viaggio, le pene, le prove, dacché ci attende colassù una felicità inenarrabile, felicità proporzionata alla grandezza delle nostre afflizioni? Sì, Dio misurerà le sue consolazioni al regolo delle nostre croci; più avremo sofferto, più grandi saranno le nostre gioie; e quel che più monta, tutti i dolori saranno passati per non ritornare più mai, e la felicità la quale ne sarà il guiderdone, avrà l’eternità per durata.
ESEMPIO.
La ristrettezza di un esempio non mi permette che di far parola di alcuna soltanto delle più rinomate Statue rappresentanti la B. V. Maria: — In Saragozza evvi la statua detta del Pilar (della colonna) di cui già diedi un cenno; la s. Vergine sta in piedi col bambino Gesù tra le braccia, il quale tiene una colomba in mano; pretendesi scolpita ai tempi dell’Apostolo s. Giacomo. — Una delle più celebri statue che vanti la Francia è incontestabilmente quella di Puy-en-Velay; vuolsi colà portata da quegli arabi che primi, dopo i Magi, venerarono Maria ed il bambino, e la scolpirono a loro modo: essa tiene Gesù sulle ginocchia. — La statua d’ebano della B. V. di Loreto, annerita dal tempo e dal fumo delle numerose lampade e candele, che ardono giorno e notte, è pure di antichissima data; v’ha delle cronache, le quali ne attribuiscono la scultura allo stesso s. Luca; rapita dall’armata repubblicana nel 1797, e trasferita a Parigi, venne riportata a Loreto per ordine di Napoleone, appena divenuto primo console. — La Madonna di Spoleto dicesi colà portata di Palestina nel 352 da tre eremiti: dapprima addimandossi S. Maria di Giosafat, poi la Madonna degli Angeli o della Porziuncula: questa chiesa fu la culla dell’ordine del Serafico d’Assisi. — Celeberrima è la statua posta all’ingresso della chiesa del santo Sepolcro in Gerusalemme; a questa si riconobbe debitrice della sua conversione Maria egiziaca nel 370. — La più antica statua di Maria venerata nel Belgio è quella di Bruges. — Beatrice vedova del conte di Dampierre, ricevette dal sommo Pontefice Gregorio IX una statua della B. Vergine deposta, dice una tradizione, dagli Angeli in una foresta d’Italia. Collocata nella chiesa dell’abbazia di Courtrai, divenne ben presto celeberrima per i suoi prodigi. Finalmente nella chiesa di Afflighem esiste la famosa statua, la quale nel 1150, salutata da s. Bernardo con le parole: Salve, Maria, gli rese il saluto: Salve Bernarde.
Orazione
O Maria che tenete in mano lo scettro della Misericordia, ricordatevi di me, povero vostro figlio che pellegrino qui in terra, sospiro verso il cielo, che è la patria mia, verso Dio che è Padre mio, verso Gesù, che è mio fratello, verso di Voi che siete la Madre mia. Deh! Guidate tutti i miei passi, finché depor possa ai vostri piedi l’immortale corona, non dovuta ai meriti miei, ma a quelli del vostro divin Figlio, ed alla materna vostra protezione. Così sia.
OSSEQUIO.
Recitate un De profundis per l’anima del purgatorio che in vita fu più devota della B. V.
GIACULATORIA.
Virgo potens, ora prò nobis.
Voi che potente
In cielo siete,
Ferventi suppliche
Per noi porgete.
371
O pura et immaculata, eademque benedicta
Virgo, magni Filii tui universorum Domini Mater
inculpata, integra et sacrosanctissima, desperantium
atque reorum spes, te collaudamus. Tibi
ut gratia plenissimae benedicimus, quae Christum
genuisti Deum et Hominem: omnes coram
te prosternimur: omnes te invocamus et auxilium
tuum imploramus. Eripe nos, o Virgo sancta
atque intemerata, a quacumque ingruente
necessitate et a cunctis tentationibus diaboli.
Nostra conciliatrix et advocata in hora mortis
atque iudicii esto: nosque a futuro inexstinguibili
igne et a tenebris exterioribus libera: et
Ad Beatissimam Virginem Mariam
Filii tui nos gloria dignare, o Virgo et Mater
dulcissima ac clementissima. Tu siquidem unica
spes nostra es securissima et sanctissima apud
Deum, cui gloria et honor, decus atque imperium
in sempiterna sæcula sæculorum. Amen
(S . Ephræm, C . D.).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodoquotidiana orationis recitatio in integrum mensem producta
fuerit (S. Pæn. Ap., 21 dec. 1920 et 9 ian. 1933).
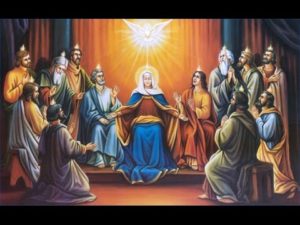
XXVII. GIORNO.
La Pentecoste.
Dopo l’Ascensione del divino Maestro, discesero gli Apostoli a Gerusalemme, e con Maria ed i discepoli si rinchiusero nel cenacolo per aspettarvi nella preghiera e nel digiuno la venuta del promesso Paracleto. Non v’ha dubbio che l’orazione della Vergine Immacolata non abbia affrettato questa venuta. Sullo scorcio dei dieci giorni di ritiro e di perseveranza nell’orazione, si fe’ udire un grande strepito, come d’impetuosissimo uragano; ed apparvero ad un tempo lingue di fuoco le quali andarono a riposarsi sulla testa di ciascuno de’ membri della Chiesa nascente colà radunata, e tutti sentironsi ripieni di Spirito Santo. Nessuno tuttavolta varrà a comprendere quello che in questo solenne giorno operò in Maria lo Spirito consolatore, e qual fu la prodigiosa trasformazione di quell’anima benedetta e privilegiata fra tutte le pure creature. Dirò solamente che tra i doni ricevuti da Maria e quelli degli Apostoli vi passò la differenza stessa che fa un magnifico e liberale monarca tra i favori largiti ai suoi ministri, e quelli compartiti ad una sposa da lui unicamente e teneramente amata. Gli uni sono trattati in amici, l’altra in sovrana, a cui le liberalità dello sposo sono in ragione del suo amore per lei. – Maria nel cenacolo c’insegna non l’utilità solamente del raccoglimento, della fuga del mondo, per albergare in noi il Santo Spirito, ed attendere con successo alla nostra perfezione; ma ci manifesta eziandio la necessità della preghiera onde ottenere dal cielo tutti i soccorsi necessari al buon esito del grand’affare di nostra eterna salate. L’adorabile Salvatore il quale conosceane tutta l’importanza come l’indispensabile necessità, raccomandolla sì ripetutamente: — Pregate senza interruzione — Domandate, e riceverete. — Tutto ciò che chiederete al Padre mio in nome mio, saravvi concesso — Laonde se inesaudite veggiamo le nostre preci, non ascriviamolo che alla poca fede, poca umiltà, poca fiducia, e specialmente alla poca perseveranza con che oriamo.
ESEMPIO.
Sebbene sia fuor di contestazione avere i popoli sentito mai sempre maggior impulso all’amor di Maria dalle di Lei immagini scolpite che dipinte, non si può negar tuttavolta che queste eziandio non siano d’origine non meno antica di quelle, poiché vantano lo stesso inventore, l’evangelista s. Luca. — Non parlo delle celebri Madonne di Raffaello, delle quali non v’ha in Italia chi ne ignori la perfezione. Michelangelo (scuola italiana, 1498) in un suo dipinto rappresentante la s. Famiglia, diede a Maria i più vivi e dolci caratteri di una buona madre. Nel quadro delle nozze di Cana di Paolo Veronese (1588) scorgesi sul volto di Maria l’interna sua inquietudine per la mancanza del vino. Alberto Durer (scuola alemanna 1500) nell’Adorazione de’ Magi, non poteva più perfettamente ritrarre la purissima gioia della B. Vergine, non disgiunta dalle sollecitudini della migliore delle madri. Nella deposizione di Gesù dalla croce del Rubens (scuola fiamminga, 1635) tu vedi la Madre desolata in siffatto atteggiamento di ambascia e di rassegnazione, che, mentre t’incanta, t’inspira una indefinibile malinconia al cuore. Capo d’opera è la Concezione del Murillo (scuola spagnola) morto nel 1682. Non meno mirabili, nella scuola francese, sono il quadro del Lebrun Carlo, morto nel 1690, per la grazia che seppe dare a Maria preparante un povero pasto al fanciullo Gesù; e quello del Jouvenet, morto nel 1717, in cui vedesi l’augusta Madre di Dio nell’atto di cantare il Magnificat. L’umiltà, la riconoscenza, una gioia tutta celeste, spiccano nell’atteggiamento di tutta la persona in guisa che ben rivelano i sentimenti da che sentivasi in quell’ora riboccante quell’immacolato Cuore.
Orazione.
O Maria. Vergine immacolata, la cui vita fu una continuata orazione, ottenete a me lo spirito della preghiera, di cui pur troppo, sì poco conosco il pregio, sebbene siami d’estrema importanza. Impetratemi dal vostro divin Figlio quello spirito di fede, di confidenza, di fervore che ne è l’anima, e che apre sopra di chi prega tutti i tesori delle celesti benedizioni. Così sia.
OSSEQUIO.
Viva Gesù, viva Maria, sia l’invocazione con che date principio ad ogni vostra azione o scritto.
GIACULATORIA.
Jesum benedictum, fructum ventris tui, nobis ostende.
Il frutto amabile
Del vostro seno
Nel ciel mostrateci
Ò Madre, almeno.
372
Deus, qui per immaculatam Virginis Conceptionem
dignum Filio tuo habitaculum praeparasti,
quaesumus, ut qui ex morte eiusdem Filii
tui praevisa eam ab omni labe praeservasti, nos
quoque mundos, eius intercessione, ad te pervenire
concedas. Per eumdem Christum Dominum
nostrum. Amen (ex Missali Rom.).
Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, oratione quotidieper integrum mensem devote reiterata (S. C. Indulg.,
23 mart. 1904; S. Pæn. Ap., 4 maii 1936).

XXVIII. GIORNO.
Gli ultimi anni di Maria.
Profondo silenzio regna nelle sacre carte intorno agli ultimi anni della nostra divina Madre, tal che noi ignoriamo ed il luogo di sua residenza, il genere delle sue occupazioni, ed il tempo del felicissimo suo transito. La tradizione tuttavolta viene ad appagare in parte la pia curiosità nostra insegnandoci che non pochi anni la visse ancora dopo la morte di Gesù, cioè fino all’età di settantadue, o settantacinque anni; che la vita di lei fu umile, ritirata, divisa tra l’orazione ed i lavori manuali; e che nell’assemblea dei fedeli non distinguevasi altrimenti che per la sola sua santità. C’insegna eziandio la tradizione stessa che questi ultimi anni di Maria furono una lenta agonia, un lungo martirio d’amore, un’incessante aspirazione al cielo; che l’unica sua consolazione era il ricevere quotidianamente dalle mani del suo figlio di adozione la santa Comunione; e che sì dolce, si consolante presentavasele il pensier della morte, che era divenuto l’abituale suo pensiero; e ben lungi dall’averla in orrore, salutavala con santa gioia, come Colei la quale doveva por fine al suo esilio, aprirle il cielo, e ridonarle l’unico oggetto dell’amor suo. – La morte è il momento che fisserà per sempre la nostra sorte. Quindi nulla di più importante per noi come la grazia di una buona morte; ed il più agevole mezzo ad ottener questa grazia si è appunto l’abituale pensiero della morte stessa. Non si fa bene se non quello che s’imparò lungo tempo a fare. Questo pensiero ci distaccherà dai beni della vita presente, dimostrandocene la caducità ed il nulla; ché di tutto ci spoglia la morte. Ci aiuterà in secondo luogo ad evitare il peccato «Sovvieniti dell’ultimo tuo fine, e non peccherai in eterno ». Difatti qual più valido freno a trattenere lo sfogo di quale che siasi passione, come il pensier della morte, la sua incertezza, il giudizio che la seguirà, e gli eterni castighi che sono il soldo del peccato, il frutto d’un istante di colpevole soddisfazione?
ESEMPIO.
Docili figli di santa Chiesa, noi onoriamo le reliquie dei santi, perché potentissimo mezzo a nutrire la pietà, condurre alla perfezione. — Siccome coll’anima della B. Vergine il corpo eziandio venne assunto al cielo, ne segue che le di Lei reliquie consistono soltanto in pezzi di veli o vesti di che andava coperta. Presentemente ancora è venerata in Chartres una tonaca di Maria, che Carlo il Calvo ebbe in dono da Carlo Magno nel 801. — Vedeasi altre volte nella chiesa della B. Vergine delle grazie in Costantinopoli un di Lei fuso portato di Palestina dall’imperatrice s. Pulcheria. — Nel 455 il vescovo s. Giovenale trasportò da Gerusalemme in Costantinopoli il sudario, ed una parte della tomba di Maria. — L’imperatrice s. Elena arricchì la chiesa di s. Croce in Gerusalemme d’una gran parte del velo della B. Vergine. — Celebre per tutta la Spagna si è la treccia dei capelli di Maria venerata in Oviedo: un’altra era, tempo fa, posseduta dalla chiesa della B. Vergine di Bruges. – Così ancora una specie di guanto in s. Omer, una specie di velo in Aix-la-Chapelle, una specie di pettine in Trèves, ed una parte del sudario e del velo in Soissons. — Il sommo pontefice Callisto III concesse nel 1455 varie indulgenze a chi visita la cattedrale di Arras, ove conservasi un velo ed una cintura dell’augusta Madre di Dio. — Memorie preziosissime e feconde mai sempre di grazie e di benedizioni più preziose ancora.
Orazione.
O Maria che insegnaste col vostro esempio il disprezzo ed il distacco dalle cose di questo mondo, ottenetemi la grazia di attaccarmi a Dio solo, unico bene che trovar possa al di là della tomba. Aiutatemi onde la mia vita sia una morte continua la quale mi prepari a ben morire, e mi ottenga la grazia di una santa morte. Così sia.
OSSEQUIO.
Nelle ore di ozio leggete libri che trattino delle lodi di Maria.
GIACULATORIA.
Monstra te esse Matrem.
So che voi siete
Madre di Dio;
Ma per mia Madre
Vi voglio anch’io.
375
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
(ex Missali Rom.).
Indulgentia quingentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodoquotidie per integrum mensem invocatio pia mente recitata
fuerit (S. Pæn. Ap., 1 aug. 1934).

XXIX. GIORNO.
Morte di Maria.
Non era per fermo né impossibile, né malagevole al Signore il preservare Maria dalla morte, come sottratta avevala all’infezione della colpa d’origine; ma anche in questo Ei volle renderla conforme al suo divin Figlio. Che se il Signore permise alla morte di addormentare dolcemente Maria, non le permise tuttavolta di far preda della corruzione il verginale corpo di Lei. Esente dal peccato originale, e dalla triste concupiscenza che ne è la sequela, sempre pura la carne di Maria non doveva conoscere le umilianti trasformazioni della tomba, non avendo punto bisogno d’essere rinnovata, purificata, onde fosse degna di venir ammessa nel soggiorno della gloria. Messaggera di pace venne la morte a Maria: essa non fu che la cessazione d’un miracolo che operava il Signore per impedirle di morire sotto le ardenti impressioni d’un amore superiore a tutte le forze della natura. Laonde, diciamolo pure: la morte di Maria fu un ultimo atto di amore più acceso, più puro, più santamente appassionato di tutti gli altri, atto il quale separando dolcemente l’anima dal corpo, portolla tutta bella d’amore e di gloria nel seno del suo Dio. – La morte non verrà a noi per fermo quale venne a trovar la nostra Madre del cielo. Peccatore ciascun di noi come tutti i figli di Adamo, dovrà, a sua volta, andar soggetto al tremendo castigo inflitto dalla divina giustizia al primo dei peccatori, ed a tutta la di lui prosapia, i dolori più o meno diuturni dell’infermità, le agonie della natura, le tristezze e le lotte supreme. Ma consoliamoci: Gesù e Maria lasciarono le orme del loro passaggio nella morte onde raddolcirne gli orrori; ed agli estremi nostri momenti, non dubitiamone, ritroveremo queste orme benedette. E poi, dopo l’ultimo sospiro di Gesù sulla croce, ed il breve suo riposo nel sepolcro del Getsemani, non più muore il Cristiano abbandonato da Dio, e deserto di consolazioni: perchè temeremo adunque?
ESEMPIO.
Se i fedeli conoscessero di quanto spirituale profitto esser possono possono le sacre immagini, non le curerebbero sì poco per fermo. Comprendiamone il molteplice vantaggio: 1. Istruzione ed erudizione; la vista infatti di un’immagine di Maria ci ricorda che Ella è la Madre dell’adorabile Salvatore; e sebbene questa verità ci sia già stata proposta a credere dalla fede, non è men vero tuttavolta che per mezzo dell’immagine, si alimenta e si ravviva questa fede stessa. 2. Amor verso Maria; e non ti senti forse commosso dai più teneri affetti il cuore nell’abbatterli in una immagine che ti presenti quest’immacolata Vergine prostesa in atto di adorazione a’ pie della culla di Gesù bambino, o desolata sul Golgota, divenuta Madre tua per mezzo di mortali dolori, e via dicendo? 3. Eccitamento all’imitazione: le immagini sono volgarmente appellate il libro dei semplici, perché in una sola occhiata insegnano lunghissime storie e, dilettando, muovono ad amare la giustizia, la pietà, la devozione. 4. La memoria di Maria: in quanto che, in mezzo a tante nostre tribolazioni ed angustie, la vista d’una sua immagine ci ricorda che abbiamo una Madre, un’avvocata in cielo, di cui possiamo con tutta fiducia implorare il patrocinio. 5. Professione di fede: col venerarne le immagini, noi protestiamo di amare la fede, l’umiltà ecc. di Maria, e volerla esemplare.
Orazione.
O Maria, Vergine purissima, cui la morte fu l’istante del trionfo, non abbandonate la povera anima mia nel supremo momento che deciderà della sua sorte eterna. Copritemi allora con la materna vostra protezione, difendetemi dal furore dei miei nemici; fate che muoia munito dei santi sacramenti, e che l’estremo mio sospiro sia un atto d’amor di Dio, e di fiducia nella sua misericordia. Così sia.
OSSEQUIO.
State in ritiro, ed osservate particolar silenzio in questo giorno.
GIACULATORIA.
Pone, Domina, custodiam ori meo.
La lingua sordida
D’ atro veleno,
Madre, cingetemi
Di doppio freno.
387
O Cuore purissimo di Maria Vergine Santissima, ottenetemi da Gesù la purità e l’umiltà del cuore.
Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria, suetis conditionibus, dummodo quotidie per integrum mensem invocatio pia mente recitata fuierit (S. Pæn. Ap. , 13 ian. 1922 et 23 apr. 1934)

XXX. GIORNO.
Assunzione.
L’abbiamo detto: la tomba non doveva innervare fino al giorno della risurrezione universale la spoglia mortale della nostra divina Madre. Spuntata appena l’alba del terzo giorno dal transito della Vergine Immacolata, Gesù per un atto di sua onnipotenza riunì l’anima di Lei al corpo; e questo sacro corpo, rivestito di tutte le qualità dei corpi gloriosi, elevossi raggiante al cielo, rapidamente trasportatovi dall’ardore dell’amor divino, circondato da innumerevoli legioni d’Angeli, avventurati di formare comitiva d’onore a Colei la quale tutti superava in purezza, in amore, in gloria; ma non basta. Gesù, Gesù attendeva sulla soglia del suo regno onde introdurvela Egli medesimo, cingere la fronte di Lei con il diadema dell’immortalità e della gloria, e farle prendere possesso del trono che preparato aveale alla destra del suo. Questa è la visione dell’apostolo bene amato: Io vidi in cielo una donna rivestita di sole. Circondata, cioè della gloria del suo divin Figlio: Avente la luna sotto i suoi piedi; simbolo dell’umanità decaduta: Cinta la fronte d’un diadema di dodici stelle, le sue eroiche virtù. In tal guisa da Dio incoronata e glorificata, regna Maria sovrana del cielo e della terra. Non diamoci però a credere che Maria regnante in cielo, dimentichi noi poveri figli suoi, sì bisognosi di suo soccorso; oh! no: Ella fu costituita il canale per cui scendono sulla terra tutte le grazie del cielo, la mano di che giovasi il Signore per far a noi l’elemosina delle sue misericordie; ed il prezioso cuore di Lei è il vaso ove la bontà divina depose il balsamo destinato a lenire ogni nostro dolore, rimarginare ogni nostra piaga, sanare ogni infermità nostra. Laonde la confidenza nostra in Maria sia incrollabile, sia illimitata, sia intera; speriamo quand’anche fossimo caduti nel baratro di tutte iniquità; la mano di Lei troverà modo di trarcene; e la voce della gratitudine nostra unirassi allora a quella di tanti altri poveri suoi figli, per ripetere: Non invano s’invoca la Madre di Gesù, e nella bontà del cuore di Lei si confida.
ESEMPIO.
Non poche ragioni animar devono il cristiano a salutare la diletta Madre del cielo ogniqualvolta s’incontra in una di Lei immagine. 1. Onde rinnovar incessantemente la memoria dell’incarnazione del Verbo; 2. Per imitare l’Arcangelo Gabriele; se questo celeste messaggero infatti salutò così riverente Maria non ancor Madre del Dio fatto carne, che cosa non dobbiamo far noi adesso che Ella regna alla destra del suo Figlio, sovrana del cielo e della terra? 3. Lo spirito di santa Chiesa, la quale fin dai suoi primordii, rese familiare tra i fedeli questo modo di onorar Maria. 4. Il precetto di Gesù Cristo: Onora il tuo padre e la tua madre. E non è forse Maria vera madre nostra? — Copiosi ne deriveranno per noi i frutti da questa pia usanza: 1. Accrescimento di fede nel mistero dell’incarnazione. 2. Maggior desiderio di partecipare alle grazie di che fu ripiena Maria. 3. Finalmente l’amore e la protezione di Maria, la quale, risalutandoci, riempie di doni spirituali il nostro cuore. Vedine la prova nella Visitazione, prova dataci dal Vangelo stesso con queste parole: Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, fu tosto riempita di Spirito Santo, ed esultò Giovanni nelle di lei viscere. Impariamo a memoria ciò che a tale proposito dice S. Bernardo: Ride il cielo, rallegransi gli Angeli, fuggono i demoni, trema l’inferno ogniqualvolta tu con riverenza dici: AVE MARIA … O Maria, egli è darti un bacio il dirti: AVE MARIA. Tante volte sei baciata, o beatissima, quante volte sei salutata coll’AVE. Dunque, fratelli carissimi, approssimatevi alla di Lei immagine, piegate il ginocchio, datele un bacio, dite: AVE, MARIA.
Orazione.
O Vergine gloriosa che conosceste tutti i dolori dell’esilio, non obliate in mezzo alle gioje della patria, i poveri vostri figli della terra. Nostra patria eziandio è il cielo, acquistato a noi dal sangue del vostro divin Figlio. Deh! non permettete che noi lo perdiamo, ma aiutateci a redercene degni, onde possiamo un giorno contemplare la vostra gloria, amarvi ed eternamente benedire a voi con Gesù Cristo. Così sia.
OSSEQUIO.
Offrite a Maria tutto che avrete a sopportare in questo giorno in unione de’ suoi dolori.
GIACULATORIA.
Fac ut tecum lugeam.
Con voi sul Golgota
Del Figlio accanto
Fate che struggansi
Quest’occhi in pianto.
419
Oratio
Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio e
Madre nostra pietosissima, umilmente ci presentiamo
al vostro cospetto e con tutta fiducia vi
supplichiamo del vostro materno patrocinio.
Dalla santa Chiesa siete stata proclamata la
Consolatrice degli afflitti ed a voi continuamente
ricorrono i tribolati nelle afflizioni, gl’infermi
nelle malattie, i moribondi nelle agonie, i poveri
nelle strettezze, i bisognosi d’ogni maniera nelle
pubbliche e private calamità e tutti da voi ricevono
consolazione e conforto.
Madre nostra dolcissima, rivolgete anche sopra
di noi, miseri peccatori, le vostre tenere
pupille e benigna accogliete le nostre umili e
fiduciose preghiere. Soccorreteci in tutte le spirituali
e temporali necessità, liberateci da tutti
i mali e specialmente dal massimo, qual’è il peccato,
e da ogni pericolo di cadervi; impetrateci
dal vostro Figlio Gesù tutti i beni, di cui ci
vedete bisognosi per l’anima e per il corpo, e
specialmente il maggiore di tutti, qual’è la divina
grazia. Consolate il nostro spirito angustiato
ed afflitto in mezzo a tanti pericoli che
ci minacciano, fra tante miserie e disgrazie che
ci travagliano da ogni parte. Ve ne preghiamo
per quel giubilo immenso, che provò l’anima vostra
purissima nella gloriosa resurrezione del
vostro Figlio divino.
Impetrate tranquillità alla santa Chiesa, aiuto
e conforto al Capo visibile di essa, il Romano
Pontefice, pace ai Principi cristiani, refrigerio
nelle loro pene alle anime del purgatorio, ai
peccatori il perdono delle loro colpe, ai giusti
la perseveranza nel bene. Raccogliete tutti, Madre
nostra tenerissima, sotto la vostra pietosa
e potente protezione, affinchè possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguir l’eterna beatitudine in cielo. Così sia.
Indulgentia quingentorum dierum.
Indulgentia plenaria additis confessione, sacra Comunione et alicuius ecclesiæ vel publici oratorii visitatione
si quotidie per integrum mensem oratio recitata fuerit
(S. C. Indulg., 10 apr. 1907; S. Paen. Ap., 7 iun. 1935).

XXXI. GIORNO.
Maria esemplare de’ cristiani.
Nel proporre la Madre del suo adorabile sposo all’imitazione dei suoi figli, a tutti dice Chiesa Santa: « Siate imitatori di Maria come Maria fu imitatrice di suo Figlio. » A rendercene capaci gettiamo, in terminando questo mese, un rapido sguardo sui precipui tratti di somiglianza che corrono tra Figlio e Madre. « Gesù scende dal cielo unicamente per glorificare il Padre suo; e Maria a tal effetto si ritira trienne nel tempio, e consacra la sua verginità al Signore. » Gesù non vuol nascere che da Madre vergine, non aver che un uomo vergine per custode; e Maria prepone questa delicatissima delle virtù alla gloria della maternità divina. Tutta la vita di Gesù può dirsi un atto continuato di umiltà e di annientamento; e Maria chiamata dall’Arcangelo all’eccelsa e singolare dignità di Madre di Dio, non sa che rispondere: « Ecco l’ancella del Signore. » Il cibo del Cuore dell’adorabile Gesù è di fare costantemente la volontà del Padre, e l’obbedienza sua al Padre si fu quella che il guidò dal presepio al Getsemani, di qui al Calvario; e per lo stesso motivo accettò Maria la maternità divina, udì silenziosa il vaticinio di Simeone, ed attaccossi alla croce in posizione degna della Madre d’un Dio. Con ragione adunque viene da Chiesa santa proposta all’imitazione dei fedeli. – Non illudiamoci punto: la vera divozione a Maria consiste precipuamente nella imitazione delle sue virtù; né ci riconoscerà per figli suoi se non in ragione della uniformità della nostra condotta con la sua. Animiamoci adunque di santo ardore, di generoso coraggio, ed ormeggiamo la nostra Madre del cielo, come essa seguì le pedate del Capo dei predestinati, dell’esemplare degli eletti Cristo Gesù. Tal via costerà sacrifici, lotte, violenze alla corrotta natura; non importa; sovvengaci che Maria ci tende la mano dal cielo, e ci mostra la corona che ci sta preparata; ed i fiori di questa corona sono le virtù esercitate qui in terra, le quali sembrano comprendersi nell’umiltà, nella pazienza, nella sommissione alla volontà di Dio, nella rassegnazione tra le afflizioni.
ESEMPIO.
Chiunque desidera d’imitare l’Arcangelo Gabriele nel salutare l’augusta Madre di Dio, veda di ritrarre in sé angelici costumi, giusta quel detto: Se vuoi entrare dalla Vergine e salutarla, Angelo esser ti conviene; ed è per insinuare a noi una tale verità che il Signore non inviò che un Angelo a salutarla col grande Ave, Maria. Or bene, il nome di Angelo, ti dice precipuamente purezza, carità, umiltà. Puro è l’Angelo perché non contaminato dalla più lieve macchia di colpa, da verun affetto terreno, o carnale commercio. Tale sia chi saluta la Vergine purissima, se brama da Lei gradire il saluto. Emulatore, in secondo luogo, della carità degli Angeli esser deve chi vuole salutar degnamente Maria. Tra gli Angeli regna somma pace, somma concordia; somma pace, somma concordia pertanto regni eziandio tra quei figli che salutar vogliono la loro Madre celeste. E poi, il saluto a Maria, ricordandoci quello dell’Arcangelo, ci ricorda ad un tempo, il mistero dell’Incarnazione, e nel mistero dell’Incarnazione appunto cominciò l’adorabile Salvatore quel trattato di pace tra Dio e gli uomini, che poi compì sul Calvario, segnandolo col suo sangue. Si imiti finalmente l’umiltà degli Angeli. Nessun di noi ignora che se una parte degli Angeli vennero dannati alla morte eterna, causa ne fu la loro superbia: come eziandio se fedeli al Signore si mantennero tanti altri, fu in grazia dell’umiltà loro. Per questa ragione usavano molti santi di non mai salutare Maria se non piegando il ginocchio, così S. Caterina da Siena, S. Maria di Ognies, la b. Margherita domenicana, figlia del re di Ungheria; usanza che conservasi ancora tra noi, genuflettendo nel cantare la prima strofa dell’Ave Maris Stella, appunto perché comincia con l’angelico saluto: AVE.
Orazione.
O Maria, la più perfetta delle creature, io risolvo di seguirvi d’or innanzi nella via della perfezione, ed a vostro esempio condurre una vita umile di cuore, casta, paziente, rassegnata. Ma senza il vostro aiuto, a nulla giovano le mie risoluzioni; quindi nel vostro cuore io le depongo, tenera Madre mia, onde possa vincere la mia leggerezza, e metterle in pratica con coraggio e costanza. Così sia.
OSSEQUIO.
Recitate qualche orazione in ossequio ai santissimi Cuori di Gesù e di Maria.
GIACULATORIA.
Fece ut ardeat cor meum in amando Christum Deum.
Inestinguibile
Fiamma nel cuore,
Madre, accendetemi
Pel mio Signore.
276
Domine Iesu Christe, qui Mariæ et Ioseph
subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtùtibus
consecrasti: fac nos, utriusque ausilio,
Familiæ sanctæ tuæ exemplis instrui et consortium
consequi sempiternum: Qui vivis et
regnas in sæcula sæculorum. Àmen (ex Missali Rom.).
Indulgentia quinque annorum.
Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo
orationis recitatio, quotidie devote peracta, in integrum
mensem producta fuerit (S. Pæn. Ap., 3 sept. 1936).
CONSACRAZIONE A MARIA
Maria, Regina e Madre mia, non disdegnate che, in terminando questo benedetto mese, a voi consacri il mio cuore, l’anima mia, tutto che sono e posseggo. Sì, io vi appartengo, o Maria, come il figlio appartiene alla madre; accettate pertanto l’omaggio della mia venerazione, della mia confidenza; accettate la mia promessa di difendere, in quale che siasi circostanza di tempo e luogo, il vostro onore, la vostra gloria, di sostenere mai sempre gli interessi di Gesù ed i vostri, e dimostrarmi in ogni evento servo fedele, figlio docile ed amoroso. Benedite, o Vergine possente, il pastore ed il gregge; impetrate ai peccatori la grazia della conversione, la perseveranza ai giusti, la rassegnazione agli infermi ed ai tribolati. Fatevi per l’infanzia e la giovinezza la stella del mattino, per l’età matura la stella del mare, per la vecchiaia la stella della sera; per tutti la porta del cielo, onde possiamo, nessuno escluso, trovarci un giorno riuniti attorno al trono della vostra gloria, come adesso ai piedi de’ vostri altari, a benedire a voi e ad eternamente amarvi. Così sia.
FINE.