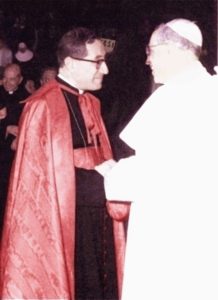
GREGORIO XVII – IL MAGISTERO IMPEDITO:
DE-DOGMATIZZAZIONE NELLA CHIESA
[«Renovatio», VIII (1973), fasc. 4, pp. 531-533]
Esiste il tentativo di abolire gradualmente i dogmi, ossia le verità definite che fissano la rivelazione divina, e quanto ne consegue? Dobbiamo rispondere affermativamente. Il pericolo verrà certamente superato, perché il divin Fondatore ha garantito l’indefettibilità alla sua Chiesa. Ma tentativo e pericolo esistono in forma preoccupante. Nel numero di «Le Monde» del 29 dicembre 1973, Henry Fesquet, un commentatore religioso ascoltato nel mondo cattolico francese, scrive: «Pio XII aveva ragione. L’ondata di protestantesimo, di cui egli aveva avvertito i primi effetti, ha invaso la Chiesa Cattolica nel suo complesso quattro secoli dopo la Riforma … Difendere la purezza della dottrina è un compito sempre più ingrato, persino impossibile». – Difendere la verità è un compito sempre grato e sempre possibile. Tuttavia riportiamo i giudizi del Fesquet perché sono una palinodia di quegli ambienti, ecclesiastici e laici, i quali non scorgevano nel corso degli anni sessanta altro che luce in tutto ciò che nella Chiesa si poneva sotto l’insegna del mutamento. Ora Fesquet ci dice che invece di mutamento spesso si è trattato di rottura e, anzi, di negazione. – I fatti parlano: eccone alcuni. Sono comparsi dei catechismi, in taluni dei quali qualche verità è svanita (e si tratta di verità fondamentali), come quella del peccato originale, senza cui si cancella la logica di tutta la Redenzione. Le titubanze, i rallentamenti nella redazione di taluni catechismi sono significativi. I discorsi teologici (e nulla si fa oggi, anche di banale, senza preporre delle «ragioni teologiche») diventano sempre più vaghi e sfuggenti dalle verità concrete, chiare, rese in semplicità di termini, accettati e capiti. Si è adottato un vocabolario diffuso, ma per il quale nessuno ha inequivocamente fissato il valore dei singoli termini. Questi termini hanno viceversa il risultato di permettere vari inconvenienti: quello di capire ciò che si vuole o, meglio, ciò che piace, quello di introdurre postulati di vario genere, hegeliano, freudiano, sociologistico, che apertamente non si enuncerebbero. Evanescenze, sfumature, lungaggini inconcludenti spingono i termini chiari della verità nel porto delle nebbie. Ciò appare a chi anche soltanto sfogli l’enormità di scritti poligrafati che siamo condannati a ricevere e, spesso, per dovere, a leggere. – L’acrimonia verso la teologia speculativa è ormai endemica. Appare non solo dal disprezzo che presso non pochi essa raccoglie, ma dalla sostituzione, anche in recenti opere notevoli, di un puro metodo storico (meglio sarebbe dire storicistico), al metodo teologico (pur se la teologia ricostruisce l’interpretazione della Bibbia e della Tradizione servendosi di elementi storici od aventi un carattere anche storico). – C’è di più. In molta predicazione ed in molta saggistica è rimasto un Cristo che si rassomiglia assai a quello del «Jesus festival» o al «Christ superstar», mentre se ne diluisce o se ne nasconde la divinità. Il tentativo di «de-dogmatizzazione» tenta di assumere un volto scientifico, alterando il metodo teologico, che è indicato dalla stessa rivelazione divina. Si tacciono gli interventi del Magistero, dimenticando magari quelli solenni (il Concilio di Trento è particolarmente colpito); si elencano i placita dei «teologi» moderni che divengono criteri di verità. – Ma i teologi non possono cambiare la teologia: al contrario, se si pongono sulla strada di un metodo sbagliato, non possono non uscire dalla comunione della verità. L’amore per il prossimo diviene la lotta di classe. E l’amore stesso, del resto, cessa di essere spirito per ridursi a eros. Riecheggia, ininterrotta, la dossologia alla fraternità, all’eguaglianza e, soprattutto, alla libertà (di fare quel che piace). Non pochi, anche tenendo conto degli atteggiamenti concreti e personali, stanno facendo la sostituzione del Cristianesimo col sociologismo. La gravissima ignoranza teologica fa sì che molti applaudono ad esibizioni apostoliche, solo per non sembrar da meno degli altri. – Si parla di fede: certo, ma senza dottrina. Ossia senza verità precise, senza proposizioni, senza formule. Abbiamo letto sulla rivista «Concilium» questa citazione di E. Durkheim: «C’è qualcosa di eterno nella religione che è destinato a sopravvivere a tutti i simboli particolari nei quali il pensiero religioso si è progressivamente sviluppato». Così, con un pizzico di simbolismo e di evoluzionismo, si arriva ad una religione senza attributi e senza manifestazioni. Le spogliazioni delle chiese ne sono il segno precorritore. Sparito il sole, restano le nebbie. Il tentativo di «de-dogmatizzare» la Chiesa comincia dall’odio alle formule ed alle proposizioni precise. Quando si delinea questo andazzo, le conclusioni sono scontate sin dai primi segni, quali l’apatia per le definizioni dei concetti, dei termini e delle cose. – La Chiesa ha sempre difeso la Rivelazione con proposizioni precise. Non che queste abbiano creato la verità, l’hanno solo posta in risalto per renderla inequivocamente chiara. La fede nell’Assunzione esisteva prima della definizione del 1950. L’Immacolata era nella fede della Chiesa prima del 1854, così come la divinità di Cristo era tenuta con una certezza tenacissima, fino al martirio, prima del Concilio di Nicea. – “Generalmente le definizioni sono venute dopo le eresie, ossia dopo gli attacchi, ed hanno costituito la linea di sbarramento. In tal modo si è salvata la Chiesa delle verità certe dal mercato delle opinioni. Le proposizioni sono state redatte talvolta in forma positiva, talvolta in forma negativa, ossia di condanna. Le due forme hanno avuto lo stesso risultato. La stima e la gratitudine degli uomini va alla Chiesa di Dio, perché è attrice di certezze, non propalatrice di dubbi eterni.
