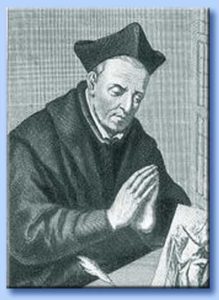Introitus Ps XXX: 3-4
Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me. – [Sii mio protettore, o Dio, e mio luogo di rifugio per salvarmi: poiché tu sei la mia fortezza e il mio riparo: per il tuo nome guidami e assistimi.]
Ps XXX:2
In te, Dómine, sperávi, non confúndar in ætérnum: in justítia tua líbera me et éripe me. – [In Te, o Signore, ho sperato, ch’io non resti confuso in eterno: nella tua giustizia líberami e sàlvami.]
Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me. – [Sii mio protettore, o Dio, e mio luogo di rifugio per salvarmi: poiché tu sei la mia fortezza e il mio riparo: per il tuo nome guídami e assistimi.]
Orémus. Preces nostras, quaesumus, Dómine, cleménter exáudi: atque, a peccatórum vínculis absolútos, ab omni nos adversitáte custódi. [O Signore, Te ne preghiamo, esaudisci clemente le nostre preghiere: e liberati dai ceppi del peccato, preservaci da ogni avversità.]
Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.
Amen.
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios.
1 Cor XIII:1-13
“Fratres: Si linguis hóminum loquar et Angelórum, caritátem autem non hábeam, factus sum velut æs sonans aut cýmbalum tínniens. Et si habúero prophétiam, et nóverim mystéria ómnia et omnem sciéntiam: et si habúero omnem fidem, ita ut montes tránsferam, caritátem autem non habúero, nihil sum. Et si distribúero in cibos páuperum omnes facultátes meas, et si tradídero corpus meum, ita ut árdeam, caritátem autem non habuero, nihil mihi prodest. Cáritas patiens est, benígna est: cáritas non æmulátur, non agit pérperam, non inflátur, non est ambitiósa, non quærit quæ sua sunt, non irritátur, non cógitat malum, non gaudet super iniquitáte, congáudet autem veritáti: ómnia suffert, ómnia credit, ómnia sperat, ómnia sústinet. Cáritas numquam éxcidit: sive prophétiæ evacuabúntur, sive linguæ cessábunt, sive sciéntia destruétur. Ex parte enim cognóscimus, et ex parte prophetámus. Cum autem vénerit quod perféctum est, evacuábitur quod ex parte est. Cum essem párvulus, loquébar ut párvulus, sapiébam ut párvulus, cogitábam ut párvulus. Quando autem factus sum vir, evacuávi quæ erant párvuli. Vidémus nunc per spéculum in ænígmate: tunc autem fácie ad fáciem. Nunc cognósco ex parte: tunc autem cognóscam, sicut et cógnitus sum. Nunc autem manent fides, spes, cáritas, tria hæc: major autem horum est cáritas.” –
Omelia I
[Mons. Bonomelli, Nuovo Saggio di Omelie, vol. I, Marietti ed. Torino, 1899 – Om. XXV]
“Quand’io parlassi lingue di uomini e di angeli, se non ho carità, divento un rame sonoro e un cembalo tintinnante. Avessi anche profezia e intendessi tutti i misteri e tutta la scienza; e avessi anche tutta la fede fino a trasportare i monti, se non ho carità, sono un bel nulla. Spendessi pure tutte le mie facoltà in nutrire i poveri, e dessi alle fiamme il mio corpo, se non ho carità, tutto questo non mi giova nulla. La carità è longanime, è benigna; la carità non invidia, non è insolente, non si gonfia, non è scomposta, non cerca le cose proprie, non si inasprisce, non pensa male, non si rallegra della ingiustizia, ma della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sostiene. La carità non vien meno mai: le profezie avran fine, le lingue cesseranno e la scienza svanirà: perché ora conosciamo in parte e in parte profetiamo; ma quando tutto sarà perfetto, allora il parziale finirà. Allorché io era fanciullo, parlava da fanciullo, ragionava da fanciullo; ma allorché divenni uomo, ho smesse le cose da fanciullo. Finora vediamo le cose come in uno specchio, in enigma; ma allora vedremo faccia a faccia; finora conosco in parte, ma allora conoscerò come sono conosciuto. Queste tre cose durano al presente, fede, speranza e carità, ma la massima di queste è la carità „ (I. Cor. XIII, 1-13).
In questo tratto che vi ho recitato, voi avete l’intero capo decimoterzo della prima lettera di S. Paolo ai fedeli di Corinto. Voi stessi udendo queste sentenze, avrete compreso che in esse si racchiude un tesoro di sapienza pratica, un capolavoro di dottrina celeste. Mi duole che la strettezza del tempo mi tolga di sviluppare con qualche ampiezza questa sì sublime pagina dell’Apostolo: dovrò sfiorarla appena; ma la vostra attenzione supplisca alla brevità forzata del commento e approfondisca ciò ch’io avrò toccato di volo. – Nei primi tempi della Chiesa erano frequentissimi i doni straordinari tra i fedeli; doni di profezia, di diverse lingue, di conoscimenti dell’interno degli spiriti, di guarigioni miracolose; Dio ne era largo allora perché trattavasi di stabilire la fede: più tardi, scemando il bisogno, perché la fede era già stabilita, scemarono anche quei doni straordinari. Questi abbondavano nella Chiesa di Corinto, e san Paolo ne parla più volte, e dopo aver dato sapienti norme intorno all’uso di questi doni passa a dimostrare, che vi sono doni ben più eccellenti e desiderabili che quelli, dei quali i Corinti facevano tanto rumore, perché quei doni straordinari, anche sommi, sono nulla senza la carità, virtù regina e radice di tutte le altre, e qui comincia 1’insegnamento dell’Apostolo. Ascoltiamolo. – “Quand’io parlassi lingue di uomini e di Angeli, se non ho carità divento un rame sonoro e un cembalo tintinnante. Avessi anche profezia e intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi anche tutta la fede fino a trasportare i monti, se non ho carità, sono un bel nulla. „ Qui l’Apostolo vuol dimostrare che la carità, s’intende verso Dio e per conseguenza anche verso il prossimo, è la massima tra le virtù a talché senza di essa tutto il resto è inutile. Non occorre che vi dica, come questa carità, di cui parla l’Apostolo, stia riposta nel cuore e si traduca poi nelle opere. E gran cosa, così S. Paolo, parlare le lingue degli uomini, più gran cosa ancora sarebbe parlare la lingua degli Angeli e possedere il dono della profezia e penetrare tutti i misteri della terra e del cielo, grandissima cosa poi sarebbe aver tal fede da trasportare i monti. Chi non ammirerebbe l’uomo che tutto questo possedesse? chi non lo saluterebbe come un miracolo vivente? Ebbene, esclama l’Apostolo: vi dico che quest’uomo, se fosse privo di carità, non sarebbe altro che un rame, il quale percosso, dà un po’ di suono; sarebbe meno ancora, un nulla. Né qui si ferma l’Apostolo; ma, incalzando l’argomento, continua e dice: “Se spendessi tutte le mie facoltà in nutrire i poveri e dessi alle fiamme il mio corpo, se non ho carità tutto questo non mi giova nulla. „ Si direbbe che questa è una esagerazione, eppure è una verità indubitata. Come! direte voi: un uomo può dar tutte le sue sostanze ai poverelli, anzi dare la vita stessa e darla in mezzo alle fiamme e non avere carità e perdersi eternamente? Gesù Cristo non dice Egli nel Vangelo, che nessuno ha maggior carità di colui che dà la sua vita per il prossimo? Dare adunque la vita per il prossimo è avere la carità in grado sommo. Come dunque qui l’Apostolo suppone che altri si immoli per il prossimo e non abbia la carità e nulla gli giovi il sacrificio stesso della vita? come ciò può essere? Sì; quando un uomo facesse tutto questo, non per amore di Dio, per ubbidire a Lui, ma per ambizione, per orgoglio, per capriccio, per ostinazione e per altre cause somiglianti, certamente peccherebbe e anziché premio meriterebbe castigo, e qualche raro esempio di tanta follia non manca nella storia. I sacrifici che si fanno, anche i massimi, come quello delle sostanze e della vita, ricevono il valore e merito dal fine, dal motivo, per il quale si fanno; se non si fanno per Iddio, per la carità, che a Lui ci lega, che valgono? Nulla. Del resto S. Paolo in questo luogo non parla del fatto, ma fa un’ipotesi, come se dicesse: Posto pure che un uomo versasse tutti i suoi beni in seno agli indigenti fino a ridursi all’estrema miseria e che immolasse la sua vita istessa (cosa umanamente impossibile, se non ha la carità), tutto è gettato inutilmente. — Comprendete, o cari, qual sia il pregio della carità: con essa, tutto giova; senza di essa, nulla giova pel cielo. Qui S. Paolo, con uno di quei rapidi passaggi, che s’incontrano non raramente nelle sue lettere, prende a tratteggiare con mano maestra le qualità della carità cristiana. Consideriamole ad una ad una e non lo faremo senza frutto. – ” La carità è longanime. „ Chi ha il cuore ripieno di carità non solo possiede la pazienza, che è fortezza e grandezza d’animo, ma è longanime, cioè è temperato per modo che i dolori e le tribolazioni, per quanto siano lunghe ed aspre, non lo turbano e lo trovano sempre eguale. “La carità è benigna. „ La carità paziente, dice S. Bernardo, basta; ma la carità benigna colma la misura: la carità paziente ama quelli che tollera; la carità benigna, li ama ardentemente. La carità compone costantemente il viso a benevolenza inalterabile e mette sulle labbra parole di pace e d’amore. “La carità non invidia. „ Chi ama il prossimo per amore di Dio, lo ama come se stesso non conosce il tuo ed il mio e gode tanto del proprio come dell’altrui bene, e perciò non sa che cosa sia invidia. – “La carità non è insolente. La carità è sempre delicata e mette ogni studio in non recare offesa o dispiacere a chicchessia con atti, o parole, o in qualsiasi modo, perché il dispiacere altrui è dispiacere proprio; perciò serba la giusta misura in ogni cosa, sempre tranquilla e modesta. – “La carità non si gonfia. „ La vanità, l’orgoglio, l’arroganza sono frutti della mala pianta dell’amor proprio sregolato; questo domato e ridotto alla obbedienza, regna la carità, che è sempre umile, mansueta, dolce con tutti. – “La carità non è scomposta. „ La virtù che tutte le altre contiene e avviva, la carità, è madre dell’ ordine e dell’armonia in ogni cosa, e perciò elimina dolcemente ogni durezza, ogni scabrosità, tutto ciò che sia o sembri meno decente; essa, come dice graziosamente il Crisostomo, con le sue ali d’oro, copre i difetti di tutti quelli che abbraccia. – “La carità non cerca il suo interesse. Se noi volgiamo intorno gli occhi, vediamo che pur troppo gli uomini cercano le cose loro, quærunt quæ sua sunt. Per sé gli onori, per sé le ricchezze, per sé i piaceri, per sé ogni cosa: il loro io è il centro a cui convergono tutti i loro pensieri, desideri! e sforzi: la carità inverte le parti: dimentica sé per gli altri, ama dare più che ricevere, simile a Dio che dà a tutti sempre e largamente. – “La carità non si inasprisce, non pensa male. „ Certamente chi ama, fa opera di rimuovere dalla persona amata qualunque male e si ingegna di procurarle ogni bene: per far ciò non è raro che sia necessario usare modi fermi ed austeri e ricorrere a mezzi spiacevoli e dolorosi: il medico che vuole la guarigione dell’infermo, lo tormenta col ferro e col fuoco; il padre che vuole 1’emenda del figlio riottoso, lo rimprovera e punisce. Forseché diremo che qui la carità si inasprisce? No, mai, carissimi. Essa, anche quando castiga e ferisce e flagella è sempre dolce e amabile e trova mille vie per far sentire e toccare, che ama e fa tutto per amore. L’occhio, l’accento, l’atteggiamento, il tutto della persona vi dice che è sempre l’amore che opera, tanto più caro e ardente in quanto che soffre e fa soffrire suo malgrado, onde è vero il detto del poeta: “Né per sferza è però madre men pia”. – La carità non tradisce mai la verità, e se altri apertamente fa male, non dirà, né penserà che faccia bene, no, per fermo. Ma se nel fratello che fa male può supporre l’inavvertenza, la buona fede, un fine lodevole, un errore involontario, ella sarà ben lieta di pensarlo e dirlo, perché non pensa male se non forzata dalla verità e sempre a malincuore. – “La carità non si rallegra della ingiustizia, ma della verità. „ Sante parole! L’anima è fatta per la virtù, per la giustizia e per la verità, come l’occhio per la luce e l’orecchio per l’armonia, e per ciò essa gode e si letizia di tutto ciò che è conforme a virtù, a giustizia e a verità: è la sua musica, è la sua gioia più pura. Figliuoli, amate sempre la verità e la giustizia, fuggite e abbominate la menzogna e l’ingiustizia dovunque appariscano. . “La carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sostiene. „ L’uomo informato alla vera carità tutto copre, cioè dissimula fin dove è possibile gli altrui difetti e pietosamente nasconde i loro falli, è inchinevole a credere alle altrui parole, perché tutti reputa buoni, spera sempre bene di tutti e tutti amorevolmente tollera senza lagnarsi e tollera perché spera. Non è poi mestieri l’osservare, che tutto si deve credere e tutto sperare secondo ragione e verità, perché dove la ragione e la verità non permettono il credere e lo sperare, sarebbe debolezza e stoltezza il credere e lo sperare, giacché non è mai virtù quella che si scompagna dalla verità. La Scrittura santa ci insegna che è leggero chi crede tosto senza motivi sufficienti. Ricordatelo bene, o dilettissimi. La religione non ci obbliga mai ad operare contro ragione, perché anche questa, come la religione, viene da Dio, e se noi prestassimo fede a tutto ciò che si dice, senza assicurarci della verità delle cose, meritamente cadremmo in disprezzo e offenderemmo la religione stessa. – L’Apostolo prosegue ancora enumerando altri pregi della carità in confronto degli altri doni sopra accennati della profezia, delle lingue e della scienza, e dice: “La carità non viene mai meno; le profezie avranno termine, le lingue cesseranno, e la scienza svanirà. „ Tutti questi doni, benché eccellenti, sono ristretti alla vita presente: sono mezzi più o meno efficaci per condurci a Dio, e alla morte cesseranno, ma non cesserà la carità. L’amore verso Dio e le sue immagini vive, acceso nelle anime qui in terra, allorché entreremo in cielo, si purificherà, crescerà a dismisura e durerà per tutti i secoli. – “Ora conosciamo in parte e in parte profetiamo, ma quando tutto sarà perfetto, allora finirà ciò che è parziale. „ Che cosa è la scienza nostra qui in terra? E una favilla, tenue favilla in confronto del sole: la nostra scienza quaggiù in terra, sia quanto vi piace grande e acuta, è sempre circoscritta a poche cose, mista a dubbi ed errori e mutevole: la profezia poi, che è parte della scienza infusa, non dà il conoscimento che di alcuni punti del futuro. Ebbene: quando porremo piede in cielo, spariranno tutti questi limiti e queste imperfezioni: alla scienza incerta e limitata, alla profezia sottentrerà la scienza piena e perfetta, perché tutto vedremo senza velo in Dio. — Qui l’Apostolo rischiara la cosa con una immagine graziosa e semplicissima. ” Quand’io ero fanciullo, parlavo da fanciullo, giudicavo da fanciullo, ragionavo da fanciullo; ma come divenni uomo, smisi ciò che era da fanciullo. „ È cosa che ciascuno di noi ha sperimentato. Il nodo di pensare, di operare, di ragionare varia secondo gli anni: a sei, a sette, a dieci, a dodici anni quali erano i nostri pensieri, discorsi e giudizi? Ditelo voi. Crescemmo e toccammo i quindici, i venti, i trent’anni; senza accorgerci, li mutammo in altri e certamente migliori e degni d’uomini fatti; passammo dall’imperfetto al perfetto relativo, dal fanciullesco al virile; così, dice S. Paolo, e in nodo ben più perfetto, ci muteremo, passando dalla terra al cielo. – Alcuni talvolta rinfacciano ad altri d’aver mutato, come se il mutarsi per se stesso fosse cosa biasimevole. Conviene distinguere: se si muta il vero in falso, il bene in male, è certo cosa altamente biasimevole; ma se si muta il falso in vero, il male in bene, l’imperfetto in perfetto, il bene in meglio, il meglio in ottimo, chi vorrà farne biasimo? Ogni cognizione che acquisto è un mutamento nell’anima mia, e in questo senso tutti ci mutiamo e sarebbe da stolti muoverne lamento o farne le meraviglie. – “Finora vediamo per ispecchio. in enigma. „ Nell’ordine presente del tempo vediamo le cose per riflesso, quasi in nube, come 1’immagine nello specchio; ma in cielo “vedremo faccia a faccia, cioè direttamente, senza mezzo, come sono in se medesime. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò come sono conosciuto, ., non già con la perfezione infinita, con cui Dio conosce me (cosa impossibile), ma sì per modo diretto, senz’ombra di mezzo creato, e in Lui e per Lui conoscerò tutto quello che mi sarà possibile di conoscere. – “Queste tre cose, conchiude l’Apostolo, durano al presente, fede, speranza e carità, ma di queste la carità è la maggiore: „ la maggiore per le cose sopra dette. Carissimi! Dio è carità, come insegna san Giovanni; figli di Dio, figli della carità, mostriamoci tali costantemente nelle parole e nelle opere, che questo è il compimento della legge.
Graduale : Ps LXXVI:15; LXXVI:16
Tu es Deus qui facis mirabília solus: notam fecísti in géntibus virtútem tuam. . [Tu sei Dio, il solo che operi meraviglie: hai fatto conoscere tra le genti la tua potenza.]
Liberásti in bráchio tuo pópulum tuum, fílios Israel et Joseph
[Liberasti con la tua forza il tuo popolo, i figli di Israele e di Giuseppe.]
Tratto: Ps XCIX:1-2
Jubiláte Deo, omnis terra: servíte Dómino in lætítia, V. Intráte in conspéctu ejus in exsultatióne: scitóte, quod Dóminus ipse est Deus. V. Ipse fecit nos, et non ipsi nos: nos autem pópulus ejus, et oves páscuæ ejus.
[Acclama a Dio, o terra tutta: servite il Signore in letizia. V. Entrate alla sua presenza con esultanza: sappiate che il Signore è Dio. V. Egli stesso ci ha fatti, e non noi stessi: noi siamo il suo popolo e il suo gregge.]
Evangelium
Luc XVIII:31-43
“In illo témpore: Assúmpsit Jesus duódecim, et ait illis: Ecce, ascéndimus Jerosólymam, et consummabúntur ómnia, quæ scripta sunt per Prophétas de Fílio hominis. Tradátur enim Géntibus, et illudétur, et flagellábitur, et conspuétur: et postquam flagelláverint, occídent eum, et tértia die resúrget. Et ipsi nihil horum intellexérunt, et erat verbum istud abscónditum ab eis, et non intellegébant quæ dicebántur. Factum est autem, cum appropinquáret Jéricho, cæcus quidam sedébat secus viam, mendícans. Et cum audíret turbam prætereúntem, interrogábat, quid hoc esset. Dixérunt autem ei, quod Jesus Nazarénus transíret. Et clamávit, dicens: Jesu, fili David, miserére mei. Et qui præíbant, increpábant eum, ut tacéret. Ipse vero multo magis clamábat: Fili David, miserére mei. Stans autem Jesus, jussit illum addúci ad se. Et cum appropinquásset, interrogávit illum, dicens: Quid tibi vis fáciam? At ille dixit: Dómine, ut vídeam. Et Jesus dixit illi: Réspice, fides tua te salvum fecit. Et conféstim vidit, et sequebátur illum, magníficans Deum. Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo.” –
Omelia II
[Mons. Bonomelli, Nuovo Saggio di Omelie, vol. I, Marietti ed. Torino, 1899 – Om. XXVI]
“Presi seco i dodici, Gesù disse loro: Ecco noi andiamo a Gerusalemme e tutte le cose scritte dai profeti intorno al Figliuol dell’uomo, saranno compiute. Perocché egli sarà dato in mano ai gentili, vilipeso, flagellato e sputacchiato. E poiché l’avranno flagellato, l’uccideranno e il terzo dì risorgerà. Ma essi non compresero nulla di queste cose, perché questo ragionamento era loro occulto e non intendevano le cose dette loro. Avvicinandosi a Gerico, avvenne, che un certo cieco stava lungo la via, chiedendo la limosina. Ora, questi, udito il rumore della folla che passava, domandò che cosa fosse, e gli risposero che passava Gesù di Nazaret. Allora egli si pose a gridare: Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. E quelli che andavano innanzi lo sgridavano affinché tacesse. E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato, e come gli fu presso, lo interrogò, dicendo: Che vuoi ch’io ti faccia? e quegli: Signore, ch’io riabbia la vista. E Gesù gli disse: Vedi; la tua fede ti ha fatto salvo. E incontanente riebbe la vista e lo seguitava, glorificando Iddio; e tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio.„
È questo, o carissimi, l’odierno Vangelo, che la Chiesa ci propone a meditare in questa Domenica detta di Quinquagesima. Esso si divide in due parti ben distinte tra di loro: nella prima si contiene l’annunzio chiarissimo che Gesù Cristo fa della prossima sua passione, morte e risurrezione: nella seconda si narra il miracolo operato da Gesù Cristo presso a Gerico nella persona d’un cieco. Tutto questo avvenne nell’ultimo viaggio di Gesù Cristo dalla Galilea a Gerusalemme, poco prima della sua entrata trionfale in quella città. — Veniamo alla spiegazione. – “Presi seco i dodici, Gesù disse loro: Ecco noi entriamo a Gerusalemme e tutte le cose scritte dai profeti intorno al Figliuol dell’uomo saranno compiute. „ Gesù aveva settantadue discepoli e dodici Apostoli, che più o meno lo seguivano dovunque, massime verso la fine di sua vita; i dodici Apostoli poi erano ammessi a speciali confidenze, come tre fra i dodici erano ammessi a specialissime; è cosa manifesta dai Vangeli. Gesù adunque dalla Galilea movendo verso Gerusalemme per l’ultima volta, ebbe a sé i dodici Apostoli e disse loro chiaramente che i vaticini dei profeti intorno alla sua Persona erano prossimi a compirsi, e venendo più al particolare intorno a questi vaticini, soggiunse: “Il Figliuol dell’uomo, cioè l’uomo che vi parla, sarà consegnato ai gentili, e vilipeso, e flagellato, e sputacchiato, e poiché l’avranno flagellato, l’uccideranno e il terzo dì risorgerà. „ Ecco, o dilettissimi, una profezia sovra ogni altra splendidissima. Che cosa si domanda per avere una profezia nel senso rigoroso della parola e una prova divina della verità? Si domanda che si annunzi in termini chiari una cosa futura; una cosa futura affatto impossibile a prevedersi con la ragione umana, e che la cosa annunziata avvenga nel tempo, luogo e modo determinati. Ora queste parole di Gesù Cristo contengono esse una profezia, che abbia tutti questi caratteri? Indubitatamente. Gesù Cristo annunzia la vicina sua morte accompagnata da circostanze particolarissime: doveva avvenire in Gerusalemme, fra breve, per opera degli Ebrei e dei gentili, dopo essere stato vilipeso, flagellato, sputacchiato. Più: predice nettamente la risurrezione e ne fissa il giorno. Tutto questo poteva Egli predire, umanamente ragionando? No: perché tutto questo dipendeva dalla volontà altrui, volontà libera, che poteva fare e non fare a quel modo, e nessuno aveva manifestato e forse allora non ci pensava nemmeno. I termini, coi quali Gesù Cristo annunzia tutto questo, non hanno ombra di incertezza, di ambiguità: la chiarezza non potrebbe essere maggiore. Dodici persone ascoltano quel vaticinio, lo riferiscono e ne sono testimoni oculari, e tanta è la certezza loro quanto all’adempimento, che tutti, a loro tempo morranno per Lui, che lo predisse. E il fatto della passione, della morte e della risurrezione, sì complesso e sì determinato, avvenne come fu predetto? Il mondo intero lo attesta. Noi dunque abbiamo in queste parole di Gesù una magnifica profezia adempiuta letteralmente e per conseguenza una prova luminosissima della sua divinità, perché Dio solo poteva conoscere tutto questo cumulo di fatti. Direte: Questa profezia prova che Gesù Cristo poteva essere ed era profeta, non mai che fosse Dio. Moltissimi furono i profeti, ma nessuno dalle loro profezie argomentò che essi fossero Dio. Obbiezione facilissima a sciogliersi: Molti, moltissimi furono i profeti, ma nessuno di loro disse: Io sono il Figliuolo di Dio e Dio. Solo l’affermò chiaramente e ripetutamente Gesù Cristo: le profezie pertanto fatte e perfettamente adempiute mostrano la sua divinità, se non vogliamo dire che Dio concorre col miracolo a provare 1′ errore e la bestemmia, e massimo errore, massima bestemmia sarebbe l’affermazione di Gesù: Io sono Dio! E perché Gesù Cristo volle fare agli Apostoli questa profezia? Evidentemente per prepararli a quella prova terribile, per togliere o almeno scemare l’effetto dello scandalo che la loro debolezza doveva risentire alla vista della sua morte obbrobriosa e per dar loro in mano un argomento perentorio della sua divina missione. “Voi vedete, così S. Giovanni Crisostomo fa parlare Gesù Cristo, voi vedete che volontariamente io vo alla morte. Allorché mi vedrete confitto in croce, badate di non considerarmi come un semplice uomo, perché se il poter morire è da uomo, il voler morire non è da uomo. „ Questa profezia pertanto era un atto di bontà e di misericordia coi suoi Apostoli, era un temperare la ferita acerbissima che avrebbero provato alla vista dello scempio e della morte crudelissima del divino Maestro. E perché Gesù Cristo disse tutto ai soli Apostoli e non a tutti i suoi discepoli e alle turbe che lo seguivano? Altre volte ciò aveva fatto, sebbene in modo men chiaro: poi, dicendolo ai dodici Apostoli, in qualche modo lo faceva conoscere anche agli altri, e forse con ciò volle dar loro un segno peculiare del suo amore. – Che dissero e fecero gli Apostoli, udendo quelle parole di Gesù Cristo? Non lo crederemmo se non lo leggessimo registrato nel Vangelo. “Essi non compresero nulla di queste cose, perché questo ragionamento era loro occulto e non intendevano le cose dette loro. „ Come ciò, o dilettissimi ? Forseché non capivano il senso materiale delle parole e non sapevano che cosa fosse l’essere dato in mano ai gentili, essere vilipeso, flagellato, sputacchiato, morire e risorgere? Certo che sì: essi comprendevano troppo bene il significato naturale delle parole, ma non comprendevano, non sapevano persuadersi che tutto questo avesse a compirsi nella persona del divino Maestro. Lo amavano, lo adoravano: attendevano da Lui la ristorazione del regno temporale d’Israele, aspettavano il suo trionfo tutto alla foggia ebraica, cioè materiale: come dunque comprendere tante umiliazioni, la morte, la risurrezione di Gesù Cristo? Non ricusavano fede alle parole di Lui, credevano anche, ma non potevano comporre tutte queste cose che a loro sembravano ripugnanti: confusi, sbigottiti, afflitti ascoltavano e tacevano: solamente i fatti avrebbero potuto snodare 1e loro difficoltà e illuminarli, e così avvenne. – Intanto ammiriamo la schiettezza veramente meravigliosa degli Evangelisti, che non esitarono a narrare tanta ignoranza degli Apostoli e a farla conoscere a tutto il mondo, e da loro apprendiamo noi pure ad amare la sincerità, ancorché ci costi assai, e a confessare, quando occorra, i nostri falli senza arrossire. Questo fatto della ignoranza degli Apostoli è anche una grande lezione per noi tutti. Gli Apostoli, formati alla scuola stessa di Gesù Cristo, non avevano ancora compreso la sostanza del suo insegnamento, che si riduce pressoché tutto alla scienza della croce: qual meraviglia pertanto che anche al giorno d’oggi molti cristiani si mostrino ripugnanti alla dottrina e alla pratica della croce, che è il succo del Vangelo? È dunque ben giusto che siam pieni di compatimento verso tanti cristiani ignoranti, pensando che lo erano anche gli Apostoli istruiti da Gesù Cristo istesso. S. Luca passa alla narrazione del miracolo del cieco, avvenuto presso Gerico (S. Matteo [XX, 29] e S. Marco [X, 46] parlano di due ciechi guariti da Gesù Cristo, e qui S. Luca d’un solo. Sembra certo che siano stati guariti l’uno nell’entrare, l’altro nell’uscire da Gerico; quei due Evangelisti li mettono insieme, S. Luca parla solamente del primo.). “Nell’accostarsi a Gerico, avvenne che un certo cieco stava lungo la via, domandando la limosina.„ Il Vangelista qui non dice il suo nome, ma è forse quel figliuolo di Timeo, del quale scrive S. Luca: come sogliono fare i ciechi poveri sedeva lungo la via, tendendo la mano e chiedendo la limosima a quanti passavano. – Il povero cieco udì l’insolito rumore della turba che precedeva e seguitava Gesù Cristo: tese l’orecchio, s’accorse di qualche cosa di straordinaria che avveniva e stimolato dalla naturale curiosità, a quelli che erano più presso, domandò che cosa fosse. E tosto gli fu risposto: “Che passava Gesù di Nazaret. „ Appena ebbe udito quel nome, che più volte era risuonato ai suoi orecchi come quello di un gran profeta, d’un taumaturgo, del Messia aspettato, nella sua mente balenò un lampo di speranza, anzi la certezza di riacquistare la vista. Levandosi, agitando le mani e muovendosi come poteva alla volta di Gesù, con quanta voce aveva in petto, gridava: “Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. „ Semplicissima e sublime preghiera, che la fede e la speranza della guarigione mettono sulle labbra del poverello, che riconosce in Gesù il Figliuolo di Davide, ossia l’aspettato Salvatore del mondo. Egli gridava per modo, che i vicini stimarono bene dargli sulla voce e imporgli silenzio, parendo loro che turbasse tutti e particolarmente Gesù Cristo. Ma più gli si intimava di tacere e più alta egli levava la voce, ripetendo sempre il suo grido: “Figliuol di Davide, abbi pietà di me. „ Figliuoli amatissimi! questo cieco, che non fa che ripetere la stessa preghiera sì bella e sì eloquente, è un perfetto modello del modo con cui dobbiamo innalzare a Dio le nostre preci, con fede viva, con perseveranza, senza rispetti umani. Allora Gesù, udendo quelle grida e forse pregatone dai vicini, si fermò e con lui si fermò quella turba che lo accompagnava. Il cieco brancolando, condotto a mano da alcuni pietosi, commosso, anelante, fu ai piedi di Gesù, ripetendo sempre il suo grido: ” O Gesù, abbi pietà di me. „ Avutolo a sé vicino, Gesù, con voce amorevole, gli disse: “Che vuoi tu che ti faccia? „ Senza dubbio Gesù Cristo conosceva ciò che tutti conoscevano, la cecità del meschinello: Egli leggeva nel cuore di lui il desiderio, la domanda che voleva fare; ma volle che la facesse, sia perché apparisse meglio il miracolo, sia perché voleva che con la domanda i n qualche modo meritasse la guarigione. Il cieco, non appena ebbe udita la domanda di Gesù, con quell’ardore dell’anima, che potete immaginare e che tutto gli traspariva sul volto, rispose con tre sole parole: “Domine, ut videam — Signore, la vista. „ Quanta semplicità, quanta fede e quanta forza in queste parole: Signore, la vista! — Il momento era sublime: la turba si accalcava intorno a Gesù ed al cieco: i lontani si premevano per avvicinarsi, si levavano in punta di piedi per vedere: il silenzio assoluto e mille occhi erano fissi sopra il Salvatore e sopra il cieco, che, levando il viso, aspettava ansante una parola, la parola del miracolo. E Gesù la disse: “Vedi. „ Quella parola fu come un lampo, aperse gli occhi del cieco, che furono inondati di luce: attonito, fuor di sé per la gioia, gettò un grido di gratitudine, di amore, a cui si unirono le acclamazioni e gli applausi della folla, che glorificava Dio. Il miracolo è operato sulla pubblica via, alla presenza, sotto gli occhi di numerosissimo popolo, con una sola parola: “Respice — Vedi. „ È narrato da testimoni di veduta, che credono essi stessi in Gesù fino a morire per Lui. Chi potrà mai dubitare della virtù divina dell’operatore? Gesù Cristo attribuì il miracolo alla fede del cieco: “La tua fede ti ha salvato, „ cioè risanato; e in un senso è vero, perché se il cieco non avesse avuto fede in Lui, non avrebbe domandato il miracolo e Gesù non l’avrebbe operato. Carissimi! se non sono molti i ciechi degli occhi corporei, pur troppo moltissimi sono i ciechi degli occhi della mente: son ciechi tanti fratelli nostri, che hanno perduto la fede o che ne dubitano: son ciechi tanti, che, pure avendola, non si curano di operare secondo i suoi dettati: son ciechi tanti, che, dimentichi dei veraci beni del cielo, corrono dietro ai fallaci della terra, schiavi dell’orgoglio e della vanità, della gola e della lussuria e di tante altre passioni. – Deh! che tutti questi ciechi si alzino, si accostino a Gesù e, col cieco di Gerico, gridino a Lui: “Signore, la vista della mente, della fede, „ e Gesù che non rimandò mai un solo inesaudito e sconsolato, dirà loro: “Vedete; la vostra fede vi ha salvati. „
Credo …
Offertorium
Orémus Ps CXVIII: 12-13
Benedíctus es, Dómine, doce me justificatiónes tuas: in lábiis meis pronuntiávi ómnia judícia oris tui. [Benedetto sei Tu, o Signore, insegnami i tuoi comandamenti: le mie labbra pronunciarono tutti i decreti della tua bocca.]
Secreta
Hæc hóstia, Dómine, quaesumus, emúndet nostra delícta: et, ad sacrifícium celebrándum, subditórum tibi córpora mentésque sanctíficet. [O Signore, Te ne preghiamo, quest’ostia ci purifichi dai nostri peccati: e, santificando i corpi e le ànime dei tuoi servi, li disponga alla celebrazione del sacrificio.]
Communio Ps LXXVII:29-30
Manducavérunt, et saturári sunt nimis, et desidérium eórum áttulit eis Dóminus: non sunt fraudáti a desidério suo. [Mangiarono e si saziarono, e il Signore appagò i loro desiderii: non furono delusi nelle loro speranze.]
Postcommunio
Orémus. Quaesumus, omnípotens Deus: ut, qui coeléstia aliménta percépimus, per hæc contra ómnia adversa muniámur. Per eundem … [Ti preghiamo, o Dio onnipotente, affinché, ricevuti i celesti alimenti, siamo muniti da questi contro ogni avversità.]