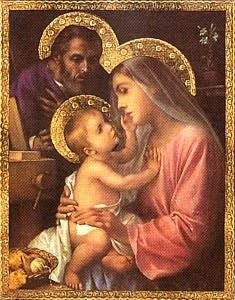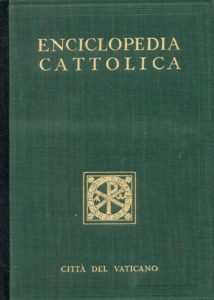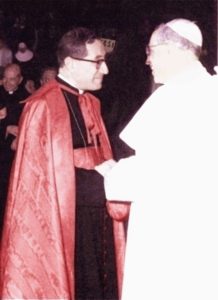
GREGORIO XVII:
IL MAGISTERO IMPEDITO
I. corso di ESERCIZI SPIRITUALI
LA PERFEZIONE
(1)
Cosa c’è di meglio, all’inizio di un nuovo anno, che praticare gli esercizi spirituali, per aver chiaro nella propria vita le cose da fare ed operare in questo tempo donatoci da Dio per crescere nello spirito? E qual modo migliore di farlo è ascoltare e leggere le parola del Santo Padre Gregorio XVII, già Cardinal Siri? – Pubblichiamo la prima serie di esercizi spirituali: “La perfezione”, tenuti agli inizi degli anni 60 anni ad Assisi, registrati, raccolti e resi pubblici dal generoso valoroso sac. Giovanni Rossi, al quale saremo per questo eternamente grati, nel 1962. Si tratta di veri e propri “tesori di sapienza cristiana”, come li definisce nella pregazione, giustamente il Rossi, contenuti in queste piissime meditazioni che sono ancora più opportune, anzi diremmo necessarie e salvifiche, oggi, nei nostri tempi di confusione in cui gli uomini ignorano in pratica, spesso volutamente e colpevolmente, tutta la dottrina cristiana, anche la più elementare, sostituita da un sentimentalismo “buonista” personal-faidatè, falsamente filantropico, e da un vago deismo gnostico profuso a piene mani dagli apostati imbonitori del “novus ordo”, quelli che hanno sostituito il Dominus Sabaoth, il Dio uno e Trino, con “il signore dell’universo”, il falsario diabolico che si spaccia e si fa passare per dio, in realtà il baphomet delle logge massoniche, il lucifero-obbrobrio, l’«abominio della desolazione», colui che governa tutti gli attuali monoteismi che stanno per confluire nella “religione unica mondiale”, cioè il noachismo talmudico …, d’altra parte ci aveva già messo in guardia millenni orsono il Re-Profeta: “omnes dii gentium dæmonia” (Ps. XCV)! In queste due settimane faremo il pieno di dottrina cristiana pratica, lucidamente e sapientemente esposta dal Santo Padre “impedito” Gregorio XVII, sperando così di promuovere la crescita spirituale di noi tutti appartenenti al “piccolo gregge” di Cattolici “eclissati”, e di qualche pecorella smarrita di buona volontà … se ancora ce ne sono! Pubblicheremo così una meditazione ogni giorno, a volte due, ma in modo tale che possano essere ben meditate e fatte proprie lentamente e profondamente. Si raccomanda in ogni caso di riguardarle anche nel corso dell’anno per consolidarne e rinnovarne i benefici.
I CORSO
1.- LA PERFEZIONE
Comincio col dirvi quale è il tema di questi Santi Esercizi, poi ve lo illustro brevemente. Il tema è questo: la perfezione. Di che? La perfezione della vita cristiana. E lo scopo di questi Esercizi è incluso nell’enunciato del tema. Noi dobbiamo arrivare alla fine di questi Esercizi con la volontà precisa, inderogabile, concreta, e per noi cogente, di essere più perfetti. Non con la presunzione di essere dei perfetti, è una cosa diversa, ma con la volontà di esserlo, perché la volontà è umile ed è sempre un dono; la presunzione è superba ed è sempre presunzione. La prima è un dare, l’altra è un rubare. Dobbiamo fissare il punto a cui dobbiamo arrivare. Io vorrei che questi Esercizi vi portassero in quella atmosfera spirituale — non sarò certamente io a farlo e per questo mi affido alla Grazia di Dio — nella quale si sente che a questo mondo si perde il tempo se non si studia la perfezione e se non ci si studia di arrivare alla perfezione. – Voi sapete bene che io faccio gli Esercizi con voi e li predico a me stesso; soltanto li predico a voce alta, e vedrete che qualche cosa potrà servire anche a voi. Tema e finalità, pur non scostandoci dalla linea ordinaria dei Santi Esercizi, ci daranno la interpretazione dei diversi oggetti che andiamo via via presentando. Ho detto che debbo dichiarare il tema, perché altrimenti non è possibile che noi orientiamo ragionevolmente la nostra anima in una forma umana e non semplicemente emotiva; l’emozione si spegnerebbe subito, se non ne conosciamo bene, con accurata definizione l’oggetto. Che cos’è la perfezione? La perfezione sta: primo, nell’aderire completamente alla volontà di Dio; secondo, nell’aderirvi attivamente, non passivamente; terzo, nell’aderirvi con tutte le risorse di natura e di grazia a nostra disposizione. Questa è la perfezione. Il giorno in cui noi avremo fatto quello che dovevamo fare, lo avremo fatto attivamente e in questo fare avremo gettato tutte le nostre risorse, con tutta l’energia, senza nessuna riserva per noi, allora toccheremo lo stato di perfezione. – Per quello che dipende da noi, certo, perché a questo punto e anche prima di questo punto si può entrare in contatto con Dio mediante certi suoi armeggi dei quali io non vi saprei parlare e dei quali io non parlo, perché se qualcheduno ci arrivasse, stia tranquillo che per sapere quello che deve fare ci penserà Iddio a dirglielo, non occorre affatto che glielo dica io. Ecco cos’è la perfezione! La perfezione non è volare, non è fare il teatro, non è smuovere il mondo, non è raccogliere dei frutti. Attenti bene, perché tutte le parole hanno un significato. La perfezione non è godere, anche se Dio può permettere che vi sia del godimento. La perfezione è la volontà di Dio abbracciata, seguita, fatta e, lasciatemi dire, preceduta da noi con tutto noi stessi. Ecco la perfezione! Come vedete, non è un concetto difficile quando si tratta di esprimerlo in via teorica. La musica difficile comincia quando si tratta di fare, ed è per questo che il discorso non finisce questa sera, anche se la definizione è già detta questa sera. E anche quando io finirò di parlare e voi di starmi a sentire, ne avrete per tutto l’anno da rifletterci sopra. Detto questo, vorrei farvi considerare in linea generale la definizione della perfezione. Prima di tutto io non parlo, l’ho già escluso, della perfezione straordinaria, cioè di quelle vie che Dio risolve con interventi suoi, che stanno nell’ordine dei miracoli, che Dio riserva a certe anime che hanno già penetrato i cieli con la loro umiltà. Parlo della perfezione ordinaria, cioè di quella che sta usando gli strumenti che sono dal Vangelo proposti a tutti i cristiani e non a qualcuno soltanto. La perfezione è una cosa semplice, non arzigogolo; la complicazione sta nel movimento che dobbiamo fare noi per toglierci la nostra complicazione e arrivare a quella semplicità. E appunto perché è semplice, esclude tutto quel complesso di pose, di mode, di ricercatezze, di fissazioni che si trovano largamente distribuite negli affari degli uomini e che negli uomini anche perbene riescono a rendere terribilmente antipatica la virtù. È semplice la perfezione! E finalmente è concreta: concreta vuol dire che è tanto nell’idea quanto nei fatti. È realizzabile tutta e deve essere realizzabile tutta nel dettaglio. Quando una cosa non è realizzabile nel dettaglio e nel fatto, è astratta, è cerebrale; serve per dare una pia illusione all’anima e lasciarla perfettamente con tutti i conti scoperti in banca. Prima di andare avanti, io mi fermo per qualche minuto su questo concetto che la perfezione è un fatto concreto, e devo mettervi subito in guardia contro tutto quello che può essere cerebrale e astratto. Se nella nostra vita spirituale c’entra qualche cosa di cerebrale e di astratto, siamo subito fuori strada. Purtroppo il cerebralismo è una tendenza che va largamente serpeggiando in mezzo ai cristiani un po’ più evoluti come tali, in mezzo agli uomini e alle donne che vivono più vicino alla Chiesa, in mezzo ai cattolici che sono militanti. E poi su tanti libri la troverete. E io sento di richiamarvi fortemente su questo concetto concreto, che è poi il linguaggio estremamente concreto di Nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo, perché Nostro Signore Gesù Cristo ha sempre parlato in modo concreto, ha usato l’astratto solo una volta in cui ha parlato di sé stesso e ha detto: « Io sono la via, la verità, la vita ». L’Evangelo ci ha sempre detto cose concrete. Non ci ha detto: abbiate una grande personalità, Gesù Cristo non ha mai pronunciato nemmeno una volta questa parola; Gesù Cristo ci ha detto: « Siate umili e poveri di spirito », in cui si realizza il massimo che esista di personalità al mondo. Perché l’unico modo per essere personalità in questo mondo, cioè per non essere dei confusi, come le facce riflesse nel mare, è quello di essere umili. Studiatevele un po’ le facce riflesse nel mare; vedete se ci riuscite; sono le più distese di tutti, quelle non le prende per il collo nessuno. Io sento molta gente che parla del Corpo Mistico di Gesù Cristo. Che pensano quando lo dicono? E’ una cosa di cui subito sospetto. Perché se continuassero e dicessero: il Corpo Mistico di Gesù Cristo per noi che siamo qui attaccati alla terra è la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, allora sì che ci siamo! E per essere nel Corpo Mistico di Gesù Cristo, io devo essere ubbidiente al Papa, altrimenti sono bell’e fuori dalla porta. Con tutti i miei sentimenti spirituali, con tutte le mie visioni, con tutto il Corpo Mistico, con tutto Cristo vivente, sono fuori della porta, se non ho l’obbedienza del piccolo bambino al Papa, se non ho questa disposizione d’animo verso il mio Vescovo. E se credo di mettermi a fare l’anticlericale e di poter dire alla Chiesa, come a quelle vecchie nonne, senza denti e con rughe e baffi lunghi così che, poveretta, bisogna dirle: nonna, mangia adesso; siediti, nonna; sta’ sù, va’ giù, va’ a dormire adesso…. Voi mi avete inteso vero? La perfezione è concreta. Vi metto in guardia perché molti spiriti del nostro tempo sono fuori strada e si salveranno solamente perché hanno una fondamentale rettitudine e perché Iddio è tanto buono che tiene conto anche della paglia. Ma se non fosse così, ci sarebbe da temere per molti che si dicono cattolici e persino spirituali. – Ora vorrei farvi fare un’altra considerazione. Noi possiamo esigere la perfezione soltanto nel campo spirituale. Negli altri campi non la possiamo esigere. Non è misura degli uomini. Io non posso esigere la perfezione letteraria da tutti, non posso esigere, non parliamone neppure, la perfezione artistica. È possibile invece esigere la perfezione spirituale. Voi lo capirete bene attraverso tutto quello che io spero di dirvi in questi giorni; ma vorrei che vi rimanesse già fin dall’inizio questo concetto: che è solo su questo terreno religioso-morale che noi possiamo parlare di perfezione. Vedete che cosa avviene nel contatto tra noi e il mondo materiale? Possiamo noi entrare in contatto con la materia, per es. con questi mattoni? Direte: sì! Io vi dico: molto poco. Vi meraviglia? Ve lo dimostro subito. Io, di questi mattoni che sono qui e che sto toccando, posso percepire soltanto quello che delle loro qualità è analogo ai miei cinque sensi, cioè poco più di nulla. Per il resto io posso dilatare leggermente questo inizio di mia cognizione usando elementi di trasformazione, cosa che noi impariamo a fare nella fisica e nell’applicazione della fisica, e con poche, leggerissime intuizioni matematiche. Non avete mai osservato che l’unico col quale possiamo pienamente e totalmente entrare in rapporto è Dio? Perché persino con questa penna, che io posso toccare, che io posso spezzare, io entro in contatto in una forma parzialissima, necessaria e sufficiente alla mia vita, ma niente più. Il mondo perde le staffe quando scopre un filamento di più. Che cos’è tutta la teoria nucleare? È un filamento e niente più. Il mondo, come vi ho detto, si prende persino paura di sé stesso perché ha scoperto questo filamento. Con le cose con le quali crediamo di essere in un contatto così profondo, così totale da dominarle, siamo invece in contatto parzialissimo. L’ente col quale possiamo essere in contatto completo con tutto il nostro essere è Iddio. Sembra una vendetta questa? Non lo è, è misericordia. L’unica strada che è veramente aperta, anche se è, si direbbe, intercettata da una cortina di nebbia, la chiamiamo fede. L’unica strada che è veramente aperta è quella che ci conduce all’unico Padre che è Creatore e Signore. Ed è proprio per tale motivo che la perfezione può essere richiesta solo in questo campo, e che in questo campo la perfezione è possibile a tutti, mentre non lo è negli altri campi. – Ed ora che l’argomento ve l’ho presentato, lasciate che io faccia una riflessione sul fine che ci proponiamo con questi Esercizi. Noi dobbiamo arrivare alla fine degli Esercizi con nella testa questo: Io devo essere perfetto. Basta, questo non si discute più. E poiché non bisogna mai dimenticare quello che è estremamente concreto nelle cose, ci vengo subito. – Guardate come è facile nella vita spirituale, quando si fa l’esame di coscienza, trovare che forse non c’è materia di cui chiedere perdono a Dio. Ci sono tanti che la sera fanno l’esame di coscienza, seppure lo fanno, e alla fine dicono: Beh! insomma, Signore, veramente oggi è andata proprio bene. E posso essere soddisfatto. Questa è la sostanza di certi modi di pregare. Ma se, facendo l’esame di coscienza la sera, noi di questo giorno ci abitueremo a tenere la velina delle eventuali imperfezioni quotidiane sopra il disegno della perfezione, che sta sotto, in modo da averlo sempre davanti agli occhi, credo che la finale degli esami di coscienza, anche quando avremo fatto parecchio cammino nella via della perfezione, sarà sempre quella di dover cominciare a dire : « Miserere mei, Domine, secundum magnam misericordiam tuam ». – Se voi vi piantate ben saldi davanti a questa considerazione, capirete perché i Santi hanno pianto sempre sui loro peccati, anche quando tutti gli altri dicevano che non ne avevano. Alcuni credono che i Santi facessero una specie di commedia, che questa fosse una certa tale esibizione, non certo gloriosa, che bisogna tollerare in vista del resto che era positivo, perché lo stare continuamente a piangere e a piagnucolare sui propri peccati e sulla propria indegnità pare loro intollerabile e persino fastidioso. Ma non è il caso di usare la parola intollerabile e nemmeno fastidioso. Amarono la verità, e la verità era questa: che la velina della piccola imperfezione quotidiana, che c’è anche nei Santi, anche se non arriva alla colpa veniale, quelli la tenevano sempre sul disegno di fondo, che era il disegno della perfezione, di quello che dovremmo essere. E allora, quando c’è questo accostamento tra il disegno permanente e la velina che passa ogni giorno, anche se non si facesse altro nella vita, per lo meno ogni giorno si piangerebbe, cioè si farebbe qualche cosa. E questo rimanga, da oggi, nella nostra consuetudine. Arrivati a questo punto noi dovremo cominciare a ragionare dei grandi motivi per cui si deve affrontare decisamente, volitivamente, l’argomento della perfezione; perché è falso ritenere che la perfezione sia da lasciarsi ad alcuni. Io devo essere perfetto e voi dovete essere perfetti. Nessuno è fuori! Qui c’è da indovinare o non indovinare la vita. Infilare o non infilare la strada. Qui c’è il sì o il no; il tutto o il niente. Questo non è argomento di elezione, è argomento di necessità. Noi dobbiamo volere essere perfetti. E siccome per essere perfetti non occorre volare, andare in estasi, fare miracoli, avere visioni, raccogliere frutti, non occorre neanche convertire il prossimo, ammetterete che è possibile essere perfetti. La complicazione dell’impossibilità avviene quando si confonde la perfezione con tutte le altre piccole cose. Lasciamo che Iddio registri e non dimentichiamo che se la nostra perfezione desse poca o nessuna luce in questo mondo, ne darà molto di più nell’altro. Passati noi, ne darà più di noi stessi. Non si darà mai il caso che una perfezione non rifletta luce sugli altri; ma potrebbe darsi il caso in cui chi irradia questa luce non veda affatto di irradiare luce sugli altri. Accetti. Sia contento dì passare per la via dell’oscurità, perché è la via più redditizia. È quella in cui darà più gloria a Dio e amerà di più il suo Signore e Padre. Ma nessuno rimanga fuori. Per la perfezione non occorre la clausura — tornerà bene anche quella, naturalmente, a coloro che ci sono — ma per la perfezione non occorre niente di strabiliante, niente che non si trovi sull’ordinario mercato della grazia di Dio. – La perfezione è aperta a tutti, è un dovere per tutti. Che Dio vi conceda di essere invasati da questa verità, santamente invasati, profondamente scossi, potentemente vitalizzati. Le preghiere mie sono per questo, per me anzitutto, e insieme, sullo stesso piano, anche per voi.
2. – La morte
La prima ragione che noi incontriamo per giustificare l’assoluto dovere di tutti noi di tendere decisamente alla perfezione è che dobbiamo morire. Non ho detto che sia la principale ragione e non lo dico; dico che è la prima che noi incontriamo. È la ragione più spettacolare, è certamente quella che incute timore agli uomini. È quella che deve essere giudicata la maggiormente percettibile dalla loro debolezza, perché là dove non regna l’amore, la porta che è sempre aperta è quella del timore; e quando anche quella si chiude, c’è la porta di servizio della paura. E allora bisogna dire: benedetta la porta di servizio; quando non c’è altro, serve bene anche la porta di servizio. Questa è dunque la prima ragione per cui bisogna essere perfetti. Ci sono altre ragioni, che verranno dopo, nelle nostre considerazioni, ma la prima che si presenta, per i motivi riportati, è che noi dobbiamo morire. – Vengo al primo punto. Quanto tempo ci resta ancora da vivere? Lo chiedo a me, e ciascheduno di voi lo chieda a sé stesso. Quanto tempo? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che, secondo la legge di natura, c’è una certa parabola, e che l’essere più o meno avanti in questa parabola dà una certa generica indicazione. Ma non è mai una indicazione che abbia un carattere decisivo. Supponiamo di avere da campare molto; e con questo? La morte dà il carattere alla vita. Perché, siccome la morte costituisce essenzialmente una chiusura del tempo della prova, e pertanto del tempo in cui si può meritare, essa riflette una incredibile preziosità su tutti i momenti della nostra vita. Questa è la vera funzione della morte. Non è quella di generare una sorta di orgasmo per la esibizione del macabro. Non è quella neppure di mettere in uno stato di eccitazione che finisca alla emotività. La morte riflette il carattere preziosissimo della vita. Perché essa dice: guarda che tu finisci; dopo di me, tu non meriti più. Quello che sarai a quel momento, rimarrai in eterno. La possibilità di riparare qualche cosa delle tue capacità e del tuo tempo e delle circostanze eterne della tua vita finisce con me. Io sono la chiusura del tuo momento. Io segno il limite della tua ricchezza. Io ti precludo la possibilità di qualsiasi aumento. È così che la morte, anche se dovessimo pensare di vivere ancora qualche centinaio di anni, avrebbe sempre lo stesso effetto, darebbe sempre la chiave vera e interpretativa della vita. Non si deve perdere nulla nella vita, per la ragione semplicissima che noi dobbiamo morire e che la morte è una chiusura di merito e di capacità ontologica di aumento. E se poi dovessimo starci poco, in questo mondo, allora alla ragione generale se ne aggiunge una particolare. Perché nella valutazione viene ad accostarsi quello che potevamo fare, quello che potevamo fare meglio e quello che non abbiamo fatto. Sono le tre articolazioni del nostro giudizio, queste, e il modo con cui emergono o scompaiono e si raffrontano tra di loro costituisce una chiusura del nostro valore; ma sono vive, hanno una eloquenza incisiva, forse terribile davanti a noi. Quello che potevamo fare, che potevamo far meglio e quello che non abbiamo fatto. E allora, siccome non è difficile che dal confronto salti fuori qualche elemento di rampogna per noi, è chiara la conclusione: bisogna aumentare l’accelerazione per guadagnare il tempo perduto. Questo è il franco e semplice linguaggio della morte, è la sincera espressione della morte. E detto questo, vi potrei dire che ho finito. Ma rimane qualcos’altro da dire. Vedete che l’articolazione del ragionamento è secca, è chiara, è cogente. – La morte riflette una luce sulla vita ed è la luce di un giudizio di preziosità senza confine. È per questo che dobbiamo desiderare di vivere. Dobbiamo accettare di morire, ma dobbiamo desiderare di vivere. Dobbiamo accettare di morire, ma dobbiamo desiderare di vivere per sfruttare ancora il talento della vita. Perché cinque minuti di più in questo mondo vogliono dire cinque minuti di possibilità di merito. Vogliono dire allungare la strada per il raggiungimento della migliore perfezione. Vogliono dire una approssimazione sempre maggiore alla completezza nella quale noi dobbiamo presentarci al Signore. Ed è proprio in nome di questa preziosità che noi dobbiamo voler essere perfetti; perché lo sfruttamento di tutto il tempo, di tutte le possibilità interiori ed esteriori della nostra esistenza è la perfezione. È la morte che esige la perfezione. Essa non sarà la voce più alta, ma una voce che bisogna sentire, ed è la voce che più facilmente si sente, perché ci eleva sempre con una singolare e dura eloquenza di convinzione su tutte le distorsioni, le evanescenze e le evasioni della nostra vita. – Vengo al secondo punto. Come saranno le circostanze della nostra morte? Questo è interessante a sapersi. Anche se dovremo rispondere che non sappiamo niente, non è inutile questa domanda. Perché il porsi questa domanda rappresenta la franchezza dell’uomo che guarda in faccia il suo destino e che non si copre la faccia. Quali saranno le circostanze della mia morte e della vostra morte? Io ho assistito in questi 12 anni di governo della mia diocesi quasi tutti i sacerdoti miei che sono morti. Nella morte dei sacerdoti ho osservato riflessa perfettamente la loro vita. Ho visto come muoiono quelli che hanno pregato piuttosto poco nella loro vita. Ho visto come muoiono quelli che nella vita non hanno indovinato tutto. Ho visto come muoiono quelli che hanno fatto il loro dovere; ho visto come muoiono i miti e gli umili di cuore. Ciò che mi ha impressionato è il fatto che nel loro tramonto si sono raccolti, con una fedeltà impressionante, tutti i colori della loro vita, e questo prescindendo dal tipo di malattia che hanno avuto, dai dolori più o meno forti. Ma Dio è incredibilmente misericordioso nella sua giustizia, perché se volesse essere soltanto giusto, non ci tratterebbe mai bene, in quanto noi abbiamo sempre dei debiti con Lui, anche quando siamo buoni. Per il mondo possiamo essere buoni, per i superiori buoni, ma con Dio abbiamo sempre dei debiti, e pertanto non è possibile parlare soltanto della giustizia di Dio, perché c’è una giustizia talmente accompagnata dalla misericordia da essere talvolta supplita da questa, ma non travisata, perché la giustizia rimane. Una volta un Generale dell’esercito nostro, che tra le altre sue avventure aveva avuto quella d’essere stato sepolto sotto una valanga, mi raccontò cosa succede quando si arriva proprio a toccare la porta della morte, senza avere nulla di guasto. – Proprio nel momento in cui si spegneva, l’hanno dissepolto, l’hanno tirato fuori. Allora ha perduto la conoscenza, ma era anche incominciata la cura, e credendo d’aprire gli occhi nell’eternità, si trovò ad aprirli in questo mondo. Di tutti i racconti che io ho sentito dalle persone che sono state in punto di morte, questo è stato il più impressionante. Mi raccontò: ero sotto, sepolto; a un certo momento ho avvertito dei sintomi che indicavano l’avvelenamento dovuto al fatto che si respira soltanto anidride carbonica e manca l’ossigeno. Fra me ho detto: io campo ancora sei o sette minuti. In quel momento, come se una luce infinita si fosse accesa dentro di me, ho visto tutta la mia vita, tutta; i particolari di essa mi si sono messi davanti come una carta geografica che io vedevo tutta insieme e nei suoi particolari; io non ho mai avuto in tutta l’esistenza una lucidità di questo genere. Né prima né dopo. Ho visto. E allora ho sentito e ho capito quello che non avevo mai capito prima. Ho chiesto perdono a Dio, e mi sono sentito bene. A questo punto finisce il racconto. – Vedete, bisogna fare i conti con questa illuminazione, incredibile illuminazione. Io non ho riportato tutto il racconto che ho avuto, l’ho riportato nella sostanza; ma ho capito che quella luce improvvisa e grande era la luce adeguata al concetto di perfezione, cioè essa faceva riemergere dal nulla il concetto di adeguarsi totalmente alla legge di Dio. Forse c’è un altro modo di morire. Ho sentito dire e l’ho letto negli studi di qualche biologo che quando si sta per morire avviene una certa composizione nel volto e tutto si va distendendo. Prima del distacco c’è una forma di pacificazione che sostiene per qualche attimo e si distende sulla faccia anche quando ci sono i dolori più forti: questi non si sentono più e tutto finisce in bellezza. Mi pare strano che la morte sia un giochetto così pacifico, un finale guidato dal flauto o dall’oboe, da un lontano arpeggio di esseri celesti. Ma tutte queste cose le dico perché, anche se possono avere un valore relativo, in realtà ci mettono dinanzi a un problema, il problema delle circostanze della nostra morte. È meglio che noi riteniamo piuttosto comune quella tale illuminazione, tremenda illuminazione; abbiamo bisogno di abituarci per tutta la vita al senso della misericordia di Dio, anziché abituarci a pensare che probabilmente tutto se ne va in arpeggi, sotto la nota febbrile di un dolcissimo choc. Bisogna che noi ci ricordiamo che la grande verità teologica che domina il mistero della morte è una proposizione « de fide », che la grazia della perseveranza finale, la quale consiste nel congiungimento dello stato di grazia col momento della morte, è una grazia particolarissima. – Tale grazia è da chiedersi al Signore per tutta la vita, e non solo da chiedersi, ma da operarsi per tutta la vita. Non bisogna credere che Dio abbia legato le sorti della nostra esistenza all’ultimo quarto d’ora. È vero che un quarto d’ora basta a salvare l’anima, e anche meno di un quarto d’ora; pochi secondi possono essere sufficienti ad articolare un atto d’amor di Dio e un atto di dolore perfetto. – Ma la grazia di farlo ordinariamente il buon Dio la lega a quello che s’è fatto in tutta la vita. C’è un terzo punto e credo che sia su questo che la meditazione della morte debba farsi con particolare insistenza. Noi abbiamo il gusto di confinare la morte all’ultimo momento; S. Francesco la chiamava « sorella morte »; ma guardate che non è sorella soltanto perché arriva all’ultimo momento. È sorella perché nasce con noi e s’accompagna a noi per tutta la vita. Che significa questa metafora? Significa che noi moriamo tutti i giorni, di noi muore qualche cosa tutti i giorni. Non è completo l’argomento quando diciamo: si muore, si morirà il giorno tale; no, perché la morte l’abbiamo noi, ora, dentro di noi; ora in noi qualche cosa muore. Si affacciano al nostro sguardo cose splendide, è vero? Le vediamo, ne sentiamo la luce, la carezza del calore. Queste cose splendide se ne vanno a una a una a morire e lasciano il vuoto; si apre una tomba dentro di noi, una luce si spegne, è la morte. Io penso a coloro, per esempio, che sono pazzi per il gioco del football, che ci riescono meravigliosamente, che non vedono altro; è una cosa splendida il giuoco del football, credo che sia così, perché se no non mi spiegherei il tifo e tant’altra sintomatologia. Supponete che uno in questa situazione un giorno si senta dire dal proprio medico curante: attento, voi siete alla vigilia di un infarto; alt, vi basterebbe fare una sola partita perché probabilmente a metà cadiate lì morto. Ve lo immaginate? Supponete che questo tipo non muoia ma campi ancora 50 anni. Ebbene, il giorno in cui, poveretto, s’è sentito dire: alt, non fate più una partita perché una sola partita per voi potrebbe essere fatale, ve lo immaginate? E ‘ morto già un po’, e quella morte lo seguirà sempre, quella tomba vuota sempre risuonerà, echeggerà, graverà su di lui. Vedrà la domenica macchine che corrono; dove vanno? Non c’è bisogno che lo chieda, vanno alla partita; lui non ci va. – Hanno detto che la cosa più difficile è di portare una grande vecchia cantante a teatro. Vedete, le cose più splendide a una a una se ne vanno. E anche le cose nuove se ne vanno. I bambini, in confronto a noi che non dovremmo essere più bambini, un vantaggio hanno, che tutti i momenti scoprono una cosa nuova. Con quei grandi occhi, con quella profonda meraviglia, con quella intensa attenzione, sono veramente il poema della vita che si schiude. Sembra di vedere gli occhi di Adamo spalancarsi quando Dio lo ha chiamato alla vita, e ha conosciuto il mondo e ha conosciuto, penso, anche intellettualmente, il suo Signore e Creatore. Quale stupore! Michelangelo si è provato a ritrarlo nella Cappella Sistina, in una di quelle pitture che forse non si finirà di considerare, e credo che solo un grande genio della pittura lo possa valutare. – Lo stupore. I bambini, il miracolo dello stupore l’hanno in continuazione. Questo miracolo si afferma sempre più, opera fino a una certa età, finché c’è qualche cosa che si scopre che non si conosceva. Ma a poco a poco questo grande patrimonio della possibilità di scoprire si esaurisce e non si scopre più nulla. Quelli che arrivano prima a non scoprire più nulla a questo mondo sono i peccatori, perché quelli vedono la faccia del mondo subito, non c’è più niente così da scoprire. Le anime sante hanno sempre qualche cosa da scoprire, e forse non sanno che, col loro sacrificio di rinunciare a scoprire qualche cosa, si mantengono sempre un’anima di bambini; esse stanno sempre al di qua della cognizione, non al di là. È importante nella vita rimanere al di qua della cognizione, non andare al di là. Io penso a tutta questa gente che ha esaurito tutto, a questi ragazzi che hanno 16 o 17 anni, e non c’è più niente per loro da scoprire a questo mondo, né il bene né il male; hanno mangiato il frutto dell’albero della vita e dell’albero della morte. – Prima c’è stato un fremito che è proprio di chi scopre qualche cosa di nuovo; poi tutto questo s’attutisce, si riduce, svanisce e lascia un vuoto che nessuna cosa può colmare. Voi capite come è vero che tutti i giorni in qualche modo noi moriamo. La cosa impressionante è che a ogni periodo di tempo che passa s’attutiscono le nostre papille gustative; le cose possono rimanere bellissime, ma s’attutisce il nostro gusto e pertanto la nostra capacità di trarne beneficio, e anche noi siamo talvolta una ruota che gira. – Vi ho detto che la perfezione sta nel voler fare la volontà di Dio con tutte le possibilità nostre. Adesso vedete la conclusione. La morte dell’ultimo giorno ci avverte che, terminato il tempo della prova, essa raccoglie la perfezione della vita, ed è questo il motivo per cui dobbiamo essere perfetti, anche se non è il più alto motivo: sono le circostanze della morte a noi sconosciute e per altro possibili a essere intuite dalla colleganza alla vita che ci avvertono, che reclamano la perfezione della vita. La morte di ogni giorno, che costituisce la incredibile tragedia degli spettatori, la morte disegna una trama, la ferisce, la colpisce, la restituisce alla sua verità, alla sua realtà, macabra, orribile, e dice: questa trama alla quale scivolate non vi piace, penso anch’io che non vi piace. Ma c’è una trama della vita, una trama non tenuta lì in serbo, ma una trama attiva ed è la volontà del Signore. Alla trama ordita dalla morte non c’è che da opporre la trama ordita dalla vita, la trama della perfezione. Il suo linguaggio lo capite e lo lascio a voi perché vi accompagni questa sera, vi lasci dormire questa notte. Quando si è perfetti, oltretutto si dorme anche bene. Ma se anche qualche poco vi rubasse il sonno, non sarà un sonno perduto.